
Prefazione a materia redenta di Marina Petrillo, Progetto Cultura, Roma, 2019, pp. 100 € 12 di Giorgio Linguaglossa
Nel saggio giovanile Tradizione e talento individuale del 1917 Eliot mette a fuoco il problema con pragmatica chiarezza: «La tradizione non è un patrimonio che si possa tranquillamente ereditare; chi vuole impossessarsene deve conquistarla con grande fatica. Essa esige, anzitutto, che si abbia un buon senso storico». Nella sua opera successiva il poeta inglese annuncia l’esaurimento della modernità.
Una delle caratteristiche principali della post-modernità è la critica alla modernità e il suo oltrepassamento all’indietro: all’idea del «nuovo» e di innovazione ininterrotta della letteratura, subentra l’idea del ri-ciclo e del ri-uso, della citazione, della de-costruzione. Questo è chiaro in molti autori post-moderni oggi inquadrati come neoclassici. Il mondo salvato dai ragazzini (1968) di Elsa Morante è un’opera tipicamente post-moderna, con il libero impiego di vari generi narrativi che si sovrappongono e si elidono nell’ambito di un discorso poetico ormai vulnerato; Trasumanar e organizzar (1971) di Pasolini segna l’ingresso di un discorso poetico sostanzialmente non dissimile dal discorso giornalistico e narrativo; La Beltà (1968) di Zanzotto è un superlavoro di microcitazioni e di variazioni… siamo arrivati alla summa del Moderno che si autocita e si fagocita. Altre foto per Album (1996) di Giorgia Stecher è una riscrittura del passato attraverso la lente di ingrandimento di alcune fotografie dimenticate nei cassetti di vari comò; il passato viene ripescato e rivissuto mediante vecchie fotografie dimenticate. Incredibile!, la vera rivoluzione della poesia la si fa mediante delle fotografie dimenticate in un cassetto, ripescate messe in forma poetica; la vera rivoluzione la fa Maria Rosaria Madonna con Stige del 1992 adesso ripubblicata insieme agli inediti da Progetto Cultura, Stige, Tutte le poesie (1985-2002) con la sua poesia in neolatino, fitta di scalfitture semantiche, ibridazioni lessicali dal tardo latino ieratico medievale ad un italiano arcaicizzato.
Ormai è chiaro che le rivoluzioni artistiche non si fanno più in avanti ma all’indietro, di lato, ripescando i brandelli e i sintagmi di un mondo trascorso. Auden e Brodskij sono autori tipicamente post-moderni, tornano al ri-uso della metrica tradizionale, la ribasano su un materiale sostanzialmente estraneo e refrattario alla gabbia metrica della tradizione qual è il parlato. Il Moderno, con tutte le sue avanguardie e post-avanguardie, tende a diventare un fenomeno del passato, un circo equestre, un patrimonio amministrato, un museo, mercato, rigatteria, vintage. Entriamo nel Postmoderno. All’idea del progresso estetico subentra l’idea di un regresso estetico, di una diffusione dell’estetico in tutte le direzioni, fuori dagli ambiti privilegiati e protetti della tradizione stilistica del Moderno. Il nichilismo antitradizionale delle avanguardie è progressivo, tende al futuro, vuole andare sempre oltre e al di là, distrugge il passato per costruire un mondo nuovo, distrugge in quanto c’è ancora un patrimonio da dilapidare e distruggere e c’è anche un mondo nuovo da abitare e conquistare.
Oggi, nelle nuove condizioni del Dopo il Moderno, non c’è più un passato da distruggere, anzi, non c’è più un passato, non c’è più nemmeno alcuno spazio per il Futuro.
La poesia di Marina Petrillo la si può inquadrare in questo ambito storico: un tentativo di scavalcamento all’indietro della modernità ripristinando le tematiche «alte» e quelle «basse», il lessico «alto» e quello «basso», il registro del «quotidiano» e quello del periechon.
Ne risulta un libro costituito da un conglomerato di due stili e due approcci metodologici completamente diversi: tendenzialmente ieratico il primo e tendenzialmente cronachistico e pragmatico il secondo. Ne risulta una divaricazione lessicale, prima ancora che stilistica; concettuale. Lo stile tendenzialmente gnomico-aforistico è agglutinato allo stile tendenzialmente cronachistico, ed è in questa ambivalenza, in questa oscillazione tra due stili contraddittori che si rivela la non pacificazione di ciò che non è stilisticamente conciliabile. Il problema della coesistenza di linguaggi disparati e divergenti, caratteristica delle scritture del Dopo il Moderno, non può essere avviato a soluzione con un atto individuale o con una opzione privata dello stile. Ma è qui che si gioca e si giocherà la partita della scrittura poetica del futuro: il bisogno di attraversare i linguaggi detritici e di riporto della tradizione del Moderno (hic facit saltus!) evitando di compromettersi con i detriti della cronaca e del quotidiano come ingenuamente fa il minimalismo.
[La sposa fetale, installazione di Marina Petrillo]
Molto dispari nella resa metrica, la scrittura della Petrillo è attraversata da una inquietudine stilistica e materica per tutto ciò che sfugge al calco mimetico. È l’ibridazione materica di cui si fa carico il discorso poetico di Marina Petrillo che rende questa scrittura sabbiosa, petrosa, scagliosa, acuminata, irrisolta.
Marina Petrillo, seguace di Mallarmé e adepta prediletta di Mnemosyne, considera la pratica poetica al pari di una liturgia nel senso letterale del termine che comprende una dimensione soteriologica, in cui è in argomento la salvezza spirituale, e una dimensione performativa, in cui l’attività creativa è un semplice comportamento pragmatico. La poesia si dà come celebrazione di un significato che sta al di là dei significati intramondani, di un significato trascendibile e trascendente. Detto questo, si capirà la predilezione della Petrillo per la catacresi e l’ellisse, che sono gli strumenti retorici che tendono a spostare il linguaggio verso la soglia dell’indicibile.
La poesia della Petrillo predilige l’espressione figurata, nella quale il letterale e il figurato funzionano come categorie proposizionali della differenza problematologica. Ad esempio nel sintagma «Io diffuso ad Uno», siamo indotti a ricercare altro da ciò che è detto in ciò che è detto attraverso ciò che è detto. Decifrarne il senso implica l’atto di aderire ad un universo concettuale e metaforico dominato dalla contradictio in adiecto e dalla tautologia dove l’enunciato è risposta ad un altro enunciato secretato, risposta alla questione del senso, impossibile a dirsi e a dire se non mediante un atto linguistico figurato. Nella poesia petrilliana la tautologia e l’ossimoro abitano la medesima casa del linguaggio, e il linguaggio ne paga le conseguenze con una situazione di infermità dove il locutore parte da una domanda secretata per andare verso la risposta; e la poesia è nel viaggio, nel percorso che intercorre tra il parlante locutore e il rispondente risponditore. È la ricerca del senso che qui ha luogo, che non può essere soltanto nel disvelarsi del linguaggio senza che vi sia al contempo il presenziarsi del risponditore. È un dialogo muto e intermesso che ha luogo in mezzo alla confusione dei rumori di fondo. È il solo modo in cui può darsi la poesia nella notte dei tempi dello spirituale della nostra epoca digitale.
Per Ezra Pound «una fondamentale accuratezza d’espressione è il solo e unico principio morale della scrittura», e la Petrillo lavora con il bulino del cesellatore per anni intorno ad una catacresi o ad una metafora ardita. È il suo modo di partecipare ad un rito olistico nell’epoca della medietà mediatica. La severità del poeta nei riguardi di se stesso è il miglior lasciapassare per la propria poesia, il lavoro poetico richiede tenacia e auto riflessione e un senso spiccatissimo di autocritica.
Ha scritto Marina Petrillo:
«il Tempo. Spoglio di ogni linearità, abita i fotoni di infinite galassie».
Quando la poetessa romana ha messo su carta questo pensiero non aveva ancora incontrato la pratica poetica della nuova ontologia estetica; tuttavia questo pensiero l’aveva messa sulla strada giusta: che il Tempo non ha alcuna linearità, e che trasporlo nella linearità sintattica e semantica del discorso unidirezionale che procede dal soggetto e passa attraverso il predicato per giungere al complemento oggetto, è un atto di traduzione che falsa sia la realtà delle cose che si presentano nel Tempo sia il racconto che noi diamo delle nostre percezioni e sensazioni. Si tratta di un atto di falsificazione.
Questo è l’assunto base da cui prende le mosse la poesia modernista europea che ha avuto inizio nel 1954, anno di pubblicazione di 17 poesie di Tranströmer. Chi non ha metabolizzato questo fatto, continua e continuerà a fare poesia tolemaica fondata sul presupposto della linearità semantica del tempo. Il concetto, credo, è molto semplice. È questo il pilastro fondamentale della nuova ontologia estetica.
Marina Petrillo stava andando per la sua strada già da molti anni, ancora prima che nascesse la nuova ontologia estetica, pensava in termini di «tempo interiore» e di «spazio interiore», scriveva una poesia della stanza interiore, di un cosmo in miniatura fitto di infinito, dove finito e infinito sono complementari e si legittimano a vicenda.
Per fare poesia nuova, o almeno, diversa, bisogna avere la forza di mettere in discussione quei precetti su cui si fonda il convincimento che confezionare una poesia significa aderirea un discorso che preveda un concetto unilineare del tempo e dello spazio, e la Petrillo ha provato a coniugare la rarefazione sintattica e metrica della poesia di Cristina Campo e di Antonia Pozzi con l’esigenza di una poesia che facesse di quei punti di debolezza, leggi la dismetria e la distassia, un punto di forza e di ripartenza.
Cupo e colmo d’angoscia risuona il lamento di Hölderlin:
«Wozu Dicther in dürftiger Zeit?».
A che scopo? A che pro? Perché i poeti nel tempo della miseria? Che cosa hanno da dirci i poeti nel tempo della povertà?
«L’espressione tedesca [in dürftiger Zeit] – scrive Blanchot – esprime la durezza con cui l’ultimo Hölderlin si difende contro l’aspirazione degli dei che si sono ritirati, mantiene la distinzione tra le due sfere, la sfera superna e quella di quaggiù, mantiene pura, con questa distinzione, la regione del sacro che la doppia infedeltà degli uomini e degli dei lascia vuota, poiché il sacro è questo stesso vuoto che bisogna mantenere puro».
Poco prima dei versi citati, l’elegia recita:
Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch.
Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber das Irrsal
Hilft, wie Schlummer und stark machet die Not und die Nacht.
“Solo per breve tempo l’uomo sopporta la pienezza divina. / Dopo, la vita non è che sogno di loro. Ma l’errore / aiuta, come sonno, la necessità rende forti come la notte”.1
L’errore, l’erranza, la penuria, l’indigenza… aiutano, rafforzano. Perché? Perché in questo tempo di durezza, la parola del poeta non dice più della dipartita degli dei, dell’abbandono, dell’assenza – la pienezza non è più udibile, essa ci dice che la dipartita degli dèi apre uno scenario di povertà nel tempo della durezza dell’essere; che la poesia significa il lutto, parola che oscilla tra memoria ed oblio, tra durezza e povertà dell’essere.
«Entrambi – uomo e dio – sono infedeli», scrive Hölderlin.
Di che cosa parla, infatti, il poeta? Qual è la sua materia? Se ad ogni tentativo di dire qualcosa intorno al proprio oggetto, consegna questo stesso oggetto all’oblio, lo affida alla dimenticanza? Vocazione del poeta è l’esercizio di una perpetua conservazione in perdita. Che ne è allora della parola del poeta, di quella parola che testimonia il sacro, e lo mantiene puro e vuoto?
La poesia della Petrillo alza gli scudi quando la tendenza ad ammutolire diventa insormontabile e soverchiante.
Nel tempo della estrema povertà (in dürftiger Zeit?), ha risposto Marina Petrillo con delle poesie che sembrano provenire dal tempo della mezza luce, della Lichtung, con delle parole sospese nel viale del tramonto, nella «radura» presso la quale l’ospite della terra giunge dopo un lungo silenzioso tragitto. Allora, ecco il segreto di quella frase hölderliniana: «Ciò che resta lo fondano i poeti», non tanto la parola in forza di «ciò che dura», ma anzitutto, la parola per la debolezza di «ciò che resta», perché in esso i poeti fondano il loro regno illusorio fatto di stuzzicadenti e di zolfanelli bagnati di pioggia come l’infrangersi della parola poetica che non è nulla di monumentale, di statuario, di memorabile, quanto un cumulo di detriti linguistici inutilizzati e abbandonati. La parola poetica non è una struttura metafisica stabile ma evento fragile e precario che si iscrive nell’epoca della debolezza e dell’infrangersi della parola poetica sugli scogli dell’essere un tempo stabile ed ora non più.
La parola poetica diventa esperienza della fragilità e della terrestrità, esperienza di un indebolimento di ciò che un tempo lontano era la pienezza del tempio greco o della basilica cristiana ed adesso è un luogo infirmato dal sole e dalla pioggia, dal vento e dagli uomini che abitano la terra e che ad essa ritornano, come erranti, come morti. Il linguaggio della Petrillo si dà come ciò che zerbricht, che si infrange sugli scogli dell’evidenza della terrestrità.
C’è un filo conduttore dall’epoca di Antonia Pozzi, di Cristina Campo, di Maria Rosaria Madonna, di Anna Ventura, di Donatella Giancaspero ad oggi che lega le voci femminili fino a Marina Petrillo, che ci racconta la scomparsa del «sacro». Una così nitida monumentalità non appariva all’orizzonte della poesia italiana da tempo immemore, dove si percepiscono distintamente le scalfitture, e le incisioni del tempo e della terra, le ferite e le abrasioni del tempo, tra il nulla e il presente, dove il tempo è presenza figurale del nostro essere nel mondo, dove la parola è scontro tra mondo e terra nella forma della terrestrità.
È là dove la Petrillo foscoleggia che ottiene l’apice della monumentalità per quell’empito della voce da basso continuo, classicista nutrita di anticlassicismo per quella fedeltà alle regole formali della poesia a partire dal ritmo franto ai raffinati tecnicismi dell’a capo, attraverso cui la poesia modernista del novecento riaffiora in una veste anacronistica e inattuale in un mondo che non sa più che farsene di quella metafisica dell’apparire e del disvelarsi, del venire alla presenza di ciò che non è più presente.
Le parole della Petrillo si presentano omologhe alle parole del corredo funebre con cui si adorna il cadavere di una giovinetta passata anzitempo tra i più…
«Nella tarda modernità l’essere sempre in viaggio, non avere una casa o un porto d’arrivo e non sentire, di conseguenza, la nostalgia per un preciso luogo cui ritornare, può persino trasformarsi in un privilegio. A cosa aspira l’anima moderna, definita da Baudelaire un veliero in cerca della sua terra utopica, un trois-mats cherchant son Icarie? E dove si dirige? Verso l’allontanamento dal noto, Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau (Le Voyage, VIII, 8), per uscire comunque dal mondo, non importa dove (Anywhere out of the world!, in Spleen de Paris, XLVIII).
Se ormai il mondo non ha né centro né periferia, non si possono più desiderare rientri nelle calme acque di un porto, ma soltanto senza meta».2
(Cosa rivela Poesia al Sacerdote del Sublime Tempio…)
Dell’insidiosa tela che il sovrano Tempo
ha posto a sigillo del Mondo
più non altro che cenere si solleva.
Scuote a fatica il capo
l’ultimo amante insoddisfatto
se i fianchi si invaghiscono dello Spirito.
Solo implora la pietà di un bacio.
Involve alfine lo Spazio in azzurrità
e di sua soave Bellezza l’oro
rivela in pudico segreto.
Se accettiamo l’affermazione heideggeriana dell’opera d’arte come «messa in opera della verità», non possiamo non chiederci quale sia il messaggio di «verità» che traluce da questi versi di Marina Petrillo posti in epigrafe.
È certo che la «verità» di cui ci parla la poesia moderna non ha nulla a che fare con la «verità» della metafisica, quella, per intenderci, della piena luminosità nella quale si staglia il marmo della Nike di Samotracia; la nostra «verità» non può che essere una scalfittura che non splende più nella «luminosità» del cielo e della terra ma che abita le intemperie, la mezza luce, lo sguardo distratto benjaminiano, il cono d’ombra, gli angoli intermessi e riposti… che si dà mediante un mezzo parlare, un parlare sibillino, un parlottio smozzicato, un balbutire; non più il tempo oracolare che oggidì risulta sbreccato e corroso; siamo giunti vicini al post-tempo un tempo postruistico e turistico dal quale non ci si affaccia più dal balcone del nulla a quello dell’essere. È il tempo della nostra temporalità infirmata. È il parlare di una modesta sibilla quello della Petrillo che ci parla della perdita perpetua, un parlare dimezzato, smozzicato e infirmato di una regalità infranta e decapitata; il parlare della bocca della testa decapitata, uno smozzicare di sillabe farneticanti senza più senso alcuno, un plesso di fonemi disarticolati e incomprensibili che si presenta nelle vesti disadorne di un «enigma» sordidamente esposto alla dimenticanza dell’essere e della memoria. Ecco perché l’enigma non deve essere interpretato quanto evocato e ricordato come un monito per ciò che è stato e per ciò che sarà nel futuro. Le parole della Petrillo sembrano aleggiare attorno ad un nucleo che si è dissolto, come un fumo che il vento ha disperso.
«Non è sempre necessario che il vero prenda corpo; è sufficiente che aleggi nei dintorni come spirito, e provochi una sorta di accordo come quando il suono delle campane fluttua amico nell’atmosfera, apportatore di pace».2
Le parole della poesia petrilliana aleggiano incerte attorno ad un nucleo assente perché hanno perso la forza di gravità della sintassi e del sensorio che un tempo le teneva legate, perché quella forza si è indebolita…
(Giorgio Linguaglossa)
1 G. Agamben Creazione e anarchia, 2017 pp. 124, 125
2 M. Heidegger, Die Kunst und der Raum, St. Gallen, Erker Verlag, 1969; trad. it. L’arte e lo spazio, di C. Angelino, Genova, Il melangolo, 1984 p. 23
 Poesie di Marina Petrillo, da materia redenta (2019) Continua a leggere →
Poesie di Marina Petrillo, da materia redenta (2019) Continua a leggere →













































 Poesie di Marina Petrillo, da materia redenta (2019)
Poesie di Marina Petrillo, da materia redenta (2019)





































 In «Leopardi platonicus?» anche Cacciari annovera il poeta tra i massimi esponenti della filosofia occidentale (secondo solo a Dante). Tuttavia Cacciari – sottolineando così fin da subito la propria distanza da Severino – si preoccupa di rivendicare la quasi totale estraneità di Leopardi proprio da quella “follia”, costitutiva dell’Occidente, che pensa ogni ente come proveniente dal nulla e ritornante nel nulla: che intende astrattamente, ossia con astratta separatezza, la differenza tra essere e nulla.
In «Leopardi platonicus?» anche Cacciari annovera il poeta tra i massimi esponenti della filosofia occidentale (secondo solo a Dante). Tuttavia Cacciari – sottolineando così fin da subito la propria distanza da Severino – si preoccupa di rivendicare la quasi totale estraneità di Leopardi proprio da quella “follia”, costitutiva dell’Occidente, che pensa ogni ente come proveniente dal nulla e ritornante nel nulla: che intende astrattamente, ossia con astratta separatezza, la differenza tra essere e nulla. Un nichilismo, insomma, quello di Leopardi, che si tratta allora non già di “oltrepassare” (alla maniera heideggeriana), e meno che mai di “confutare” (nel senso severiniano), bensì di “custodire”:
Un nichilismo, insomma, quello di Leopardi, che si tratta allora non già di “oltrepassare” (alla maniera heideggeriana), e meno che mai di “confutare” (nel senso severiniano), bensì di “custodire”:













 Scrivevo in Dopo il Novecento. Monitoraggio della poesia italiana contemporanea (Società Editrice Fiorentina, 2013):
Scrivevo in Dopo il Novecento. Monitoraggio della poesia italiana contemporanea (Società Editrice Fiorentina, 2013):











 Giorgio Linguaglossa
Giorgio Linguaglossa




 .
.













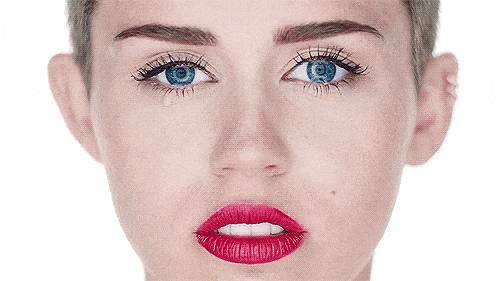
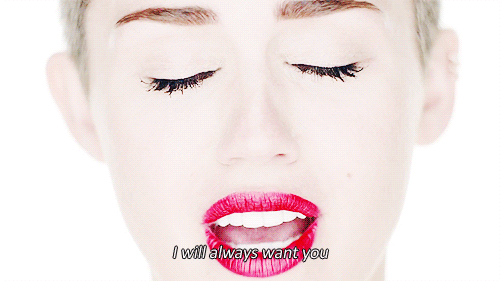


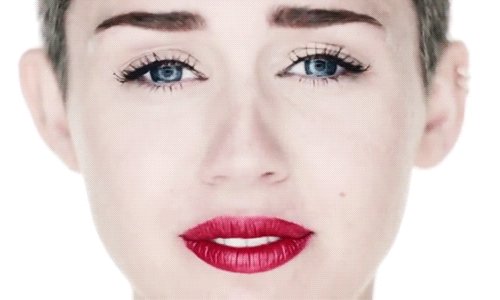








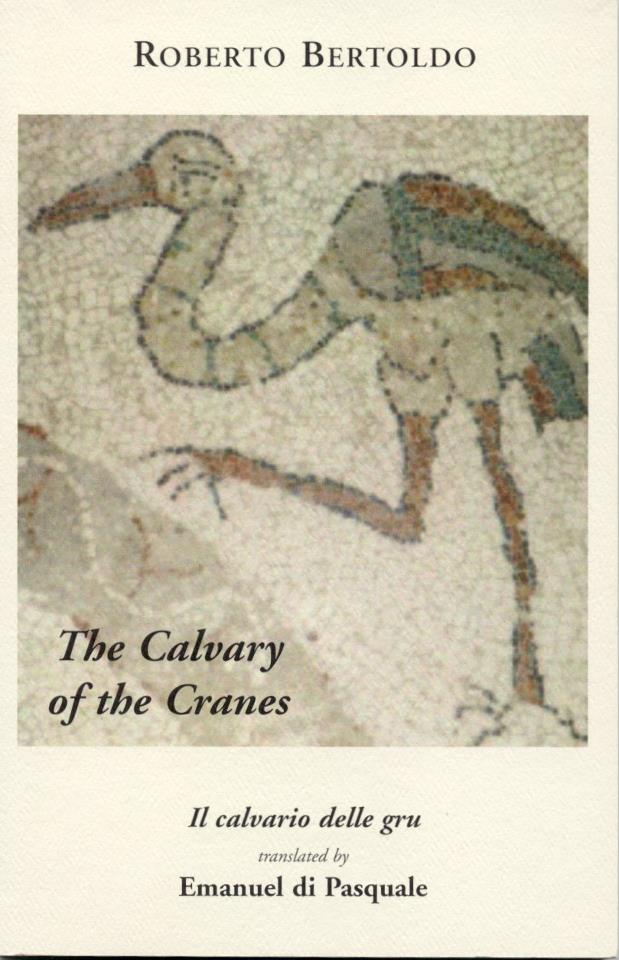
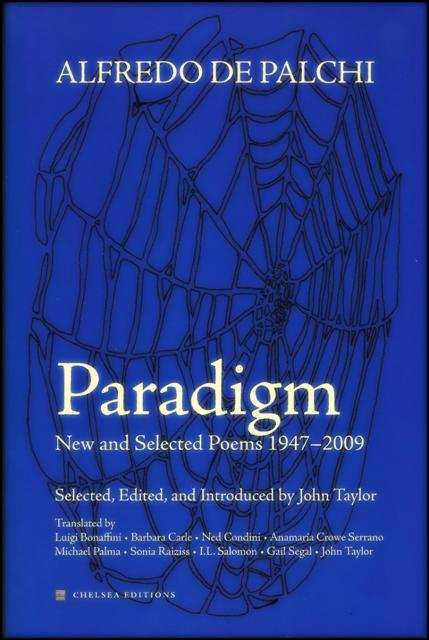


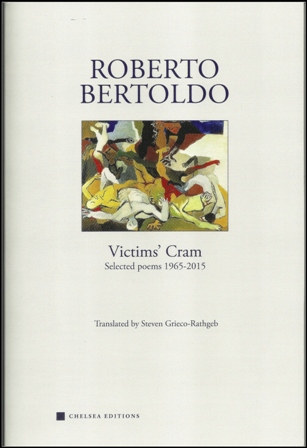





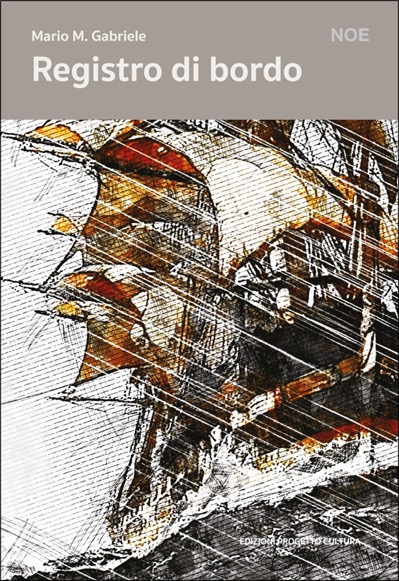

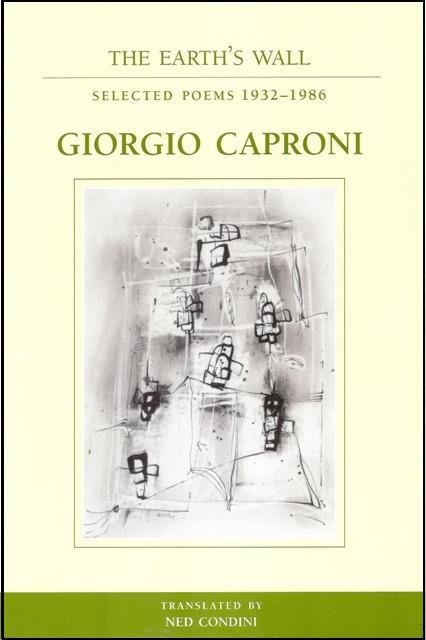
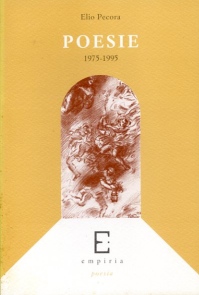

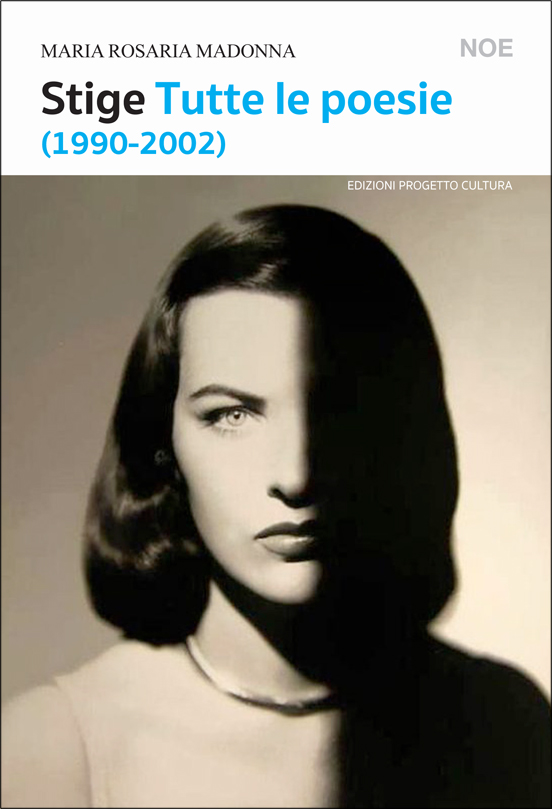

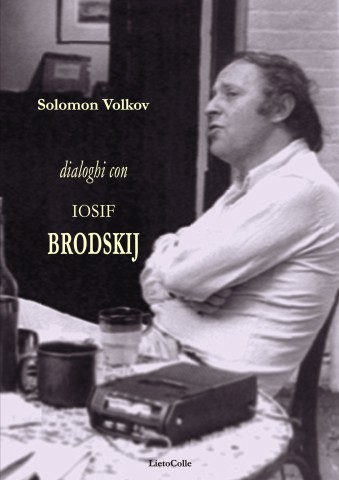



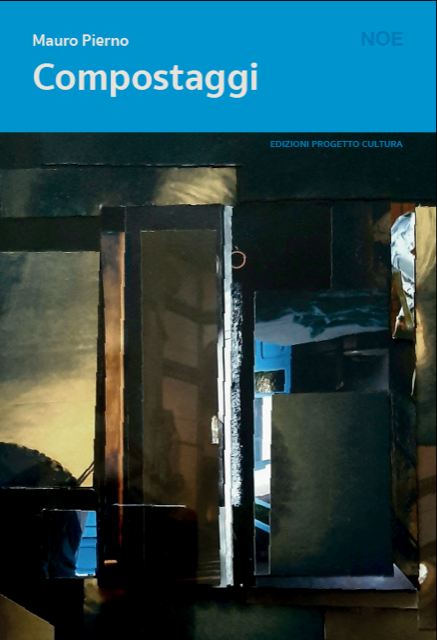




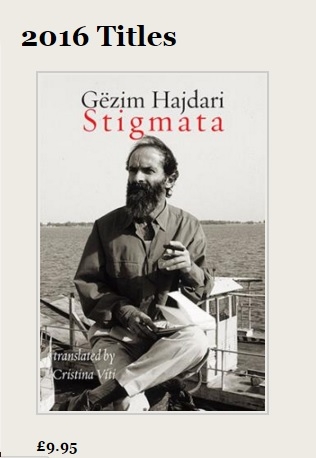






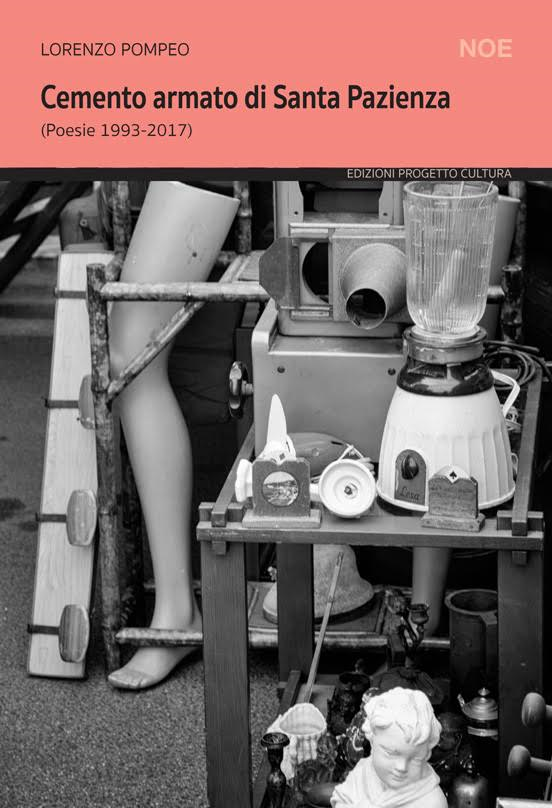







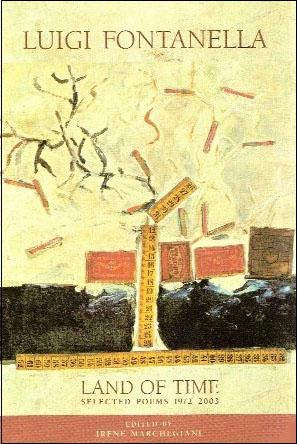








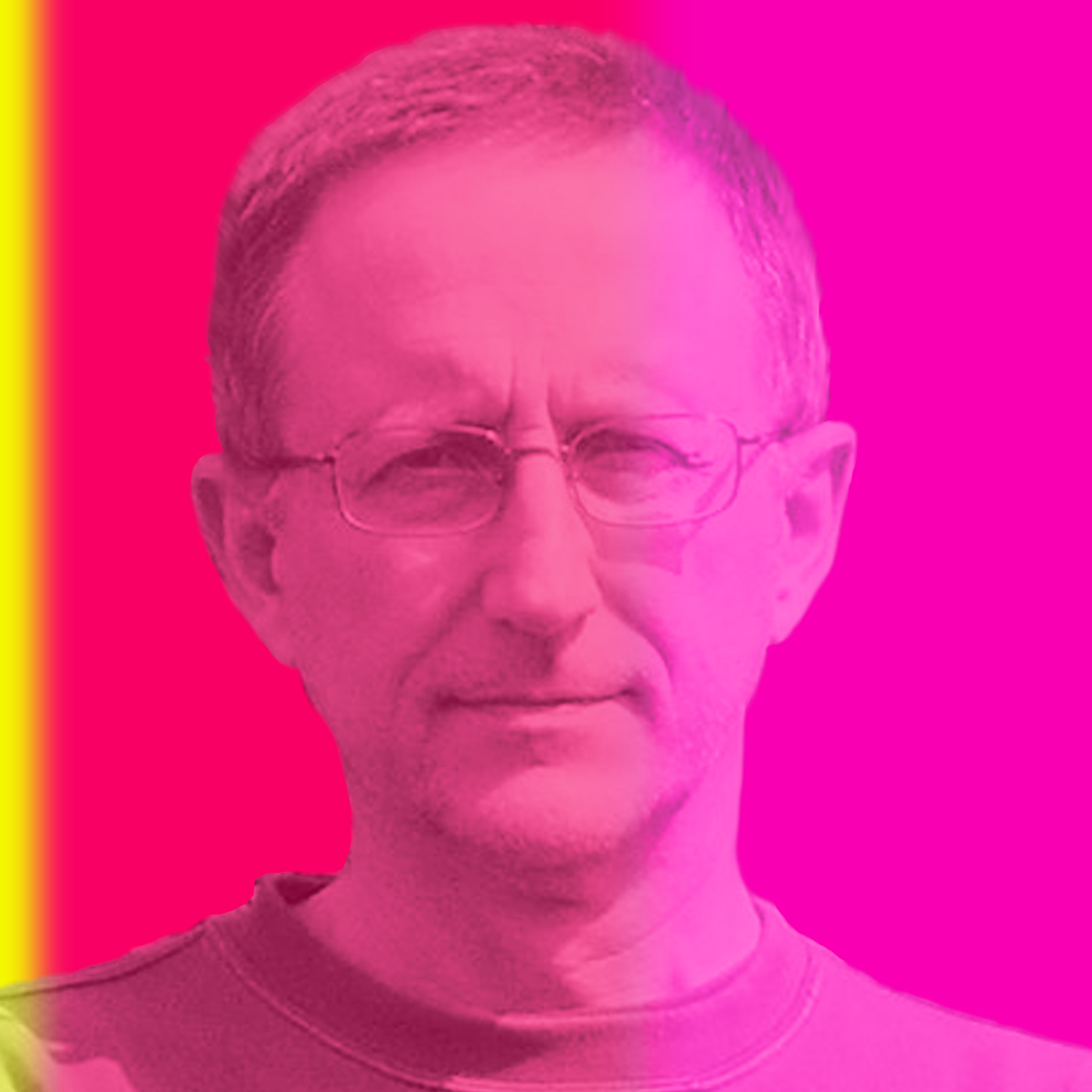







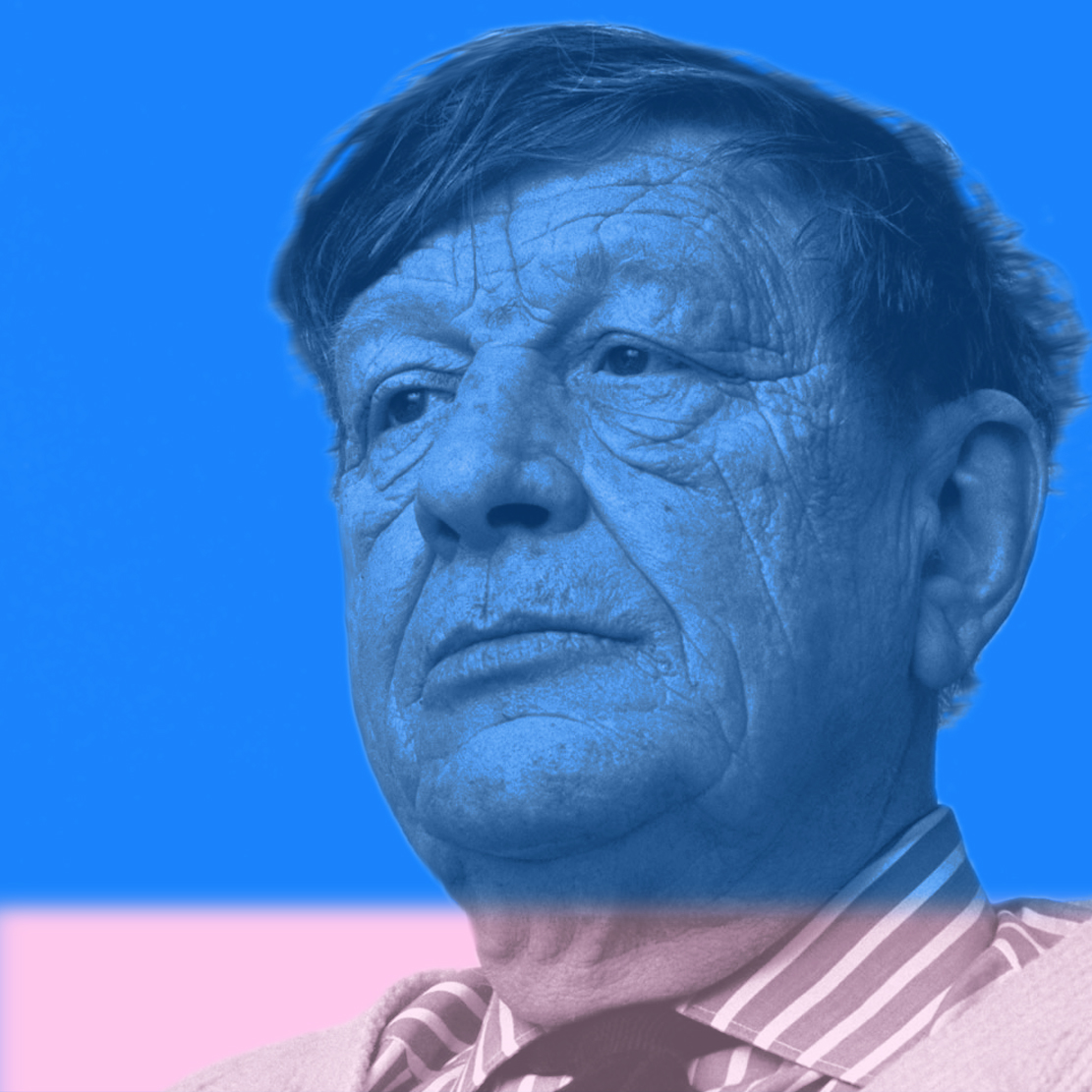





















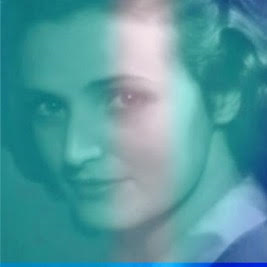































Una poesia inedita di Donatella Costantina Giancaspero da Al quadro manca una ragione con il commento di Gino Rago e una Ermeneutica di Giorgio Linguaglossa
Da qualche giorno, il sospetto che il mare è là dietro
Costantina Donatella Giancaspero vive a Roma, sua città natale. Ha compiuto studi classici e musicali, conseguendo il Diploma di Pianoforte e il Compimento Inferiore di Composizione. Collaboratrice editoriale, organizza e partecipa a eventi poetico-musicali. Suoi testi sono presenti in varie antologie. Nel 1998, esce la sua prima raccolta, Ritagli di carta e cielo, Edizioni d’arte Il Bulino (Roma), a cui seguiranno altre pubblicazioni con grafiche d’autore, anche per la Collana Cinquantunosettanta di Enrico Pulsoni, per le Edizioni Pulcinoelefante e le Copertine di M.me Webb. Nel 2013, terza classificata al Premio Astrolabio (Pisa). Di recente pubblicazione è la silloge Ma da un presagio d’ali (La Vita Felice, 2015).
*
Da qualche giorno, il sospetto che il mare è là dietro.
Dietro lo schermo sbavato di case.
Tra loro si afferrano ai fianchi, come sostegno.
Qui, la persiana ha una fessura puntata sulla scala di ferro battuto.
Sale a chiocciola. Dal cortile, al terrazzo condominiale – testimonia la foto
scampata al massacro dei ricordi –.
Una perfezione fonda, inconoscibile, è forse oltre.
Lo lasciano intendere i gabbiani – stanno qui, da poco tempo, dentro i muri
Più grandi, sul terrazzo condominiale. Sforano la luce.
Ma non è concesso di seguirne i voli. Dall’alto ci sorvegliano.
Se intuiscono uno sguardo intento, scendono in picchiata.
Rasentano gli occhi.
***
Commento di Gino Rago
“La remora, piccolo per statura e grande per la Potenza, costringe le superbe fregate del mare a fermarsi; avventura che, come ci racconta Plinio, toccò alla quinquereme dell’imperatore Caligola.
Mentre questi ritornava dall’Astura ad Anzio, il pesciolino, lungo mezzo piede, si attaccò succhiando al timone della nave, provocandone l’arresto.
Plinio non finisce mai di stupirsi del potere della remora.
La sua meraviglia evidentemente impressionò gli alchimisti al punto di indurli a identificare il pesce rotondo del nostro mare proprio con la remora.
La remora divenne così il simbolo dell’estremamente piccolo nella vastità dell’inconscio.
Che ha un significato tanto fatale: esso è infatti il Sé, l’Atman, quello di cui si dice che è il più piccolo del piccolo, più grande del grande.”
Carl Gustav Jung, Ricerche sul simbolismo del Sé
In questi tuoi versi recentissimi, Costantina cara, mostri di avere sconfitto la remora. Brava.
Qui, la persiana ha una fessura puntata sulla scala di ferro battuto.
Sale a chiocciola. Dal cortile, al terrazzo condominiale
Ermeneutica di Giorgio Linguaglossa
L’enigma non può essere sciolto da un atto di padronanza categoriale, può solo essere rivissuto.
La poesia è un enigma ma un enigma è un labirinto che contiene innumerevoli percorsi, che non può essere sciolto da un atto di padronanza categoriale ma può soltanto essere percorso. La poesia indica questo, indica il percorso da seguire per risolvere l’enigma. Ed il percorso ha la struttura dell’esistenza, una struttura labirintica, soltanto esistendo si può sciogliere l’enigma. L’esistenza è sostanzialmente un vedere, capacità visiva, potenza della capacità visiva. Non è un caso che la poesia termini con l’accenno ai «gabbiani» i quali «sforano la luce», essi che «dall’alto ci sorvegliano», che hanno una suprema capacità di visione, e «scendono in picchiata», ci «rasentano gli occhi».
La poesia rappresenta l’impossibilità di vedere l’Altro,1] di vedere, afferrare il reale con occhio frontale. L’Altro come luogo della parola, è il luogo del reale. È impossibile vedere il reale guardandolo dritto negli occhi, previo il suo svanire. Non si può cioè fare del linguaggio l’oggetto di una visione diretta in quanto «il linguaggio è esso stesso quel presupposto che consente la visione». Il linguaggio, ci dice Giorgio Agamben,2] è ciò che deve necessariamente presupporre se stesso. Il che significa che, come tale, esso è ciò che in ultima istanza manca di presupposto, e questo mancare si dà come esperienza irriducibile, come condizione stessa affinché via sia linguaggio. Dire che non c’è metalinguaggio significa così affermare che ogni dire – e lo stesso ordine significante – si smarrisce una volta posto di fronte ai suoi presupposti.
È qui che ci viene in aiuto la nozione lacaniana di «fantasma», nozione singolare e alquanto oscura che Lacan introduce per descrivere la natura più profonda del desiderio umano, e cioè quel suo essere «desiderio di nulla» che presto si rovescia in un «nulla di desiderio», quel nulla in cui la parola scava la sua dimora e in cui il soggetto fa esperienza della sua propria mancanza a essere. Il soggetto della poesia scopre il proprio svanire come soggetto nel momento in cui vede per la prima volta il «reale», ma, per farlo deve necessariamente sogguardarlo da «dietro lo schermo», dal riparo di un nascondiglio.
Un pensiero ricorrente, ricorsivo, si presenta, anzi, si insinua nella soggettività «da qualche giorno», e con esso il «sospetto che il mare è là dietro», che la soggettività sia un nonnulla, un vuoto che si riempie con gli sguardi. E infatti, l’io si trova a sbirciare da dietro una «persiana»: «qui, la persiana ha una fessura puntata sulla scala di ferro battuto». La poesia ci dice che c’è una «scala di ferro battuto [che] sale a chiocciola». È un preciso frammento di realtà. Una indicazione segnaletica. Soltanto un frammento può illuminare un altro frammento. È possibile sogguardare un frammento di «reale» sostando in un altro frammento del «reale». Tra i due «reali» c’è un collegamento: il soggetto, che si scopre vuoto, che evanesce una volta posto sotto l’imperio dello sguardo, del significante. La poesia deve sfuggire all’imperio dello sguardo-significante e, per far questo, deve procedere come se la parola fosse muta, come un sogno, o meglio, un incubo silenzioso.
La rappresentazione è nitida e precisa come una pittura iperrealista, il lettore deve solo seguire i nessi e ripercorrere il percorso dello sguardo.
Pensiero ed essere sono reciprocamente estranei, non possono comunicare se non da una distanza abissale. La poesia ci narra questa distanza abissale, l’assenza del pensiero. Infatti il pensiero è nello sguardo, fuori dello sguardo il pensiero semplicemente non esiste, non c’è, in quanto l’essere del soggetto appartiene all’esperienza della parola, che è l’esperienza della mancanza. Il soggetto è cioè costantemente rimandato al di là, per la natura stessa del linguaggio, dello sguardo, alla ricerca di una significazione che lo racchiuda. Il suo essere non è, pertanto, lì dove la soggettività pensa, non è lì dove il soggetto si dice e si afferma come cogito, ma lì dove non c’è, dove si dà allo stato come mancanza, come mero sguardo.
[…]
Ecco come risponde Vincenzo Vitiello ad una mia domanda.
Domanda: Lei scrive che «noi abitiamo lo spazio, ma non siamo-nello-spazio; noi abitiamo il tempo, ma non siamo-nel-tempo; e cioè: abitiamo il mondo, ma non siamo-nel-mondo – è ben antica: la si legge in forma concisa e straordinariamente efficace in un testo che è all’origine della nostra civiltà, della civiltà dell’Occidente: «autoì en tô kósmo eisín […] ouk eisìn ek toû kósmou» («essi sono nel mondo […] ma non sono dal mondo»).
Ciò vuol dire che l’uomo è un essere quadri dimensionale, che è il solo essere vivente che vive nelle quattro dimensioni perché si muove nella dimensione temporale della memoria? Ma come possiamo «abitare» il mondo se non siamo nel tempo e non siamo nello spazio?
Risposta: S’aggiunga poi che il mondo moderno, la Neuzeit, l’età nuova – che è pur sempre la “nostra età”, pur quando questa si definisce, per contrasto, “post-moderna” – l’ha ripresa e radicalizzata nella forma di una (metodologica, epperò “possibile”) Weltvernichtung. Quest’ultimo riferimento ci impone di chiarire subito che la tesi, or enunciata, non ha nulla a che fare con la disputa sull’“Io puro”, il “soggetto weltlos”, et similia, non foss’altro perché riteniamo che all’origine di tale disputa vi sia un radicale fraintendimento dell’epoché cartesiana e husserliana del mondo. Anticipiamo pertanto anche la conclusione del saggio: se l’abitare indica la cura per le cose del mondo, quindi il vincolo che ci lega al mondo, il non-essere-nel-mondo sta a significare che questa cura non ci “appartiene”, non è nostra “proprietà” (Eigentlichkeit), non viene da noi, non è-per-noi (ek hemôn), ma viene da “altri”, è per-“altri” (ek állon). Anzitutto: viene da “altro”, è-per-“altro” (ek hetérou).
Se qualcosa non di “nuovo”, ma di “diverso” il lettore può aspettarsi da questo saggio, che riprende questioni antiche e moderne, non è, pertanto, la via percorsa, ma il modo di percorrerla. Diverse non sono le domande. Diversa è la prospettiva da cui vengono poste.
Domanda: Perché il nesso dello spazio col tempo? Perché non possiamo uscire dal circolo dell’interrogazione? Quel circolo dal quale non possiamo uscire con la domanda e la risposta ma che la poesia ci indica allusivamente?
Risposta: Le domande, dunque: a) perché il nesso dello spazio col tempo? b) chi sono gli autoí, i “noi” che abitano spazio e tempo, il mondo, e non sono-per-sé nello spazio e nel tempo, nel mondo? E chi gli “altri”, per i quali abbiamo un mondo, abitiamo spazio e tempo? E chi, o “che” è l’“altro”? La seconda domanda, chiaramente, investe quegli stessi che pongono la domanda. Piega la domanda sull’interrogante. Quanto, allora, la domanda e la risposta, che le vien data, dipendono dallo stare nel circolo dell’interrogazione su se stessa ri-flessa? E non ha senso dire che il problema non è di uscire dal circolo, ma di saper muoversi in esso in modo appropriato, perché anche il giudizio sull’“appropriatezza” del movimento dipende dall’essere-già nel circolo.
Non resta, dunque, altro da fare che… iniziare avendo già iniziato. Non resta, cioè, che muoversi nel circolo in cui già da sempre siamo, e da dove siamo. Senza però la pretesa di porsi dal punto di vista del circolo. Come in fondo pretese Heidegger, che si pose dapprima nella prospettiva del “chi” si muove nel circolo, in seguito – un seguito già previsto e annunciato nel primo movimento – nell’opposta “visione” dell’“Es”, del neutro esso che muove il circolo.
Ci stiamo muovendo in circolo. Purtroppo in un circolo non virtuoso, anzi vizioso, viziosissimo.
il linguaggio di Celan sorge quando il linguaggio di Heidegger muore, volendo dire che il linguaggio della poesia – della ‘nuova’ poesia – può sorgere soltanto con il morire del linguaggio tradizionale che la filosofia ha fatto suo, o – forse – che si è impadronito della filosofia.
***
Dall’alto ci sorvegliano./ Se intuiscono uno sguardo intento, scendono in picchiata./ Rasentano gli occhi.
Gino Rago: La poesia è un Enigma?
(…)
Per J. Derrida «Una poesia corre sempre il rischio di non avere senso e non avrebbe alcun valore senza questo rischio».
In ultima analisi, la poesia è un Enigma. Quando qualcuno parla, parla l’Enigma […] Sicchè nella sua chiosa Linguaglossa traccia un solco fra «poesia-Enigma» e «linguaggio-comunicazione», ovvero l’uso del linguaggio per scopi contingenti o per fini socialmente necessari, utili soltanto alla comunicazione reciproca fra gli uomini di una stessa comunità.
Inoltre, sempre per Derrida «Scrivere, significa ritrarsi… dalla scrittura. Arenarsi lontano dal proprio linguaggio, emanciparsi o sconcertarlo, lasciarlo procedere solo e privo di ogni scorta. Lasciare la parola… lasciarla parlare da sola, il che essa può fare solo nello scritto».3
Risposta di Giorgio Linguaglossa: La poesia è un Enigma. Ogni poesia è il tentativo di impadronirsi di una refurtiva, un tentativo di scasso, e ha senso soltanto se tenta, rischia di sottrarre alle parole del linguaggio comune il senso recondito del significato.
Gino Rago: Da queste premesse alla «metafora silenziosa» (come quel qualcosa che sta prima del linguaggio) il passo è breve. Ci puoi chiarire questo aspetto?
Risposta di Giorgio Linguaglossa: La metafora silenziosa forse è la più alta forma di metafora, la più pura. È quella che non si fa vedere, che preferisce l’inappariscenza, che si mostra simile a ciò che metafora non è. La metafora per Bataille è un «istante privilegiato», l’istante in cui appare il «sacro», che serve a dare «un senso al resto degli istanti senza privilegio» della scrittura. L’apparizione della metafora spezza la normalizzazione del linguaggio. «Questa craquelure spazio-temporale circonda la pointe dell’istante privilegiato, e dimostra in crisi l’ubi consistam, insomma la sostanza, quel qualcosa che sta sotto, a cotesto istante».4
Penso che il linguaggio della nuova poesia sorge quando muore il linguaggio del secondo Montale e di Zanzotto. Penso che questa poesia della Giancaspero sia la sconfessione radicale di quel linguaggio, la sua negazione.
1] Si veda, J. Lacan, Écrits, Édition de Seuil, Paris 1966; trad. it. a cura di G. B. Contri, Scritti 2 voll., Einaudi, Torino 1970; in particolare Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell’inconscio freudiano, pp. 815-16: “Partiamo dalla concezione dell’Altro come luogo del significante. Ogni enunciato d’autorità non trova in esso altra garanzia che la sua stessa enunciazione, perché è vano che la cerchi in un altro significante, che in nessun modo potrebbe apparire fuori da questo luogo. Cosa che formuliamo col dire che non c’è un metalinguaggio che possa esser parlato o, più aforisticamente, che non c’è Altro dell’Altro ”. deve necessariamente presupporre se stesso. Il che significa che, come tale, esso è ciò che un ultima istanza manca di presupposto, e questo mancare si dà come esperienza irriducibile, come condizione stessa affinché via sia linguaggio. Dire che non c’è metalinguaggio significa così affermare che ogni dire – e lo stesso ordine significante – si smarrisce una volta posto di fronte ai suoi presupposti
2] G. Agamben, La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Milano 2004, p. 28
3] J. Derrida La scrittura e la differenza trad. it. Einaudi, 2002 p. 177
4] P. Bigongiari La poesia come funzione simbolica del linguaggio, Rizzoli,
Milano, 1972, p.165
Condividi:Twitter
20 commenti
Archiviato in critica dell'estetica, critica della poesia, Senza categoria
Con tag Bigongiari, Commento di Gino Rago, Donatella Costantina Giancaspero, Ermeneutica di Giorgio Linguaglossa, Giorgio Agamben, Heidegger, La poesia è un Enigma, Lacan Derrida, Montale, Poesia di Donatella Costantina Giancaspero, Vincenzo Vitiello, zanzotto