
Roberto Carifi è nato nel 1948 a Pistoia, dove risiede. Le sue raccolte di poesia: Infanzia (Società di Poesia, 1984), L’obbedienza (Crocetti, 1986), Occidente (Crocetti, 1990), Amore e destino (Crocetti, 1993), Poesie (I Quaderni del Battello Ebbro, 1993), Casa nell’ombra (Almanacco Mondadori, 1993), Il Figlio (Jaka Book, 1995), Amore d’autunno (Guanda, 1998), Europa (Jaka Book, 1999), La domanda di Masao (Jaca Book, 2003), Frammenti per una madre (Le Lettere, 2007), Nel ferro dei balocchi 1983-2000 (Crocetti, 2008), Madre (Le Lettere, 2014), Il Segreto (Le Lettere, 2015). Tra i saggi: Il gesto di Callicle (Società di Poesia, 1982), Il segreto e il dono (EGEA, 1994), Le parole del pensiero (Le Lettere, 1995), Il male e la luce (I Quaderni del Battello Ebbro, 1997), L’essere e l’abbandono (Il Ramo d’Oro, 1997), Nomi del Novecento (Le Lettere, 2000), Nome di donna (Raffaelli, 2010), Tibet (Le Lettere, 2011), Compassione (Le Lettere, 2012). È inoltre autore di racconti: Victor e la bestia (Via del Vento edizioni, 1996), Lettera sugli angeli e altri racconti (Via del Vento edizioni, 2001), Destini (Libreria dell’Orso, 2002); e traduttore, tra l’altro, di Rilke, Trakl, Hesse, Bataille, Flaubert, Racine, Simone Weil, Prévert, Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre; Amorosa sempre. Poesie (1980-2018) (La nave di Teseo, 2018).
Il punto di vista di Giorgio Linguaglossa
Adesso che abbiamo sotto gli occhi l’ampia antologia delle poesie di Roberto Carifi, possiamo tracciare la linea di sviluppo che ha percorso la sua poesia che compendierei così: dalla poesia neo-orfica degli inizi del 1980 alla compiuta narrativizzazione della forma-poesia delle ultime raccolte che si andrà accentuando a far luogo dagli anni novanta fino ai giorni nostri. Perché sia accaduto proprio questo, perché la parabola della poesia italiana dagli anni settanta ad oggi sia defluita nell’ampio delta di una poesia narrativa o narrativizzante, resta a tutt’oggi un problema aperto, ed è il vero problema cui la poesia italiana più consapevole si trova di fronte. Il dato di fatto di questa parabola resta indubitabile ed ha le sue ragioni storiche e stilistiche che potremmo individuare in questi termini: nell’esaurimento delle poetiche propulsive che sono state messe in campo durante gli anni ottanta e novanta dalla compagine dei «nuovi» poeti: da Giuseppe Conte e Milo a De Angelis, che ha preso il nome esaustivo di «poesia neo-orfica» che ben tratteggia lo spettro (da destra a sinistra) della nuova poetica messa in campo. Le figure carifiane della madre, dell’angelo e dell’infanzia perduta («Caduta angeli d’infanzia» è il titolo di una sua raccolta), è la ternità da cui si dipana una poesia fortemente accentuata sul piano anti sperimentale con corto circuiti semantici, intensificazioni linguistiche e scorciatoie di una lessicalità che puntava alla nuda dizione memoriale («un luogo qualunque dell’infanzia»; «l’infanzia chiede di entrare nel fuoco degli anni») con slittamenti nell’elegia compositiva («i volti prosciugati dell’amore»; «ognuno ha una madre che trafigge»), con la percussiva presenza del tema dell’«esilio» e del «mistero» («Ciascuno ha un mistero, un ago/ che lo ricuce al nulla»); con il tema della maternità trattato mediante catacresi di tipo elegiaco («Madre scolpita nel dolore, forestiero al tuo ventre»). È un universo stilistico aurorale che si esprime mediante un linguaggio povero e umile.
Annota Andrea Temporelli:
«Le prime esperienze poetiche di Carifi, tuttavia, si muovono su un più duro terreno fonosimbolico: siamo del resto nella seconda metà degli anni Settanta e in zone dell’esperienza creativa in cui sperimentalismo e orfismo si intersecano (oggi, credo sia rimasta solo la rivista “Anterem” a portare avanti il discorso da questo limen). L’opacità della lingua che si muove pastosamente sulla pagina, creando ingorghi, scivolamenti, catturando insomma una tensione espressiva da liberare magari improvvisamente con tmesi e improvvisi enjambements, è evidente per esempio nella poesia che porta lo stesso titolo della raccolta d’esordio, Simulacri:
carnet d’incauti appuntamenti
la trova assente come
di lusso e miseria la vide figlio
eccitato e regredito la
consumò e rimase
quando di stucco l’altro (benché impossibile)
rispose (amico finché la membrana vischiosa)
tra angelo e bestia stanco dis
seminare mancanze crudele e bianco
di notti bianco biancore abiterò
mistico e poeta gridando
la la lalangue è questo
peregrinare angelico
amore di doppio corpo amore di
corpo di doppio al mercato
del bimbo stupendo amore di bête
amore di bêtise:
l’amore l’azzurro sacrale di Uno
l’icona di marmo
l’amour
Il procedere della scrittura con passo surrealista e tono incandescente già si avvale di un ricco patrimonio culturale (Rilke, Lacan) per proclamare la propria anfibia condizione di “mistico e poeta”, ben inserito in una cosmologia che lo vuole esiliato in un regno intermedio “tra angelo e bestia”, intento a ricostruire sulle rovine del linguaggio la lingua dell’in-fans, legata all’effigie materna e ancora partecipe della figura del doppio (l’angelo androgino) che precede il formarsi dell’ordine simbolico e desiderante del pensiero adulto.1]
 “L’angelismo è il mio télos”, dichiara il Carifi»; «la tecnica è violenza, ontologia senza segreto»,2] scrive Carifi che interpreta in modo personale un pensiero heideggeriano, un pensiero spinto alle estreme conseguenze fino alla rinuncia alla «tecnica». E questa rinuncia indubbiamente segna lo stile del primo Carifi fino agli anni novanta quando interverrà una naiveté, l’abbandono del tono oracolare e incipitario della raccolta d’esordio e un comportamento prosastico che, sì, fungerà da correttivo dell’elegia e della impostazione neo-crepuscolare che stavano al fondo della poesia del suo periodo aurorale degli inizi, ma tenderà a determinare uno stile che espunge dal proprio demanio la radicalità della metafora, la dissonanza, qualsiasi cacofonia o distonia puntando invece sulla confluenza delle lessicalità e dei ritmi in un unico contesto compositivo.
“L’angelismo è il mio télos”, dichiara il Carifi»; «la tecnica è violenza, ontologia senza segreto»,2] scrive Carifi che interpreta in modo personale un pensiero heideggeriano, un pensiero spinto alle estreme conseguenze fino alla rinuncia alla «tecnica». E questa rinuncia indubbiamente segna lo stile del primo Carifi fino agli anni novanta quando interverrà una naiveté, l’abbandono del tono oracolare e incipitario della raccolta d’esordio e un comportamento prosastico che, sì, fungerà da correttivo dell’elegia e della impostazione neo-crepuscolare che stavano al fondo della poesia del suo periodo aurorale degli inizi, ma tenderà a determinare uno stile che espunge dal proprio demanio la radicalità della metafora, la dissonanza, qualsiasi cacofonia o distonia puntando invece sulla confluenza delle lessicalità e dei ritmi in un unico contesto compositivo.
«I topoi della poesia di Carifi sono allo stesso tempo metafore letterarie e filosofiche: esilio, erranza, evento, destino, caduta, vuoto, cenere, rovine, disastro, debolezza, tracce, simulacri, distanza, infanzia e luogo, angelo e dimora, viandante e straniero, viaticità ed abitare. Sono metafore che si radicano al colloquio tra parola filosofica e parola poetica, all’Heidegger che legge Hölderlin, Rilke, Trakl e George, al Celan della “via creaturale” e dell’evento, allo Jabès dell’interrogazione e del silenzio, al Nietzsche che inaugura il pensiero del “sospetto”. Richiamano l’angelo caduto, della custodia o maledetto, l’angelo di Baudelaire, di Hölderlin o di Artaud, la casa e l’infanzia: Hölderlin, Novalis e Trakl; l’Empedocle sempre di Hölderlin: il pensatore e il cantore, la vicinanza tra pensiero e poesia. Le metafore di Carifi nascono da questa vicinanza e da Rilke a George, i poeti prediletti sono pensatori che parlano poeticamente e da Nietzsche a Heidegger, i filosofi sono quelli che parlano attraverso le immagini dei poeti».3]
In Viaggi d’Empedocle, appare chiara la tendenza ad un disboscamento dei topoi retorici con conseguente infoltimento dell’universo simbolico e una intensificazioni di «voci» esterne che pronunciano misteriose sentenze apodittiche; ritornano le tematiche dell’infanzia il tutto in un clima avvolgente di dramma imminente. Si avverte un infoltimento di sintagmi oscuri, di colpe non espiate, oscure, la presenza del mondo dei morti, il senso di perdita, un universo monocromo, una suggestione per le tinte cruente, per le visioni minacciose.
Questa drammatizzazione scenografica, viene intensificata nel successivo libro, Infanzia (1984), nel quale Carifi trova il suo linguaggio più delicato ed equilibrato. Non a caso il lessico e lo stile si riaggancia in qualche modo a quello di Luzi:
Il posto dei ciliegi, l’erba minuta
quando era in un luogo
qualunque dell’infanzia, solo
con le mille azioni
scaraventate nei cortili e tutti,
anche l’albero del noce,
danno un sentiero
che non risparmia nulla…
nessuno,
nessuno si salverà
nel giusto di questi anni
che strappano il viso
e basterà annientarsi, invecchiare
per essere in quel punto
terribile,
prima della tua nascita.

 Giunto a metà degli anni novanta, balugina in Carifi la consapevolezza che la povertà del lessico non è più sufficiente, che uno spettro si aggira nella poesia italiana, che la poesia del Dopo il Moderno è un tipo di produzione che testimonia l’invecchiamento e la deperibilità come fattori positivi che consentono sempre nuove aperture di senso, che la poesia è una forma di produzione che si presenta in termini ostili alla organizzazione del consenso cui invece soggiacciono tutte le altre forme di produzione. Si tratta ancora di un pensiero che albeggia, non ancora percepito forse nella sua chiarezza e nella sua interezza («la carie che rode la parola/ è questo ronzio dietro le tende»), una intuizione che avrebbe potuto condurre ad uno sviluppo diverso e ulteriore la poesia carifiana («c’è un muto che prende la parola»), sviluppo che però si arresta sull’orlo dell’io, con conseguente ricaduta nel pendio elegiaco («sto con le cagne e i contagiati/ non so più nulla di chi amo»).4]
Giunto a metà degli anni novanta, balugina in Carifi la consapevolezza che la povertà del lessico non è più sufficiente, che uno spettro si aggira nella poesia italiana, che la poesia del Dopo il Moderno è un tipo di produzione che testimonia l’invecchiamento e la deperibilità come fattori positivi che consentono sempre nuove aperture di senso, che la poesia è una forma di produzione che si presenta in termini ostili alla organizzazione del consenso cui invece soggiacciono tutte le altre forme di produzione. Si tratta ancora di un pensiero che albeggia, non ancora percepito forse nella sua chiarezza e nella sua interezza («la carie che rode la parola/ è questo ronzio dietro le tende»), una intuizione che avrebbe potuto condurre ad uno sviluppo diverso e ulteriore la poesia carifiana («c’è un muto che prende la parola»), sviluppo che però si arresta sull’orlo dell’io, con conseguente ricaduta nel pendio elegiaco («sto con le cagne e i contagiati/ non so più nulla di chi amo»).4]
La riflessione di Heidegger (Sein und Zeit è del 1927) sorge in un’epoca, quella tra le due guerre mondiali, che ha vissuto una problematizzazione intensa intorno alla de-fondamentalizzazione del soggetto. Durante gli anni novanta, agli inizi di un periodo di crisi economica e stilistica, avviene in Italia una riflessione intorno alle successive tappe della de-fondamentalizzazione del soggetto e dell’oggetto. Si scopre che l’esserci del soggetto è il nullo fondamento di un nullificante. La poesia carifiana, come del resto tutta la poesia italiana di quegli anni non riesce a prendere piena consapevolezza delle conseguenze della de-fondamentalizzazione del soggetto e si limita a navigare intorno al soggetto con una poesia in via di indebolimento progressivo. La «nuova ontologia estetica» dei nostri anni non potrà non prendere atto di questa problematica per trarne le debite conseguenze in sede stilistica.
Con gli anni novanta appare evidente che il mondo ha cessato di essere significativo, e forse al poeta non è concesso l’accesso alle esperienze significative, ed è emblematico che alla poesia di Carifi sia toccato in sorte dover stendere in versi l’epicedio esistenziale forse più disincantato della poesia di matrice tardo novecentesca della sua generazione. Oggi probabilmente, a distanza di più di due decenni, questa problematica appare in tutta evidenza, nei suoi limiti stilistici e nei suoi pregi; oggi noi possiamo parlare dell’indebolimento della soggettività con la tranquilla consapevolezza che ciò che possono dare le parole poetiche forse non è granché ma è pur sempre qualcosa di importante. E infatti, La nuova ontologia estetica prende atto del fatto che non si può uscire dal sortilegio, o dall’immaginario direbbe Lacan, non possiamo sortire né entrare in un luogo sconosciuto se non mediante un trucco, un dispositivo, un cavallo di Troia, con annessa e connessa la rivalutazione della «tecnica» e del ruolo dell’inconscio, perché la città del senso la puoi prendere soltanto con un trucco, con un dispositivo estetico, con un sortilegio, un atto di raggiro, di illusione, perché il poeta è ragguagliabile ad un illusionista che illude con le parole ed elude con le parole. «Il fatto è che non si può davvero uscire dal trucco, o dall’immaginario, come direbbe nel suo linguaggio Lacan».5]
E forse in questo bivio soltanto, che non è soltanto un nodo stilistico ma anche esistenziale e quindi storico, può abitare il senso residuo dopo la combustione e il raffreddamento delle parole della nuova civiltà della comunicazione globale, se davvero v’è un senso nella parola poetica, costretta a sopravvivere in questo «indebolimento della soggettività»,6] e in questa ibernazione dei linguaggi che dura ormai da tanto tempo che ne abbiamo perfino dimenticato la scaturigine.
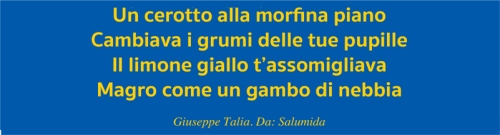
 Il linguaggio paradossale per eccellenza è il linguaggio mitico e il linguaggio poetico che ne è l’erede. Nel mito le categorie del pensiero non-contraddittorio e del principio di non-contraddizione vengono meno, sono inutilizzabili. L’esperienza e l’esistenza sono per eccellenza il terreno della contraddittorietà. Anche la forma-poesia, dunque, deve farsi carico del contraddittorio e del paradosso quali proprietà di ciò che è e di ciò che non è. Di qui la necessità di costruirsi una procedura altamente conflittuale e contraddittoria che congiunga ciò che è contraddittorio come elemento ineliminabile della contraddittorietà incontraddittoria.
Il linguaggio paradossale per eccellenza è il linguaggio mitico e il linguaggio poetico che ne è l’erede. Nel mito le categorie del pensiero non-contraddittorio e del principio di non-contraddizione vengono meno, sono inutilizzabili. L’esperienza e l’esistenza sono per eccellenza il terreno della contraddittorietà. Anche la forma-poesia, dunque, deve farsi carico del contraddittorio e del paradosso quali proprietà di ciò che è e di ciò che non è. Di qui la necessità di costruirsi una procedura altamente conflittuale e contraddittoria che congiunga ciò che è contraddittorio come elemento ineliminabile della contraddittorietà incontraddittoria.
Così, scopriamo che la poesia oggi ha a che fare più con l’illusione e l’abbaglio, piuttosto che con la certezza e la verità, categorie che già filosofi come Platone ed Eraclito non potevano accettare, poiché avrebbero messo in dubbio ciò su cui si edifica il mondo dell’edificabile, il mondo del nomos e del logos, parole altisonanti ma false all’orecchio della Musa. L’illusione è lo specchio della verità: anzi, è la verità che si guarda allo specchio.
Il frammento, l’abbaglio, l’illusione, l’illusorietà delle illusioni, lo specchio, il riflesso dello specchio, il vuoto che si nasconde dentro lo specchio, il vuoto che sta fuori dello specchio, che è in noi e in tutte le cose, che è al di là delle cose, che è in se stesso e oltre se stesso, che dialoga con se stesso…
Di fronte a questa nuova situazione epocale dell’analitica dell’esserci, la petizione panlinguistica propria delle poetiche del tardo novecento scivola invariabilmente nell’ombelico autoreferenziale. Il linguaggio poetico è diventato un linguaggio che si ciba di linguaggio, una dimensione auto-fagocitatoria, metalinguaggio autoreferenziale. Che lo si voglia o no, la poesia del novecento e del Post-novecento è stata colpita a morte dal virus del panlogismo. Invece, c’è sempre qualcosa al di fuori del discorso poetico, qualcosa di irriducibile, che resiste alla irreggimentazione nel discorso poetico. Ecco, quello che resta fuori è l’essenziale: quel qualcosa, la «cosa», di cui nulla sappiamo se non che c’è, che esiste. E, con essa, esiste il «vuoto», che incombe sulla «cosa», risucchiandola nel non essere dell’essere. Forse è proprio questa la ragione fondamentale che ci impedisce di poetare alla maniera del Passato e ci spinge verso una nuova ontologia estetica. Il «vuoto», che incombe sinistro su noi tutti e tutto divora.
 L’oblio della memoria
L’oblio della memoria
Il recupero della memoria di cui la poesia di questi ultimi anni è protagonista e di cui in Carifi c’è una forte traccia, ha radici senz’altro in una crisi di sistema della nostra recente storia poetica nazionale. Ho già avuto modo di parlare dell’oblio della memoria che data dal 1972, anno di pubblicazione della poesia Lettera a Telemaco di Iosif Brodskij; in particolare, la crisi del sistema Italia di cui assistiamo alla recita sul palco della politica in questi ultimi anni, una narrativa per certi aspetti comico-drammatica, tutto ciò, penso, ha avuto delle conseguenze e delle ripercussioni anche nel mondo della poesia. I recentissimi libri di Letizia Leone, Viola norimberga (2018), di Mario Gabriele, L’erba di Stonehenge (2016) e In viaggio con Godot (2017), Donatella Costantina Giancaspero, Ma da un presagio d’ali (2015), il mio Il tedio di Dio (2018), quello di Giuseppe Talia, La Musa Last Minute (2018) quello di Gino Rago, I platani sul Tevere diventano betulle (2019) sono alcuni tra i tanti esempi di un pensiero poetante che segna un ritorno alla ri-costruzione problematica della memoria, di una identità personale e collettiva. Questo è un compito che la poesia non può delegare ad altre forme d’arte e che deve far proprio.
«Ciò che rimane lo fondano i poeti»: ma non tanto in ciò che dura, ma anzitutto in quanto «ciò che resta» è significativo per l’arte: traccia, memoria, monumento scheggiato e corroso, frammento. Questa è l’unica verità a cui oggi possiamo accedere…
La poesia è il riconoscimento dello Zerbrechen (infrangersi) della parola, la sua terrestrità e mortalità…
1] https://www.andreatemporelli.com/2017/02/20/poeti-contemporanei-roberto-carifi/
2] Roberto Carifi, La carità del pensiero, Porretta Terme, I Quaderni del Battello Ebbro, 1990, p. 75
3] Isabella Vincentini, Topografia di una metafora, in «I Quaderni del Battello Ebbro», III, 5, 1990, pp. 36-7
4] Roberto Carifi, Il Figlio, 1995
5] citato in Pier Aldo Rovatti, Abitare la distanza, Raffaello Cortina Editore, 2007 p. 87
6 ]Ibidem

Roberto Carifi
Roberto Carifi
Poesie da Amorosa sempre Poesie (1980-2018), La nave di Teseo, 2019 pp. 357 € 18
Infanzia. Poesie (1980-1983)
Passi del fuoco
“Credevi nella riga perfetta”, i primi
giorni con la bambola azzurra la voce
imprestata
… quando mi chiamerai…
la parte nello specchio del giallo
allontana
le mani o metti le ali sul cuscino
… prendili ora… poi le distanze
infieriva la stagione dei crateri,
a pezzi tornammo dentro l’immagine.
.
Percorsi leggeri (I)
Affonda ora, te lo dico da una linea
di figurine increspate, nel guanto fiorito
d’animaletto stellare
“c’è un testimone, raccontano che avesse
un terzo, un’erba fina”
nella brocca minuscola… prendi… un cenno
lieve, uno scirocco (scivoleranno, vedi,
scivoleranno troppo)
da un delitto uguale, ripetuto, vieni
dipinta d’aria e di mughetto.
.
Nel giusto di questi anni
Il posto dei ciliegi, l’erba minuta
quando era in un luogo
qualunque dell’infanzia, solo
con le mille azioni
scaraventate nei cortili e tutti,
anche l’albero del noce,
danno un sentiero
che non risparmia nulla…
nessuno,
nessuno si salverà
nel giusto di questi anni
che strappano il viso
e basterà annientarsi, invecchiare
per essere in quel punto
terribile,
prima della tua nascita.
.
Ognuno ha una gloria
A volte l’azzurro è una piaga
che rompe il quadrato
dove il mondo riposa ed ognuno
ha una gloria da condurre
nel seno della terra, una ferocia
orfana che chiama amore
e stringe chi lo separa
dalle stagioni, il buio.
.
Finché una mano
Si amano anche così, alla fermata
cancellati da una pioggia
che è lì, da secoli, proprio in quel punto
che li inghiotte e loro
con una smorfia, si
separano dall’autunno
per vedere meglio chi li consuma
finché una mano, decrepita
disegna una stagione lenta
molto più lenta dell’istante
che afferra la loro attesa,
e spara.
.
Nell’angolo più segreto
C’è sempre un graffio, una linea
che rompe i patti e li separa
finché ognuno torna
nell’angolo più segreto, diventa
mistero e forza
fecondata dall’esilio:
allora scoprono che un volto
è ancora poco, troppo poco
per essere un miracolo
e si gettano nudi
in questa piazza
dove qualcuno li cancellerà.

da Occidente (1990)
A occidente
A occidente affondano le navi. Quando?
E’ giusta la voce che racconta il nulla?
scintillano, a volte, ma non è sole
piuttosto un fuoco, un fuocherello acceso nella notte.
Accade a occidente, soltanto a occidente
se danno l’ordine le mani
e comanda il gesto spaventoso.
E’ ora di scendere, degradare laggiù,
verso le nebbie, arrancare se occorre
come morti che cercano l’uscita;
questi sono gli ordini, poi basta.
E’ neve la donna che saluta i marinai,
si scioglierà dietro l’angolo,
si annullerà in segreto,
quando si accende la brace dei ricordi
a occidente è perduto chi non salpa.
Sarà un anno, o due, che hanno portato la notizia.
Uno afferrò il tuo braccio, un altro la mia mano,
insieme afferrammo il legno della morte,
insieme facemmo un fuoco nel giardino
illuminammo tutto, tutto fino al buio.
Sarà un anno,o due, che una voce ci disse è stato,
che un’altra ci disse è primavera,
che una mano ci mostrò la sera
dove respirano le ombre.
Non so da quanto una lacrima entrò nelle parole
e imparammo a scrivere a singhiozzi.
Cenere e sangue. Due parole.
Una per dire la foglia secca, sbriciolata,
l’altra perché il tuo sangue scorra nelle mie vene,
sorella desolata.
.
Ontologie du secret
La morte è un disegno a Porte Dauphine
per questi nati tra bancarelle,
Boutang e il libro del segreto,
la gioia di scoprire il mercato degli uccelli
e la disperazione, a un tratto, nei vetri
dei grandi magazzini
fu vista a marzo
sul muro che divide due quartieri
“Paris esprit de mort”
con il ragazzo a cui gonfiava il collo
e il commesso che diceva:
“venne epurato, il mio maestro,
nessuno ne sa più niente”.
da Il figlio (1995)
Dopo cresciuti, Sonecka, con le bandiere e i corpi
sfiniti dalla corsa abbiamo pianto
dov’era buio e tremavano le stanze…
che ci minaccia, hai domandato,
perché quell’angelo si ammala tra le cose povere,
perché ne parli?
Siamo tornati, Sonecka, alla tua Russia devastata
con l’amore terrestre e una casa gelida
le bambole senti, ragionano nel cuore
questo cielo ci apparterrà per sempre,
magra nella mia paura
contieni un soffitto sgangherato,
figurine da un soldo,
la gioia più limpida e feroce.
*
Una lampada, tra noi, una lanterna fredda
febbraio oppure capodanno, tesse qualcosa la tua mano
o forse disfa, rovina qualcosa la tua mano
e tesse. Che filo, che filo di lana,
che pianto porta la tramontana.
Chi tesse, chi disfa con la sua mano,
qualcuno tiene la lampada,
il sangue dorato della lucerna,
qualcuno è andato e c’è chi torna
con un buio mortale sulla bocca.
Una lampada, tra noi, una lanterna fredda,
narra qualcosa la parola, qualcosa che consuma.
Chi porta questa parola consumata,
chi parla, chi parla in questa lingua arata.
*
È tanto che prego, impiccata a questa corda.
Mi chiamano Marina, come l’acqua!
C’è una brezza marmata nei miei occhi,
una condanna senza appello.
Dicono: verrà di notte, con un grido.
Quando, domando, quando sarà?
È molto, troppo che spenzolo
da questo lampadario. La luce è in fronte,
piantata a caso. La luce è qui,
nelle mie costole.
Se non fosse per gli stracci,
per i cadaveri appesi alle finestre
canterei la fioritura,
la più bella fioritura.
È già l’estate?
Così hanno detto, ma qui è mancato il pane,
anche l’ultima briciola
e nevica ancora sull’erba tenera,
sulla tomba di Sergej.
*
da Nel ferro dei balocchi Poesie (1983-2000)
.
“C’è una luce fortissima, un vento che piega le ginocchia”
“Dove?”
“Dove non puoi guardare”
“Dovrò uccidermi, lentamente, come una cosa abbandonata”
“Non ti capisco”
“Non parlo più la stessa lingua… non posso…”
“Deco andare”
“Perché?”
“Qualcuno dà degli ordini… degli ordini inflessibili”
“Ti aspetterò…”
“È inutile, hanno sospeso il tempo, c’è una neve che
fa tremare anche qui, in questo campo arato”.
.
Voci
I
“Doveva attraversare un paese, ogni sera, vicino a Danzica.
Portava delle lettere, dei sacchi di grano”
“Come si è salvato?”
“Aveva in sé la propria fine. Anche quando parlava, accanto alla lampada, si capiva che era condannato”
“Non è successo altro?”
“Il buio. A un tratto tutte le luci si sono spente, proprio tutte, perfino in periferia”
“Erano in molti?”
“Sì, erano morti… avevano fame, ma non hanno chiesto nulla”
*
(2014)
.
Parlavo in una lingua strana
accanto al tuo letto e tu ad un tratto, facesti il nome di tuo padre.
Quello fu il segno che eri già morta, ed io che piangevo
vidi un debole sorriso sulla tua bocca. O forse mi sembrò
che ti vedevo volare o benedire tutto il mondo mentre il tuo corpo
stava là, immobile, gli occhi incavati che non guardavano nulla,
ma io ti vedevo lasciare il tuo corpo e sorridevi.
*
Sto invecchiando a un passo dalla morte,
mentre tu te ne vai col tuo abito rosa, eterna,
passi le stagioni, i millenni, ogni tanto ti sento
volare sulle mie lenzuola come un angelo
o al mare negli ultimi tempi quando la malattia
era già vicina. Eppure porti ancora quel cappellino
rosso, nella mia vecchiaia me lo immagino così,
liberata dalla morte.
*
da Poesie inedite
Vai nel lastricato, a monte
o a valle, ma che sia una gola
attorcigliata, un imbuto a morte
per quelli come noi
deserto, deserto, deserto
che arde nella notte.
*
Tu che dreni il tuo respiro
a mezzanotte dove i pipistrelli
ti puniscono i capelli,
ci vuole un crepitio
a crepare,
un mormorio d’uccelli.
*
Nella profondità dell’anima
stanno degradati sinonimi
è racchiuso il gelo-buio,
pra si alzeranno i boccaporti
con le maree frastagliate
nel freddo d’ottobre.
.
*
La più logora delle parole
prendila per mano,
conducila alle labbra dei morti,
stella di terrea notte,
palpitano occhi,
scese per te il mio tramonto.

 Chaurapanchasika – Canto dell’amore furtivo
Chaurapanchasika – Canto dell’amore furtivo 12
12





 Guido Galdini
Guido Galdini
 Lucio Mayoor Tosi
Lucio Mayoor Tosi Lucio Mayoor Tosi
Lucio Mayoor Tosi Giorgio Linguaglossa
Giorgio Linguaglossa Mario M. Gabriele
Mario M. Gabriele

 Lucio Mayoor Tosi
Lucio Mayoor Tosi



 “L’angelismo è il mio télos”, dichiara il Carifi»; «la tecnica è violenza, ontologia senza segreto»,2] scrive Carifi che interpreta in modo personale un pensiero heideggeriano, un pensiero spinto alle estreme conseguenze fino alla rinuncia alla «tecnica». E questa rinuncia indubbiamente segna lo stile del primo Carifi fino agli anni novanta quando interverrà una naiveté, l’abbandono del tono oracolare e incipitario della raccolta d’esordio e un comportamento prosastico che, sì, fungerà da correttivo dell’elegia e della impostazione neo-crepuscolare che stavano al fondo della poesia del suo periodo aurorale degli inizi, ma tenderà a determinare uno stile che espunge dal proprio demanio la radicalità della metafora, la dissonanza, qualsiasi cacofonia o distonia puntando invece sulla confluenza delle lessicalità e dei ritmi in un unico contesto compositivo.
“L’angelismo è il mio télos”, dichiara il Carifi»; «la tecnica è violenza, ontologia senza segreto»,2] scrive Carifi che interpreta in modo personale un pensiero heideggeriano, un pensiero spinto alle estreme conseguenze fino alla rinuncia alla «tecnica». E questa rinuncia indubbiamente segna lo stile del primo Carifi fino agli anni novanta quando interverrà una naiveté, l’abbandono del tono oracolare e incipitario della raccolta d’esordio e un comportamento prosastico che, sì, fungerà da correttivo dell’elegia e della impostazione neo-crepuscolare che stavano al fondo della poesia del suo periodo aurorale degli inizi, ma tenderà a determinare uno stile che espunge dal proprio demanio la radicalità della metafora, la dissonanza, qualsiasi cacofonia o distonia puntando invece sulla confluenza delle lessicalità e dei ritmi in un unico contesto compositivo.
 Giunto a metà degli anni novanta, balugina in Carifi la consapevolezza che la povertà del lessico non è più sufficiente, che uno spettro si aggira nella poesia italiana, che la poesia del Dopo il Moderno è un tipo di produzione che testimonia l’invecchiamento e la deperibilità come fattori positivi che consentono sempre nuove aperture di senso, che la poesia è una forma di produzione che si presenta in termini ostili alla organizzazione del consenso cui invece soggiacciono tutte le altre forme di produzione. Si tratta ancora di un pensiero che albeggia, non ancora percepito forse nella sua chiarezza e nella sua interezza («la carie che rode la parola/ è questo ronzio dietro le tende»), una intuizione che avrebbe potuto condurre ad uno sviluppo diverso e ulteriore la poesia carifiana («c’è un muto che prende la parola»), sviluppo che però si arresta sull’orlo dell’io, con conseguente ricaduta nel pendio elegiaco («sto con le cagne e i contagiati/ non so più nulla di chi amo»).4]
Giunto a metà degli anni novanta, balugina in Carifi la consapevolezza che la povertà del lessico non è più sufficiente, che uno spettro si aggira nella poesia italiana, che la poesia del Dopo il Moderno è un tipo di produzione che testimonia l’invecchiamento e la deperibilità come fattori positivi che consentono sempre nuove aperture di senso, che la poesia è una forma di produzione che si presenta in termini ostili alla organizzazione del consenso cui invece soggiacciono tutte le altre forme di produzione. Si tratta ancora di un pensiero che albeggia, non ancora percepito forse nella sua chiarezza e nella sua interezza («la carie che rode la parola/ è questo ronzio dietro le tende»), una intuizione che avrebbe potuto condurre ad uno sviluppo diverso e ulteriore la poesia carifiana («c’è un muto che prende la parola»), sviluppo che però si arresta sull’orlo dell’io, con conseguente ricaduta nel pendio elegiaco («sto con le cagne e i contagiati/ non so più nulla di chi amo»).4]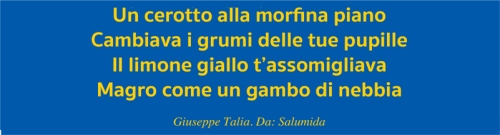
 Il linguaggio paradossale per eccellenza è il linguaggio mitico e il linguaggio poetico che ne è l’erede. Nel mito le categorie del pensiero non-contraddittorio e del principio di non-contraddizione vengono meno, sono inutilizzabili. L’esperienza e l’esistenza sono per eccellenza il terreno della contraddittorietà. Anche la forma-poesia, dunque, deve farsi carico del contraddittorio e del paradosso quali proprietà di ciò che è e di ciò che non è. Di qui la necessità di costruirsi una procedura altamente conflittuale e contraddittoria che congiunga ciò che è contraddittorio come elemento ineliminabile della contraddittorietà incontraddittoria.
Il linguaggio paradossale per eccellenza è il linguaggio mitico e il linguaggio poetico che ne è l’erede. Nel mito le categorie del pensiero non-contraddittorio e del principio di non-contraddizione vengono meno, sono inutilizzabili. L’esperienza e l’esistenza sono per eccellenza il terreno della contraddittorietà. Anche la forma-poesia, dunque, deve farsi carico del contraddittorio e del paradosso quali proprietà di ciò che è e di ciò che non è. Di qui la necessità di costruirsi una procedura altamente conflittuale e contraddittoria che congiunga ciò che è contraddittorio come elemento ineliminabile della contraddittorietà incontraddittoria. L’oblio della memoria
L’oblio della memoria




 Lucio Mayoor Tosi
Lucio Mayoor Tosi

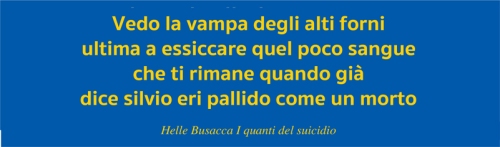 Edith Dzieduszycka
Edith Dzieduszycka
 Sabino Caronia
Sabino Caronia Giuseppe Cornacchia
Giuseppe Cornacchia

 Il Punto di vista di Giorgio Linguaglossa
Il Punto di vista di Giorgio Linguaglossa










 Commento di Nunzia Binetti
Commento di Nunzia Binetti






















































































































































