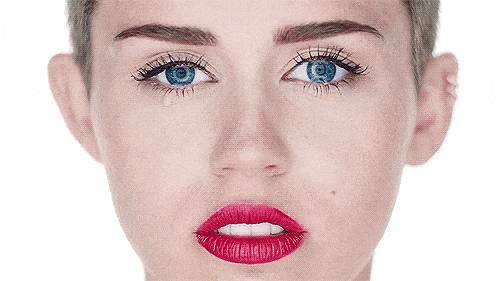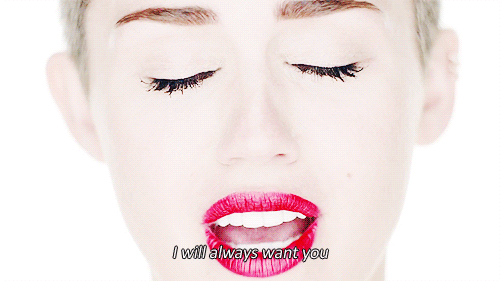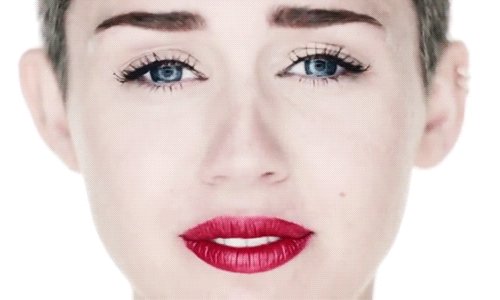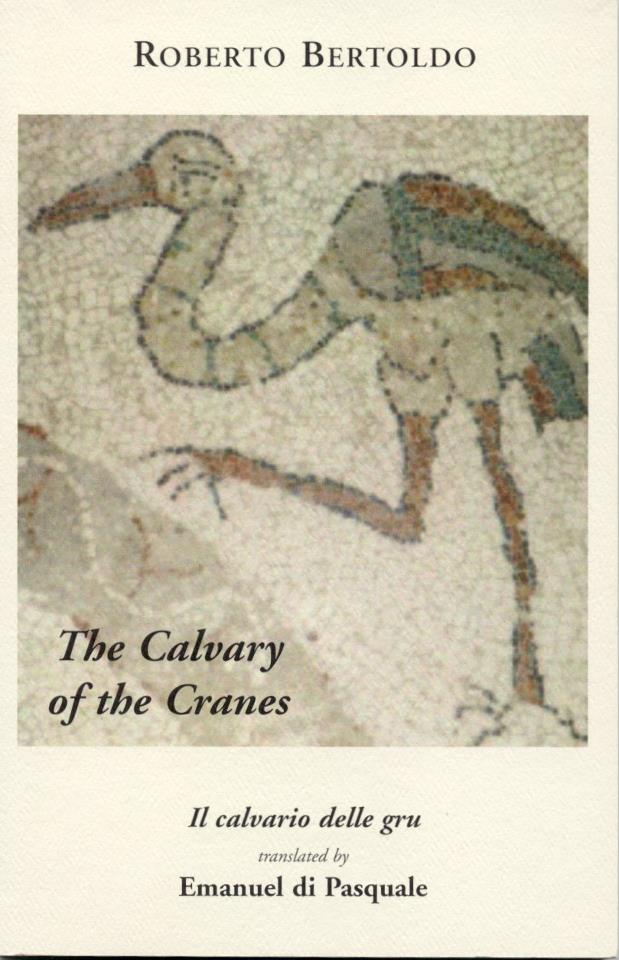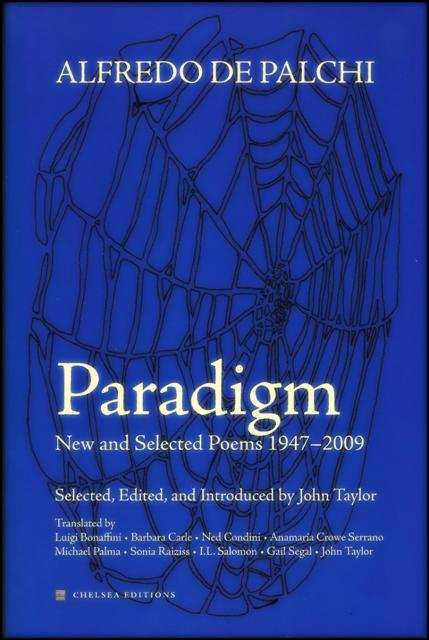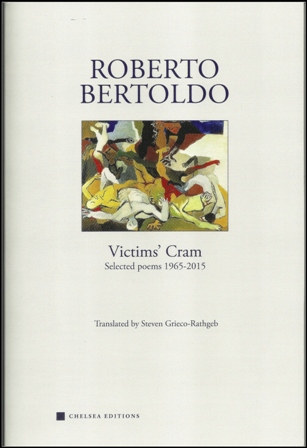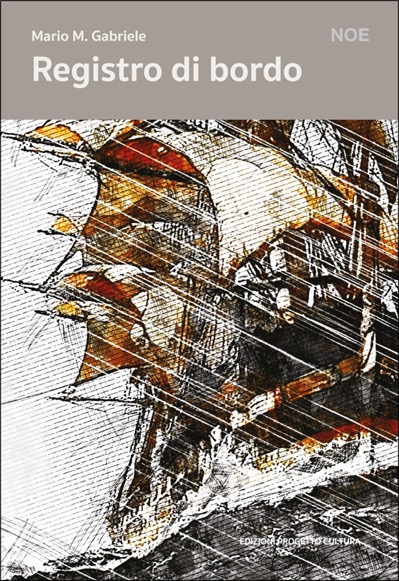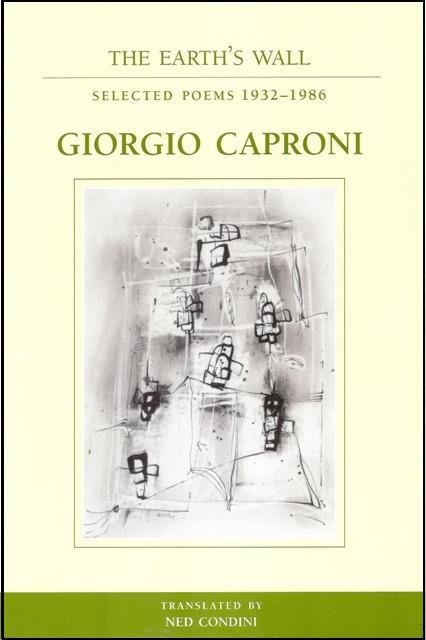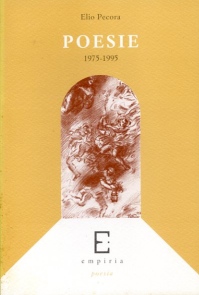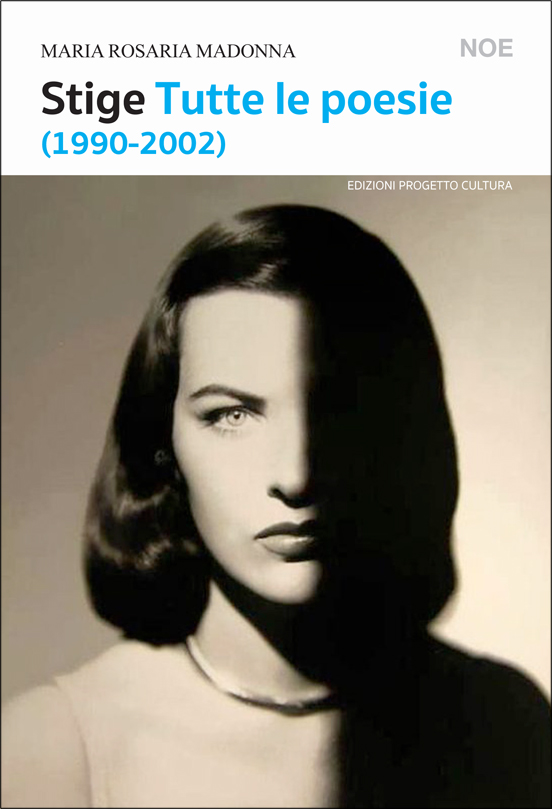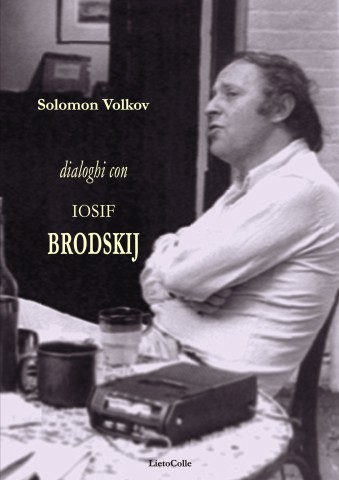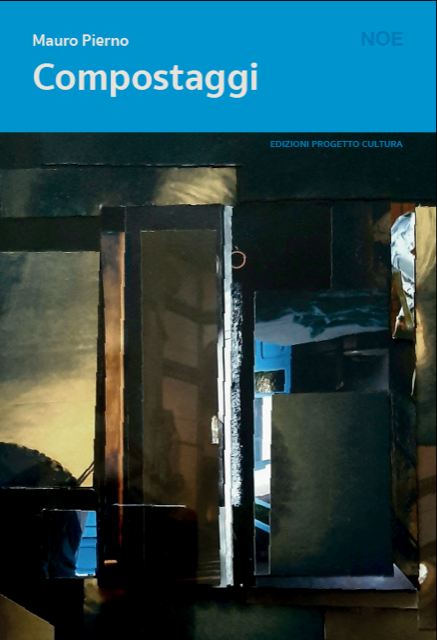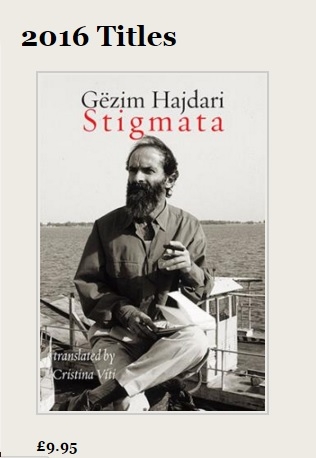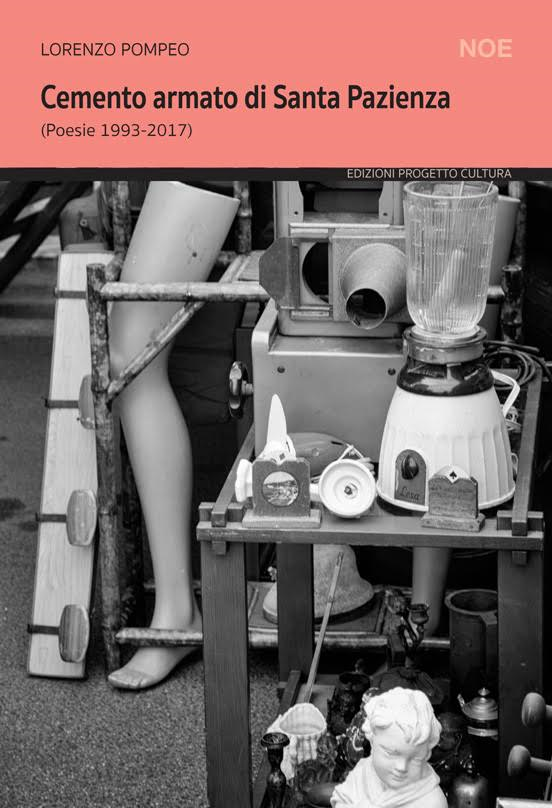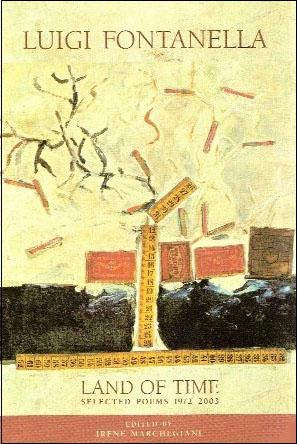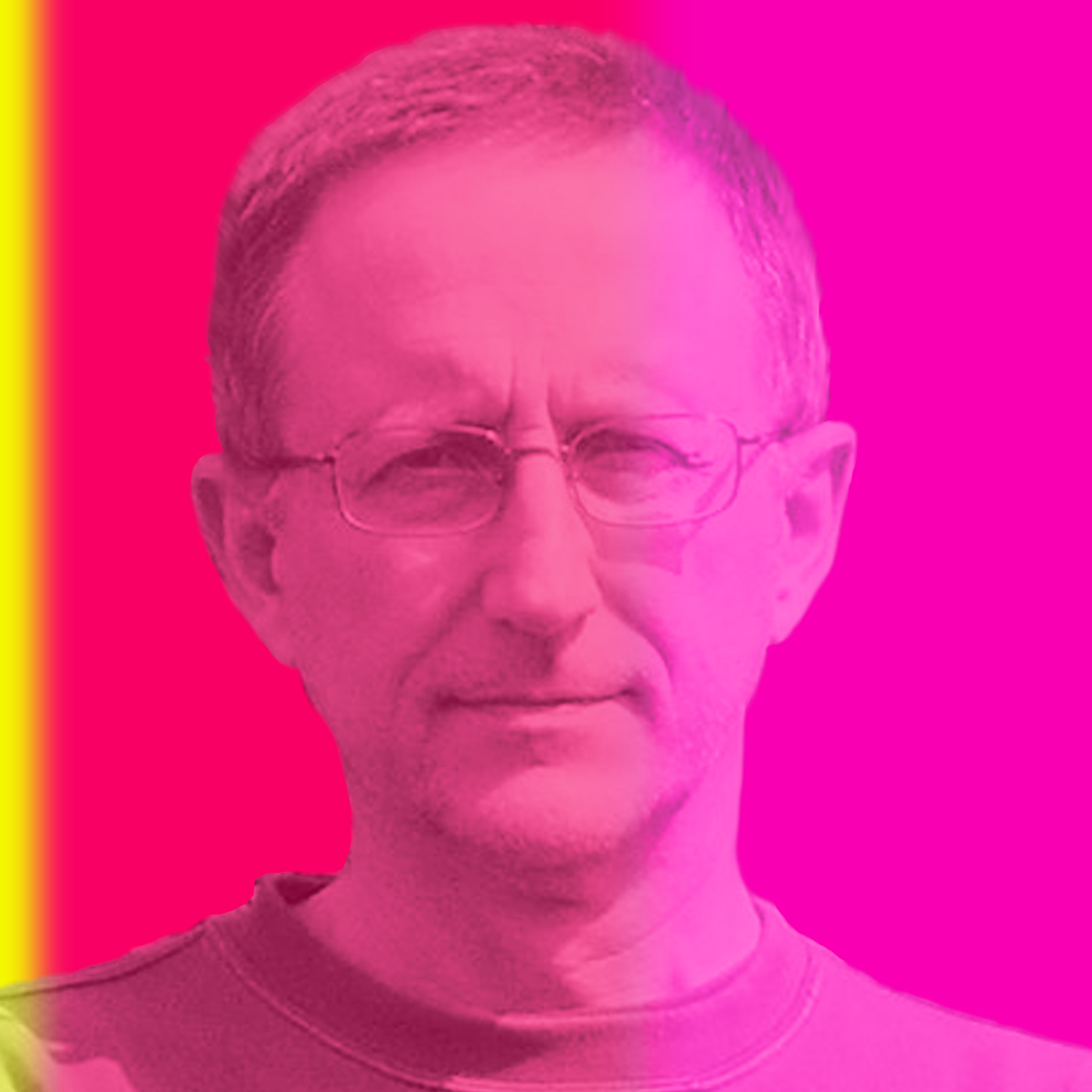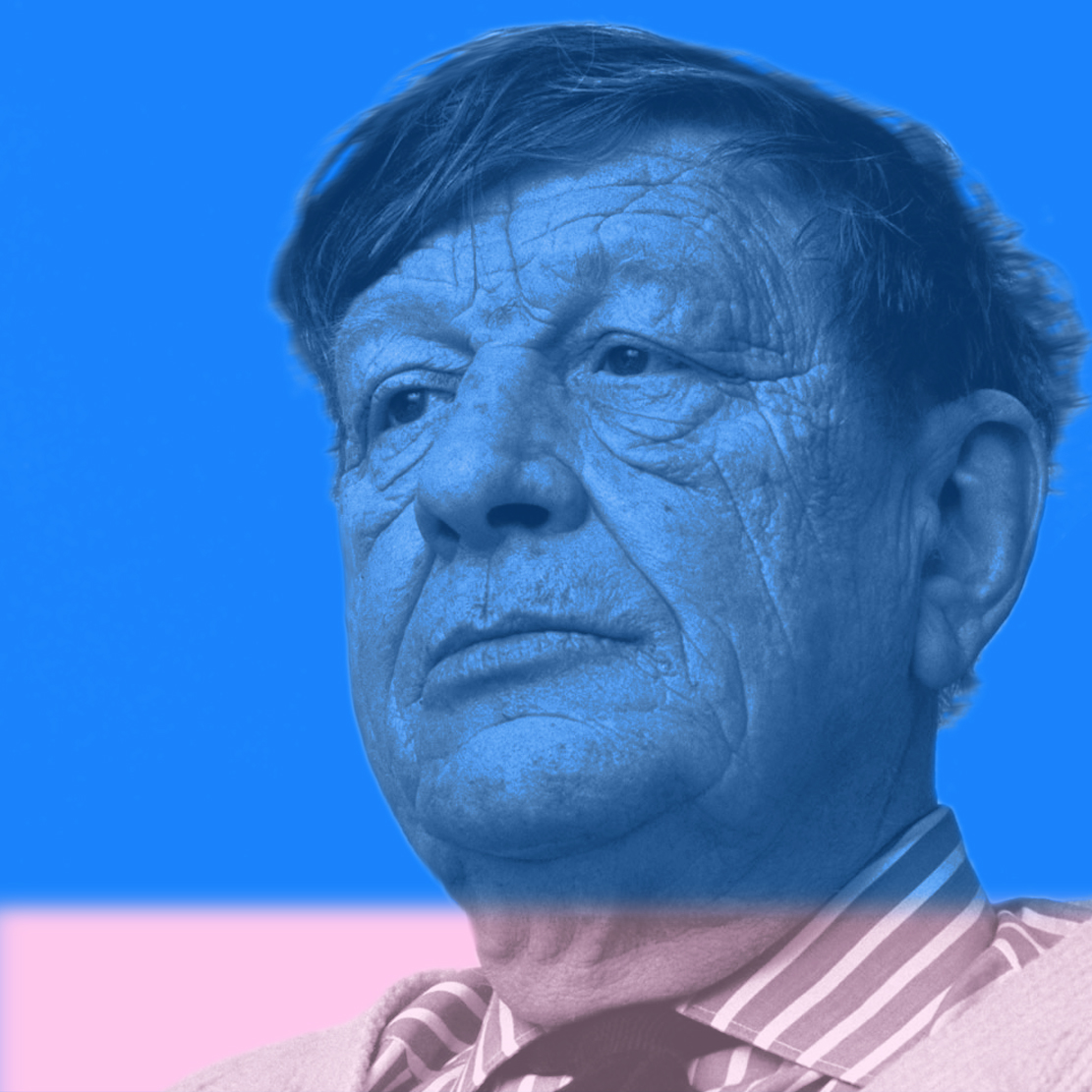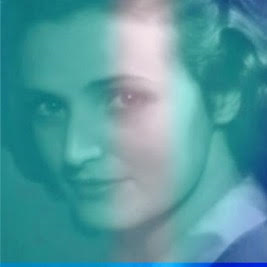Marie Laure Colasson, Struttura dissipativa, acrilico, 35×55, 2015
.
Struttura dissipativa “Z” di Marie Laure Colasson, acrilico 55×35 cm, 2015
ci offre la rappresentazione di oggetti cha non ci sono, che è tutto ciò che accade. L’essenziale non rappresentabile è contenuto in questa «struttura dissipativa». Il reale, nella sua intima estraneità all’ordine simbolico, può manifestarsi solo nei termini di un eccesso residuale. Ecco allora che fuori dal simbolico c’è del reale, ma in quel fuori così intimo che è al contempo un dentro. Fuori dal significato, fuori dal senso il reale si dà al soggetto in tutta l’ambiguità del suo statuto ontico.
Una colonna color rosso imperiale che si sdipana dal basso all’alto su uno sfondo di nerità luciferina e una ricca varietà di narrazioni di contorno, intersezioni intersemiche e polisemiche in un arco di semicolori abbaglianti, cangianti e sfumanti. I colori della Colasson oscillano tra il rosso porpora, il viola cardinalizio, l’arancione acrilico, il verde bottiglia e il blu cobalto delle carrozzerie Audi insudiciate degli anni sessanta, il senape e lo zafferano, la sfumatura di melanzana delle Fiat millecento anni cinquanta, il mandarino e il ciclamino, il cinabro dei vecchi muri scrostati dell’Urbe, il carminio dei rossetti popcorn, il bianco sgualcito e rarefatto delle camicie da mettere in lavatrice, le nuances color mostarda e majonese, la cioccolata, del budino, i colori dell’ovatta usata, il rosa scialbo e livido del yogurt alla albicocca, il violetto sbiadito, il lillà, il color albume dei dentifrici antiplacca, il pourparler delle insalate francesi farcite di creme e cremagliere, gli esantemi di funghi arrostiti, gli unguenti di argan, i sorbetti alla mela verde, il vino novello e quello in barrique, la variantistica dei rettangoli amputati, delle semi sfere, delle losanghe periferiche e della colonna centrale di rosso imperiale che impressiona per la miriade di pigmenti pulviscolari di contorno che scollima con l’effetto di una luminosità iridescente.
(Giorgio Linguaglossa)
Nel tempo terminale dell’antropocene
cari interlocutori, Vi informo che la poesia kitchen è diretta come un meteorite in rotta di collisione contro i denti di drago delle parole, eretti dall’homo sapiens per chissà quale veredizione nel tempo terminale dell’antropocene. È che in questa condizione di confusione ontologica la poiesis di oggi non ha altro scampo che recitare di voler picconare quel «muro» per provare a vedere che cosa c’è là dentro, là dietro, frangere il tegumento delle parole per sondare che cosa c’è dentro l’ovetto Kinder…
Scrive Le Clézio: «Abbiamo voluto dimenticare il fatto che il mondo linguistico è un mondo totale, totalmente chiuso; non ammette compromessi, non ammette condivisione. Dal momento in cui vi siamo penetrati, non ci è più possibile tornare indietro, verso quell’altro mondo, quello del silenzio».1
Dobbiamo prendere atto che il mondo linguistico è un mondo totale, totalmente chiuso, un mondo concentrazionario, che però ammette tutti i compromessi possibili in quanto consente ogni condivisione e anche tutti i contrasti possibili proprio in quanto consente ogni condivisione. Dal momento in cui abitiamo la fase terminale dell’antropocene, ci è possibile tornare indietro o andare avanti nel futuro mediante l’immaginazione o il metaverso, verso quell’altro mondo, quello dell’immaginazione e di un universo ektraneo. Siamo quindi condannati ad andare avanti a tentoni, verso il rumore delle parole, quelle assurde, insignificanti, plurisignificanti, impostore, fasulle, farisaiche, nauseabonde. Siamo diventati esseri serendipici senza saperlo, senza volerlo; in quanto post-edipici viviamo senza la minaccia dell’angoscia, liberi da Edipo, oscilliamo tra un tartufesco non voglio e un tartufesco non posso; non siamo minacciati che da noi stessi, dalle nostre fisime e dal nostro ego, in realtà siamo tutti diventati ciechi come veggenti.
La procedura serendipica esiste da sempre, ma è solo adesso, nel tempo terminale dell’antropocene e con la poetry kitchen che questo fenomeno da episodico viene elevato al rango di consapevolezza critica e di statuto poietico, di centralità ontologica ed epistemologica, ovvero, di procedura della prassi, artistica e non.
Ha scritto Jules-Henri Poincaré nel 1914: «Ogni giorno rimanevo […] seduto a tavolino, provavo un gran numero di combinazioni e non arrivavo a nessun risultato. Una sera, contrariamente alle mie abitudini, bevvi una tazza di caffè nero, e non riuscii a prendere sonno: le idee scaturivano in una ridda, le sentivo quasi cozzare le une con le altre, fino a quando due di esse non si agganciavano […] a formare una combinazione stabile. Al mattino, avevo stabilito l’esistenza di una classe di funzioni fuchsiane […]. Non mi restava altro da fare che mettere per iscritto i risultati.»
Il Reale la poiesis kitchen lo raffigura in modo traslato e intersemico e lo convoca in una struttura auto sufficiente e auto immune, erige la propria struttura difensiva e ostensiva perfettamente in grado di rendersi indifferente ed estranea alla prassi, perché la felicità non è nella prassi ma al di là della prassi, al di là della storia. La sola felicità compossibile è quella che è contenuta nella prassi di una poiesis intesa alla stregua di una «struttura dissipativa» come atto di negazione e di rinegoziazione.
Nella poiesis di oggi la forza della negatività è visibile nella sua rara avvertenza e nel rigore del suo statuto ontologico perché percepisce la prassi ermeneutica come intimidatoria e insidiosa, poiché la poiesis non rappresenta nulla, ritiene il concetto di rappresentazione inadeguato oltre che inefficace in quanto la felicità è sempre aldilà, irraggiungibile perché sempre un po’ più in là. Come Scrive Adorno nella Teoria estetica (1970): «La forza della negatività nell’opera d’arte dà la misura dell’abisso fra prassi e felicità».
1 J.M.G. Le Clézio, La torre di Blabele , in P. Barbetta, E. Valtellina (a cura di), Louis Wolfson. Cronache da un pianeta infernale, Manifestolibri, Roma 2014, p. 101

M.L. Colasson Struttura dissipativa, acrilico 25×40, 2019
.
Poesia kitchen di Francesco Paolo Intini
INSEGUENDO UN PESCIOLINO D’ARGENTO IN UN SERBATOIO DEL VUOTO
(ovvero tentando un compostaggio viene fuori un puzzle)
Dal libro di Poe un pesciolino
grande quanto un orangutan
E su in alto c’è un aereo
Che ronza tutto attorno
Seguitava un pesciolino a mostrare le ferite d’argento.
Il microfono era salvo per miracolo e poteva fare il suo servizio.
L’evoluzione è ovvia. La cucina contiene tutti gli elementi di un perfetto disordine. Se la lavastoviglie è la suocera, il frigo è la nuora. C’è spazio per Antigone ma anche per un pesciolino d’argento o un’aragosta nella grotta del divano.
Invece solo un pesciolino è sembrato interessarsi a te,
ti avrebbe persino adulato e citato uno dei tuoi versi
se gli avessi promesso di tirarlo fuori dal lavandino
anche solo per le zampette d’argento.
Non è il caso di invidiare il pesciolino
che pattina tranquillo
sul ghiaccio dell’argento
godendo l’ aria fresca
dell’alcol all’aceto.
Tutti al pesciolino d’argento!
E quello si gira, fa un tentativo di sfuggire alla potenza dei piedi, a zig zag sui mattoni.
Poi arriva un verso, sfuggito da un catorcio nel cestino, che gli abbaia dietro. La ricerca del corpo fu inutile. Ognuno aveva la sua ragione, il pezzo di racconto rumoreggiava tra i denti. Le parole insomma ne furono orgogliose.
Il mondo libero è anche un pesciolino morto, tre miliardi di anni o quattro spazzati via da un verso che crede di aver visto un lupo correre dentro casa.
FORTUITO
Nuvole imbracciano il fucile
L’una contro l’altra, armate dal tuono.
Occasione di cicoria che siede
Come un platano alla cena della Caritas.
Molliche della rinascita cadono sul mattone
Tra splendori e il veleno del mostro di komodo.
Avanzano le insegne dell’acido.
Ci siamo anche noi al banchetto d’idee
Tocca alle nostre forche il nervo prediletto da dio.
Comincia così:
un difetto nella pelle o se il popolo non ha pazienza
Un orifizio, largo come la bocca di un lupanare
Poi, al rilascio dei muscoli, la zebra alza la testa
Mentre la morte veste iena.
Nemmeno un lapsus ci salverà
E il giorno che diventeremo immortali
Un afflosciarsi di bottiglia
Indicherà il fulmine abbattuto
sul re delle aspirapolveri.

M.L. Colasson Struttura dissipativa, acrilico 25×40, 2019
.
Poesie di Marie Laure Colasson
La serendipità del linguaggio corrisponde alla serendipità del funzionamento della nostra mente, come bene illustra la citazione del matematico Poincaré. La poetry kitchen non può fare a meno della prassi serendipica, e questo conferisce una novità straordinaria e dà straordinarie possibilità alla scrittura poetica. Eccone un esempio.
12.
Un berlingot* géant dit à la blanche geisha
“Écoute cette mélopée guerrière écoute
Tagada boum boum…”
“Eh bien oui c’est crever le plein
et le vider comme un cochon bio-orthogonal
assis sur un fauteuil Louis Philippe”
répond-elle allongée sur un tapis volant
“Ou bien” ajoute Eredia
“Un tuyau d’aspiration muni de 48 dents
et 3 ventricules!”
“Cela semble vraiment une source de nourriture
pour un yaourt rempli de poils de pubis”
tranche sévèrement Madame Green
L’homme du vide muet Continua a leggere

 da La campana di vetro (The Bell Jar) trad. Adriana Bottini e Anna Ravano, Mondadori, 2017, pp. 244, € 12,00
da La campana di vetro (The Bell Jar) trad. Adriana Bottini e Anna Ravano, Mondadori, 2017, pp. 244, € 12,00





 Marie Laure Colasson, Struttura dissipativa ZZY, acrilico 50×50 cm, 2020
Marie Laure Colasson, Struttura dissipativa ZZY, acrilico 50×50 cm, 2020  Marie Laure Colasson, Struttura dissipativa ZZX, acrilico 50×50 cm, 2020
Marie Laure Colasson, Struttura dissipativa ZZX, acrilico 50×50 cm, 2020 










 Da sempre siamo costretti a sopportare la liquidazione del pensiero leopardiano come pessimistico, e solo in alcuni casi si è avuto un serio recupero delle sue istanze vitalistiche. Si sa che lo Zibaldone rappresenta un capolavoro assoluto della filosofia asistematica di tutti tempi, un crogiolo di trattati e teorizzazioni che avrebbero potuto dare origine a saggi di estetica, critica letteraria, linguistica, storia, filosofia e altro, con argomenti in sé condotti in modo lucido e razionale nonostante la forma frammentata.
Da sempre siamo costretti a sopportare la liquidazione del pensiero leopardiano come pessimistico, e solo in alcuni casi si è avuto un serio recupero delle sue istanze vitalistiche. Si sa che lo Zibaldone rappresenta un capolavoro assoluto della filosofia asistematica di tutti tempi, un crogiolo di trattati e teorizzazioni che avrebbero potuto dare origine a saggi di estetica, critica letteraria, linguistica, storia, filosofia e altro, con argomenti in sé condotti in modo lucido e razionale nonostante la forma frammentata. Leggiamo direttamente dallo Zibaldone (Zibaldone di pensieri, Einaudi, Torino, p. 1977, p. 20):
Leggiamo direttamente dallo Zibaldone (Zibaldone di pensieri, Einaudi, Torino, p. 1977, p. 20):