Pubblicato sul n°304 di POESIA, Crocetti Editore (Maggio 2015)
N.B. I testi qui riprodotti sono una parte di quelli pubblicati nella monografia del numero di POESIA succitato.
INTRODUZIONE di Francesca Diano
In un primo momento abbaglia, poi stordisce, poi oscura, poi consola. Infine illumina, seppur di una flebile luce, la tenebra in cui ti ha fatto penetrare. È quanto si prova nel leggere la parola di James Harpur e il suo inglese corrusco.
Un lungo percorso di ricerca escatologica, tanto personale quanto collettiva, il suo, che emerge chiarissimo dalle sue stesse parole. “Sono giunto alla poesia solo negli anni dell’università. D’un tratto mi sono trovato ad obbedire a un impulso sotterraneo e decisi che la poesia era un’impresa nobile e un mezzo per esplorare le fondamentali questioni spirituali, quali l’esistenza di un Dio, se la vita abbia un senso, cosa c’è dopo la morte, ecc. questioni che nella mia vita sono sempre state una forza centrale e propulsiva. Forse tutti quegli uomini di chiesa nel mio DNA… La poesia mi apparve una missione, il mezzo che mi avrebbe permesso di penetrare l’escatologia della vita o, almeno, di venire a patti con i miei rapporti personali, con i grandi temi dell’esistenza. Da questo punto di vista, per me scrivere era ed è tuttora un’attività sacra, quasi quanto la meditazione e la preghiera.” [1]
Non sono molti, oggi, i poeti che vedono nella poesia un’attività che li collega al Sacro, così com’era alle sue origini. Ma Harpur è un poeta delle origini. Un Urdichter, si potrebbe dire, poiché la sua poesia attinge proprio a quel magma originario da cui la Parola emerge come lògos, come portatrice di tutti i significati possibili e, allo stesso tempo, come potenza ordinatrice dell’universo. Che separa, distingue, nomina e ordina.
Che questa sia la funzione che Harpur le attribuisce è forse sommamente evidente nel lungo poemetto Voices of the Book of Kells, (Voci del Libro di Kells) esplorazione della genesi di questo prodigioso Evangeliario miniato, dell’animo degli anonimi monaci irlandesi che lo miniarono e, allo stesso tempo, della genesi dell’arte. In quella sfera misteriosa della creazione, che è anche lotta costante fra la materia e lo spirito.
Nato in Inghilterra nel 1956, da padre irlandese e madre inglese, di antiche ascendenze anglonormanne, Harpur tiene a spiegare che il significato originario del suo cognome, documentato già nel XII secolo, è arpista, dunque poeta. Lo fu sicuramente un suo antenato. Ma discende anche da una tradizione familiare di uomini di chiesa, Church of Ireland, come lo fu suo nonno e altri prima di lui. Tuttavia Harpur ha scelto un’altra strada. In lui si sono fuse l’anima dell’arpista medievale e quella del mistico. Perché Harpur è un cantore del Sacro. Nel senso più ampio del termine.
La sua prima raccolta organica, A Vision of Comets, (Anvil Press) è del 1993 e raccoglie buona parte dei testi poetici scritti durante il suo soggiorno a Creta, dove ha vissuto per un anno insegnando inglese. L’isola egea gli fa esplodere dentro una potenza poetica e visionaria che diventerà negli anni la sua voce originale, e la poesia che dà titolo alla raccolta ne è riconoscimento e accoglimento.
Le raccolte successive, The Monk’s Dream, 1996 Oracle Bones, 2001 The Dark Age, 2007, Angels and Harvesters, 2012, tutte edite da Anvil Press, insieme a The Gospel of Joseph of Arimathea, (Iona Books) 2007 e Voices of the Book of Kells, (2012), confermano la natura esplorativa di questa ricerca, attraverso i due elementi che raccolgono e alimentano la poesia di Harpur: la luce e la tenebra, che non solo non le è opposta, ma le è complemento speculare ed essenziale.
Uno degli aspetti più profondi e significativi della mentalità celtica è la fascinazione per tutto ciò che è passaggio, trasformazione, per il liminale, per quello spazio e quel tempo che si insinuano fra il momento in cui tutto finisce e quello in cui tutto inizia di nuovo, secondo un tempo ciclico, per quello iato abissale che si apre sul mistero che irrompe fra il “non più” e il “non ancora”. Il non casuale twilight di Yeats. Questo spazio incommensurabile, temibile nel quale si inoltra il pensiero del mistico e dell’artista.
È questo spazio che Harpur esplora. Perché per lui il faticoso e misterioso processo creativo è simile a quello della ricerca spirituale. Lo afferma più volte lui stesso. Un’avventurosa, travagliata esplorazione come uomo e come artista, non immune dal dolore, che tanto somiglia al fortunoso viaggio di Brendano, cui del resto Harpur dedica in The Dark Age un testo qui presentato.
Come dice Adam Zagajevski, “nella poesia si mette ciò che non si sa”. Ma il non sapere richiede che solidi siano i supporti da cui muovere. Per non perdersi nelle fauci del nulla. Il percorso che Harpur si è scelto quindi, chiede strumenti adatti. La sua formazione classica (conosce perfettamente il greco e il latino e gli autori della classicità, di cui ha fatto alcune traduzioni) lo spinge ad esplorare le possibilità che la metrica antica, greca soprattutto, offre alla sua lingua. Trimetro giambico, pentametro, distico elegiaco suonano nel suo inglese con lo stesso elegante equilibrio classico dei testi redatti dagli antichi monaci e santi irlandesi che preservarono la cultura antica e la mantennero viva nelle abbazie, nei cenobi e nei monasteri da loro fondati. Ma l’attingere al patrimonio metrico degli antichi non è solo un espediente tecnico, è l’attingere direttamente alla fonte poetica di quella cultura, da cui non si sente affatto separato o lontano.
Tipicamente irlandese è questa fusione armonica – quasi un fluire dell’una nell’altro – fra l’antica cultura celtica, rutilante di meandri, miti visionari, eroi luminosi anche se sconfitti, percorsi circolari e un cristianesimo coltissimo, esplorativo, costellato di santi anacoreti, misticismo, bizzarria e magia. Una spiritualità in fondo non poi così diversa, nelle sue componenti, da quanto l’ha preceduta in quell’isola.
Ed è infatti questo momento aurorale del cristianesimo, irlandese, ma anche latino, greco e siriaco, che affascina Harpur. Non meno del lento estinguersi dell’antica tradizione classica nei suoi epigoni. Si veda la sua traduzione di Boezio dal titolo The Fortune’s Prisoner, oppure L’augure a riposo, in Ossa oracolari; non meno del patrimonio mitologico celtico, che è costantemente presente in sottofondo.
Nell’interazione fra questi due momenti nella storia dell’Occidente, fra il paganesimo e il cristianesimo, fra l’antico e la modernità, Harpur non legge solo il passaggio fra due epoche, fra due culture, ma un aspetto ben più profondo e inquietante; la lotta, appunto, fra natura e spirito. Come è nel mito di fondazione della conversione irlandese al cristianesimo da parte di San Patrizio, in cui i serpenti che egli scaccia dall’Irlanda, non sono altro che i pericolosi “rettili della mente” di Blake, niente affatto sconfitti.
“Il mio rapporto con la religione, col Cristianesimo e la chiesa è complesso. Mi considero un agnostico rinato, o un ricercatore spirituale. Sono attratto dai mistici di ogni religione e cultura, da Meister Eckhart a Rumi, a Kabir e dal più profondo e radicale maestro spirituale dei tempi moderni che io abbia mai incontrato, J. Krishnamurti. Nutro profonda diffidenza nei riguardi delle strutture religiose istituzionali e delle gerarchie e mi piace il commento di Blake, che, per il culto religioso, un pub sarebbe un luogo migliore di una chiesa”, afferma ancora Harpur nell’intervista già citata.
Fra quelle che Harpur definisce “questioni che nella mia vita sono state forza centrale e propulsiva”, non di secondaria importanza è il problema del Fato, il chiedersi se un destino segnato esista, se lo si possa cambiare. È sicuramente centrale in The Monk’s Dream, raccolta pubblicata nel 1996, successivamente alla morte del padre. La poesia che dà il titolo alla raccolta si riferisce alle sospette circostanze della morte del poco amato re Guglielmo II (1056- 1100) in un incidente di caccia. Pare che un anonimo monaco avesse sognato la fine del re e l’avesse fatto avvertire, ma questo non cambiò il fato che lo attendeva. La sezione centrale di questa raccolta è dedicata interamente alla malattia, alla morte e ai funerali del padre di Harpur ed è una lunga meditatio mortis, ma anche una profonda riflessione sul destino finale di ogni vita. E ancora ritorna, come questione aperta, in Ossa oracolari, dove l’eroe nazionale Cuchulainn, protagonista del ciclo mitologico dell’Ulster, sfida il proprio destino già segnato, ignorando volutamente i segni premonitori e i tabù che non potrebbe infrangere, andando consapevolmente verso la morte. Morendo da eroe e da uomo libero.
Fondamentale è stata per lui, in età giovanile, la lettura di Jung e la scoperta della sua teoria dell’inconscio collettivo, che gli dischiudono una nuova visione del mito, quale narrazione fondante della psiche. Così Harpur legge, nelle vite dei santi, talvolta bizzarre e sorprendenti, una ricchezza di miti e leggende non meno articolati e variegati di quelli del mondo pagano e classico, tale da tracciare una mappa della psiche umana.
In questa inesausta ricerca della luce del Sacro attraverso la tenebra della psiche, individuale e collettiva, e della storia dell’uomo, Harpur conversa con i santi e i mistici e gli asceti pagani e cristiani, talvolta anonimi o immaginari, spesso realmente esistiti, ai quali non di rado dà voce. Con Jakob Böhme, con Giuliano di Norwich, con Richard Rolle, con Marguerite Porete. E, soprattutto, in un poemetto di circa 400 versi, con San Simeone lo Stilita, l’anacoreta la cui vita è una parabola della via negationis che, non potendo fuggire dal mondo in orizzontale, lo fuggì in verticale, dimorando per trentasette anni su di una colonna alta quindici metri. Negando se stesso, la propria natura, la propria umanità, il mondo, alla ricerca dell’Assoluto. Ma solo per accorgersi poi, che il mondo accorreva a frotte verso di lui, talché sotto la sua colonna, come dice Harpur, si radunava una sorta di permanente Woodstock!
San Simeone, come lo scrittore, come il poeta, ha sete d’isolamento, di solitudine, ma come l’artista creatore, comprende poi di non poter trascendere, di non poter negare il mondo. Così come lo comprese Faust. Sostenute da un virtuosismo linguistico prodigioso, da una perizia tecnica degna di un antico bardo irlandese, tensione, ascensione, sete e cerca sono i punti nevralgici della sua poesia – poesia mistica, religiosa si potrebbe dire, consapevoli che per Harpur un mistico è anche l’artista – che forse ha solo in Gerard Manley Hopkins, seppur in modo e con origine del tutto diversi, un predecessore in lingua inglese. Forse soprattutto nella ricerca di un metro nuovo, di una lingua nuova, capaci di esprimere l’ineffabile, l’invisibile, l’ascesi, ma che nascono dalla consuetudine con l’antico, ponendosi Harpur volutamente al di fuori delle correnti contemporanee postmoderne, e tantomeno limitandosi a un chiuso mondo, in cui l’io rimane prigioniero delle cose cui arriva la sua vista fisica. No, il mondo di Harpur è fatto più di visioni, di rivelazioni che dalle cose emanano – della capacità di vedere il miracolo, il mistero, irrompere nel quotidiano, come nel testo Angeli e mietitori che dà il nome all’ultima raccolta – e non ha confini né di tempo né di luogo. Ė terra incognita, l’oceano sconosciuto su cui si avventuravano Brendano e i suoi monaci alla ricerca dell’Isola dei Beati, incontrando nel corso del viaggio mostri minacciosi e dèmoni. È la sua stessa anima di poeta e di uomo.
L’uso di immagini sorprendenti e inattese, il concatenarsi delle metafore, la fluidificazione del mito, che scorre potente verso di noi con l’ardore bruciante della fiamma ma con veste rinnovata, e della sua potenza visionaria, la profonda conoscenza del patrimonio culturale dell’Irlanda celtica, della cultura classica, della tradizione cristiana, l’uso sottilissimo del linguaggio, fanno di Harpur il più irlandese dei poeti irlandesi. Perché è su queste basi culturali che si è formata l’Irlanda moderna. Tutta la sua produzione poetica è un unico, ininterrotto dialogo, che fluisce lungo quel costone semi-illuminato che è il passaggio dal mondo antico e pagano alla modernità, e dalla modernità alla contemporaneità.
È una poesia fortemente impregnata di spiritualità dunque, molto nella grande tradizione poetica bardica irlandese, ma una spiritualità che ha una profondissima connessione con la modernità. Il travaglio del passaggio da un’epoca a un’altra infatti è l’eco del nostro, le domande che torturano i suoi asceti, cristiani e pagani, i dubbi che attanagliano i suoi uomini, i suoi peccatori, i suoi indovini, i suoi monaci, sospesi tra un mondo e un altro, sono i nostri, la fine drammatica di un’epoca che si avvia incerta verso l’ignoto è la nostra.
[1] Intervista su Poetry Ireland Review, N° 105 Inverno, 2011/12
Anassimene
L’anima nostra è aria, guarda il respiro
Che entra gelido, riappare
Fantasma che s’arriccia mentre cammini all’alba
Fra boschi di pini che s’estendono
Sulle colline sopra la città dormiente.
Come in basso così in alto. Un inverno in cui
Gli arbusti si rattrappirono in nudi agglomerati
Le querce e i faggi, gli sfavillanti salici
Lasciarono la luce scorrere lungo gli spogli rami;
Quando l’erba decrebbe, si sciolsero i cespugli
E la foresta spalancò i suoi sentieri
Come canali che dopo la meditazione si liberano
Quando il sole velato si fermò
All’improvviso ebbi la visione –
Creazione come momento non creato
Lo pneuma è un flusso ininterrotto
Di infinita mobilità e delicatezza
Che assume sempre rinnovate forme,
Una luce che nulla perde di se stessa
Mentre si materializza nel mondo
E si sposta come uno sciame d’api
Per dar forma a nuove particole di senso:
L’aria s’andò addensando in foschia
Poi lentamente s’ingrossò in pioggia
Che creò attrito, cadde a schizzi
Nei solchi e riempì le pozzanghere
Poi più s’addensò in fango e melma
Che il tempo avrebbe indurito come pietra
O per rarefazione ritrasformata in bruma
Per sollevarsi ancora diluendosi in aria
E rarefarsi ancora sempre più –
Raffinandosi e ancora raffinandosi
In oscillanti granuli di fiamma
Fluenti verso l’alto in piccole faville
Per riunirsi in pozze ardenti a risplendere
Dall’emisfero delle tenebre
In forma di stelle e di luna e di sole.
Anaximenes
Our souls are air, just watch the breath
That enters icy, reappears
A curling ghost on early morning walks
Through groves of pines that stretch
Along the hills above the sleeping town.
As below, so above. One winter, when
Shrubs shrank in naked tangles
Oaks and beeches, flashing willows
Let light glide through bare branches;
When grass subsided, bushes melted
And the forest opened up its paths
Like channels clearing after meditation
When the shrouded sun stood still
I suddenly saw the vision –
Creation as an uncreated movement
The pneuma in a never-ending stream
Of infinite mobility and tenderness
Assuming ever-fresher forms,
A light that loses nothing from itself
Materializing in the world
And shifting like a swarm of bees
To shape new particles of meaning:
Air was thickening into mist
Then slowly coarsened into rain
Which gathered friction, splashed
In ruts and filled up pools
Grew denser into slush and mud
That time would harden into stone
Or turn by rarefaction back to mist
To rise up thinning into air again
Then growing rarer still –
Refining and refining further
Into flickering grains of flame
Streaming up in sparklings
To coalesce in fiery pools to shine
From the hemisphere of darkness
As stars and moon and sun.
Da L’età oscura The Dark Age (2007)
.
Brendano
L’eremita nudo, scogliere di ghiaccio, il gelo
E l’isola dei santi che emerge dalla
Nera nebbia come luce, i suoi lidi di polvere d’oro
E in ogni frutteto mele che vanno maturando
La gioventù che tutti ci accolse chiamandoci per nome –
Questi morirono attorno ai fuochi stabili di Clonfert.
Ma Giuda sul suo scoglio, riarso dai venti, denudato,
Che si contorce sul massacro del mare
È ancora intatto nella mia tenebra più fonda
Gli occhi all’erta per l’approssimarsi dei demoni –
Li vedo ardere come quando remando ce ne andammo
E udimmo la sua voce sopra l’oceano rauco,
“L’inferno è stasi, continuate ad andare verso il sole
E giunti alla luce, ancora, ancora navigate.”
Brendan
The naked hermit, cliffs of ice, the cold,
The island of the saints emerging from
Black fog as light, its shore of powdered gold
And apples ripening in every orchard
The youth who welcomed each of us by name –
These died around the settled fires of Clonfert.
But Judas, on his rock, wind-burnt, stripped wise,
Writhing above the slaughter of the sea
Remains pristine inside my deepest darkness
His eyes alert for the approach of demons –
I see them glowing as when we rowed away
And hear his voice above the raucous ocean,
‘Hell is stasis, keep heading for the sun
And when you reach the light, sail on, sail on,’
L’orario astrale del monaco
“Nella santa notte di Natale
Quando vedi sul dormitorio il Dragone
E Orione sospeso sopra il tetto della cappella
Sii pronto a suonare la campana.”
Attorno a me nel convento si raggela la tenebra.
Parole su pergamena e gli astri impongono lo schema
Bisbigliando come le preghiere incessanti che rivolgiamo a Dio.
Chi ha da proteggere il mondo non può andare a dormire.
“Nella festa di San Germano
Cerca sulla freccia del Sagittario il gioiello
Sospeso sopra il centro della torre:
ecco quando iniziare le salmodie notturne.”
Le stelle sono nostre stagioni, chiavi di nostra prigione:
Nevicate invernali, sparsi brillanti di piogge in primavera
I globi dei papaveri nei campi delle messi
Le meteore morenti di faggi rossi, di querce e di sambuchi.
“Nel giorno della circoncisione del Signore
Quando la chiara stella sul ginocchio di Artofilace
S’allinea all’angolo del dormitorio
È tempo di dar luce alle lampade.”
L’emozione della fiamma viva! Spirito palpitante,
La cappella è un’anima dalla pelle di oro.
Questa luce io cerco oltre le costellazioni;
O lux aeterna incenerisci la mia vita crostosa!
“Nella festa di nostra amata Santa Agnese
Quando vedi le lance della Vergine levarsi chiare
Sopra lo spazio fra la sesta e la settima finestra
Sii pronto al santo ufficio.”
Temo le notti di nebbia, foschia, vapori, nuvole
L’assenza che s’avvinghia, il distacco da Dio.
Signore, quanto prima che in me una stella s’espanda
E l’anima e la carne mi inondi di luce della grazia?
“Nella festività di San Clemente
Orione sorgerà sull’estremo del refettorio –
Ma attendi di vedere la spada e la guaina
Prima di risvegliare i confratelli.”
L’eternità, per quante notti l’ho attesa
Atteso di sentire la musica, cercato un senso.
Ma solo ho percepito il buio fra le stelle,
Come campana il battito del cuore, frasi della mortalità.
The Monastic Star-timetable
‘On the holy night of Christmas
When you see the Dragon above the dormitory
And Orion poised above the chapel roof
Prepare yourself to sound the bell.’
Darkness freezes round me in the cloister.
The vellum words and stars inflict their patterns
Whispering like the ceaseless prayers we send to God.
No one must lie asleep who must protect the world.
‘On the festival of Saint Germanus
Look for the jewel of the Archer’s arrow
Hanging above the middle of the tower:
That is when to start the night-time hymns.’
The stars are our seasons, the keys of our prison:
Winter snowfall, glittery scatterings of spring rain
The globes of poppies in the harvest fields
The dying meteors of copper beech, oak and elder.
‘On the Lord’s circumcision
When the bright star in the knee of Artophilax
Is level with the corner of the dormitory
It is time to bring the taper to the lamps.’
The thrill of live flame! A writhing spirit,
The chapel like a soul skinned with gold,
This is the light I seek beyond the constellations;
O lux aeterna, burn off my crusted life!
‘On the feast of our beloved Saint Agnes
When you see the Virgin’s spears rising clear
Above the space between the sixth and seventh windows
Make ready for the sacred office.’
I dread nights of fog, mist, vapours, cloud
The clinging absence, the separation from God.
Lord, how long before a star expands inside me
Flooding my soul and flesh with gracious light?
‘On the feast day of Saint Clement
Orion will rise above the end of the refectory –
But wait until you see the sword and scrabbard
Before you wake the brethren.’
So many nights I’ve waited for eternity
Listening for music, looking for meaning,
But all I’ve felt is the dark between the stars,
My heart, beating like a bell, the phrases of mortality.
.
Da Angeli e mietitori Angels and Harvesters (2012)
La prima volta che vidi il Libro di Kells
Mi unisco alla lenta fila che sosta e poi riprende
Nervoso come chi a un funerale sfila accanto
A un corpo cereo in una cassa aperta,
So che avrò solamente un minuto
Circa, i miei occhi due grilletti sensibili
Ci sono quasi, ci sono quasi,
Bang –
Come venissi scaraventato su un palco
Mettendo a fuoco un pubblico seppia –
Vedo il vangelo animarsi in ghirigori
Con sovraimpresse forme oblunghe, circoli
Quali cornici atte a intrappolare api d’oro
Così veloci che il volo è invisibile
Ma lasciano tracce luminose in nastri
Di infiniti voli che si intrecciano;
Sto contemplando un sogno
Ritagliato dal sonno di qualcuno e pressato
Su pergamena in decalcomania;
O una zona di pelle assalita da
Un tatuatore folle, o una cianografia
Della creazione fatta dal Demiurgo,
I pianeti a ruotargli negli occhi
Col tocco del pennello dà vita ad ogni cosa
In ocra, in verde e in orpimento,
In lapislazzuli ed in nerofumo;
O un cervello che frulla dall’interno all’esterno
Mettendo a nudo gangli, acceso
In ogni sinapsi, o fibra che s’incurva,
Come da scariche di un mal di testa
O la visione del carro di Elia.
Su tutto questo troneggia San Giovanni
Un malinconico alchimista
In un laboratorio di cilindri ribollenti
Che di nuovo ha fallito nel trovare
Il lapis philosophorum.
Meno fisso lo sguardo più vedo,
Le lettere iniziano a muoversi e strisciare –
Dov’è il Verbo? E che mondo è questo
In cui una n con la testa di pavone
Resiste ai viticci di una vigna,
e la i finge d’essere un arpista
Che pizzica una c allungata
O una nave vichinga che si solleva al suo estremo?
Alzo la testa per vedere l’insieme
E lievemente sfoco la visione,
Le lettere paiono legarsi
Qualcuno mi spinge perché io avanzi,
Fa’che arrivi, fa’ che arrivi,
Altri trenta secondi, per favore
E sì, eccolo, perfetto e liberato
In
Prin-
ci-
pio erat
Verbum.
On First Seeing the Book of Kells
I join the shuffling stop-start queue
As edgy as a mourner filing past
A waxy body in an open box,
I know I’ll only have a minute
Or so, my eyes are two hair-triggers
I’m nearly there, nearly there
Bang –
As if I’ve just been shoved on stage
Adjusting to the sepia audience –
I see the gospel squiggle into life
With oblongs, circles branded on
As frames to trap the golden bees
So quick they fly invisibly
But leave an afterglow in ribbons
Of countless plaited flights;
I’m looking at a dream
Cut out from someone’s sleep and pressed
On vellum like a transfer;
Or a swathe of skin assaulted by
A mad tattooist, or a blueprint
Of creation by the Demiurge,
The planets spinning in its eyes
His paintbrush touching things to life
In ochre, green and orpiment,
Lamp-black and lapis lazuli;
Or a brain that’s whirring inside out
Its ganglia revealed, lit up
In every synapse, curling fibre,
As by the electrics of a migraine
Or vision of Elijah’s chariot.
Above it all St John looks down
A melancholy alchemist
In a lab of bubbling cylinders
Who yet again has failed to find
The lapis philosophorum.
The less I stare the more I see,
Letters begin to stir and creep –
Where is the Word? And what’s this world
In which a peacock-headed ‘n’
Resists the tendrils of a vine,
An ‘i’ pretends to be a harpist
Plucking an elongated ‘c’
Or longship raised up on its end?
I raise my head to see the whole
And slightly blur my focus,
The letters seem to link together
There’s someone nudging me to move,
Let it come, let it come,
Another thirty seconds, please,
And yes, it’s there, pristine and freed
In
Prin-
ci-
pio erat
Verbum.
Peccatore
in memoria di Marguerite Porete, morta a Parigi il 1 giugno 1310
Senza la volontà nessuno pecca, diceva.
Ma chi non pecca se non il Signore?
Di noi nessuno morta la voleva
Ma lei insisteva a spargere bugie
Fra i semplicioni e fra i miscredenti;
Le sue eresie dovevamo fermarle.
E inoltre era una pseudo-mulier
Né carne né pesce, ma puzzava di entrambi
In mezzo al fumo che mondò la piazza
Il viso un fiordaliso che avvizzisce
Sopra il sacco di tela del suo corpo.
Mantenne una certa dignità
Finché gli artigli rossi delle fiamme
Non le azzannarono la faccia
Adempiendo alla legge di dio –
Strepitando come mille oche
La folla emise un gemito corale
Quando l’oro le zampillò dagli occhi.
Ma fummo fiduciosi: la pira
Liberò l’anima in cui lei voleva che dio entrasse
E la mandò piangente al fuoco eterno.
Quella notte le ceneri le scaricammo nella Senna –
“Faccia prediche ai pesci
Sul volere ed il suo annientamento!”
Senza la volontà nessuno pecca.
Noi non peccammo: la nostra era la volontà di dio.
La nostra opera era sacra dottrina
Il nostro ragionare valido e irrefutabile,
Abbiamo mille anni di sapere.
Perché giurava ch’eravamo in errore?
A meno che non fossero sue quelle parole –
Di chi dunque? Chi diceva simili sozzure?
Chi le dava convinzioni simili
Se non il diavolo? Nessuno blatera
Con quell’intensità se non pazzo, malvagio;
O toccato da dio, cosa che lei non era.
Dovevamo proteggere gli altri da quel suo lievito,
L’odio per noi. Doveva morire.
Doveva morire – Cristo mi aiuti.
Sinner
i.m. Marguerite Porete, died in Paris, 1 June, 1310
Without a will no one can sin, she said.
Who cannot sin except the Lord?
We didn’t want her dead.
But she insisted on spreading lies
To simpletons and miscreants;
We had to stop her heresies.
Besides, she was a pseudo-mulier
Not fish or fowl, but smelling of them both
In the smoke that purified the square
Her face a wilting fleur-de-lys
Above the sackcloth of her body.
She had some dignity
Until the flame’s red claws
Were gripping at her face
And carried out god’s law –
Screeching like a thousand geese
The crowd let out a choral groan
When gold broke from her eyes.
But we were sanguine: the pyre
Released the soul she wanted god to enter
And sent it weeping to eternal fire.
That night we damped her ashes in the Seine –
‘Let her preach to fishes
About the will and its annihilation!’
Without a will no one can sin.
We didn’t sin: our will was god’s.
Our work was holy doctrine
Our reasoning was unassailably strong,
We had a thousand years of learning
Why did she swear that we were wrong?
Unless her words were not her own –
Then whose? Who spoke that filth?
Who gave her that conviction
If not the devil? No one spouts
With that intensity unless mad, evil:
Or touched by god, which she was not.
We had to safeguard others from her yeast,
Her hatred for us. She had to die.
She had to die – so help me Christ.
Francesca Diano è nata a Roma. Si è laureata in Storia della Critica d’Arte e ha vissuto a Oxford, Cambridge, Londra, dove ha lavorato al Courtauld Insitute e all’Istituto Italiano di Cultura e in Irlanda, dove ha insegnato all’Università di Cork. Dal 1981 è traduttrice letteraria di narrativa, poesia e saggistica e ha collaborato con Fratelli Fabbri, Cappelli, Neri Pozza, Donzelli, l’irlandese Collins e Guanda. È la traduttrice italiana delle opere della grande scrittrice indiana Anita Nair. Autrice di poesia, saggi e narrativa, nel 2012 ha vinto il Premio Teramo. Ha tenuto corsi di Storia dell’Arte all’Università per Stranieri di Perugia e seminari di traduzione letteraria, ha organizzato convegni ed eventi, fra cui Terrazza sull’India per il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ha pubblicato una raccolta di racconti, Fiabe d’amor crudele, 2013 Edizioni La Gru e nel 2010 il romanzo La Strega Bianca – una storia irlandese.


























































































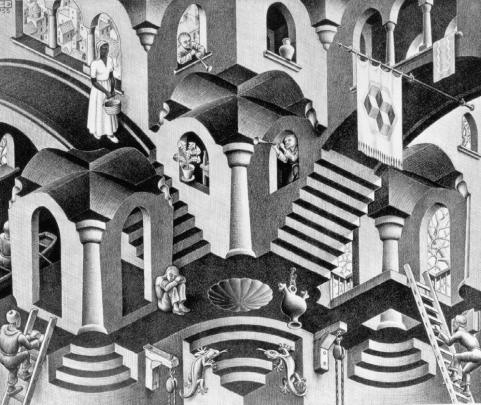

























































































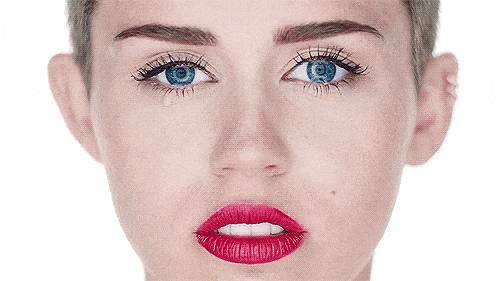
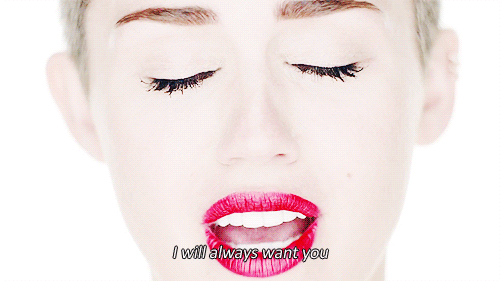


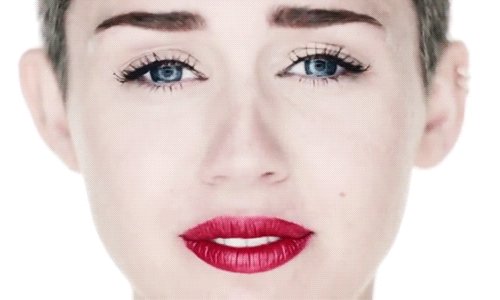








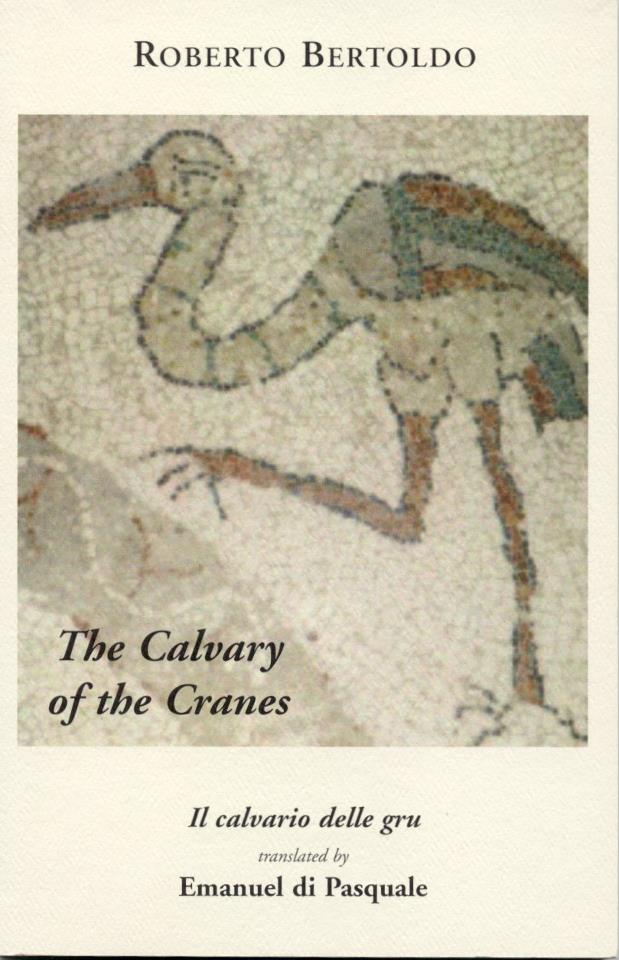
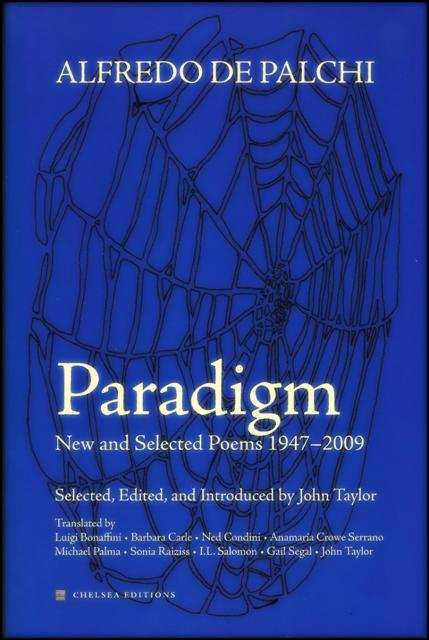


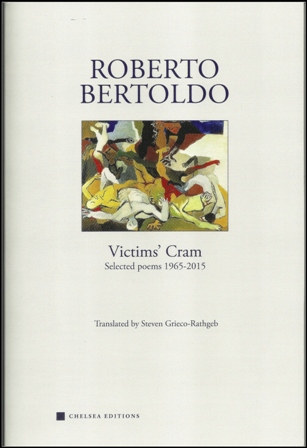





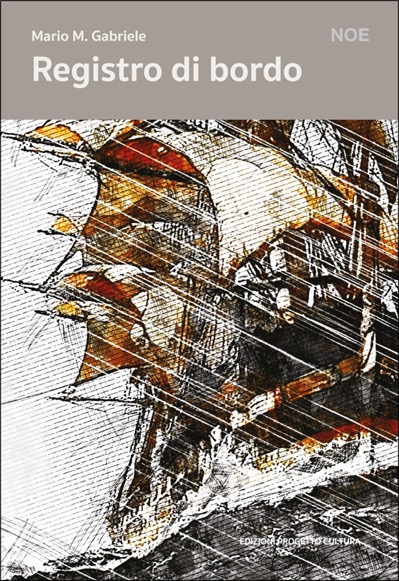

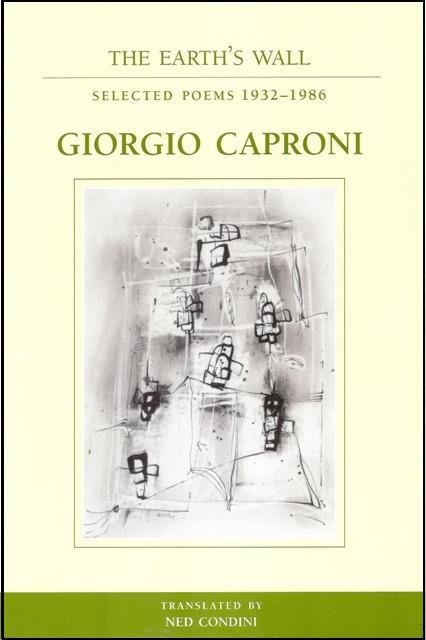
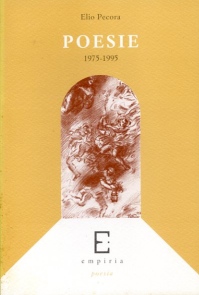

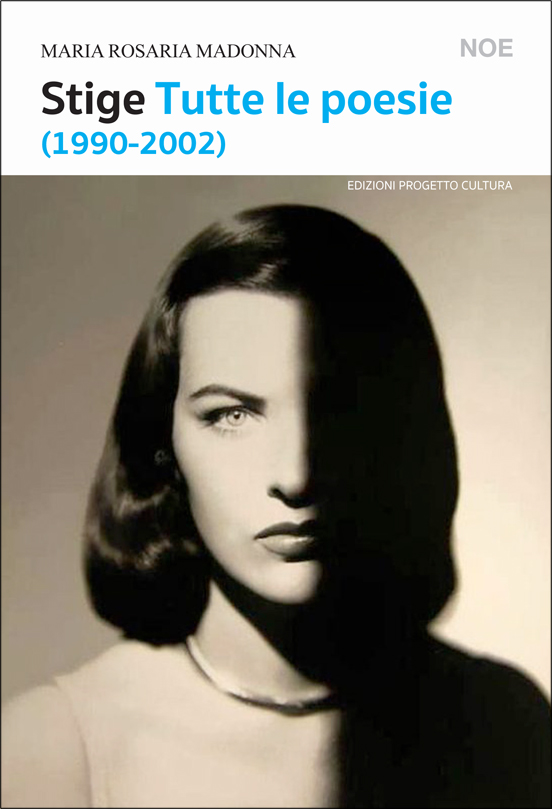

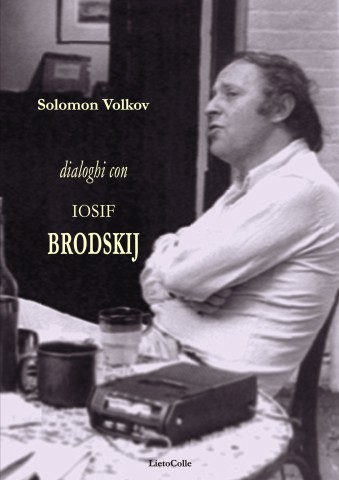




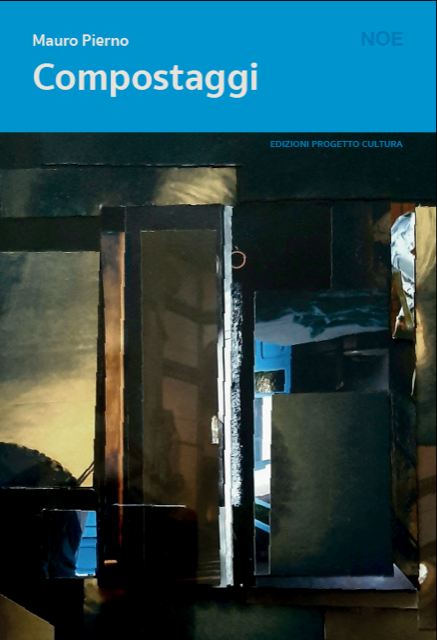




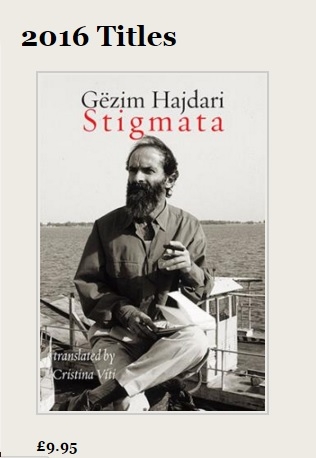






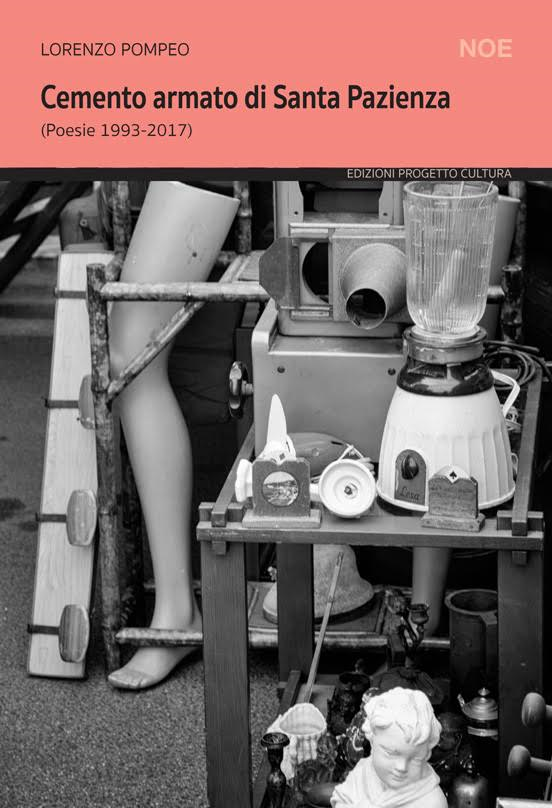







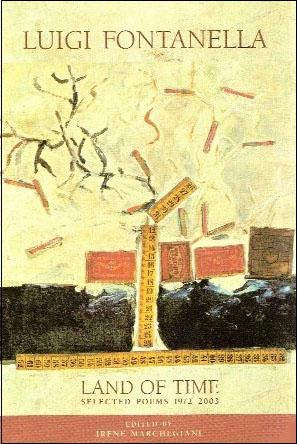








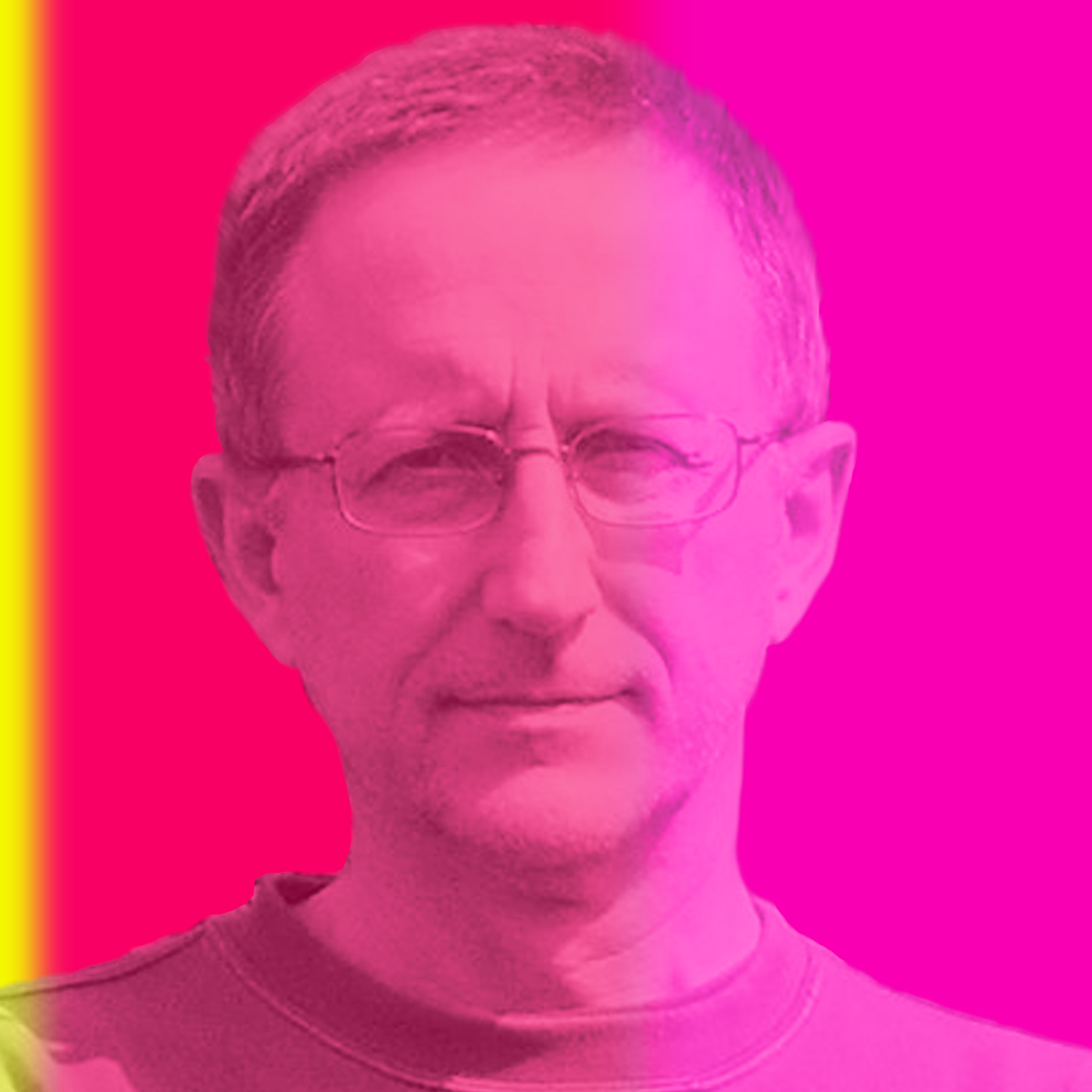







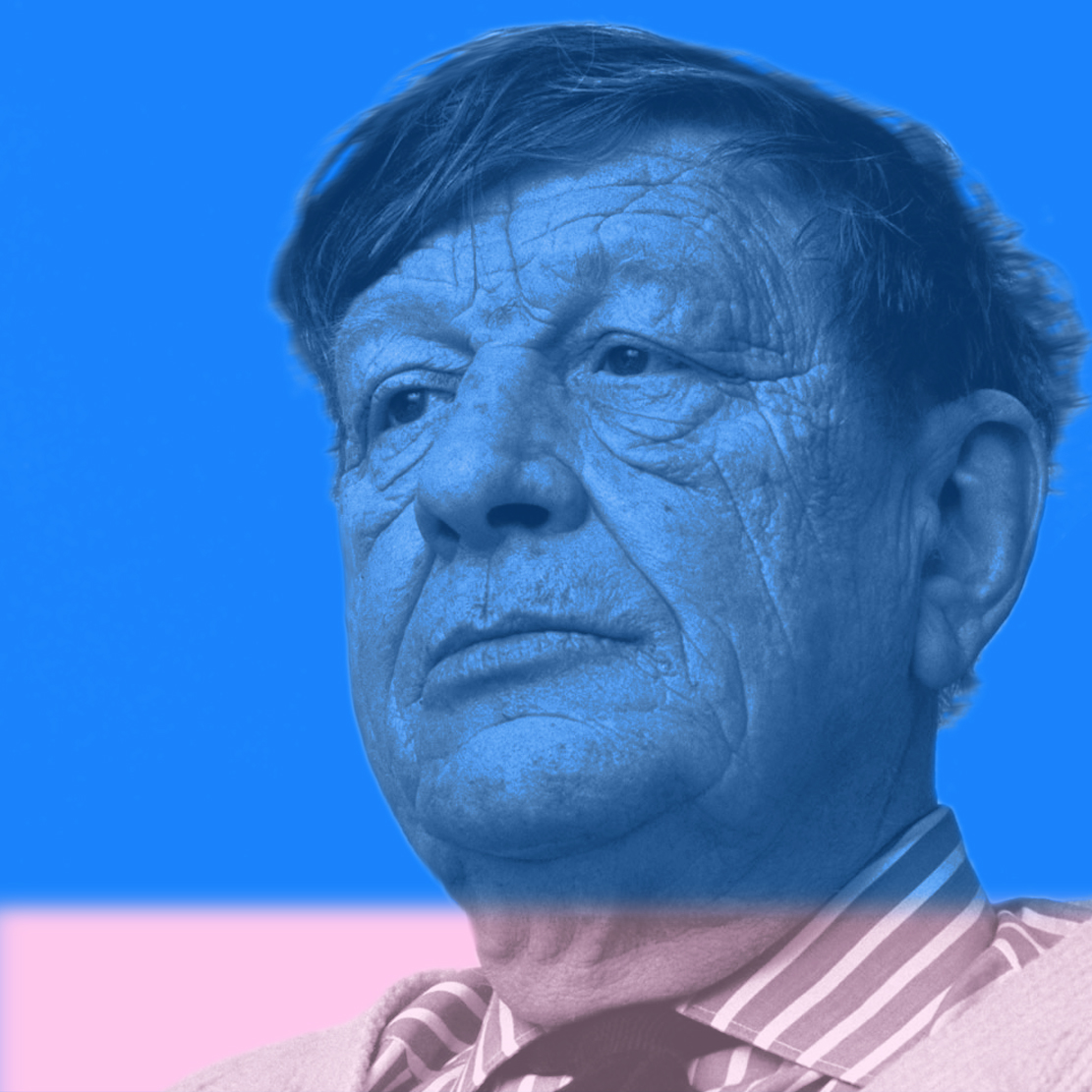





















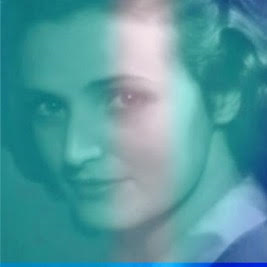































flavio almerighi
almerighi
2 maggio 2015 alle 14:43 Modifica
Caro Giorgio, Sagredo da riformattare a parte, trovo la tua risposta un po’ semplicistica. Io non sto parlando dei soliti noti da De André in giù, io sto parlando di una stirpe di poeti, molto più musicali del poema giocagiò della Perrone o dell’erotismo poelnta e osei della Leone, giusto per citare un paio di nefandi post recentemente apparsi, che hanno prestato poesia alla canzone, Parlo per esempio di Roberto Roversi, di Pasquale Panella di Pier Paolo Pasolini se pure in tono più minore, e anche con Piero Ciampi.. Con questi dobbiamo fare i conti, e il post con le poesie di Grieco così asciutte e così belle mi ha fornito lo spunto per parlarne. Non possiamo classificarli a facitori di filastrocche per meri motivi commerciali.
“Il mare
al tramonto
salì
sulla luna
e senza appuntamento
dopo uno sguardo
dietro tendine di stelle
se la chiavò”
Ti ricorda qualcosa?
E’ una canzone di Zucchero, dirai. Sbagliato.
E’ il plagio di una poesia di Piero Ciampi da parte di Zucchero, che solo in seguito ad una causa intentatagli riconobbe il “furto” e citò la fonte nelle ristampe del suo disco. Non è che il povero Sagredo ha preso il verso da Ciampi?