
Praga, fiume Moldava, foto di Donatella Costantina Giancaspero
Petr Král nasce a Praga il 4 settembre 1941, in una famiglia di medici. Dal 1960 al ’65 studia drammaturgia all’Accademia cinematografica FAMU. Nell’agosto del 1968 trova impiego come redattore presso la casa editrice Orbis. Ma, con l’invasione sovietica, è costretto ad emigrare a Parigi, la sua seconda città per più di trent’anni. Qui, Král si unisce al gruppo surrealista, che darà un indirizzo importante alla sua poesia. Svolge varie attività: lavora in una galleria, poi in un negozio fotografico. È insegnante, interprete, traduttore, sceneggiatore, nonché critico, collaborando a numerose riviste. In particolare, scrive recensioni letterarie su Le Monde e cinematografiche su L’Express. Dal 1988 insegna per tre anni presso l’Ecole de Paris Hautes Études en Sciences Sociales e dal ‘90 al ’91 è consigliere dell’Ambasciata ceca a Parigi. Risiede nuovamente a Praga dal 2006.
Petr Král ha ricevuto numerosi riconoscimenti: dal premio Claude Serneta nel 1986, per la raccolta di poesie Pour une Europe bleue (Per un’Europa blu, 1985), al più recente “Premio di Stato per la Letteratura” (Praga, 2016).
Tra le numerose raccolte poetiche, ricordiamo Dritto al grigio (Právo na šedivou, 1991), Continente rinnovato (Staronový kontinent, 1997), Per l’angelo (Pro Anděla, 2000) e Accogliere il lunedì (Přivítat pondělí, 2013). Curatore di varie antologie di poesia ceca e francese (ad esempio, l’Anthologie de la poésie tcheque contemporaine 1945-2002, per l’editore Gallimard, 2002), è anche autore di prosa: ricordiamo “Základní pojmy” (Praga, 2003), 123 brevi prose, tradotte in italiano da Laura Angeloni nel 2017, per Miraggi Edizioni. Attivo come critico letterario, cinematografico e d’arte, Petr Král ha collaborato con la famosa rivista “Positif “e pubblicato due volumi sulle comiche mute.

Petr Král, grafica di Lucio Mayoor Tosi
Ermeneutica di Giorgio Linguaglossa
Con Petr Král ci troviamo senza dubbio di fronte a uno dei maggiori poeti europei: più lo leggo e più me ne convinco. Certo, la sua poesia è lontanissima dalle corde foniche della poesia italiana di questi ultimi decenni. Questo dimostra proprio il valore della poesia di Král, non altro… Del resto, ricordo che il poeta praghese, in una sua noticina, avvertiva già il lettore italiano che si sarebbe trovato davanti una poesia dissimile, molto dissimile, da quella a cui è stato da sempre abituato…
La ricchezza fenomenica della poesia di Král è il risultato di un equilibrio instabilissimo tra la verosimiglianza e l’inverosimile; certi accorgimenti retorici come la sineciosi e la peritropè (il capovolgimento), il deragliamento (controllato) delle sue perifrasi, le deviazioni, l’entanglement sono gli elementi base sui quali si fonda la sua poesia, che ha il privilegio di godere dei vantaggi del surrealismo al quale Král aderì, sia a Praga che a Parigi: un surrealismo innervato nella sua storia e nella sua lingua. Egli proviene dall’esperienza del secondo surrealismo ceco filtrato attraverso la disillusione politica sopravvenuta dopo l’invasione della Cecoslovacchia ad opera dei carri armati sovietici, una esperienza traumatizzante e traumatica, che ha segnato in modo profondo molti altri poeti e scrittori praghesi. Nella prospettiva surrealista, il linguaggio cessa di essere funzionale al referente, si rende improprio alla parola, viene visto come uno strumento non utilizzabile secondo uno schema mentale di adeguazione della parola al referente.
Scrive Lacan:
«Nella misura in cui il linguaggio diventa funzionale si rende improprio alla parola, e quando ci diventa troppo peculiare, perde la sua funzione di linguaggio.
È noto l’uso che vien fatto, nelle tradizioni primitive, dei nomi segreti nei quali il soggetto identifica la propria persona o i suoi dei, al punto che rilevarli è perdersi o tradirli […]
Ed infine, è dall’intersoggettività dei “noi” che assume, che in un linguaggio si misura il suo valore di parola.
Per un’antinomia inversa, si osserva che più l’ufficio del linguaggio si neutralizza approssimandosi all’informazione, più gli si imputano delle ridondanze […]
Infatti la funzione del linguaggio non è quella di informare ma di evocare.
Quel che io cerco nella parola è la risposta dell’altro. Ciò che mi costituisce come soggetto è la mia questione. Per farmi riconoscere dall’altro, proferisco ciò che è stato solo in vista di ciò che sarà. Per trovarlo, lo chiamo con un nome che deve assumere o rifiutare per rispondermi.
Io m’identifico nel linguaggio, ma solo perdendomici come un oggetto. Ciò che si realizza nella mia storia non è il passato remoto di ciò che fu perché non è più, e neanche il perfetto di ciò che è stato in ciò che io sono, ma il futuro anteriore di ciò che sarò stato per ciò che sto per divenire.»1]
1 J. Lacan Ecrits, 1966, Scritti I, trad. it. Einaudi, 1974, p. 293
Oggi, probabilmente, non si può scrivere, in Europa, una poesia veramente moderna, senza fare riferimento, in qualche modo, al retaggio del surrealismo: il surrealismo inteso come allontanamento consapevole del referente e dal referente. In Italia, nella tradizione poetica di questi ultimi decenni (con l’ottima eccezione della poesia di Angelo Maria Ripellino e di Maria Rosaria Madonna e a parte, ovviamente, gli autori della «Nuova ontologia estetica»), non c’è davvero molto del surrealismo: siamo ancora invischiati e raffreddati dentro un concetto di verosimiglianza con il «reale» che ha finito per impoverire la gamma espressiva della poesia italiana.
Dunque, siamo grati ad Antonio Parente per aver reso in mirabile italiano la poesia di questo “ostico” poeta ceco; altrettanto lo siamo all’editore Mimesis Hebenon che, con le sue pubblicazioni, ha fornito una sponda importantissima a quanto andiamo scrivendo intorno alla nuova poesia europea.
Il segreto di questa poesia è in quel concetto di «continuamente presente» di cui parla Petr Král, è in una modalità espressiva che non contempla la «memoria» e, al pari della «musica», risulta incoglibile, se non come assolutamente presente, unicamente presente. «Presente» come manifestazione paradossale dell’Assoluto, assoluto contro – senso, assoluto paradosso, assoluta incoglibilità del paradosso. Quel «presente» che rimane sempre incoglibile. Alla luce di questa impostazione krláiana, tutti i presenti si equivalgono, tutti sono compossibili e tutti assurdi, assoluti e, quindi, inconsistenti, incoglibili se non attraverso esso «presente». È questo il fulcro della concezione della vita e dell’arte di Petr Král. Ed è questa, senza ombra di dubbio, la linea di ricerca della «Nuova ontologia estetica».
Ciò che riesce di problematica identificazione, e perfino incomprensibile, nella poesia di Petr Král dal punto di vista della poesia italiana degli ultimi decenni, diventa pienamente intellegibile dal punto di vista della «Nuova ontologia estetica». Com’è possibile? Come può accadere questo? La risposta all’interrogativo traspare dai contributi che seguono, di Carlo Livia, di Gino Rago, è negli appunti critici di Donatella Costantina Giancaspero, così come credo sia in queste mie riflessioni. Quanto noi stiamo dicendo e facendo da tempo, è riconoscere e affermare che una nuova poesia sorge sempre e soltanto quando si profila un nuovo modo di concepire il linguaggio poetico.
Ad esempio, negli autori della «Nuova ontologia estetica» si verifica un uso di alcune categorie retoriche piuttosto che di altre: innanzitutto la categoria retorica fondamentale (che poi, in realtà, non è una categoria retorica, ma un procedimento che concerne il modo stesso con il quale si concepisce l’essenza e la funzione del linguaggio poetico), ovvero il concetto di verosimiglianza tra il «linguaggio» e il «reale». Nei loro testi, non si dà alcuna corrispondenza equivalente e/o mimetica tra la «parola» e l’«oggetto» del reale, non si dà «corrispondenza» affatto, non si dà alcuna «riconoscibilità» a priori, in quanto la «riconoscibilità» deve essere scoperta volta per volta nell’ambito del dispiegamento del discorso poetico, deve essere «ricostruita» ogni volta ex novo. Così come accade nella poesia di Petr Král, il raffreddamento della composizione linguistica dà luogo ad uno zampillio di deviazioni, il linguaggio viene utilizzato per una «ricostruzione» non più «mimetica» del reale, ma ultronea, sovra reale.
Un augurio speciale a Petr Král nel giorno del suo compleanno.

Petr Král
Herméneutique de Giorgio Linguaglossa
(Traduction par Edith Dzieduszycka)
Avec Peter Kràl nous nous trouvons sans aucun doute en face de l’un des principaux poètes européens: plus je le lis plus je m’en persuade. Certes, sa poésie est bien loin des cordes phoniques de la poésie italienne de ces dernières décennies. Ce qui démontre précisément la valeur de sa poésie, rien d’autre… Du reste, je me souviens que le poète praguois, dans une de ses petites notes, avertissait déjà le lecteur italien qu’il se serait trouvé devant une poésie différente, très différente de celle à laquelle il avait été habitué…
La richesse phénoménale de la poésie de Kràl est le résultat d’un équilibre très instable entre la vraisemblance et l’invraisemblable; certains moyens rhétoriques come la sineciosi
e la peritropè (le renversement), le déraillement (contrôlé) de ses périphrases, les déviations, l’entanglement. sont les éléments base sur lesquels se fonde sa poésie, qui possède le privilège de jouir des avantages du surréalisme auquel Kràl a adhéré, à Prague comme à Paris: un surréalisme innervé dans son histoire et dans sa langue. Il provient de l’expérience du second surréalisme tchèque, filtré à travers la délusion politique survenue après l’invasion de la Tchécoslovaquie par le chars soviétiques, une expérience traumatisante et traumatique, qui a marqué profondément beaucoup d’autres poètes et écrivains praguois. Dans la perspective surréaliste, le langage cesse d’etre fonctionnel au référent, il devient impropre à la parole, considéré comme un instrument non utilisable selon un schéma mental d’adaptation de la parole au référent.
Lacan écrit:
“Dan la mesure où le langage devient fonctionnel il se rend impropre à la parole, et quand cela devient trop caractéristique, il perd sa fonction de langage.”
Nous savons l’usage fait dans les traditions primitives, des noms secrets à travers lesquels le sujet identifie sa propre personne ou ses dieux, au point que les relever correspond à se perdre ou à les trahir (…)
Enfin, c’est dans l’intersubjectivité des “nous” qu’il assume, que se mesure dans un langage la valeur de sa parole.
Par une antinomie inverse, on observe que plus l’usage du langage se neutralise en se rapprochant de l’information, plus on lui attribue des redondances.
Effectivement la fonction du langage n’est pas d’informer mais d’évoquer.
Ce que je cherche dans la parole est la réponse de l’autre. Ce qui me constitue en tant que sujet est ma question. Pour me faire reconnaitre de l’autre, je profère ce qui a été seulement en vue de ce qui sera. Pour le trouver, je l’appelle avec un nom qu’il doit assumer ou refuser pour me répondre.
Je m’identifie dans le langage, mais seulement en m’y perdant comme un objet. Ce qui se réalise dans mon histoire n’est pas le passé lointain de ce qui fut parce qu’il n’est plus, et non plus le parfait de ce qui a été dans ce que je suis, mais le futur antérieur de ce que j’aurai été pour ce que je suis en train de devenir.” 1)
J:Lacan Ecrits, 1966, trad. it. Einaudi, 1974, p. 293
Aujourd’hui il est probablement impossible, en Europe, d’écrire une poésie réellement moderne, sans se référer de quelque façon, à l’héritage du surréalisme: le surréalisme entendu come éloignement conscient du référent et au référent. En Italie, dans la tradition poétique de ces dernières décennies (avec l’excellente exception de la poésie de Angelo Maria Ripellino et de Maria Rosaria Madonna, et à part, évidemment, les auteurs de la “Nouvelle ontologie esthétique”), il y a bien peu de surréalisme: nous sommes encore englués et refroidis dans un concept de vraisemblance avec le “réel” qui a fini par appauvrir la gamme expressive de la poésie italienne.
Nous sommes donc reconnaissants à Antonio Parente pour avoir admirablement traduit la poésie de ce difficile poète tchèque; comme nous le sommes envers l’éditeur Mimesis Hebenon qui, avec ses publications, a fourni un terrain d’envol important pour ce que nous sommes en train d’écrire concernant la nouvelle poésie européenne.
Le secret de cette poésie réside dans ce concept de “continuellement présent” dont parle Petr Kràl; il s’agit d’un mode expressif qui ne contemple pas la “mémoire” et, de même que pour la musique, impossible à cueillir, se non en tant qu’absolument présent, uniquement présent. “Présent” comme manifestation paradoxale de l’Absolu, absolu contre-sens, paradoxe absolu , impossibilité absolue à cueillir le paradoxe. Ce présent” qui reste toujours impossible à cueillir. A la lumière de cette structure “kralienne”, tous les présents s’équivalent, ils sont tous possibles ensembles et tous absurdes, absolus et par conséquent inconsistants, “incueillables” si ce n’est à travers lui-même, “présent”. Là se trouve l’épicentre de la vie et de l’art de Petr Kràl. Et c’est là que se trouve, sans ombre de doute, la ligne de recherche de la “Nouvelle ontologie esthétique”.
Ce qui semble difficile à identifier, et même incompréhensible, dans la poésie de Petr Kràl du point de vue de la poésie italienne des dernières décennies, devient pleinement intelligible vu de la part de la “Nouvelle ontologie esthétique”. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il se produire? La réponse à cette demande apparait à travers les contributions suivantes, de Carlo Livia, Gino Rago, e dans les notes critiques de Donatella Costantina Giancaspero, ainsi que dans mes réflexions. Ce que nous disons et faisons depuis longtemps est reconnaitre et affirmer qu’une nouvelle poésie nait toujours et seulement avec l’apparition d’un nouveau mode de concevoir le langage poétique.
Par exemple, dans les auteurs de la “Nouvelle Ontologie esthétique”, on peut observer l’usage de certaines catégories rhétoriques plutôt que d’autres: principalement la catégorie rhétorique fondamentale (qui en réalité n’est pas une catégorie rhétorique, mais un procédé qui concerne le moyen même avec lequel on peut concevoir l’essence et la fonction du langage poétique), autrement dit le concept de vraisemblance entre le “langage” et le “réel”. Dans leurs textes, il n’existe aucune correspondance équivalente et/ou mimétique entre la “parole” et “l’objet” du réel; il n’existe aucune “correspondance”, aucune “reconnaissance” a priori, étant donné que la “reconnaissance” doit être découverte pas à pas au cours du déploiement du discours poétique, doit être “reconstruit” neuf chaque fois. Ainsi que nous le constatons dans la poésie de Petr Kràl, le refroidissement de la composition linguistique donne lieu à un jaillissement de déviations, le langage sert à une “reconstruction” non plus “mimétique” du réel, mais en dehors et au-dessus du réel.
Nos vœux très spéciaux à Petr Kràl pour le jour de son anniversaire.

Praga, fiume Moldava, foto di Donatella Costantina Giancaspero
Ermeneutica di Donatella Costantina Giancaspero
In merito alle differenze, sappiamo che Petr Král è del tutto consapevole della distanza che divide la propria poesia da quella italiana. Lo dichiara esplicitamente nella nota introduttiva all’antologia Tutto sul crepuscolo:
«Di sicuro la mia poesia è necessariamente un po’ lontana dalla tradizione poetica italiana; nonostante il mio amore per l’Italia (e le poesie di questa raccolta che vi si sono ispirate direttamente) provengo da altri luoghi, da altri orizzonti, e non tutto quello che offro può risultare allettante ed eloquente per il lettore italiano. Perciò è anche possibile che vi sia uno scontro tra le mie e le sue abitudini e preferenze; laddove nella poesia italiana prevale la fluidità del canto, i miei sguardi alla realtà, spesso piuttosto perfidamente obliqui, possono anche suscitare un minimo di disturbo. Tuttavia, voglio credere che nemmeno in questo caso il mio confronto con il lettore italiano sia vano, e che ne risulti almeno qualcosa di benefico per entrambe le parti».
Petr Král ci avverte anche che, per questa antologia tradotta in italiano da Antonio Parente, ha selezionato in primo luogo le poesie ispirate all’Italia. Evidentemente, volendo così omaggiare il nostro Paese. Ma, come puntualizza nella sua nota:
«Ogni selezione di testi dal corpo poetico di un autore è necessariamente una semplificazione, mette in risalto alcuni aspetti dell’opera, e ne esclude altri che ne costituiscono un supplemento di precisazione e arricchimento – o persino un contrappeso necessario. Ciò è vero anche quando – come nel caso di questo volume – la scelta è opera dell’autore. Nemmeno lui – fortunatamente – sa tutto della sua opera, può anch’egli trascurare aspetti importanti così come sottolinearne in maniera un po’ eccessiva (ossessiva) altri. Io stesso mi sono accorto soltanto dopo aver selezionato i testi che queste poesie in maggior parte “hanno luogo” fuori, all’aria aperta, e soltanto a tratti mettono in relazione questa loro estensione con lo spazio interno. Può darsi che questa scelta sia derivata – senza esserne stato precedentemente consapevole – proprio dalla mia idea dell’Italia come di uno spazio ideale per la libertà umana; ad ogni modo, non ho cambiato nulla della mia scelta, nella speranza che sarà il tempo stesso a rivelarne il suo significato nascosto».
Ogni «selezione di testi» – dice Král – è una «semplificazione». Perciò, credo che non si possa conoscere in pieno un autore se non leggendone almeno due o tre opere intere.
La poesia di Král ci libera dall’obbligo di mirare alla cosa, e libera la stessa poesia di dover sempre mirare allo scopo della significazione; la cosa, se c’è viene colta attraverso un processo di aggiramento e di concentrazione intensiva, infrange i limiti costituiti dalla abitudine che noi abbiamo di pensare la cosa nell’assetto linguistico consolidato dalle norme linguistiche e sintattiche, perché i pensieri, quelli profondi è inevitabile che si rinnovino incessantemente altrimenti l’esperienza della cosa ne sarebbe impedita o offuscata. È la consequenzialità imprevedibile degli sviluppi delle fraseologie kraliane quella che ci offre una visione inedita dell’oggetto; ogni «deviazione» è un impensato che apre le porte del pensato, ogni «deviazione» è un indeterminato che infrange il determinato, e il contenuto di verità, se c’è, si dà nella dimensione della costellazione in divenire che non è mai un percorso sintatticamente automatico o unidirezionale ma è un percorso snodato, che contiene degli shifter, degli scambi, snodabile e orientabile all’interno di una vastissima gamma di possibilità espressive. La pratica della poesia è intesa da Král come una pratica domestica del pensiero, del pensiero che riparte ad ogni momento da zero, che vuole appropriarsi di ogni singola esperienza ma che, per assumersi questo compito, deve ogni volta ripartire da un punto dietro il quale non c’è più nulla. Quello che appare come un esercizio stilistico è in realtà un esercizio spirituale, una pratica ascetica, una via laica verso l’ascesi della composizione poetica.
E allora, l’augurio che rivolgo a Petr Král nel giorno del suo compleanno, è proprio quello di poter vedere presto tradotti in italiano molti dei suoi libri.
Herméneutique de Donatella Costantina Giancaspero Continua a leggere →

































 Leopoldo Attolico, (Roma, 5 Marzo 1946), ha pubblicato, a partire dal 1987, sei titoli di poesia e quattro plaquettes in edizioni d’arte, materiale confluito assieme a numerosi inediti nell’opera omnia Si fa per dire, Tutte le poesie, 1964-2016, Marco Saya Edizioni, 2018.
Leopoldo Attolico, (Roma, 5 Marzo 1946), ha pubblicato, a partire dal 1987, sei titoli di poesia e quattro plaquettes in edizioni d’arte, materiale confluito assieme a numerosi inediti nell’opera omnia Si fa per dire, Tutte le poesie, 1964-2016, Marco Saya Edizioni, 2018. La strategia della disparizione della scrittura poetica
La strategia della disparizione della scrittura poetica




































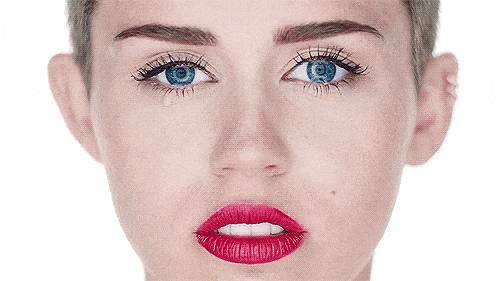
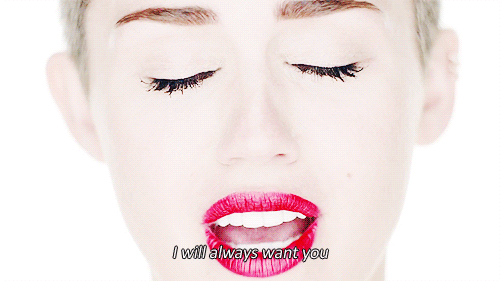


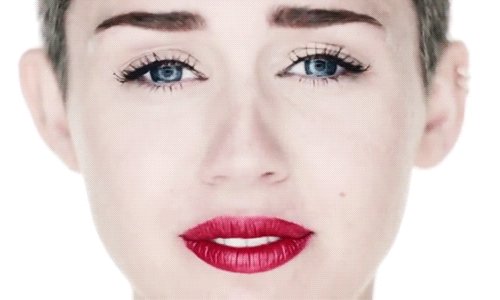








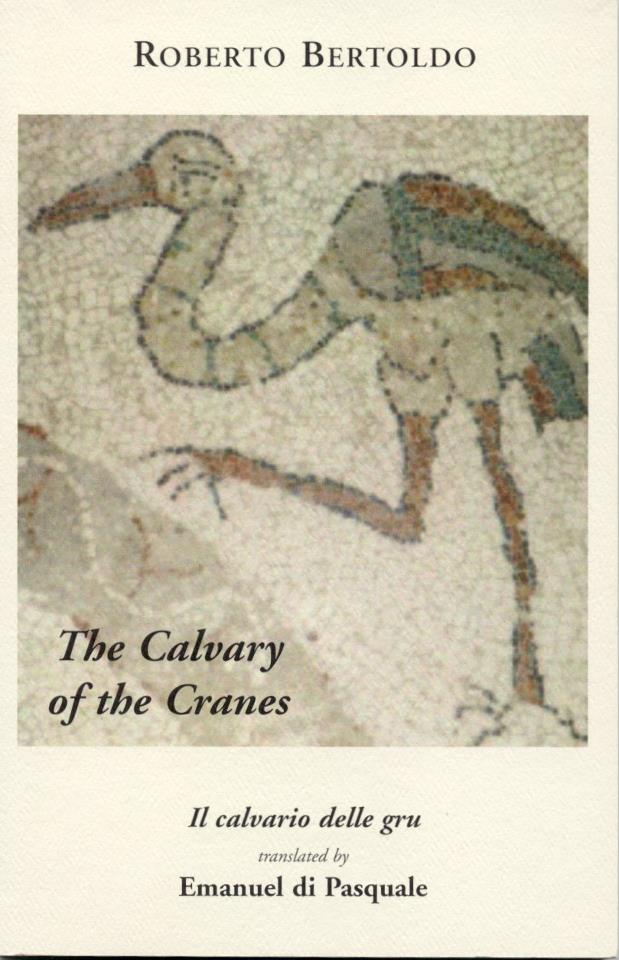
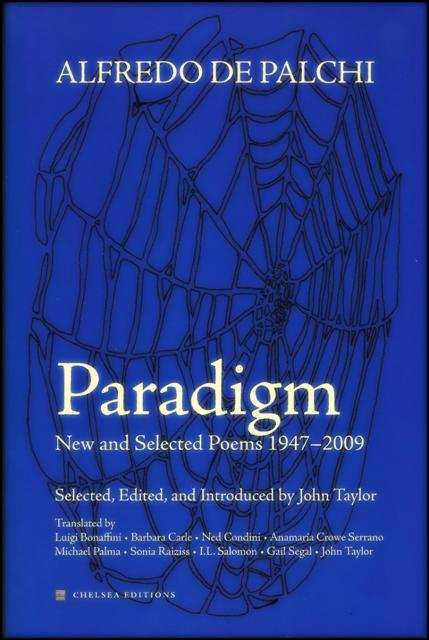


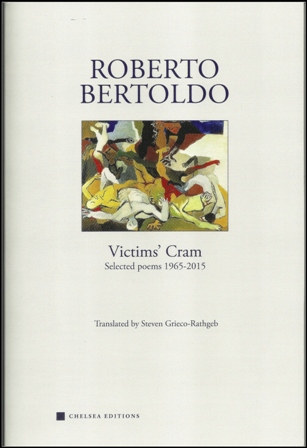





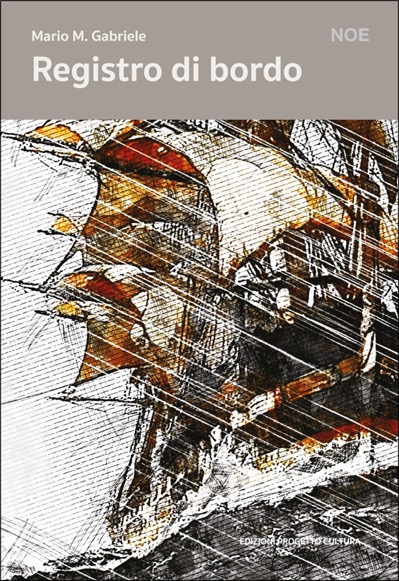

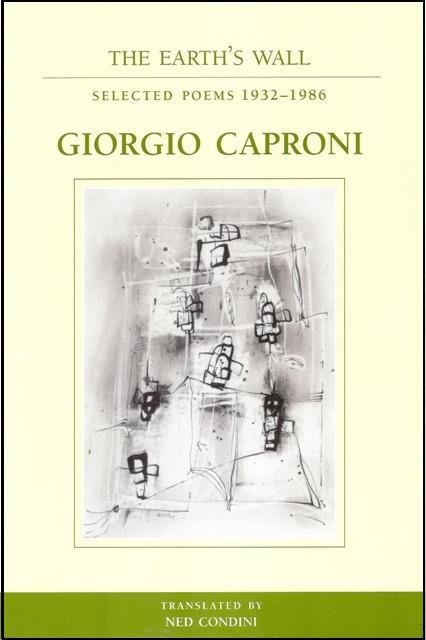
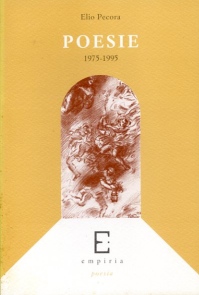

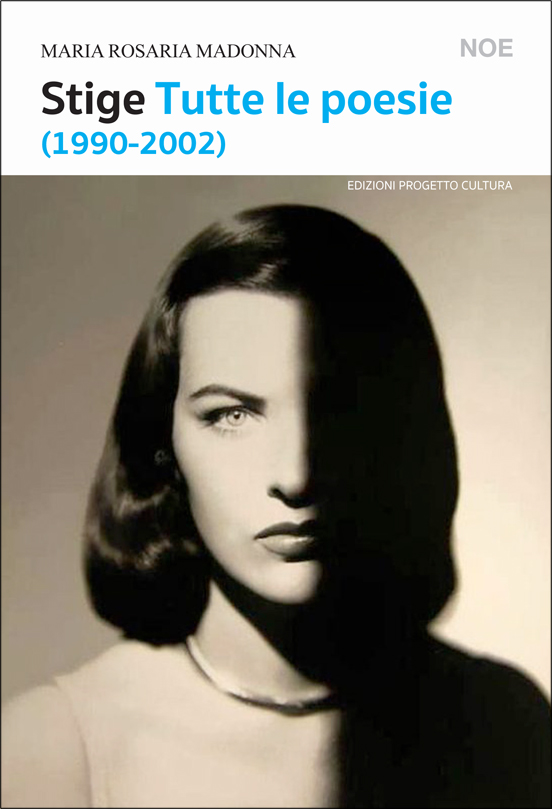

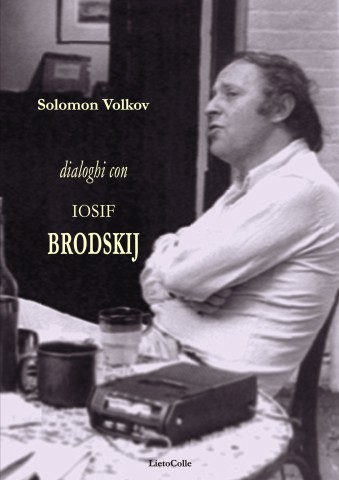




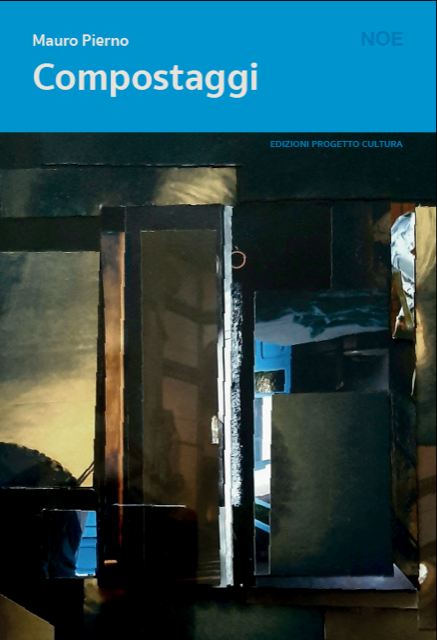




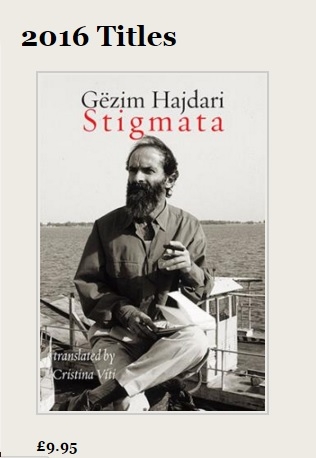






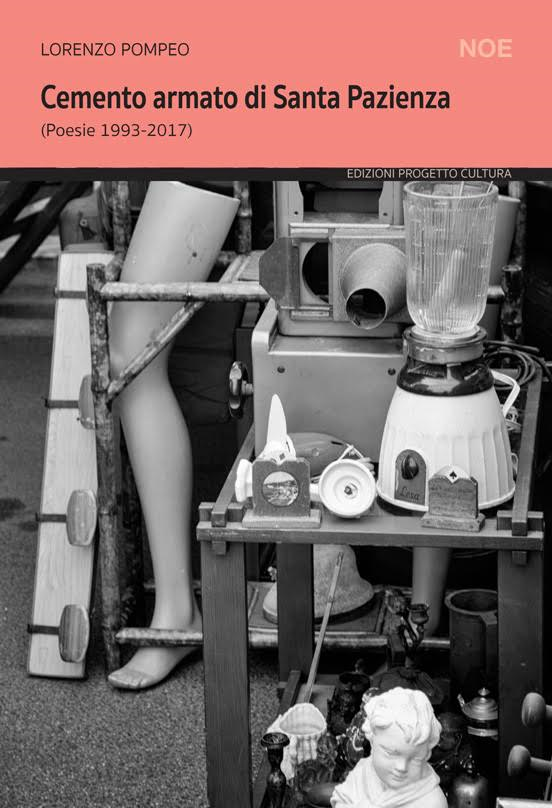







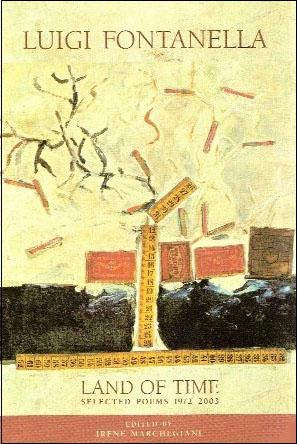








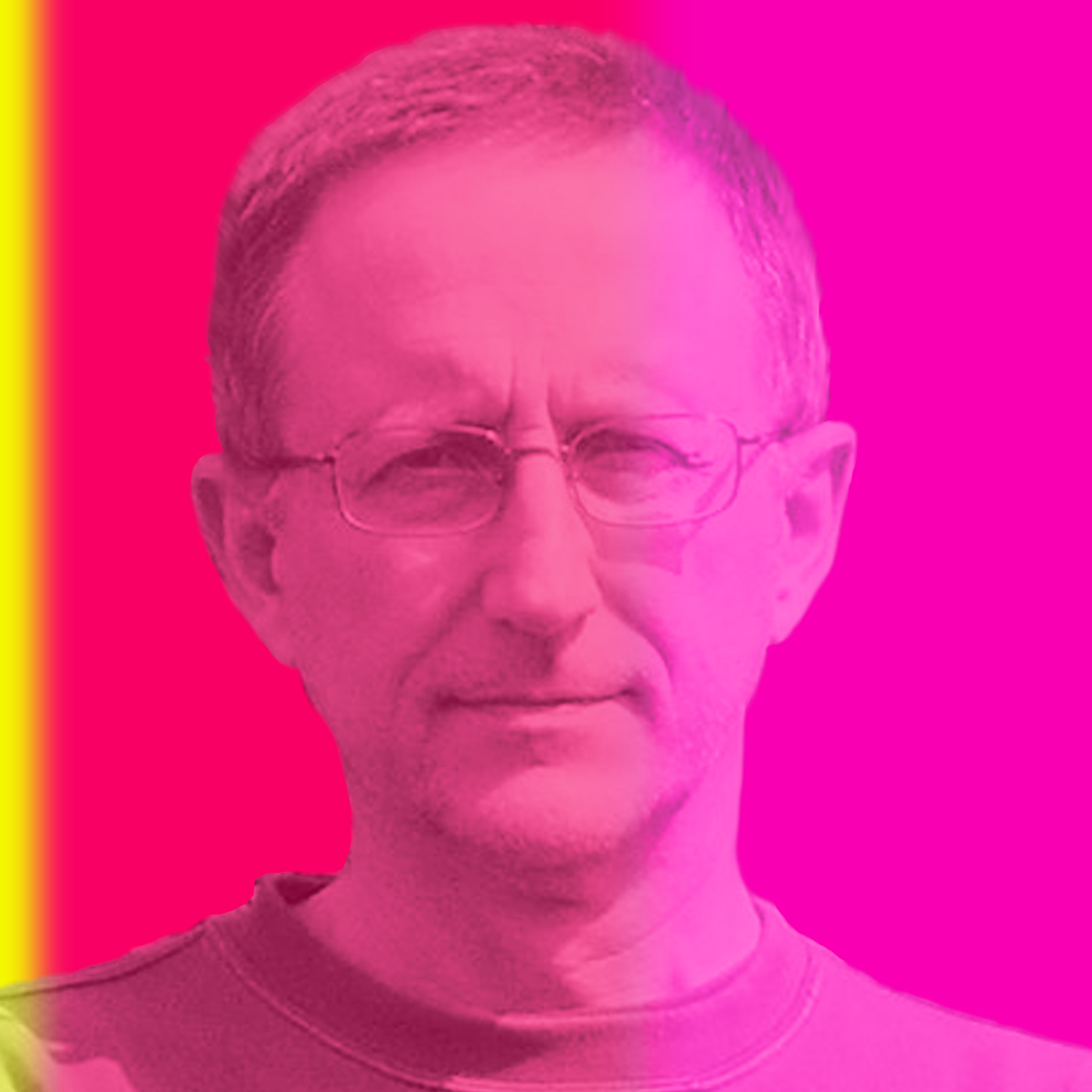







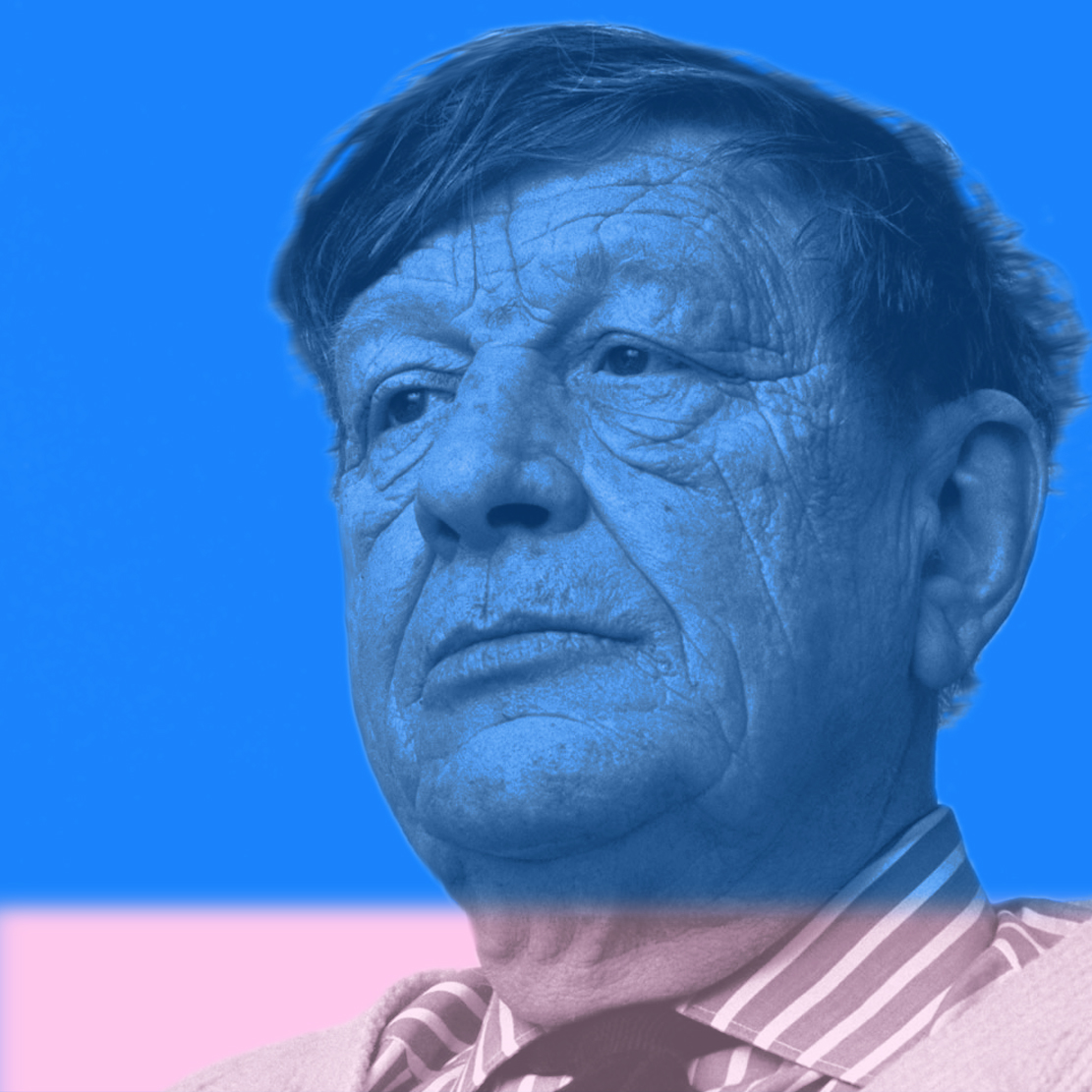





















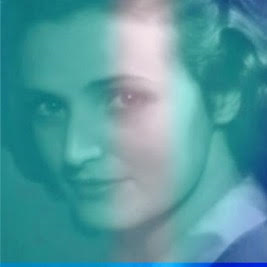































In una Danimarca travolta dalla peste e sprofondata nella disperazione torna dalle crociate il nobile cavaliere Antonius Block. Al suo arrivo sulla spiaggia trova ad attenderlo la Morte, che ha scelto proprio quel momento per portarlo con sé. Il cavaliere decide di sfidarla a scacchi: inizia una partita che sarà giocata nel corso di vari incontri, mentre Antonius e lo scudiero Jöns attraversano la Danimarca e incontrano molte persone, pronte a espiare con dure punizioni i propri peccati o a godere senza freni degli ultimi istanti. Il cavaliere s’imbatte anche in una famiglia di saltimbanchi, che sembrano non accorgersi della tragedia che li circonda, uniti dall’amore e dal rispetto reciproco… [sinossi]
Quando l’agnello aprì il settimo sigillo,
nel cielo si fece un silenzio di circa mezz’ora
e vidi i sette angeli che stavano dinnanzi a Dio
e furono loro date sette trombe.
[Apocalisse, 8, I]
Mi chiedo spesso, quando leggo una poesia o un romanzo italiani, a quale film della odierna filmografia italiana possa ragguagliarli e non trovo, ahimè, nulla, nulla cui possa ragguagliare quelle storie che ho letto. E allora, penso che qualche domanda dovremmo porcela, dovremmo chiederci perché l’odierna filmografia italiana è ricchissima di barzellette e di storie stereotipate raccontate con un linguaggio filmico stereotipato. Quando invece leggo una poesia di Kjell Espmark vedo in filigrana il grande cinema di Bergman. Non a caso. Forse, mi chiedo, la poesia italiana degli ultimi decenni non presenta nulla di importante? Di importante da poter interessare un regista? – Ricordo una frase di Milosz il quale commentando le poesie di Eliot dice che non si potrebbero comprendere i Film di Antonioni se non tenessimo conto di certe atmosfere de La terra desolata (1922) di Eliot. L’affermazione di Milosz mi colpì molto e cominciai a chiedermi se la poesia italiana che stiamo facendo, la nuova ontologia estetica, un giorno possa ispirare la regia di un regista del futuro. Io penso di sì, la nuova ontologia estetica richiede fortemente una nuova fenomenologia filmica per essere compresa. Ecco dunque che siamo arrivati al punto: una nuova estetica poetica richiede sempre l’accompagnamento delle arti sorelle: la filmografia, l’arte figurativa, la scultura, la musica di ricerca, la danza… Se leggiamo queste poesie di Kjell Espmark, autore svedese ormai novantaduenne non possiamo non pensare a certe atmosfere dei film di Bergman.
Mi ha colpito molto il titolo di uno dei libri di poesia di Espmark: «Lo spazio interiore». Ecco, qui siamo all’interno di una concettualità che vorrei fosse la nostra casa comune, nostra dico della nuova ontologia estetica: creare spazi, creare tempi, moltiplicare gli spazi e i tempi, demoltiplicare le immagini, defondamentalizzare la costruzione sintattica, defondamentalizzare la colonna sonora della forma-poesia: eliminare il più possibile i verbi (che il più delle volte sono dei sostituti del nome), eliminare le soggettività (vuole e inutili) dell’io, raccontare sì ma senza l’ausilio scontato della ipostasi dell’io come collante e centro di tutte le cose. Dobbiamo porre in primo piano quando scriviamo una poesia, lo «spazio interno» e il «tempo interno», tutto il resto è secondario…