
Prefazione a materia redenta di Marina Petrillo, Progetto Cultura, Roma, 2019, pp. 100 € 12 di Giorgio Linguaglossa
Nel saggio giovanile Tradizione e talento individuale del 1917 Eliot mette a fuoco il problema con pragmatica chiarezza: «La tradizione non è un patrimonio che si possa tranquillamente ereditare; chi vuole impossessarsene deve conquistarla con grande fatica. Essa esige, anzitutto, che si abbia un buon senso storico». Nella sua opera successiva il poeta inglese annuncia l’esaurimento della modernità.
Una delle caratteristiche principali della post-modernità è la critica alla modernità e il suo oltrepassamento all’indietro: all’idea del «nuovo» e di innovazione ininterrotta della letteratura, subentra l’idea del ri-ciclo e del ri-uso, della citazione, della de-costruzione. Questo è chiaro in molti autori post-moderni oggi inquadrati come neoclassici. Il mondo salvato dai ragazzini (1968) di Elsa Morante è un’opera tipicamente post-moderna, con il libero impiego di vari generi narrativi che si sovrappongono e si elidono nell’ambito di un discorso poetico ormai vulnerato; Trasumanar e organizzar (1971) di Pasolini segna l’ingresso di un discorso poetico sostanzialmente non dissimile dal discorso giornalistico e narrativo; La Beltà (1968) di Zanzotto è un superlavoro di microcitazioni e di variazioni… siamo arrivati alla summa del Moderno che si autocita e si fagocita. Altre foto per Album (1996) di Giorgia Stecher è una riscrittura del passato attraverso la lente di ingrandimento di alcune fotografie dimenticate nei cassetti di vari comò; il passato viene ripescato e rivissuto mediante vecchie fotografie dimenticate. Incredibile!, la vera rivoluzione della poesia la si fa mediante delle fotografie dimenticate in un cassetto, ripescate messe in forma poetica; la vera rivoluzione la fa Maria Rosaria Madonna con Stige del 1992 adesso ripubblicata insieme agli inediti da Progetto Cultura, Stige, Tutte le poesie (1985-2002) con la sua poesia in neolatino, fitta di scalfitture semantiche, ibridazioni lessicali dal tardo latino ieratico medievale ad un italiano arcaicizzato.
Ormai è chiaro che le rivoluzioni artistiche non si fanno più in avanti ma all’indietro, di lato, ripescando i brandelli e i sintagmi di un mondo trascorso. Auden e Brodskij sono autori tipicamente post-moderni, tornano al ri-uso della metrica tradizionale, la ribasano su un materiale sostanzialmente estraneo e refrattario alla gabbia metrica della tradizione qual è il parlato. Il Moderno, con tutte le sue avanguardie e post-avanguardie, tende a diventare un fenomeno del passato, un circo equestre, un patrimonio amministrato, un museo, mercato, rigatteria, vintage. Entriamo nel Postmoderno. All’idea del progresso estetico subentra l’idea di un regresso estetico, di una diffusione dell’estetico in tutte le direzioni, fuori dagli ambiti privilegiati e protetti della tradizione stilistica del Moderno. Il nichilismo antitradizionale delle avanguardie è progressivo, tende al futuro, vuole andare sempre oltre e al di là, distrugge il passato per costruire un mondo nuovo, distrugge in quanto c’è ancora un patrimonio da dilapidare e distruggere e c’è anche un mondo nuovo da abitare e conquistare.
Oggi, nelle nuove condizioni del Dopo il Moderno, non c’è più un passato da distruggere, anzi, non c’è più un passato, non c’è più nemmeno alcuno spazio per il Futuro.
La poesia di Marina Petrillo la si può inquadrare in questo ambito storico: un tentativo di scavalcamento all’indietro della modernità ripristinando le tematiche «alte» e quelle «basse», il lessico «alto» e quello «basso», il registro del «quotidiano» e quello del periechon.
Ne risulta un libro costituito da un conglomerato di due stili e due approcci metodologici completamente diversi: tendenzialmente ieratico il primo e tendenzialmente cronachistico e pragmatico il secondo. Ne risulta una divaricazione lessicale, prima ancora che stilistica; concettuale. Lo stile tendenzialmente gnomico-aforistico è agglutinato allo stile tendenzialmente cronachistico, ed è in questa ambivalenza, in questa oscillazione tra due stili contraddittori che si rivela la non pacificazione di ciò che non è stilisticamente conciliabile. Il problema della coesistenza di linguaggi disparati e divergenti, caratteristica delle scritture del Dopo il Moderno, non può essere avviato a soluzione con un atto individuale o con una opzione privata dello stile. Ma è qui che si gioca e si giocherà la partita della scrittura poetica del futuro: il bisogno di attraversare i linguaggi detritici e di riporto della tradizione del Moderno (hic facit saltus!) evitando di compromettersi con i detriti della cronaca e del quotidiano come ingenuamente fa il minimalismo.
[La sposa fetale, installazione di Marina Petrillo]
Molto dispari nella resa metrica, la scrittura della Petrillo è attraversata da una inquietudine stilistica e materica per tutto ciò che sfugge al calco mimetico. È l’ibridazione materica di cui si fa carico il discorso poetico di Marina Petrillo che rende questa scrittura sabbiosa, petrosa, scagliosa, acuminata, irrisolta.
Marina Petrillo, seguace di Mallarmé e adepta prediletta di Mnemosyne, considera la pratica poetica al pari di una liturgia nel senso letterale del termine che comprende una dimensione soteriologica, in cui è in argomento la salvezza spirituale, e una dimensione performativa, in cui l’attività creativa è un semplice comportamento pragmatico. La poesia si dà come celebrazione di un significato che sta al di là dei significati intramondani, di un significato trascendibile e trascendente. Detto questo, si capirà la predilezione della Petrillo per la catacresi e l’ellisse, che sono gli strumenti retorici che tendono a spostare il linguaggio verso la soglia dell’indicibile.
La poesia della Petrillo predilige l’espressione figurata, nella quale il letterale e il figurato funzionano come categorie proposizionali della differenza problematologica. Ad esempio nel sintagma «Io diffuso ad Uno», siamo indotti a ricercare altro da ciò che è detto in ciò che è detto attraverso ciò che è detto. Decifrarne il senso implica l’atto di aderire ad un universo concettuale e metaforico dominato dalla contradictio in adiecto e dalla tautologia dove l’enunciato è risposta ad un altro enunciato secretato, risposta alla questione del senso, impossibile a dirsi e a dire se non mediante un atto linguistico figurato. Nella poesia petrilliana la tautologia e l’ossimoro abitano la medesima casa del linguaggio, e il linguaggio ne paga le conseguenze con una situazione di infermità dove il locutore parte da una domanda secretata per andare verso la risposta; e la poesia è nel viaggio, nel percorso che intercorre tra il parlante locutore e il rispondente risponditore. È la ricerca del senso che qui ha luogo, che non può essere soltanto nel disvelarsi del linguaggio senza che vi sia al contempo il presenziarsi del risponditore. È un dialogo muto e intermesso che ha luogo in mezzo alla confusione dei rumori di fondo. È il solo modo in cui può darsi la poesia nella notte dei tempi dello spirituale della nostra epoca digitale.
Per Ezra Pound «una fondamentale accuratezza d’espressione è il solo e unico principio morale della scrittura», e la Petrillo lavora con il bulino del cesellatore per anni intorno ad una catacresi o ad una metafora ardita. È il suo modo di partecipare ad un rito olistico nell’epoca della medietà mediatica. La severità del poeta nei riguardi di se stesso è il miglior lasciapassare per la propria poesia, il lavoro poetico richiede tenacia e auto riflessione e un senso spiccatissimo di autocritica.
Ha scritto Marina Petrillo:
«il Tempo. Spoglio di ogni linearità, abita i fotoni di infinite galassie».
Quando la poetessa romana ha messo su carta questo pensiero non aveva ancora incontrato la pratica poetica della nuova ontologia estetica; tuttavia questo pensiero l’aveva messa sulla strada giusta: che il Tempo non ha alcuna linearità, e che trasporlo nella linearità sintattica e semantica del discorso unidirezionale che procede dal soggetto e passa attraverso il predicato per giungere al complemento oggetto, è un atto di traduzione che falsa sia la realtà delle cose che si presentano nel Tempo sia il racconto che noi diamo delle nostre percezioni e sensazioni. Si tratta di un atto di falsificazione.
Questo è l’assunto base da cui prende le mosse la poesia modernista europea che ha avuto inizio nel 1954, anno di pubblicazione di 17 poesie di Tranströmer. Chi non ha metabolizzato questo fatto, continua e continuerà a fare poesia tolemaica fondata sul presupposto della linearità semantica del tempo. Il concetto, credo, è molto semplice. È questo il pilastro fondamentale della nuova ontologia estetica.
Marina Petrillo stava andando per la sua strada già da molti anni, ancora prima che nascesse la nuova ontologia estetica, pensava in termini di «tempo interiore» e di «spazio interiore», scriveva una poesia della stanza interiore, di un cosmo in miniatura fitto di infinito, dove finito e infinito sono complementari e si legittimano a vicenda.
Per fare poesia nuova, o almeno, diversa, bisogna avere la forza di mettere in discussione quei precetti su cui si fonda il convincimento che confezionare una poesia significa aderirea un discorso che preveda un concetto unilineare del tempo e dello spazio, e la Petrillo ha provato a coniugare la rarefazione sintattica e metrica della poesia di Cristina Campo e di Antonia Pozzi con l’esigenza di una poesia che facesse di quei punti di debolezza, leggi la dismetria e la distassia, un punto di forza e di ripartenza.
Cupo e colmo d’angoscia risuona il lamento di Hölderlin:
«Wozu Dicther in dürftiger Zeit?».
A che scopo? A che pro? Perché i poeti nel tempo della miseria? Che cosa hanno da dirci i poeti nel tempo della povertà?
«L’espressione tedesca [in dürftiger Zeit] – scrive Blanchot – esprime la durezza con cui l’ultimo Hölderlin si difende contro l’aspirazione degli dei che si sono ritirati, mantiene la distinzione tra le due sfere, la sfera superna e quella di quaggiù, mantiene pura, con questa distinzione, la regione del sacro che la doppia infedeltà degli uomini e degli dei lascia vuota, poiché il sacro è questo stesso vuoto che bisogna mantenere puro».
Poco prima dei versi citati, l’elegia recita:
Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch.
Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber das Irrsal
Hilft, wie Schlummer und stark machet die Not und die Nacht.
“Solo per breve tempo l’uomo sopporta la pienezza divina. / Dopo, la vita non è che sogno di loro. Ma l’errore / aiuta, come sonno, la necessità rende forti come la notte”.1
L’errore, l’erranza, la penuria, l’indigenza… aiutano, rafforzano. Perché? Perché in questo tempo di durezza, la parola del poeta non dice più della dipartita degli dei, dell’abbandono, dell’assenza – la pienezza non è più udibile, essa ci dice che la dipartita degli dèi apre uno scenario di povertà nel tempo della durezza dell’essere; che la poesia significa il lutto, parola che oscilla tra memoria ed oblio, tra durezza e povertà dell’essere.
«Entrambi – uomo e dio – sono infedeli», scrive Hölderlin.
Di che cosa parla, infatti, il poeta? Qual è la sua materia? Se ad ogni tentativo di dire qualcosa intorno al proprio oggetto, consegna questo stesso oggetto all’oblio, lo affida alla dimenticanza? Vocazione del poeta è l’esercizio di una perpetua conservazione in perdita. Che ne è allora della parola del poeta, di quella parola che testimonia il sacro, e lo mantiene puro e vuoto?
La poesia della Petrillo alza gli scudi quando la tendenza ad ammutolire diventa insormontabile e soverchiante.
Nel tempo della estrema povertà (in dürftiger Zeit?), ha risposto Marina Petrillo con delle poesie che sembrano provenire dal tempo della mezza luce, della Lichtung, con delle parole sospese nel viale del tramonto, nella «radura» presso la quale l’ospite della terra giunge dopo un lungo silenzioso tragitto. Allora, ecco il segreto di quella frase hölderliniana: «Ciò che resta lo fondano i poeti», non tanto la parola in forza di «ciò che dura», ma anzitutto, la parola per la debolezza di «ciò che resta», perché in esso i poeti fondano il loro regno illusorio fatto di stuzzicadenti e di zolfanelli bagnati di pioggia come l’infrangersi della parola poetica che non è nulla di monumentale, di statuario, di memorabile, quanto un cumulo di detriti linguistici inutilizzati e abbandonati. La parola poetica non è una struttura metafisica stabile ma evento fragile e precario che si iscrive nell’epoca della debolezza e dell’infrangersi della parola poetica sugli scogli dell’essere un tempo stabile ed ora non più.
La parola poetica diventa esperienza della fragilità e della terrestrità, esperienza di un indebolimento di ciò che un tempo lontano era la pienezza del tempio greco o della basilica cristiana ed adesso è un luogo infirmato dal sole e dalla pioggia, dal vento e dagli uomini che abitano la terra e che ad essa ritornano, come erranti, come morti. Il linguaggio della Petrillo si dà come ciò che zerbricht, che si infrange sugli scogli dell’evidenza della terrestrità.
C’è un filo conduttore dall’epoca di Antonia Pozzi, di Cristina Campo, di Maria Rosaria Madonna, di Anna Ventura, di Donatella Giancaspero ad oggi che lega le voci femminili fino a Marina Petrillo, che ci racconta la scomparsa del «sacro». Una così nitida monumentalità non appariva all’orizzonte della poesia italiana da tempo immemore, dove si percepiscono distintamente le scalfitture, e le incisioni del tempo e della terra, le ferite e le abrasioni del tempo, tra il nulla e il presente, dove il tempo è presenza figurale del nostro essere nel mondo, dove la parola è scontro tra mondo e terra nella forma della terrestrità.
È là dove la Petrillo foscoleggia che ottiene l’apice della monumentalità per quell’empito della voce da basso continuo, classicista nutrita di anticlassicismo per quella fedeltà alle regole formali della poesia a partire dal ritmo franto ai raffinati tecnicismi dell’a capo, attraverso cui la poesia modernista del novecento riaffiora in una veste anacronistica e inattuale in un mondo che non sa più che farsene di quella metafisica dell’apparire e del disvelarsi, del venire alla presenza di ciò che non è più presente.
Le parole della Petrillo si presentano omologhe alle parole del corredo funebre con cui si adorna il cadavere di una giovinetta passata anzitempo tra i più…
«Nella tarda modernità l’essere sempre in viaggio, non avere una casa o un porto d’arrivo e non sentire, di conseguenza, la nostalgia per un preciso luogo cui ritornare, può persino trasformarsi in un privilegio. A cosa aspira l’anima moderna, definita da Baudelaire un veliero in cerca della sua terra utopica, un trois-mats cherchant son Icarie? E dove si dirige? Verso l’allontanamento dal noto, Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau (Le Voyage, VIII, 8), per uscire comunque dal mondo, non importa dove (Anywhere out of the world!, in Spleen de Paris, XLVIII).
Se ormai il mondo non ha né centro né periferia, non si possono più desiderare rientri nelle calme acque di un porto, ma soltanto senza meta».2
(Cosa rivela Poesia al Sacerdote del Sublime Tempio…)
Dell’insidiosa tela che il sovrano Tempo
ha posto a sigillo del Mondo
più non altro che cenere si solleva.
Scuote a fatica il capo
l’ultimo amante insoddisfatto
se i fianchi si invaghiscono dello Spirito.
Solo implora la pietà di un bacio.
Involve alfine lo Spazio in azzurrità
e di sua soave Bellezza l’oro
rivela in pudico segreto.
Se accettiamo l’affermazione heideggeriana dell’opera d’arte come «messa in opera della verità», non possiamo non chiederci quale sia il messaggio di «verità» che traluce da questi versi di Marina Petrillo posti in epigrafe.
È certo che la «verità» di cui ci parla la poesia moderna non ha nulla a che fare con la «verità» della metafisica, quella, per intenderci, della piena luminosità nella quale si staglia il marmo della Nike di Samotracia; la nostra «verità» non può che essere una scalfittura che non splende più nella «luminosità» del cielo e della terra ma che abita le intemperie, la mezza luce, lo sguardo distratto benjaminiano, il cono d’ombra, gli angoli intermessi e riposti… che si dà mediante un mezzo parlare, un parlare sibillino, un parlottio smozzicato, un balbutire; non più il tempo oracolare che oggidì risulta sbreccato e corroso; siamo giunti vicini al post-tempo un tempo postruistico e turistico dal quale non ci si affaccia più dal balcone del nulla a quello dell’essere. È il tempo della nostra temporalità infirmata. È il parlare di una modesta sibilla quello della Petrillo che ci parla della perdita perpetua, un parlare dimezzato, smozzicato e infirmato di una regalità infranta e decapitata; il parlare della bocca della testa decapitata, uno smozzicare di sillabe farneticanti senza più senso alcuno, un plesso di fonemi disarticolati e incomprensibili che si presenta nelle vesti disadorne di un «enigma» sordidamente esposto alla dimenticanza dell’essere e della memoria. Ecco perché l’enigma non deve essere interpretato quanto evocato e ricordato come un monito per ciò che è stato e per ciò che sarà nel futuro. Le parole della Petrillo sembrano aleggiare attorno ad un nucleo che si è dissolto, come un fumo che il vento ha disperso.
«Non è sempre necessario che il vero prenda corpo; è sufficiente che aleggi nei dintorni come spirito, e provochi una sorta di accordo come quando il suono delle campane fluttua amico nell’atmosfera, apportatore di pace».2
Le parole della poesia petrilliana aleggiano incerte attorno ad un nucleo assente perché hanno perso la forza di gravità della sintassi e del sensorio che un tempo le teneva legate, perché quella forza si è indebolita…
(Giorgio Linguaglossa)
1 G. Agamben Creazione e anarchia, 2017 pp. 124, 125
2 M. Heidegger, Die Kunst und der Raum, St. Gallen, Erker Verlag, 1969; trad. it. L’arte e lo spazio, di C. Angelino, Genova, Il melangolo, 1984 p. 23
 Poesie di Marina Petrillo, da materia redenta (2019) Continua a leggere
Poesie di Marina Petrillo, da materia redenta (2019) Continua a leggere




















 Giorgio Linguaglossa
Giorgio Linguaglossa















 Milaure Colasson
Milaure Colasson


























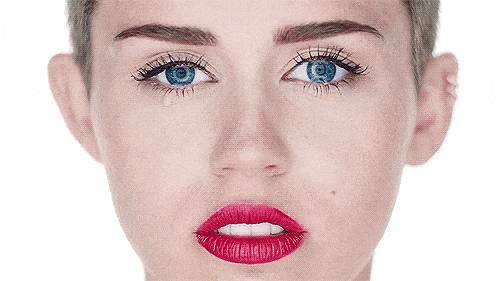
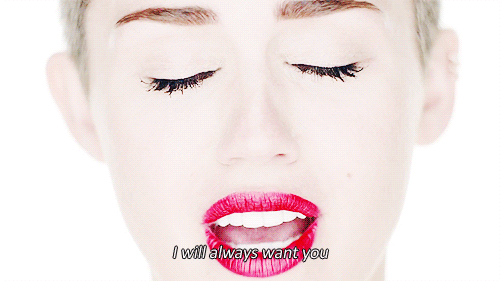


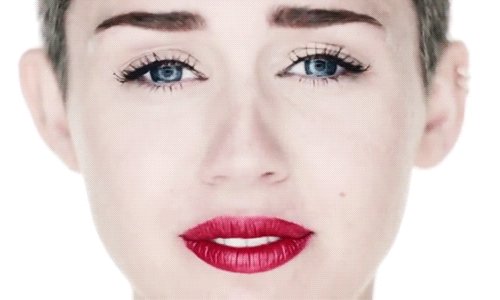








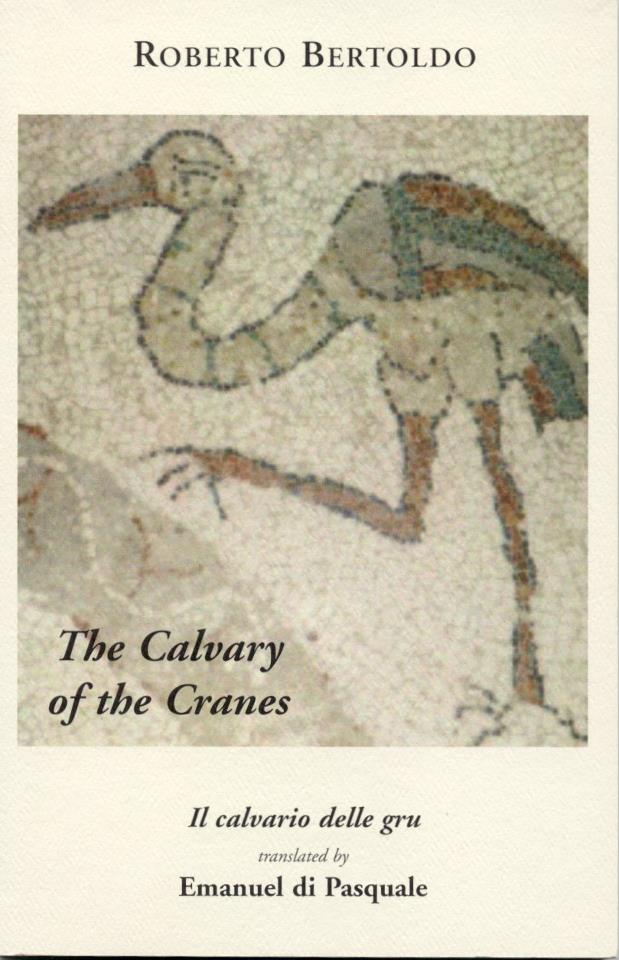
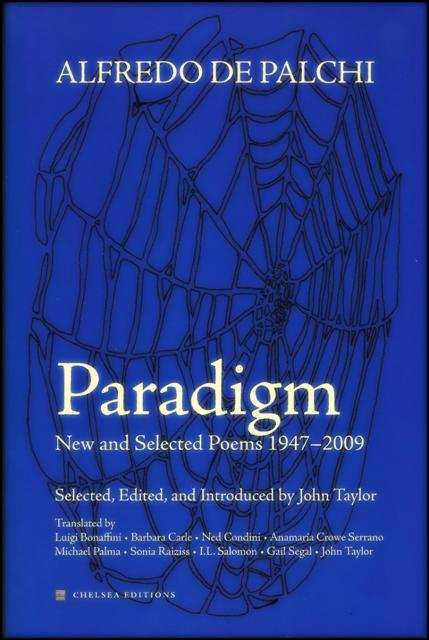


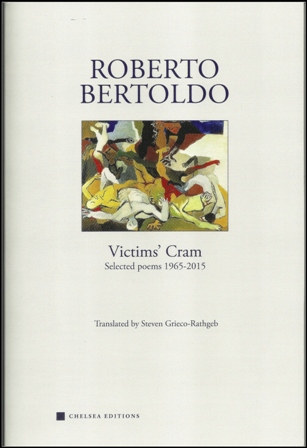





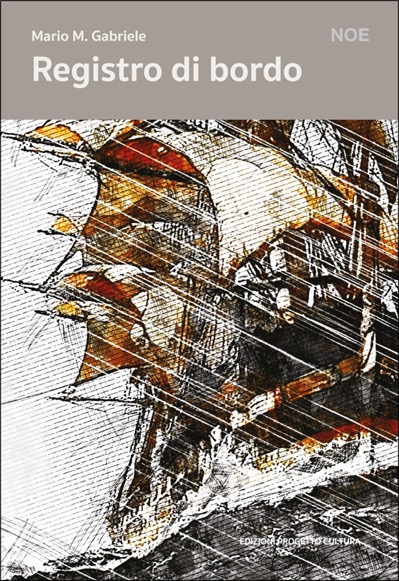

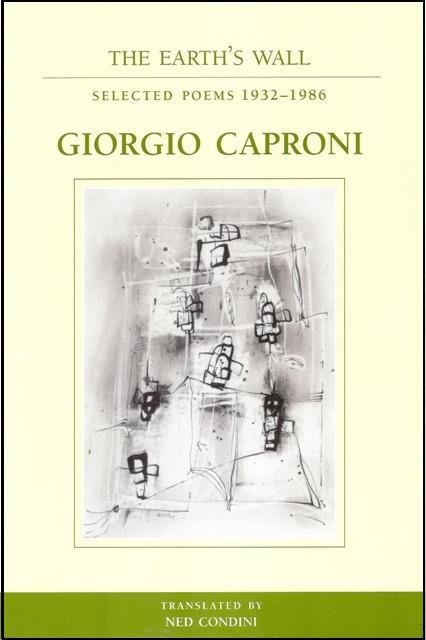
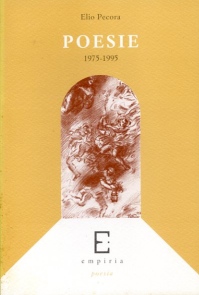

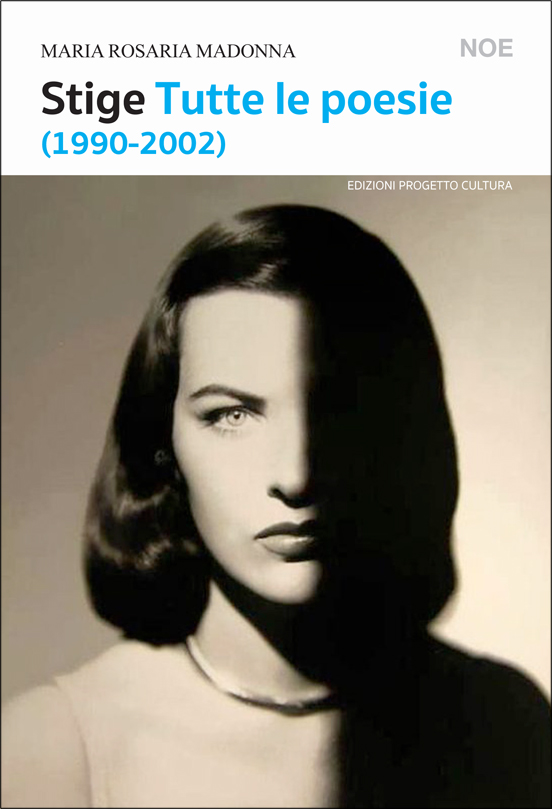

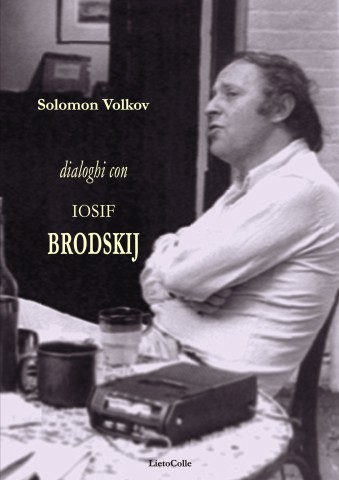




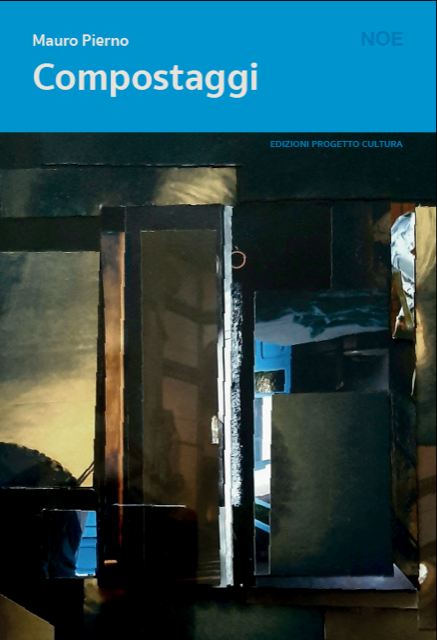




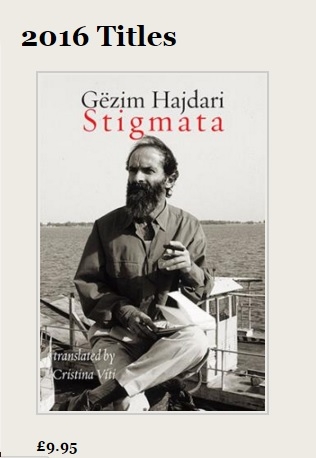






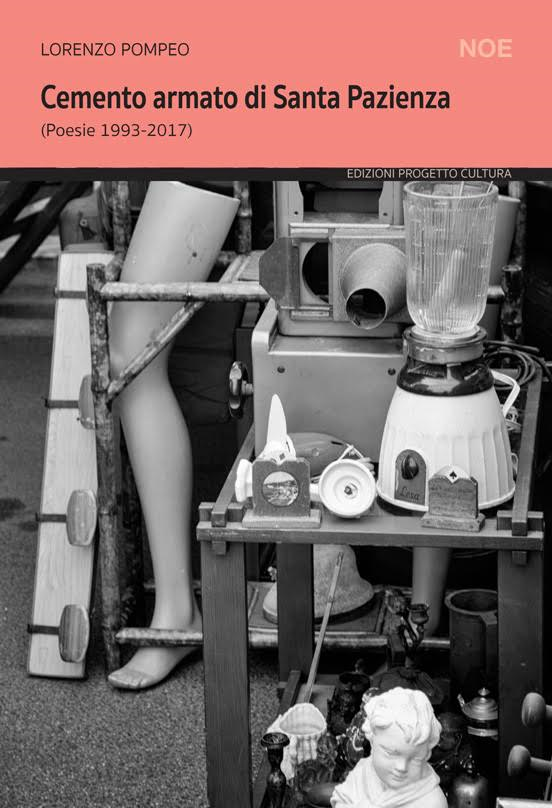







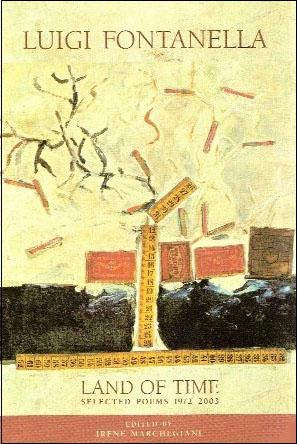








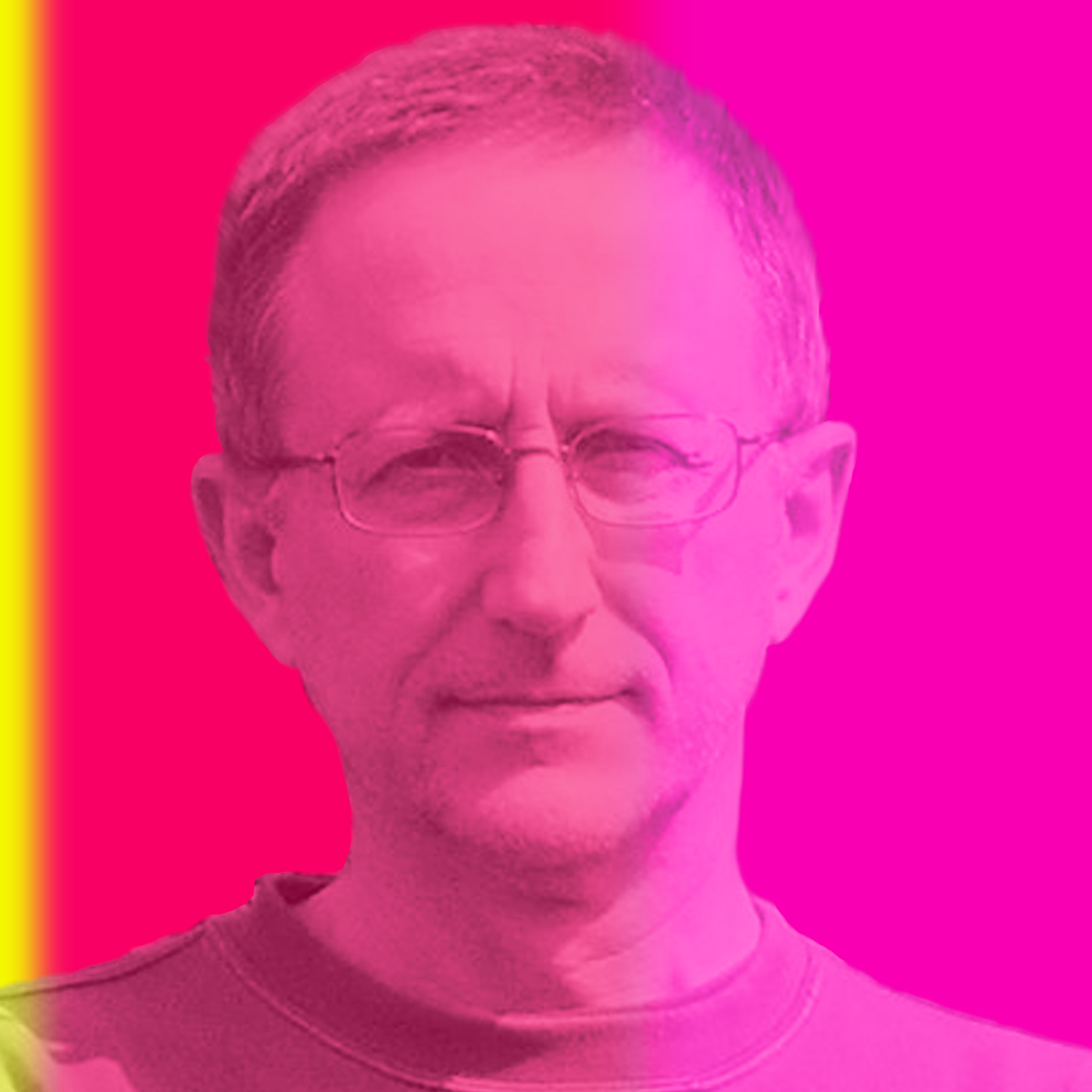







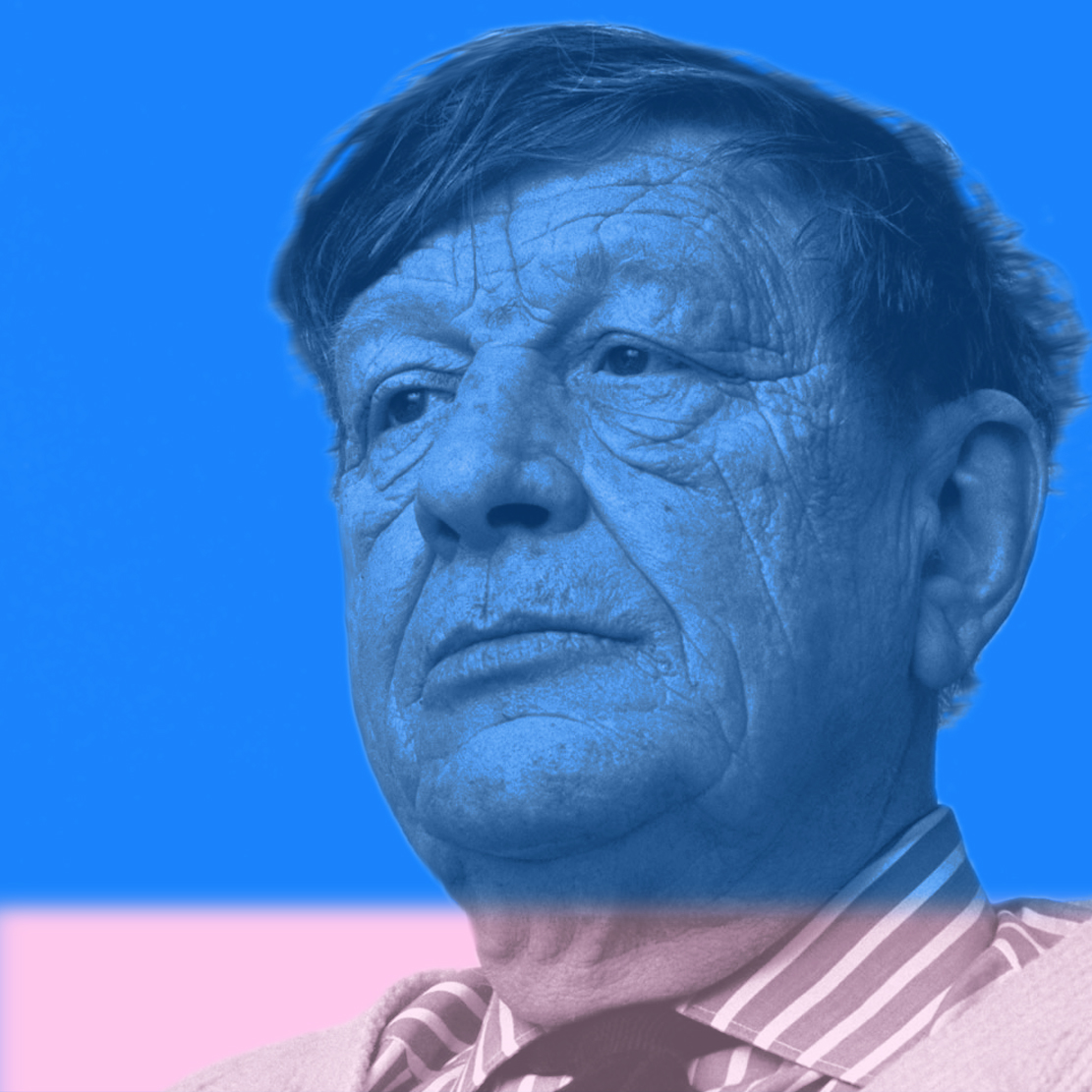





















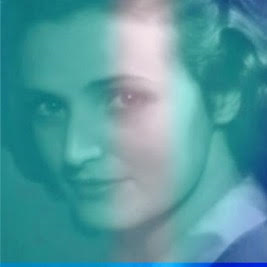































La Poesia Polittico di Mario M. Gabriele, Francesco Paolo Intini, Mario Sgalambro, Commenti di Lucio Mayoor Tosi, Giorgio Linguaglossa, Gino Rago, Massimo Donà, Friedrich-Wilhelm von Herrmann
Mi perdoni, Signora Swanson!
Non volevo toglierle il clip dalla memoria
Mario M. Gabriele
20 giugno 2019 alle 15:27
(in corso di pubblicazione con Progetto Cultura di Roma)
1 (Polittici)
Mi perdoni, Signora Swanson!
Non volevo toglierle il clip dalla memoria.
Alle cinque Lola vola via.
Watson la segue con l’ombrello di Mary Poppins.
Il cielo questa mattina era così triste
da lasciare acqua -fontana nei giardini.
E’ stato un lavoro delicato,da peritropé,
con aghi e fil rouge.
Pound ha provato a rimettere le scarpine.
Non credo voglia fare jogging.
Si inasprisce l’aria di mele guaste.
Gli occhi della Signora Rowinda non incantano più.
Le distanze non sono mai parallele
neanche a leggere Postkarten.
Con la tua mente puoi andare oltre il buco nero
a sintetizzare l’universo con un Haiku.
Non regalarmi Gilet.
Se ci riesci, portami le ossa di Rimbaud!
Oh, Mon Dieu! Quanti Woodoo e streghette
tolgono il profumo ai fiori di Bach!
Ci pensavo da due giorni. Questa sera vado da Ilena
e le dico di considerare la sera come il mattino.
-Abbiamo una squadra sul Calvario-, disse il Governatore.
-Basteranno due o tre chiodi per muovere il cielo!-
L’autopsia dirà chi ha ucciso la giovinezza
e in quale Ambasciata si è rifugiato l’assassino.
Ti assomiglia in positivo la gardenia.
Possibile un trasloco nell’anima.
Larry si diverte a disegnare cartoline Christmas.
La roccia non ha muschio per il presepe.
(…)
Abbiamo chiesto strofinacci per il passato.
Il tempo resiste ad ogni attacco.
Il dado si fermò sul rosso.
La memoria è un ammasso di rottami.
Diletta da Rotterdam si fermò un mese
nella Episcopal Church a parlare con gli angeli.
Michael Rottmayr è con Abele a Vienna
nella Osterreichische Galerie.
Nessuno sa quanto tempo resteremo quaggiù!
Hai visto come si sfolla il quartiere?
Il decano di Amburgo ha letto le terzine di Frost
per la conoscenza della notte.
Dormi se vuoi, così ti abitui alla morte.
Adam tornò a rivedere la barista di Fellini.
-Cara Denise, sono Duchamp e mi piacerebbe
sostare con te nel soggiorno-.
Si scivola nel metrò.
Anche Malone muore, azzerati i mitocondri.
Oh, guarda qui, Mariette! Ci sono ancora le t-shirts del 68
e una retrospettiva canora di Bessie Smith!
Le croisette de Paris nei galà dello chateau
scambiavano l’omelette per il sushi!
Chi lasciò la parola si avvicinò al Verbo
chiedendone una nuova.
Madame O’Brian mi fa compagnia la notte
in quel dolce paese che non dico.
Milena scrive da Harvard:
-neanche qui abbiamo trovato Nonna Eliodora-.
Caro Signor Bernard, spero di essere stato chiaro.
La sirenetta di Copenaghen è una donna di incontri e reviews.
(…)
Che sappiamo del Galateo in bosco?
Poesia. Zona keep out!
A Frankfurt am Main ci siamo fermati
a comprare le affinità elettive nello Skyline.
E’ destino che non ci si incontri mai.
Eppure oggi c’è il cambio di stagione!
Abbiamo trovato serpenti nel giardino.
Lucy mi volle con sé a cercare l’erba sotto la pietra.
La stanza accumula fumi, appanna lampade e vetri.
I miei morti sono quelli che non ricordo.
Miss Olson non è più tornata tra noi.
Le abbiamo mandato una chiave. Lei sa come aprire la porta.
Chi apprezzò la sera amò anche il giorno.
Il lupo è sotto le mura. Attenta, Signorina Rosemary!
Magda von Hattingherg scrisse a Rilke:
-Caro Amico, ho scoperto la Storia del buon Dio-.
-Mister Gruman- disse un bodyguard,- la folla è alle porte!-.
E Gelinda dal balcone che gridava:- dillo a me il tuo peccato-.
Mario M. Gabriele
16 giugno 2019
Caro Giorgio,
i miei testi poetici sono come lampada a raggi fotonici, indirizzati verso chi si porta addosso il -male di vivere- e la tua critica lo rivela tutte le volte che leggi una mia poesia.
Non so scrivere altro, come divagazione estemporanea e pittorica, e quant’altro. Mi rifaccio sempre ad una decostruzione gnoseologica, di cui ogni elemento si lega autonomamente ad un discorso ontologico di orientamento heideggeriano, ma pullulante di lessemi che la società tecnologica ci ha abituati da tempo.
Ecco il motivo per cui mi avvicino al tuo brillante esame critico, quando scrivi che la mia poesia è costruita lessicamente ”alla stregua delle circolari della Agenzia delle Entrate o delle Direttive della Unione Europea”, ovviamente non per minimizzare l’assunto estetico, ma per mirare ad un modello poetico di contrapposizione contro l’edilizia linguistica che ancora oggi pervade il grande Distributore Automatico della Tradizione.
Mi sto accorgendo solo ora, che con Ritratto di Signora, (2015), L’Erba di Stonehenge (2016), La porte ètroite (2013), In viaggio con Godot (2018), e tra poco con Registro di bordo, abbia unificato un linguaggio pluriconverso, unitario e positivista,
In linguistica il concetto di struttura si è sempre diversificato da quello precedente, realizzando classificazioni diverse, sia diacroniche che sincroniche. Da Saussurre bisogna apprendere molto degli insegnamenti di questo maestro che intuì come la lingua è una forma non una sostanza dove si distinguono l’espressione, ossia quella dei significanti, e il piano del contenuto, quello dei significati.
Certamente un autore non si giudica soltanto per un post poetico apparso su Riviste e in un reading. Qui, vorrei citare Charles Mauron che volle identificare la personalità inconscia dell’Autore a partire dall’analisi dei suoi scritti.
Attraverso la sedimentazione di più testi vengono fuori fili di associazione nel rapporto tra le immagini e le multiforme figure grammaticali, (metafore, ipotiposi, ecc.) il cui richiamo consente di giungere alla ”Personalità dell’autore”, quell’ombra che ad ogni istante si stacca dal fondo del subconscio per salire in superficie.
Quanto alla moltitudine di frasari, citazioni, varia toponomastica e oggettistica anglosassone, tutte queste cose non fanno parte che di un continuo aggrovigliarsi di plurisensi, dove l’inconscio si permette qualunque mescolanza o slittamento da un significato all’altro. Per meglio coordinare quanto esposto, una eventuale trascrizione dei miei 3 polittici, farebbero da guida al lettore, a meno che tu non abbia altri progetti di connessione. Cordialmente, Mario.
Giorgio Linguaglossa
21 giugno 2019 alle 11:58
caro Mario,
è che il tuo lessico così sistemato dentro la camicia di forza del distico brilla proprio per la propria inadeguatezza ontologica a dire qualcosa che non sia meramente pleonastico e felicemente virtuale, ormai i linguaggi della nostra mondità si rivelano per quello che sono: una superficie di gelatine linguistiche dove convivono senza collidere le superfici riflettenti dell’esserci costretto alla afasia disorganizzata qual è divenuto il nostro mondo. Il tuo è il più rigoroso e compiuto linguaggio della mondità telematica, della metafisica meta stabile, del positivo significare, che è un significare disseminato e moltiplicato dalla insensatezza cui ormai sono relegati i linguaggi della mondità telematica.
A proposito del linguaggio della tua poesia, mi viene in mente quanto asserisce Giorgio Agamben quando ci parla del linguaggio poetico di oggi che non può che essere, a suo avviso, che un linguaggio «musaicamente non accordato», un linguaggio disseminato di interruzioni, di lapsus, di deviazioni, di referti di decessi di significati già avvenuti; un linguaggio fatto per le comunicazioni di breve gittata, un linguaggio di ponti interrotti e di segmenti non significativi. Con questo linguaggio non sarà più possibile mettere in piedi un qualsiasi linguaggio poetico significativo dal senso compiuto come è avvenuto per la poesia della «nobile» tradizione, non sarà possibile comunicare alcunché di comunicabile in assoluto. Ecco le ragione per cui il «polittico» è la sola casa dell’essere linguistico, la sola casa oggi possibile e abitabile, e dovremo accostumarci all’idea di dover dimorare sotto i cornicioni pericolanti di questo edificio malmesso e terremotato. Non abbiamo altra scelta che dimorare in questa mondità infirmata.
L’oblio della memoria, che tanta parte della nuova poesia occupa, è l’altro modo con cui si rende manifesto l’oblio della verità, il velamento con il quale la verità viene esposta nel linguaggio come sua custodia, una esposizione che sa di intemperie e di precarietà. Continua a leggere →
Condividi:Twitter
10 commenti
Archiviato in critica dell'estetica, critica della poesia, nuova ontologia estetica, Senza categoria
Con tag Commenti di Lucio Mayoor Tosi, Distico, Emanuele Severino, Francesco Paolo Intini, Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Gino Rago, Giorgio Agamben, giorgio linguaglossa, Heidegger, L'oblio della memoria, La Poesia Polittico di Mario Gabriele, l’oblio della verità, Mario Gabriele, mario sgalambro, Massimo Donà