Paul Valéry (Sète, 30 ottobre 1871 – Parigi, 20 luglio 1945) è un poeta chiave per comprendere la poesia europea del Novecento; finalmente abbiamo qui riunite in un unico volume le opere poetiche del poeta francese insieme alle più importanti riflessioni sull’arte poetica e sulla Poetica. Valéry è il primo poeta europeo che crea una teoria del linguaggio e una teoria della composizione poetica, per lui il linguaggio è la fonte della metafisica come illusione intellettuale e la zona di massima dispersione e confusione intellettuale e linguistica. È caratteristico di Valéry che lui pervenga alla poesia da una teoria critica della poesia, da una via fino allora considerata impensabile. È un poeta e un teorico della poesia allo stesso tempo di straordinaria importanza.
«Tutta la mia filosofia – scrive Valéry – si riduce ad accrescere quella precisione o coscienza di sé che ha per effetto di separare nettamente le domande dalle risposte […] Bisogna imparare a pensare che ciò che è non è necessariamente una domanda. E che non ogni domanda ha necessariamente un senso». Valéry pensa che il linguaggio sia il luogo stesso della confusione. Di qui quella sua forsennata ricerca di una poesia che fosse applicazione di una geometria assoluta, di un rigore quasi matematico. Il superamento del linguaggio naturale in Valéry non può essere compiuto grazie a un linguaggio ideale ma grazie alla vita, che pone dei problemi reali per dei bisogni reali e grazie all’azione.
 Scrive Valéry: «Si potrebbe – e forse lo si dovrebbe – assegnare come unico oggetto alla filosofia quello di porre e di precisare i problemi, senza preoccuparsi di risolverli. Si tratterebbe allora di una scienza degli enunciati, e dunque di una purificazione delle domande». «Una riflessione semplicissima ci fa pensare che la Letteratura è e non può essere altro che una specie di estensione e di applicazione di certe proprietà del linguaggio. Essa utilizza per esempio ai propri fini le proprietà foniche e le possibilità ritmiche del parlare, che sono trascurate nel discorso comune […] È questo il mondo delle “figure”, di cui si preoccupava l’antica Retorica […] La formazione delle figure è indivisibile da quella dello stesso linguaggio, in cui tutte le parole “astratte” sono ottenute tramite qualche dilatazione d’uso o trasferimento di significato, seguito da un oblio del senso primiero. Il poeta che moltiplica le figure non fa dunque che ritrovare in se stesso il linguaggio allo stato nascente […] La Poetica si proporrebbe non tanto di risolvere i problemi quanto di enunciarli. Il suo insegnamento non sarebbe separato dalla ricerca stessa… dovrebbe essere trattato e mantenuto in uno spirito di massima generalità… quest’ultima considerazione conduce… a un’importante distinzione: quella delle opere che sono come create dal loro pubblico (di cui rispondono all’attesa e sono perciò quasi determinate dalla sua conoscenza) e delle opere che, invece, tendono a creare il loro pubblico». (qui pp. 380-381)
Scrive Valéry: «Si potrebbe – e forse lo si dovrebbe – assegnare come unico oggetto alla filosofia quello di porre e di precisare i problemi, senza preoccuparsi di risolverli. Si tratterebbe allora di una scienza degli enunciati, e dunque di una purificazione delle domande». «Una riflessione semplicissima ci fa pensare che la Letteratura è e non può essere altro che una specie di estensione e di applicazione di certe proprietà del linguaggio. Essa utilizza per esempio ai propri fini le proprietà foniche e le possibilità ritmiche del parlare, che sono trascurate nel discorso comune […] È questo il mondo delle “figure”, di cui si preoccupava l’antica Retorica […] La formazione delle figure è indivisibile da quella dello stesso linguaggio, in cui tutte le parole “astratte” sono ottenute tramite qualche dilatazione d’uso o trasferimento di significato, seguito da un oblio del senso primiero. Il poeta che moltiplica le figure non fa dunque che ritrovare in se stesso il linguaggio allo stato nascente […] La Poetica si proporrebbe non tanto di risolvere i problemi quanto di enunciarli. Il suo insegnamento non sarebbe separato dalla ricerca stessa… dovrebbe essere trattato e mantenuto in uno spirito di massima generalità… quest’ultima considerazione conduce… a un’importante distinzione: quella delle opere che sono come create dal loro pubblico (di cui rispondono all’attesa e sono perciò quasi determinate dalla sua conoscenza) e delle opere che, invece, tendono a creare il loro pubblico». (qui pp. 380-381)
 «Una poesia su un foglio di carta non è che uno scritto, sottoposto a tutto quel che si può fare di uno scritto. Ma fra le sue varie possibilità, ce n’è una, e una soltanto, che pone infine quel testo nelle condizioni in cui prenderà forza e forma d’azione. Una poesia è un discorso che esige e che provoca un legame continuo fra la voce che è e la voce che viene e che deve venire. E questa voce deve essere tale da imporsi, e da stimolare lo stato emotivo di cui il testo sia l’unica espressione verbale. Togliete la voce, e la voce che occorre, e tutto diventa arbitrario. La poesia diviene una serie di segni legati l’uno all’altro solo dal fatto di essere stati materialmente tracciati uno dopo l’altro. (qui p. 394) «Anche nella testa più solida la contraddizione è la norma; la consequenzialità è l’eccezione […] Ma ecco una circostanza stupefacente: tale dispersione, sempre imminente, importa e concorre alla produzione dell’opera quasi quanto la stessa concentrazione». (qui 396) «L’opera d’arte è un’opera in sé inutile, in rapporto al senso preciso di utilità: è una categoria completamente a parte». (qui p. 416) «Una poesia deve essere una festa dell’intelletto».
«Una poesia su un foglio di carta non è che uno scritto, sottoposto a tutto quel che si può fare di uno scritto. Ma fra le sue varie possibilità, ce n’è una, e una soltanto, che pone infine quel testo nelle condizioni in cui prenderà forza e forma d’azione. Una poesia è un discorso che esige e che provoca un legame continuo fra la voce che è e la voce che viene e che deve venire. E questa voce deve essere tale da imporsi, e da stimolare lo stato emotivo di cui il testo sia l’unica espressione verbale. Togliete la voce, e la voce che occorre, e tutto diventa arbitrario. La poesia diviene una serie di segni legati l’uno all’altro solo dal fatto di essere stati materialmente tracciati uno dopo l’altro. (qui p. 394) «Anche nella testa più solida la contraddizione è la norma; la consequenzialità è l’eccezione […] Ma ecco una circostanza stupefacente: tale dispersione, sempre imminente, importa e concorre alla produzione dell’opera quasi quanto la stessa concentrazione». (qui 396) «L’opera d’arte è un’opera in sé inutile, in rapporto al senso preciso di utilità: è una categoria completamente a parte». (qui p. 416) «Una poesia deve essere una festa dell’intelletto».
Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1892, a Genova, cade in quella che in seguito avrebbe indicato come una profonda crisi esistenziale intellettuale. Al mattino decide di ripudiare gli idoli dell’estetica simbolista tutta volta alla ricerca di una sopra-realtà e si concentra su una concezione tutta razionale dell’arte quale mezzo di conoscenza e di auto-costruzione; l’opera sarà un espediente per l’affinamento delle doti spirituali e intellettuali, un «esercizio spirituale», una «ginnastica», una «danza», un «fare», una «scherma», un «gioco di scacchi», una «strategia». La via dello spirito è una via anagogica, ce lo testimoniano i suoi cahiers, (diari) nei quali annota ogni mattino le sue riflessioni. Aggiunge, come battuta di spirito, «avendo consacrato queste ore alla via dello spirito, mi sento in diritto di essere sciocco per il resto del giorno». «Ogni poema che non avesse la precisione esatta della prosa non ha nessun valore» dichiara Valéry, oppure, segue le orme di Malherbe il quale aveva detto che «un buon poeta non è più utile al suo paese di quanto non sia un buon giocatore di bocce».
 Nel 1894, si trasferisce a Parigi, dove lavora come redattore al ministero della guerra. Rimane volontariamente lontano dalla scrittura poetica per consacrarsi alla conoscenza di sé e del mondo. Segretario personale di Edouard Lebey, amministratore della Havas, la prima agenzia di stampa, si dedica ogni mattino, dalle quattro alle sette, alla redazione dei suoi Cahiers, diari intellettuali, che vedranno la parziale pubblicazione solo dopo la sua scomparsa. Nel 1917, sotto l’influenza principalmente di André Gide, ritorna alla poesia, con La Jeune Parque, pubblicato presso Gallimard. In piena epoca di avanguardie e di libertà formale, Valéry ritorna all’alessandrino di Racine, a un modello formale seicentesco riproposto con due secoli di ritardo; sembra una provocazione, un lavoro a ritroso, e invece è subito un successo; il poema non è altro che «una fabbricazione artificiale che ha preso una sorta di sviluppo naturale» scriverà in seguito Valéry. Seguono Le Cimetière marin (1920) e una raccolta, Charmes (1922). Valéry non finisce mai di stupire, a proposito dei poeti simbolisti, durante una conferenza nega l’esistenza dei poeti simbolisti in quanto alla loro epoca nessuno di essi sapeva di essere dei simbolisti. Scrive:
Nel 1894, si trasferisce a Parigi, dove lavora come redattore al ministero della guerra. Rimane volontariamente lontano dalla scrittura poetica per consacrarsi alla conoscenza di sé e del mondo. Segretario personale di Edouard Lebey, amministratore della Havas, la prima agenzia di stampa, si dedica ogni mattino, dalle quattro alle sette, alla redazione dei suoi Cahiers, diari intellettuali, che vedranno la parziale pubblicazione solo dopo la sua scomparsa. Nel 1917, sotto l’influenza principalmente di André Gide, ritorna alla poesia, con La Jeune Parque, pubblicato presso Gallimard. In piena epoca di avanguardie e di libertà formale, Valéry ritorna all’alessandrino di Racine, a un modello formale seicentesco riproposto con due secoli di ritardo; sembra una provocazione, un lavoro a ritroso, e invece è subito un successo; il poema non è altro che «una fabbricazione artificiale che ha preso una sorta di sviluppo naturale» scriverà in seguito Valéry. Seguono Le Cimetière marin (1920) e una raccolta, Charmes (1922). Valéry non finisce mai di stupire, a proposito dei poeti simbolisti, durante una conferenza nega l’esistenza dei poeti simbolisti in quanto alla loro epoca nessuno di essi sapeva di essere dei simbolisti. Scrive:
«Quanto a loro, i nostri simbolisti dell’86 [concordi in una comune risoluzione di rinuncia al suffragio della massa], senza appoggi nella stampa, senza editori, senza approdi […], si adattano a questa vita fuori norma; si fanno le loro riviste, le loro edizioni, la loro critica interna; e si formano a poco a poco quel piccolo pubblico di loro scelta […]. Operano così una sorta di rivoluzione nell’ordine dei valori, poiché sostituiscono progressivamente alla nozione di opere che sollecitano il pubblico, che lo prendono per il suo lato debole o abitudinario, quella di opere che creano il loro pubblico». (pp. 1109-10) Scrive ancora Valéry: «I miei versi hanno il senso che si dà loro […] È un errore che va contro la natura della poesia potrebbe esserle fatale pretendere che a ogni poesia corrisponda un significato autentico, unico, conforme o identico a un pensiero dell’autore» (pp. 1298-9).
Scrive nella prefazione la Giaveri: «diversamente dalle opere giovanili (a cui d’altra parte rivendicava un senso preciso), le poesie della raccolta non vivono di un gioco metaforico costruito a posteriori, tramite la mediazione letteraria, ma di una analogia originaria fra due stati psicofisici che si strutturano secondo le stesse leggi e permettono le stesse varianti» (p. XXXIII). Diventa il “poeta ufficiale” di Francia ma resta schivo ed estraneo ai riconoscimenti e agli onori. Nel 1924, viene eletto presidente del Pen Club francese e componente dell’Académie Francaise. Seguono anni di riconoscimenti e di onori e la cattedra (quella di poetico al Collège de France).
Ma durante tutto questo tempo, la sua vera professione continua nell’ombra: la profondità delle riflessioni che dà alle stampe in opere consistenti (Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, La soirée avec monsieur Teste), i suoi studi sul divenire della civiltà (Regards sur le monde actuel) e la sua viva curiosità intellettuale ne fanno un interlocutore ideale per Raymond Poincaré, Louis de Broglie, Henry Bergson e Albert Einstein. Sotto l’occupazione nazista, si rifiuta di collaborare e perde il suo posto d’amministratore a Nizza. Muore il 20 luglio 1945, poche settimane dopo la fine della seconda guerra mondiale. Charles de Gaulle richiede per lui i funerali di Stato e viene sepolto a Sète, nel cimitero marino che aveva già celebrato nel suo famoso poema.
(Giorgio Linguaglossa)
 Ecco come il critico André Durand presenta La jeune Parque (1917):
Ecco come il critico André Durand presenta La jeune Parque (1917):
Depuis 1892, Valéry n’avait publié qu’un très petit nombre de poèmes d’une esthétique fort différente des compositions antérieures, en particulier pour la nature et le fonctionnement des métaphores. Vers le milieu de 1912, sur l’insistance d’André Gide et de Gaston Gallimard, il accepta d’éditer l’ensemble de ses œuvres de jeunesse, vers et prose. Mais, ne sachant comment transformer ces vers anciens qui lui paraissaient étrangers, il entreprit un poème d’une quarantaine de vers, qui serait un adieu à la poésie.
Dans sa dédicace à André Gide, il déclara : «Depuis des années, j’avais laissé l’art des vers ; essayant de m’y astreindre encore, j’ai fait cet exercice que je te dédie.» Et il précisa ses intentions : «Lorsque j’ai voulu me remettre à la poésie, j’ai voulu faire œuvre de volonté, combiner dans une oeuvre, tout d’abord les idées que je m’étais faites sur l’être vivant et le fonctionnement même de son être en tant qu’il pense et qu’il sent ; ensuite…, ne pas verser dans l’abstraction, mais au contraire incarner dans une langue aussi imagée que possible, et aussi musicale que possible, le personnage fictif que je créais.» Nulle contrainte n’était plus précieuse à cet athlète mental que celle de la versification traditionnelle, de la prosodie la plus rigoureuse. Il voulait que le poème en vers soit le chant continu d’une voix portée par un «je» et dont l’efficacité poétique tienne aux ressources souplement modulées d’une matière verbale où la musique du sens est étroitement nouée à la musique du son. Son projet n’était pas de dire quoi que ce soit mais chercher à faire, c’est-à-dire à rigoureusement composer un poème dont le sens ne se dégagerait que plus tardivement.
Si, après un long silence, il était revenu à la poésie, il n’en avait pas, pour autant, abandonné ses idées centrales. Leur restant fidèle ou ne parvenant pas à s’en détacher, les jugeant essentielles, il voulait traiter, dans un poème aussi, le thème de la passion de l’intellect ou, mais c’est la même chose, de la connaissance et de la conscience. Il voulut d’abord l’intituler “Psyché” (l’âme) et a d’ailleurs défini son objectif de la manière la plus claire : «Songez que le sujet véritable du poème est la peinture d’une suite de substitutions psychologiques et en somme le changement d’une conscience pendant la durée d’une nuit.» Il voulut montrer l’opposition entre deux états et le passage de l’un à l’autre : du non-être de la conscience à l’existence de la conscience, cette prise de conscience de la conscience étant le motif central de toute sa réflexion.
La difficulté était donc quasi insurmontable : unir la matière abstraite la plus éloignée de toute forme poétique à la forme poétique la plus éloignée de l’abstraction. Au surplus, il était obligé de compter avec les exigences propres à la poésie, sachant qu’elle ne concède rien et qu’elle veut rester rythme, image, chant. Il a donc tenté de tenir cette gageure : rendre l’abstrait voluptueux sans qu’il perde rien de son austérité et créer une plasticité sans qu’elle perde rien de son rayonnement sensoriel. Puisque l’étude du mécanisme de l’intelligence, surpris dans le moment propice de l’élaboration ou de l’invention, restait sa curiosité profonde, il a corrigé la sécheresse d’un tel dessein et il en a vécu l’émotion.
Par une sorte de miracle, l’objet même qui devait l’obliger à l’usage de la prose et au vocabulaire technique l’a conduit à une prosodie rigoureuse, une syntaxe audacieuse et puriste, un choix de mots rares, des images, des symboles, des métamorphoses, une langue sensuelle, chatoyante et précieuse, si harmonieuse et si pleine que sa beauté paraît se séparer de son sens et autorisa, en son temps, l’extravagante erreur de tenir ses poèmes pour de la poésie pure, soit sans signification.
Cette tentative apparut d’abord à travers un brouillon intitulé ‘’Hélène’’. Ainsi, la mythologie grecque ajoutait aux différentes significations du poème des effets complexes de résonance. Hélène sortait de la grotte de la Nuit et voulait exister par elle-même et non par le désir des autres («Suis-je quelque chose Moi qui ne me vois que dans le vertige des autres. Et qu’y suis-je?»), explorer les mystères de son être «en tant qu’il pense et qu’il sent». Mais, se regardant dans un miroir, elle se voyait séparée de ce reflet par des larmes, qui provoquaient aussitôt la question : «Si je me vois au miroir, des larmes me viennent, d’où?»). Puis elle se posait des questions sur un lieu inconnu, sur une identité autre et mystérieuse : «Mais qui pleure / seule et de diamants séparés?» Questions inachevables qui s’articulaient déjà sur un décor «élémental» : Astres, Nuit, Distance, Larmes, Regard, et cette objet indispensable à tout questionnement chez Valéry : le Miroir. Mais, en quarante vers, c’était trop. D’autant plus que l’écriture fit surgir en s’accomplissant les problèmes du «système» auquel il ne cessait de travailler : les substitutions, l’acte de conscience et la mémoire, les déplacements et les condensations du Moi par la pratique du langage, le fonctionnement des figures, la production de l’imaginaire par les structures formelles, etc.
Gardant la préoccupation du double manque, le manque qui cause les larmes, le manque qui fait de cette autre d’Hélène dans Hélène un être sans nom, il envisagea donc une œuvre plus ample, qu’il appelait d’ailleurs «mon opéra», dans laquelle il voulut donner à la poésie les valeurs des récitatifs des drames lyriques (« Glück et Wagner m’étaient des modèles secrets» (lettre à Aimé Lafont, septembre 1922), pour laquelle différents titres furent ébauchés à mesure pour aimanter diversement le travail : ‘’Pandora’’, ‘’Vers anciens’’, ‘’Ébauche’’, ‘’Étude ancienne’’, ‘’Discours’’, ‘’La seule Parque’’, ‘’L’aurore’’, puis ‘’Psyché’’ qui fut proposé par Pierre Louÿs, ‘’Île’’, enfin ‘’La jeune Parque’’ en 1916. Le poète a choisi de faire parler une Parque, non une des trois Parques qui, chez les Anciens, étaient les divinités du Destin, symbolisaient les étapes de la destinée humaine, la troisième coupant le fil de la vie ; mais une Parque qui est une mortelle et qui, surtout, est jeune, se trouvant à l’âge où l’individu doit définir son identité, voit naître «la conscience de soi-même», rencontre les divers problèmes de «la conscience consciente».
La composition dura plus de quatre ans. Le poème se développa par fragments remis vingt fois sur le métier : il y eut plus parfois plus de trente états successifs. Une note d’un ‘’Cahier’’ de 1917, intitulée «Comment j’ai fait la J.P.», précisa la chronologie du travail :
– 1912 : Genèse
– 1913 : Serpent
– 1914
– 1915 : «Harmonieuse Moi», Sommeil
– 1916 : Îles
– 1917.
 Il commenta : «D’écart en écart, cela s’est enflé aux dimensions définitives». Pour ces 512 vers, il avait rédigé plus de cent brouillons dont la reproduction occuperait 600 pages ! La pression de la guerre accompagna l’invention du poème. Il avait fini par considérer comme un devoir de léguer à notre langue menacée cet ouvrage «fait de ses mots les plus purs et de ses formes les plus nobles». – «Je ne me l’explique à moi-même, je ne puis concevoir que je l‘ai fait, qu‘en fonction de la guerre. Je l’ai fait dans l’anxiété et à demi contre elle. J’avais fini par me suggérer que j’accomplissais un devoir; que je rendais un culte à quelque chose en perdition. Je m’assimilais à ces moines du premier Moyen Âge qui écoutaient le monde civilisé autout de leur cloître crouler, qui ne croyaient plus qu’en la fin du monde ; et toutefois qui écrivaient difficilement, en hexamètres durs et ténébreux, d’immenses poèmes pour personne […] Il n’y avait aucune sérénité en moi.» (lettre à Georges Duhamel, 1929). Mais les bruits de la guerre n’étaient peut-être pas nécessaires car il avoua : «angoisse, mon vrai métier».
Il commenta : «D’écart en écart, cela s’est enflé aux dimensions définitives». Pour ces 512 vers, il avait rédigé plus de cent brouillons dont la reproduction occuperait 600 pages ! La pression de la guerre accompagna l’invention du poème. Il avait fini par considérer comme un devoir de léguer à notre langue menacée cet ouvrage «fait de ses mots les plus purs et de ses formes les plus nobles». – «Je ne me l’explique à moi-même, je ne puis concevoir que je l‘ai fait, qu‘en fonction de la guerre. Je l’ai fait dans l’anxiété et à demi contre elle. J’avais fini par me suggérer que j’accomplissais un devoir; que je rendais un culte à quelque chose en perdition. Je m’assimilais à ces moines du premier Moyen Âge qui écoutaient le monde civilisé autout de leur cloître crouler, qui ne croyaient plus qu’en la fin du monde ; et toutefois qui écrivaient difficilement, en hexamètres durs et ténébreux, d’immenses poèmes pour personne […] Il n’y avait aucune sérénité en moi.» (lettre à Georges Duhamel, 1929). Mais les bruits de la guerre n’étaient peut-être pas nécessaires car il avoua : «angoisse, mon vrai métier».
Dans une lettre à Aimé Lafont (septembre 1922), il a ainsi défini son poème : «C’est une rêverie qui peut avoir toutes les ruptures, les reprises et les surprises d’une rêverie dont le personnage en même temps que l’objet est la conscience consciente. Figurez-vous que l’on s’éveille au milieu de la nuit, et que toute la vie se revive, et se reparle à soi-même […] Sensualité, souvenirs, paysages, émotions, sentiment de son corps, profondeur de la mémoire et lumière ou cieux antérieurs revus, etc.. Cette trame qui n’a ni commencement ni fin, mais des nœuds, j’en ai fait un monologue auquel j’avais imposé avant de l’entreprendre des conditions de ‘’forme’’ aussi sévères que je laissais au fond de liberté. Je voulais faire des vers non seulement réguliers mais césurés, sans enjambement, sans rimes faibles.»
Dans une lettre à A. Mockel (1917), il précisa le but qu’il s’était donné : «Faire un chant prolongé, sans action, rien que l’incohérence interne aux confins du sommeil ; y mettre autant d’intellectualité que j’ai pu le faire et que la poésie en peut admettre sous ses voiles ; sauver l’abstraction prochaine par la musique, ou la racheter par des visions, voilà ce que j’ai fini par me résoudre à essayer, et je ne l’ai pas toujours trouvé facile […] Il y a de graves lacunes dans l’exposition et la composition, je n’ai pu me tirer de l’affaire qu’en travaillant par morceaux. Cela se sent, et j’en sais trop sur mes défaites !» Son projet était aussi de composer un poème «cent fois plus difficile à lire qu’il n’eût convenu», dont le sens ne se dégagerait que plus tardivement. Cette obscurité résulterait d’abord de la nature du sujet. Il a voulu rassembler dans ce poème un grand nombre d’idées qui l’occupaient depuis longtemps
Ces «morceaux», les divers états du manuscrit font voir qu’ils ne se sont pas toujours succédé dans l’ordre où le texte définitif les présente, le plus important de ces déplacements concernant le dernier épisode. C’est que l’œuvre s’est formée en restant volontairement aveugle à son destin.
Ailleurs encore, on peut lire : «Ce chant est une autobiographie. J’ai supposé une mélodie, essayé d’attacher, de «ritardare», d’enchaîner, de couper, d’intervenir, de conclure, de résoudre, et ceci dans le sens comme dans le son…» (‘’Cahiers’’, VI, 508-509).
Armé de ces renseignements, invité par Valéry lui-même qui disait : «Il ne suffit pas d’expliquer le texte, il faut aussi expliquer la thèse», on peut essayer de déchiffrer ce poème dense et difficile dont l’obscurité ne résulterait pas d’une intention délibérée d’hermétisme (les raccourcis et les ellpises étant exigés par l’harmonie) et qui, grâce à la musique verbale, transpose une idée abstraite et revêche dans un érotisme onduleux, la pureté de l’idée étant atteinte à travers la pureté de la sensation, sans l’intermédiaire du sentiment.
“La jeune Parque” (1917)
Poème de 512 alexandrins
«Le Ciel a-t-il formé cet amas de merveilles
Pour la demeure d’un serpent?»
Pierre Corneille
Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure
Seule avec diamants extrêmes?… Mais qui pleure,
Si proche de moi-même au moment de pleurer?
Cette main, sur mes traits qu’elle rêve effleurer,
Distraitement docile à quelque fin profonde,
Attend de ma faiblesse une larme qui fonde,
Et que de mes destins lentement divisé,
Le plus pur en silence éclaire un cœur brisé.
La houle me murmure une ombre de reproche,
10 Ou retire ici-bas, dans ses gorges de roche,
Comme chose déçue et bue amèrement,
Une rumeur de plainte et de resserrement…
Que fais-tu, hérissée, et cette main glacée,
Et quel frémissement d’une feuille effacée
Persiste parmi vous, îles de mon sein nu?
Je scintille, liée à ce ciel inconnu…
L’immense grappe brille à ma soif de désastres.
Tout-puissants étrangers, inévitables astres
Qui daignez faire luire au lointain temporel
20 Je ne sais quoi de pur et de surnaturel ;
Vous qui dans les mortels plongez jusques aux larmes
Ces souverains éclats, ces invincibles armes,
Et les élancements de votre éternité,
Je suis seule avec vous, tremblante, ayant quitté
Ma couche ; et sur l’écueil mordu par la merveille,
J’interroge mon cœur quelle douleur l’éveille,
Quel crime par moi-même ou sur moi consommé?…
… Ou si le mal me suit d’un songe refermé,
Quand (au velours du souffle envolé l’or des lampes)
30 J’ai de mes bras épais environné mes tempes,
Et longtemps de mon âme attendu les éclairs?
Toute? Mais toute à moi, maîtresse de mes chairs,
Durcissant d’un frisson leur étrange étendue,
Et dans mes doux liens, à mon sang suspendue,
Je me voyais me voir, sinueuse, et dorais
De regards en regards, mes profondes forêts.
J’y suivais un serpent qui venait de me mordre.
Quel repli de désirs, sa traîne !… Quel désordre
De trésors s’arrachant à mon avidité,
40 Et quelle sombre soif de la limpidité ! Continua a leggere










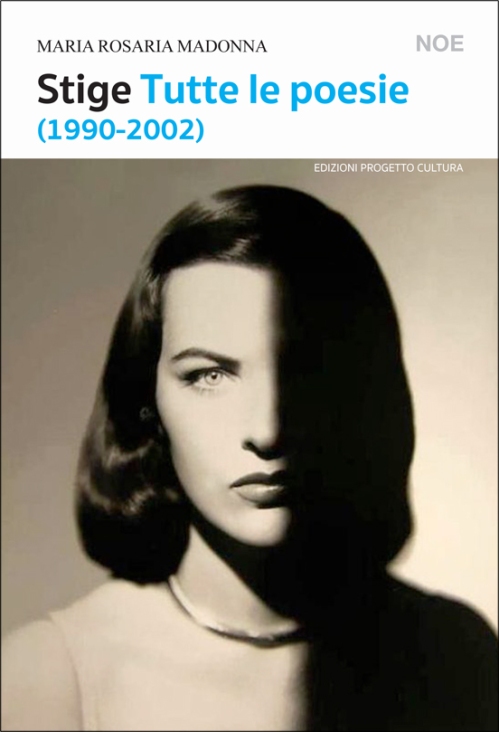









































































































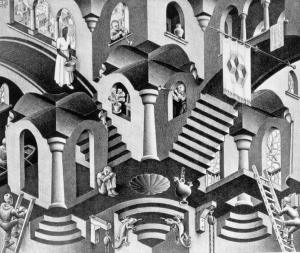









































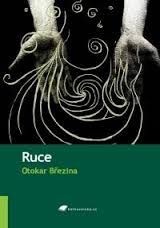






































 Giorgio Linguaglossa
Giorgio Linguaglossa


 Stanza n. 17
Stanza n. 17



































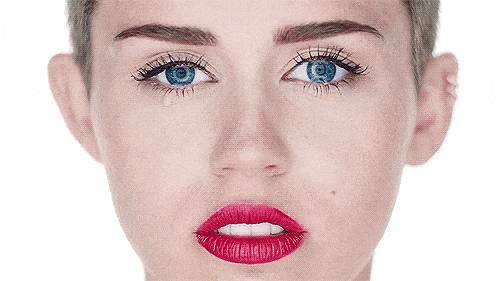
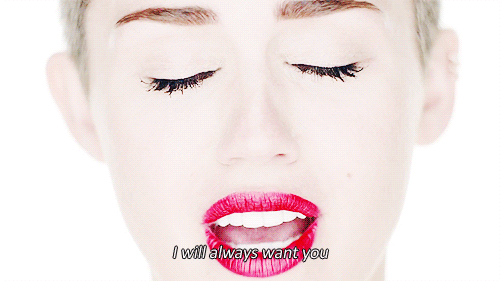


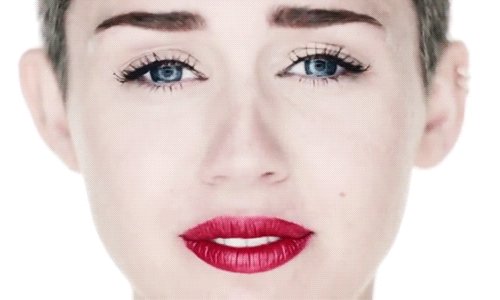








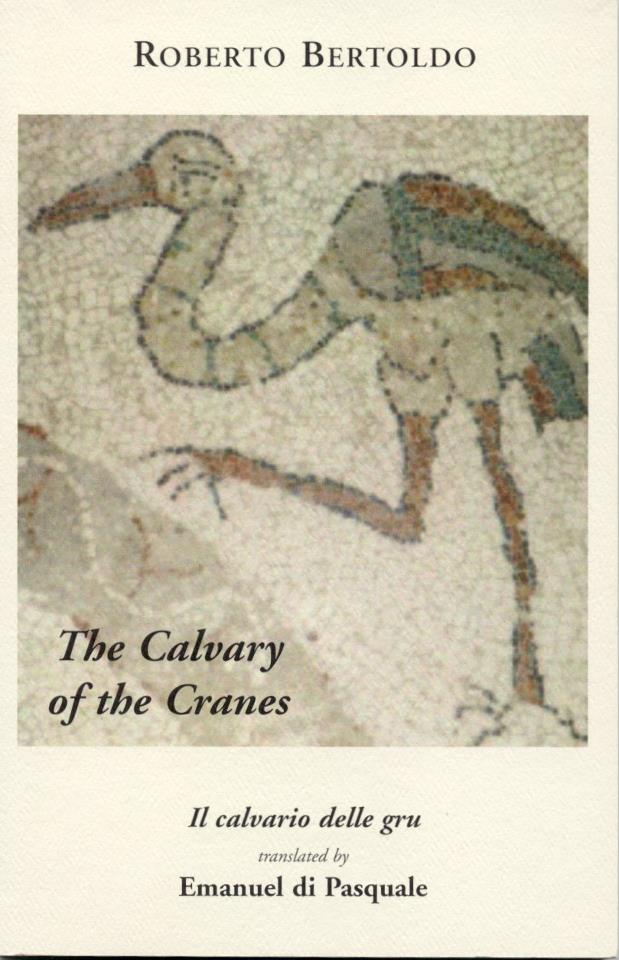
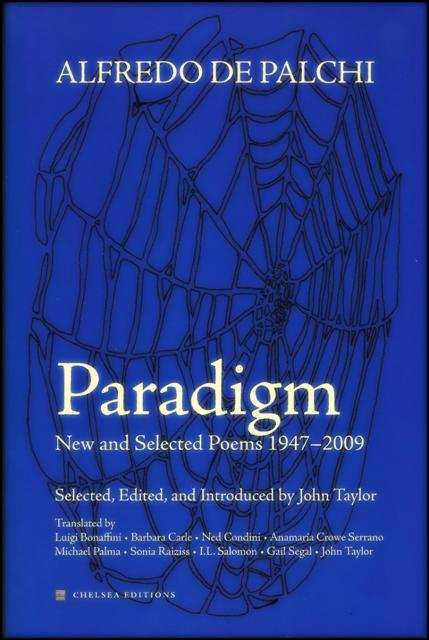


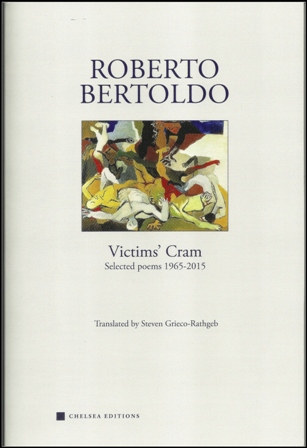





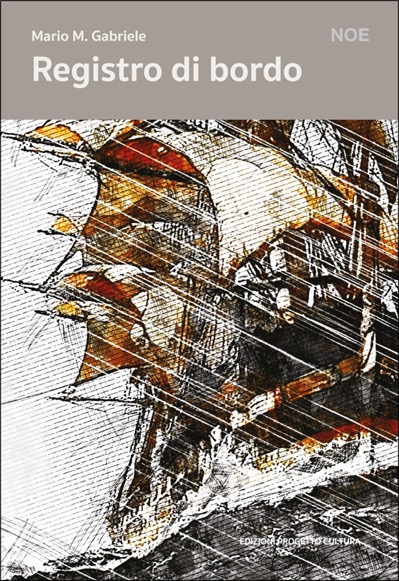

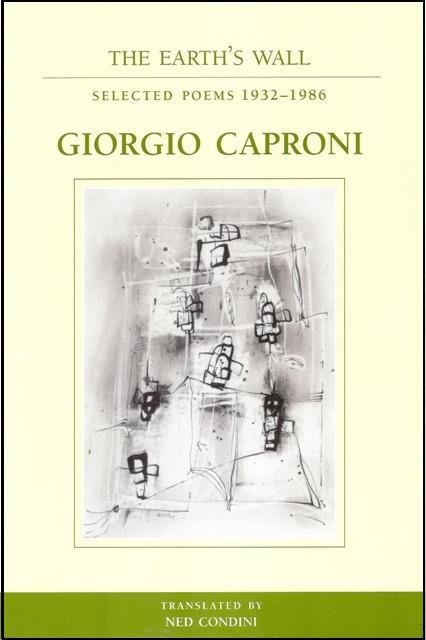
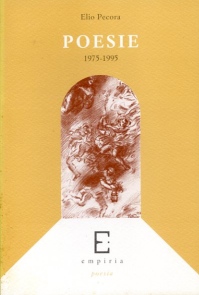

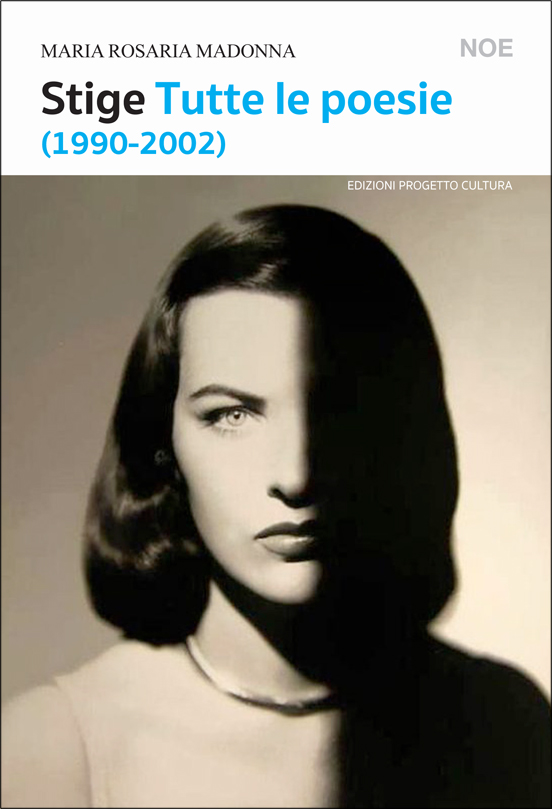

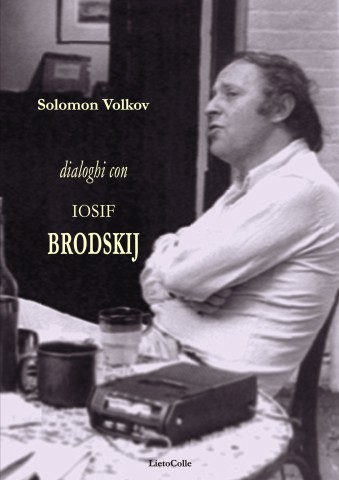




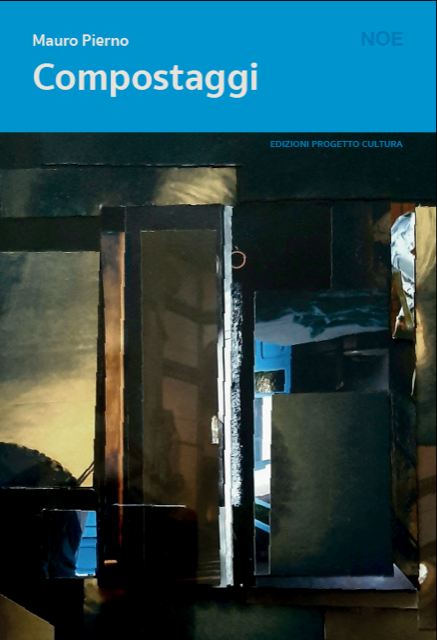




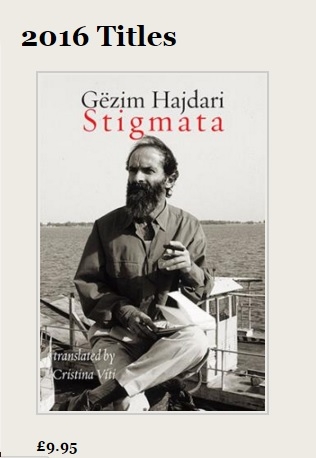






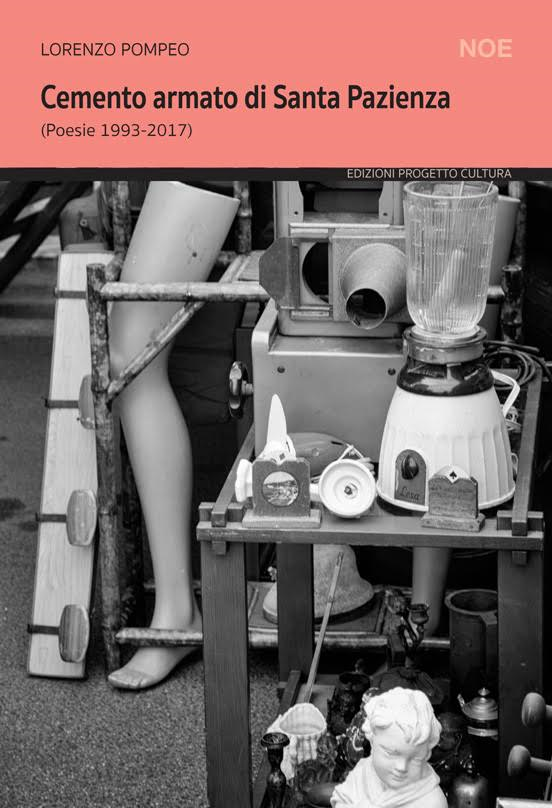







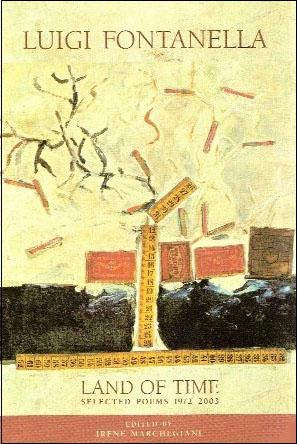








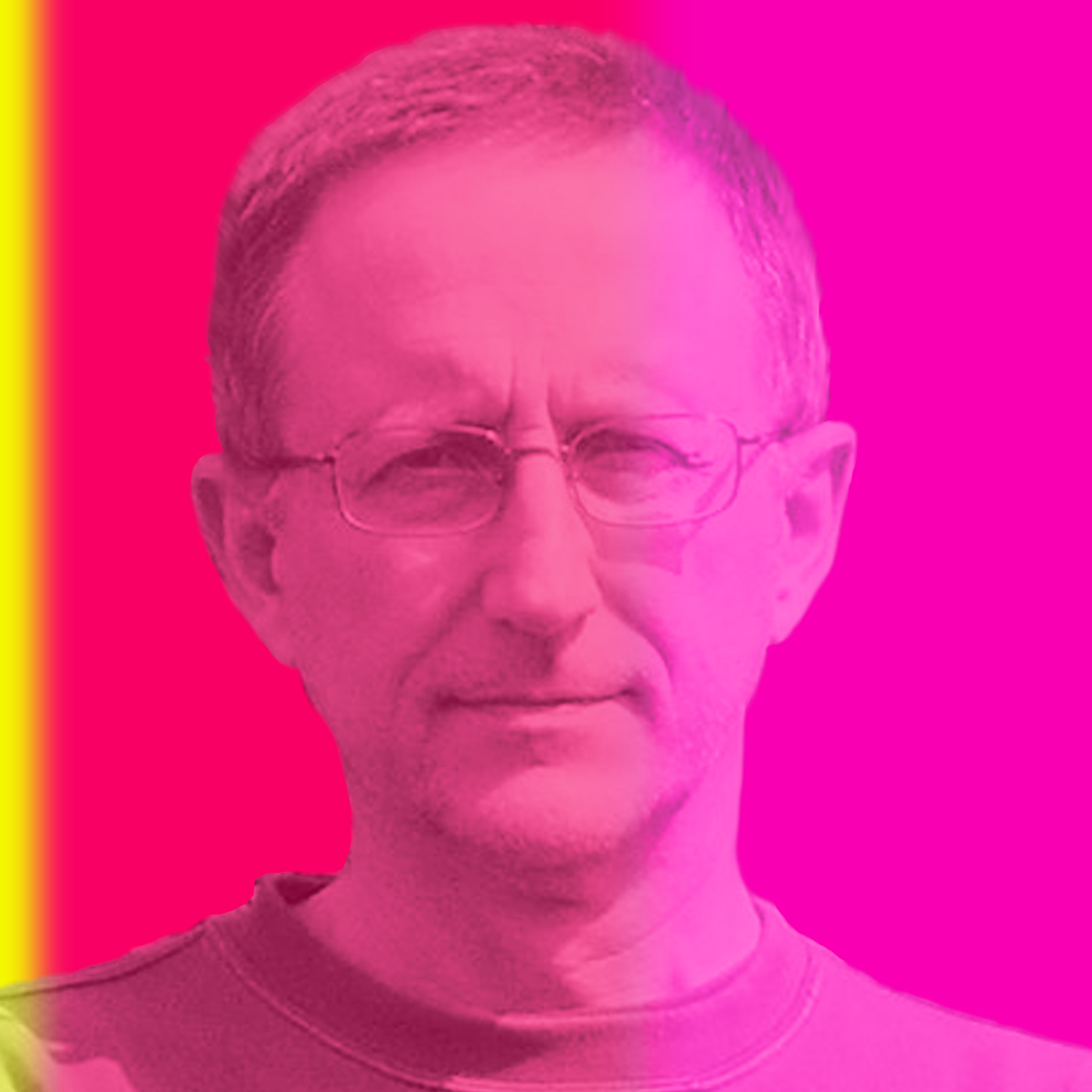







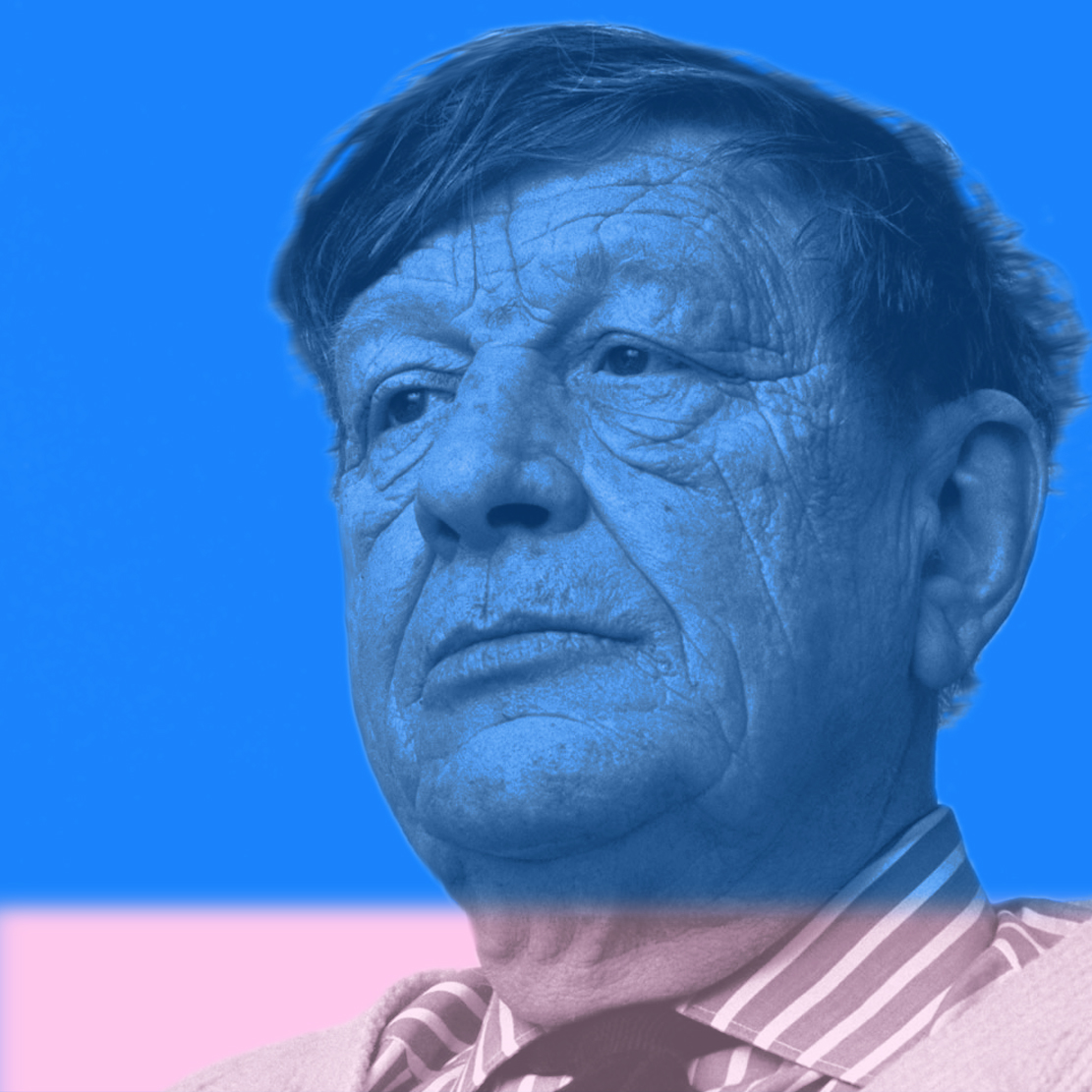





















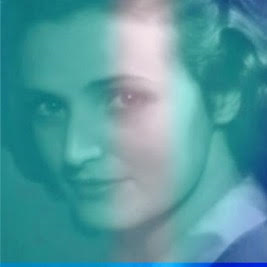































LA POESIA METAFISICA – De profundis o madre – di Giuseppe Pedota da Equazione dell’infinito (1996) Commento di Giuseppe Elio Ligotti a cura di Giorgio Linguaglossa
opera di Giuseppe Pedota, ciclo dei pianeti spenti, anni Novanta
Giuseppe Pedota (Genzano di Lucania – Pt – 26.01.1933 – Cremona 15.05.2010). Dall’età di cinque anni compie studi musicali quindi, studi medi, ginnasiali e classici a Potenza tra i gesuiti. Dà concerti d’organo e pianoforte. Di formazione laica, instaura legami con Carlo Levi, Rocco Scotellaro, Vito Riviello, Orazio Gavioli, Lucio Tufano e riunisce il meglio dell’ intellighenzia lucana di allora proponendo un inedito ed importante centro di dibattito politico e culturale. Si lega a Crippa, Fontana, Kodra, Buzzati, Vittorini, Roversi.. Per reazione a certi modi e mode d’arte si dedica per motivi di lavoro soprattutto all’architettura, al design, alla pubblicità e scenografie. Tra i lavori degli anni ’60, la commissione per gli interni dell’hotel “due Foscari” di Busseto; gli interni totali del cinema Vittoria di Crema. Alcuni progetti, come la villa Kesten a Ginevra, sono considerati esempi ante litteram di bioarchitettura.
Giuseppe Pedota, ciclo dei pianeti spenti, anni Novanta
A Cremona, mostra personale con interventi di Elda Fezzi (1965). A Roma, mostra personale di pittura e scultura con catalogo titolato dai curatori ”Pittura sovvertitrice, Pittura dell’inconscio, con testi di Fiammetta Selva, Vito Riviello, Ernst Zeisler, Sebastiano Carta con una poesia dedicata (1968). A Matera, personale alla “Scaletta” con presentazione di Franco Palumbo (1970).
Giuseppe Pedota che fuma foto anni Settanta
In un’asta di maestri contemporanei a Milano, viene per la prima volta quotato a livello internazionale (1970). È invitato a Palermo dove allestisce una mostra personale di pittura e scultura alla “Trinacria” (1972). Il catalogo è di Ugo Moretti con testi dello stesso, mentre alla vernice interviene con una prolusione Leonardo Sciascia. Testi critici sui maggiori quotidiani, reti TV-Rai3. Nella primavera del ’73 è chiamato a dirigere “Trinacria” dove allestisce, tra le altre, un’importante antologica al suo amico Tot. Segue poi quest’ultimo, titolare di seminari di scultura in campus universitari, durante un iter americano. Visita a New York i più importanti studi di artisti americani (Robert Kleinman, N.Y. “Tormentingly poetic”, 1974). È invitato a numerose mostre nelle maggiori città europee.
Giuseppe Pedota nudo femminile, anni Novanta
Dal ’95 è redattore e art director della rivista di letteratura “Poiesis”. Giorgio Linguaglossa presenta le poesie di Giuseppe Pedota nel numero sette di “Poiesis” (settembre ’95); nel medesimo numero Pedota firma il “Manifesto della Nuova Poesia Metafisica”. 1996, pubblica il poema Equazione dell’infinito per i tipi “Scettro del Re” – Roma. Nel 1999, pubblica il poema “Einstein, i vincoli dello spazio” con prefazione di Luigi Reina. Nel 2009, esposizione a Roma presso la Domus Talenti. Nel 2005 esce il numero speciale di «Poiesis» (32) con il titolo Acronico comprendente tutte le poesie di Pedota.
*
Il verso di Giuseppe Pedota, fin dal suo primo germinarsi, soddisfa l’affermazione per cui la poesia non è vaga, non meglio definita ispirazione, è bensì, esattamente, folgorazione da contrasto: pietra focaia degli opposti, sistema di equivalenze tanto calibrate quanto drammatiche, limite grafico dell’illimite per un impossibile pareggio delle sorti. È, in definitiva, quell’equazione dell’infinito che è poi lo sfolgorante titolo sidereo della nostra silloge ed è pure, per così dire, lo zoccolo duro tematico dei paragrafi di cui si compone.
Giuseppe Pedota foto anni Settanta
Ed è dunque l’unico luogo, la poesia, in cui si possa tentare di conciliare l’inconciliabile: le tre facce della storia, il desiderio e la realtà, l’aristocrazia del pensiero e la sua irrealizzabilità, la relatività della vita e della morte. Tutti temi e motivi che caratterizzano la poesia di Pedota, che anzi la esaltano fino ad essere risaltati. “…io siedo al crocevia del tempo” – dice il poeta – “spietato dono per il nostro limite.” E ancora, in una lirica dedicata alla Lucania delle origini, parla di “sogno di remote/civiltà stellari…la mia Lucania è un’Itaca/ di tutte le ombre/ che mi crearono la luce.” Dove mi pare evidente la visione orfica e metamorfica delle cose della terra e dell’uomo. Orfismo che è parametro e paradigma dell’eterno. L’orfico Pedota, il pitagorico Pedota, ci ricorda che il tempo è ritmicità, rotazione e ciclicità: è la teoria dell’eterno ritorno di Nietzsche: teoria portatrice sì di fatalità, ma anche di serenità cosmica, per cui l’uomo la terra le cose sono viste dall’alto, al di sopra del tempo: afferma, il poeta: “sarà solo un abbaglio/ una cifra che ho inciso nel mio seme/ disincarnato e immemore/ di questi miei silenzi a darvi il segno/ forse d’amarmi anche non capendo/ mi basterà questo amore mai detto/ a risalire dalle mie vertigini/e inondarmi di stelle.”
giuseppe pedota al pianoforte 2009
Alla funzionalità di un tale processo orfico-metamorfico, destinato al sottile succo dell’ebbrezza della metempsicosi, contribuiscono le più impensate contaminazioni, gli accostamenti mitopoietici più audaci, le plasmabilità della creta compositiva: fino ad estrarne figurazioni ed immagini nuove, miste ed icastiche: l’esito è d’uno splendido ibridismo delle forme. Ecco allora il “seme del tuo pube di seta/ innalzato a ostensorio/ il tuo ventremuschio rovesciato /in filigranavene di luce/ per i figli che nasceranno/nei silenzi dei nuovi pianeti.” E poi: “l’autoritratto è un efebo/per i languori di saffo ed i corrucci di michelangelo.” Ora è l’androgino: “ha mani di rebus intrico di spazi/ha il tuo culo di gioia irrispettabile/che spiega i paradossi/della gravitazione oscillante.” Ora appare “l’amico cogitans/ maitre à penser della contrada/fons bandusiae” il quale “vede Orazio scendere dai fianchi/d’una lucida mula di massari.” Ecco poi riaffiorare le figure torbide e insanate del Mito greco: da Medea a Edipo, da Elena alle Arpie, al Minotauro: “antropofaghi sputi del peccato.” E il corpo di chi quei miti ha sempre vissuto, “il mio corpo di giunco vecchio/ attraversato da meteore.” Infine, l’epifania d’un “gigante guerriero/ venuto ad inseminare la mente/ d’un branco di scimmie prensili.”
ritratto femminile di Giuseppe Pedota inizi anni Settanta
E mi si passi questa serie di estrapolazioni necessariamente riduttiva, ma non accidentale, atta com’è a dimostrare che, in definitiva, la dimensione spazio-temporale, anzi spazio-atemporale, in cui muove la poesia di Pedota è quella del simbolismo, per meglio dire: d’un neosimbolismo e contenutistico e formale. La concezione orfica di cui s’è detto – e che niente concede a forme di epigonismo di maniera – ha al centro l’evocazione, la necessità cioè di fermare nel moto ciclico dell’eterno ritorno, nuove sembianze e nuove prospettive: ma perché ciò sia possibile, perché cioè lo spessore della suggestione sia colto nella sua forma più elevata e più astratta, s’impone un uso prepotentemente connotativo della parola, un supplemento di immagini, al di la del valore semantico-lessicale suo proprio, sia sul piano analogico sia su quello fonico e, soprattutto, cromatico. Questo è un punto focale. Il maestro di pittura Pedota fa del cromatismo verbale uno degli elementi fondamentali del suo metabolismo metamorfico. Il pittore poiètes inventa, attizza, metaforizza e rassembla: in lui è vivissimo il gusto della sciarada come neologismo: termini come “orosalmastro, ambraviola, ditapiume, falloseme, ventremuschio” hanno una loro autonomia plurisensoriale, venendo a soddisfare, fra l’altro, la sintesi di quel processo di sinestesia (per cui un senso s’innesta nell’altro) che è uno dei cardini della costruzione simbolista.
Giuseppe Pedota anni Novanta
In Pedota tutto è pulsione, ricerca e distinzione: tutto è, grecamente, istorìa: indagine, visione, esplorazione oltre i limiti del sensibile e del visibile: pur all’interno d’un disegno formale che non esula dalla filigrana della tradizione: basti considerare l’unità di base metrico-ritmica che resta pur sempre l’endecasillabo, ma si tratta d’una levigatezza, d’una morbidità accesa, stupita di sé e di un mondo e di un tempo che non hanno confini, solo avvicendamento di “più futuri/innumerabili… dove l’alfa si tocca con l’omega.”
In questo contesto, l’endecasillabo espanso in enjambement, l’isolamento della parola, l’andamento ossimorico teso a saldare gli opposti, giocano un ruolo basilare, direi cardinale, giacchè il moto che prevale è quello dell’altitudine o, se preferite, della perlustrazione delle profondità, ora stellari interplanetarie siderali, ora terrestri ctonie magmatiche. N’è collante, ripeto, il cromatismo verbale: punto di congiunzione e sutura fra, ad esempio, il Sud della Lucania, il sud lucano, e una stella antelucana (la radice è sempre quella: lux, lucis), un pianeta “dai solo blu”, dove, attenzione alla fulminazione michelangiolesca, “dove/ un laser di pensiero/è una nostra vita di parole.” La scommessa è rischiosa, lo sappiamo, ma l’esito è non di rado sorprendente. La poesia di Pedota è un quasar di sorprese. Inventa soluzioni o riscopre movimenti di una bellezza assurda totale esaustiva. Si legga l’ungarettiana “Mater”, un respiro purissimo della memoria e della pietas, in cui la contrapposizione è il saldo di due esistenze: un saldo risaltato, reso altorilievo da uno splendido chiarismo: i “sublimi fallimenti”del figlio, cui si contrappongono le “fedi ostinate”della madre.
C’è infine un aspetto di questa poesia che non va trascurato. Ed è la vis polemica, il propellente morale, l’ethos, a proposito di ciò che la poesia e il mondo delle lettere non dovrebbero, anzi non devono essere. La critica allora diviene sferzante: “se ne andranno i servi che si dimisero/ dalla categoria dell’uomo… chi imprigionò i poeti/ chi non volle vedere l’invisibile”. Orfismo, dunque, è anche immanenza, necessità di fare i conti con la storia, con le sue brutture, con le sue deviazioni. E nulla pare offenda più Pedota dell’andazzo corrente del decadimento culturale degli ultimi decenni. Ancora una volta il vero artista, e Pedota è un vero artista, dà per implicito il rischio dell’impresa, dove impresa e rischio codificano la necessità di una nuova arte, comunque elitaria. Il poeta questo lo sa, ad altri il compito di affrancarsi, di leggere, d’inchiodare al loro vero bassissimo rango i falsi poeti e i falsi profeti.
Giuseppe Pedota L’universo acronico, anni Novanta
Pedota è un iniziatore di avventure, di nuove stagioni e viaggi, di ricognizioni nei buchi misterici del tempo: è un iniziato del cosmo, non meno che della zolla e del sangue. Né forse è un caso che l’anagramma di PEDOTA è ADEPTO o, ad essere più sottili, togliendo da ADEPTO la “D” di Delirio, resta AEPTO, il cui anagramma, guarda caso, è POETA. Ora, chi crede a queste numerologie combinatorie, resti soddisfatto, chi non ci crede, sia quanto meno incuriosito o presti attenzione e riguardo alla preziosità di un’opera come Equazione dell’infinito. Un’opera che si ascrive a pieno titolo (ed è un titolo esteticamente vertiginoso), si badi bene, non nel presente, un presente ancora malversato e nebuloso, ma nel futuro, nel futuro prossimo, quello costruito dall’istorìa del verso.
(Giuseppe Elio Ligotti)
Giuseppe Pedota, L’universo acronico, ani Novanta
da Equazione dell’infinito, 1996
I campi dello splendore
I
De profundis o madre l’inesausta
chiara tristezza e queste lunghe lune
ti chiamano e le stanze luminose
ancora mi posseggono all’incanto
delle verdi stagioni della luce
sono tornato dall’illimite
per la felicità di nascermi da un sogno
tuo acerbo di granoverdemaggio
Lucania lucis l’eden tra la torre
normanna di Tricarico e le selve
di lupi che odoravano di neve
e falchi neri le ali di rugiada
inseminati da sapienza i venti
grand’inventori di storie e di sciarade
sulle flotte ulissiache dei sogni
e l’avida di spazi
Genzano emersa da abissali
valloni ebbri d’aglianico e di risa
scenografia arrogante per attori
cattivi contro il cielo come solo
sanno esserlo per genìe segrete
le progenie di Orazio e di Pitagora
matematica e mistica lubrica e libertà
crudele sole nostre ospiti
II
e ancora andiamo per queste strade di vento
con un frullo di stelle tra le ciglia
Lucania lucis come allora andiamo
quando ancora sottile nel tuo ventre
sentivo raggrumarsi i vaticini
delle imminenti apocalissi e glorie
ma è sublime vertigine del tempo
il grande gioco
di frantumarci nell’oblio di ciò che fummo
e che saremo
e fu storia mai sazia
di coincidenti epifanie
nascere l’anno della croce uncina
che provava i suoi artigli d’acefalia deforme
devastando i colori ed il cuore di Klee
e per quali segnali d’elezione
egli mi rese la sua scienza
di render l’invisibile visibile?
III
quali segni esaltanti e disperanti
protessero da intrighi
la mia stupefazione a menti aliene
perché annulla i dies irae della storia
il sonno d’un bambino
perché si aprivano le vene
di dèmoni e sibille e di profeti
tra le dita
di Michelagnolo che urlava
al suo papa i crediti mancati
dei lapislazzuli sistini
per quali segni
a pretesto di fame si compose
Amadeus il suo Requiem
e può un blu-viola distico
disperare all’abiura d’un amore?
Giuseppe Pedota Panorama di pianeta spento, anni Novanta
IV
ed ora che traslata la tua forma
e lunare innocenza
hai superato l’ultimo confino
dove hai scienza del nostro paradosso
sai perché le cento teste dell’idra
furie dell’ombra attraversarono
il grande enigma delle nostre vite
e del mondo
perché dopo l’abbaglio delirante
di più soli immortali
in un’alba porgesti a me il sudario
del fratello
con lo stupore di tutte le madri
cui in quel tempo rovente in un crogiolo
di fumo si strapparono quaranta
milioni di figli
ora tu sai perché sedevo sempre
su orli d’universo e ad ogni balzo
non s’esauriva ancora la mia sete
e ancora… e ancora
V
e poi ti raccontai gli occhi di Luis
d’arcobaleno sceso nei recessi
degli oceani e dei vuoti siderali
occhi che soli hanno percorso
il mio stellare labirinto
ti raccontavo i viaggi da mutante
tra città dagli acùmini di diaspro
non abitate
ma impregnate da abitatori-luce
con scale che salivano a volute
arditissime al nulla interrompendosi
come accade
ai percorsi-pensiero degli umani quando
dopo gli arditi giri del troppo chiedersi
sperdendosi sull’improvviso balzo
della rarefazione d’assoluto
dell’acuto abbisognano d’un volo
VI
de profundis ti chiama questa chiara
tristezza e già un disincarnato alto
canto mi porta ai nostri
campi dello splendore
le mie ali si chiusero a uno spazio
d’attesa appena
stanche
creature ho amato senza le radici
che il dolore esorcizzano
con incensi d’abiura
alla vita e gioie
d’atarassia
ancora molte teste di quell’idra
miti d’alterità aberrante
a intelligere nostro evolutivo
VII
per quei lampi comete-apparizioni
che danno il senso e il conto
di viverci fluttuati dalle stelle
per quei percorsi curvi d’occhi chiari
levitanti alle estreme
regioni della mente
e all’immisura
delle nostre stagioni capovolte
nell’incommensurabile
questo è il dono maturo delle nostre
storie che finalmente
coincidono elidendosi in un punto
essenziale
Giuseppe Pedota, stella segreta, anni Novanta
stella segreta
o mia stella segreta come l’ombra
dell’altra luna
se le finzioni del cuore preservassero
dalle comete amare
io tramerei un bozzolo di luce
per incontaminarti
e appannerei il mio specchio con un alito
di senno
ma il mio riflesso è un tempo
che si diverge in più futuri
innumerabili
le ragioni segrete
che dipanarono i tortuosi
sentieri del minotauro
assaltano il mio labirinto
dove l’alfa si tocca con l’omega
Condividi:Twitter
5 commenti
Archiviato in antologia di poesia contemporanea, critica dell'estetica, poesia italiana contemporanea, poesia italiana del novecento
Con tag "Equazione dell'infinito" di Giuseppe Pedota, Commento di Giuseppe Elio Ligotti, giorgio linguaglossa, giuseppe pedota, LA POESIA METAFISICA "De profundis o madre" di Giuseppe Pedota, neosimbolismo di Giuseppe Pedota