















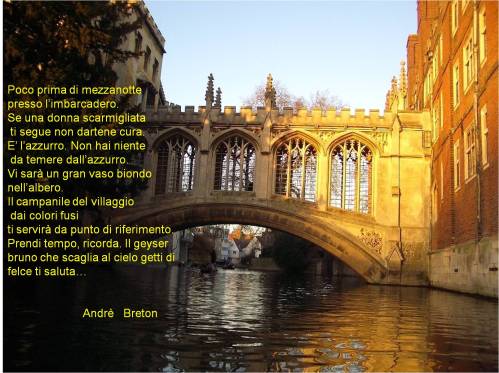

Archivi tag: Giuseppe Ungaretti
Antologia di poesie e immagini a cura di Carlo Livia
















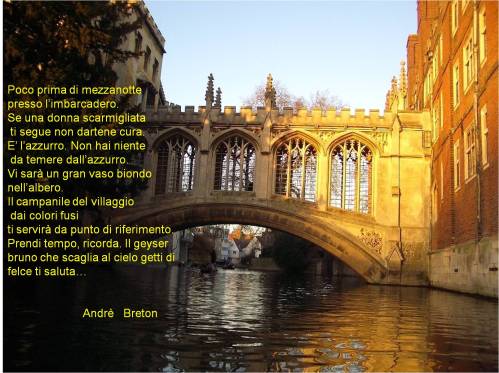

Archiviato in Poesia del Novecento, Senza categoria
Marco Onofrio. Lettura di Giuseppe Ungaretti tra vocalità e immagine televisiva negli anni Sessanta. L’aspetto fonosimbolico della poesia di Ungaretti dalla “Allegria” al rientro nella Tradizione
Commento di Marco Onofrio
Le apparizioni in video di Ungaretti cominciano negli anni ’60. A quel tempo “televisione” in Italia significa monopolio esclusivo della Rai, e questa, in quanto Tv di Stato, non ancora condizionata dalla concorrenza delle reti private, è in grado di privilegiare criteri qualitativi nella gestione del palinsesto. Con il democristiano Ettore Bernabei al timone (1961), la Rai plasma il mezzo televisivo in senso pedagogico e politico, come opinion leader egemonico, utilizzabile a fini di consenso. L’assenza di strategie commerciali salvaguarda la durata del prodotto culturale. Caso emblematico il programma L’Approdo, curato da Leone Piccioni e trasmesso a cadenza settimanale dal 2 febbraio 1963 al 28 dicembre 1972. Si tratta della trasposizione televisiva di una rubrica radiofonica della Rai, già rivista cartacea trimestrale pubblicata dalla ERI. Ungaretti è membro di un comitato di redazione sontuoso, che annovera nomi del calibro di Bacchelli, Betocchi, Bo, Cecchi, De Robertis, Longhi, Valeri…
È soprattutto attraverso L’Approdo che passa l’apparizione in video di Ungaretti. Fin dalla seconda puntata (9 febbraio 1963: a poche ore dal sessantacinquesimo genetliaco), la trasmissione dedica tributi di attenzione ad uno dei suoi maggiori garanti di dignità culturale. E certo Ungaretti – grande poeta e già universalmente noto – sembra adatto quant’altri mai ad incarnare lo spirito di un programma che si propone di coniugare qualità e divulgazione: sostanzialmente perfetto, insomma, per l’“iperdimensione” pubblica che il mezzo televisivo si appresta con il tempo a veicolare. Ungaretti? Conosciuto dalla gente, non solo dai letterati. La sua fama pubblica già consolidata gli garantisce l’autorevolezza e la credibilità necessarie per proporsi alla platea televisiva come “il” poeta; la televisione finisce a sua volta per estendere e approfondire questa fama oltre il riverbero banalmente rimasticato del «M’illumino d’immenso», sino a farne una sorta di mito vivente. Egli può così ritagliarsi uno spazio nell’immaginario collettivo ed essere identificato anche da chi non lo conosce, o non conosce la sua poesia, o nutre scarso interesse per il fatto culturale. È anche grazie alla Tv che Ungaretti assurge, anno dopo anno, alla statura di personaggio. Nel 1968, per esempio, traduce e commenta l’Odissea in Rai, e la gente comune, incontrandolo, lo scambia per “quel grande attore della televisione”. Qualcuno, più fantasiosamente, potrebbe anche immaginare che Omero stesso sia stato catapultato a parlare dagli schermi televisivi, tanto ieratica e autorevole appare la figura del poeta. Si era fatto crescere una barba bianca alla Hemingway, da vecchio lupo di mare, pur mantenendo accesi i suoi celebri occhi da bambino, enigmatici come quelli d’un gatto: un appeal nobile e umano, austero e familiare, in grado perciò di guadagnare piuttosto naturalmente il centro della scena, assicurandosi non solo il rispetto ma anche l’affetto dei telespettatori.

Ma la sua presenza nei programmi Rai non si limita a L’Approdo, giacché comprende anche diversi “specials” nel contesto di altre trasmissioni: sin dal “ritratto” di diciotto minuti che gli dedica Clemente Crispolti, trasmesso la sera del 7 luglio 1959. Sono appunto “ritratti”, “incontri”, “conversazioni” e “documentari” incentrati sull’uomo e sul poeta. Generalmente Ungaretti appare in video per recitare poesie, ma anche per esprimersi su certe questioni, rispondendo alle domande di un intervistatore; o per presiedere o ricevere un premio letterario; o per partecipare a un convegno o a un festival; o per incontrare gli studenti nelle scuole. Le riprese sono per lo più in interno. Ma l’occhio indiscreto della telecamera deve anche poter soddisfare le curiosità del pubblico, che vuole conoscere il poeta-personaggio nella totalità della sua sfera esistenziale. Ed ecco “Ungà” colto nel privato quotidiano, ripreso a passeggio per Roma, lungo il Tevere o tra le rovine di Caracalla, o nell’avita Lucca, o a parlare al tavolino di un bar, o a casa con accanto la nipotina… Il caso più tipico è offerto dal poeta nel suo studio mentre recita versi. Nelle immagini televisive lo si vede seduto in poltrona, inquadrato a mezzo busto, in primo piano. Non accompagna la lettura con gesti delle mani, che sono occupate a reggere il libro. La performance vocalica è doppiata da smorfie espressive e dal movimento degli occhi. Di tanto in tanto li alza dal libro verso un punto immaginario, in alto alla sua sinistra. Lo sguardo è intensamente visionario, inciso nelle rughe di sofferenza che lampeggiano sul volto per l’ansimante scansione sillabica dei versi. È come se scorgesse, fuori di sé, una sorta di oggettivazione simbolica delle parole che pronuncia; o le parole stesse gli nascessero spontanee, per la prima volta, dettate da ciò che “vede”.

Quando legge ad alta voce le sue poesie, in televisione, o in pubblico durante le presentazioni, Ungaretti può destare sospetti di istrionismo; in realtà non è un fine dicitore o un “attore” distanziato dalla materia, ma un uomo che soffre dal vivo, autenticamente –: che dona e spende tutto se stesso, e si ricapitola dalle origini, ancora una volta, ogni volta daccapo. Non risparmia nulla al “fratello umano” che lo ascolta: offre tutto ciò che può dare, anche ciò che ancora non sa di poter dare. La parola è vissuta nel sangue, in ogni sua fibra. Il pathos espressivo è autentico e per questo impressionante. Ungaretti arde all’improvviso come un tirso, e la sua fiammata non si lascia facilmente dimenticare. Sul viso gli si rende visibile una sofferenza, una pena effettiva, e a tratti un illuminarsi e vibrare che colpisce per sempre chi lo vede. È in definitiva un grande comunicatore, capace di bucare il silenzio o il teleschermo con i suoi sguardi profondissimi e la sua voce cavernosa e dolce, i suoi estri repentini e i suoi furori. Ricorda Francesco Paolo Memmo: «Aveva quegli occhi incredibili, scavati, che ti scavavano, quando lo vedevo in televisione; con una bellissima barba bianca, negli ultimi anni: lo ricordo, ad esempio, seduto accanto a un albero, su un prato, in un videoclip ante litteram, mentre Iva Zanicchi cantava una canzone evidentemente a lui dedicata» (ma Ungaretti stravedeva per Mina).
Della vocalità di Ungaretti si è occupato Emerico Giachery in un breve e magistrale saggio, Ungaretti a voce alta (2008). Occorre premettere che ogni voce, nella sua grana originaria, ha per natura incorporato un destino di credibilità. La voce non è mai neutra, ma ha significato di per sé: è portatrice di un “valore” che prescinde dal linguaggio. Questo spiega perché un bravo attore, dotato di bella voce, è in grado di far apparire valida una poesia mediocre; o, viceversa, perché una poesia valida, o anche splendida, può essere completamente rovinata da una lettura scadente. La vocalità (grazie a cui il testo poetico viene eseguito, a mo’ di partitura musicale) abbraccia i poteri del significante – intonazione, accento, ritmo, interpretazione delle figure foniche e metro-ritmiche del testo – che, secondo la distinzione di Émile Benveniste, consentono al registro semiotico-denotativo di espandersi negli “armonici” del livello semantico-connotativo: la pienezza del senso poetico (ovvero la “significanza” epifanica del testo) scaturisce dalla coesione strutturale che incorpora i poteri del significante, sondati dalla voce, ai messaggi convenzionali del significato.
 Il linguista Giuseppe Paioni ha descritto in modo assai preciso la fonetica ungarettiana: il celebre “sillabato”, la nettezza degli iati, la purezza delle vocali e la variabilità della loro durata, «la vibrante rinforzata se associata a dentale o velare (…), ma senza asprezza, quasi che il suo ruolo simbolico fosse quello di virilizzare la dolcezza, senza abbandonarla (…), la sibilante preconsonantica o geminata allungata, come accarezzata (…), le nasali marcate a delimitare il prefisso»… Il sillabato ungarettiano cerca «la letteralità, le articolazioni naturali della lingua. L’effetto di questi eccessi, di questi timbri marcati è quello di astrarli, come se la voce ne accentuasse l’idea, l’evidenza, cioè di allucinarli». È un recitativo che frantuma il continuum vocale in un “salmodiare” rotto e sofferto, modulato su variazioni di volume e di altezza. «Né meramente illustrativa o espressiva né enfatica o al limite isterica, la performance ungarettiana si definisce essenzialmente come una drammaturgia sottile della parola, una “mise-en-scène” puntuale e allo stesso tempo lussuosa del testo e delle modalità con cui il testo e la sua ritmicità “lavorano” la lingua e i suoi significanti».
Il linguista Giuseppe Paioni ha descritto in modo assai preciso la fonetica ungarettiana: il celebre “sillabato”, la nettezza degli iati, la purezza delle vocali e la variabilità della loro durata, «la vibrante rinforzata se associata a dentale o velare (…), ma senza asprezza, quasi che il suo ruolo simbolico fosse quello di virilizzare la dolcezza, senza abbandonarla (…), la sibilante preconsonantica o geminata allungata, come accarezzata (…), le nasali marcate a delimitare il prefisso»… Il sillabato ungarettiano cerca «la letteralità, le articolazioni naturali della lingua. L’effetto di questi eccessi, di questi timbri marcati è quello di astrarli, come se la voce ne accentuasse l’idea, l’evidenza, cioè di allucinarli». È un recitativo che frantuma il continuum vocale in un “salmodiare” rotto e sofferto, modulato su variazioni di volume e di altezza. «Né meramente illustrativa o espressiva né enfatica o al limite isterica, la performance ungarettiana si definisce essenzialmente come una drammaturgia sottile della parola, una “mise-en-scène” puntuale e allo stesso tempo lussuosa del testo e delle modalità con cui il testo e la sua ritmicità “lavorano” la lingua e i suoi significanti».
Peraltro, la lettura a voce alta di un testo è – già di per sé – un atto ermeneutico. Lettura e critica convergono: l’interpretazione vocale della poesia va intesa come «momento di sintesi e punto d’arrivo del processo interpretativo». E aggiunge, precisando, Giachery: «Si tratta, entro un certo limite, anche di una sorta di lettura-confessione, e certo», per ciò che riguarda Ungaretti, «di una lettura che aiuta non poco ad intendere il suo modo di sentire, di vivere l’esperienza della parola, di scandire, spaziare, scatenare la materia verbale». Orbene, che rapporto intercorre tra la vocalità dell’Ungaretti performer e il presunto ermetismo della sua poesia? E anzitutto: che cosa c’è di realmente ermetico in Ungaretti, prescindendo ovviamente dalla classificazione scolastica che lo assomma – nella comune cifra dell’ermetismo – a due poeti molto differenti (anche tra loro) come Quasimodo e Montale? La poesia di Ungaretti è “ermetica” in quanto rende ampio lo spettro del senso e si apre alla libertà delle interpretazioni. Il lettore è coinvolto attivamente nella produzione del senso (cioè nell’attuazione di una fra le tante letture possibili) della poesia. Si legga, ad esempio, l’attacco di “O notte” (da Sentimento del tempo, 1933):
Dall’ampia ansia dell’alba
svelata alberatura.
 Dove si noti il predominio fonosimbolico della [a], vocale di apertura cosmica a uno «smisurato orizzonte in ansia crescente di luce e di evento» (Giachery); ma anche l’ambivalenza di «alberatura», che può denotare sia (com’è più probabile) un intrico di fronde “svelato” dalla luce del nuovo giorno, sia gli alberi di una nave privata di vele, con gradienti simbolici successivi di identificazione del mondo (compatto divenire delle cose esistenti) in imbarcazione che attraversa gli «oceanici silenzi» del tempo, e a cui l’alba toglie le vele tenebrose della notte… Quanto più cresce, come in questo caso, la libertà interpretativa del lettore, tanto più il testo è “oscuro”, cioè ambiguo, polisemantico, non chiaramente determinato. La poesia di Ungaretti è “ermetica” anche nella misura in cui tiene nascosta la significanza, cioè il livello semantico globale che saprebbe – viceversa – renderla chiarissima. Per meglio dire: tiene la significanza accessibile soprattutto alla voce viva, attraverso l’operazione supplementare, successiva alla scrittura, della performance.
Dove si noti il predominio fonosimbolico della [a], vocale di apertura cosmica a uno «smisurato orizzonte in ansia crescente di luce e di evento» (Giachery); ma anche l’ambivalenza di «alberatura», che può denotare sia (com’è più probabile) un intrico di fronde “svelato” dalla luce del nuovo giorno, sia gli alberi di una nave privata di vele, con gradienti simbolici successivi di identificazione del mondo (compatto divenire delle cose esistenti) in imbarcazione che attraversa gli «oceanici silenzi» del tempo, e a cui l’alba toglie le vele tenebrose della notte… Quanto più cresce, come in questo caso, la libertà interpretativa del lettore, tanto più il testo è “oscuro”, cioè ambiguo, polisemantico, non chiaramente determinato. La poesia di Ungaretti è “ermetica” anche nella misura in cui tiene nascosta la significanza, cioè il livello semantico globale che saprebbe – viceversa – renderla chiarissima. Per meglio dire: tiene la significanza accessibile soprattutto alla voce viva, attraverso l’operazione supplementare, successiva alla scrittura, della performance.
La performance ungarettiana, in particolare. Come un testo magico che suppone la tradizione di un rito vocalico, e solo in esso e per esso accetta di rivelare o riflettere il proprio segreto. La voce è il passepartout che permette di aprire le gabbie del segno, di entrare nel testo, di chiarirlo nella sua verità originaria. Il suono performativo della voce è un imbuto che ci porta nell’utero della poesia, dentro la cuna del senso. Oltre quest’utero si spalanca l’abisso del silenzio infinito che contiene tutte le parole, e ogni parola è l’imboccatura di questo abisso. La voce scardina l’ordigno della poesia, ne spiega le pieghe, ne svela i sottotesti, laddove urgono i significati più profondi e veri. Capiamo allora che l’oscurità era solo apparente: si trattava in realtà di un bagliore nascosto dentro la tenebra opaca dei segni. Il “senso” della poesia ermetica è come una candela accesa: si vede appena in piena luce, alla superficie della “forma”, ma risplende come un piccolo sole nel buio cavernoso dei sottotesti. Leggendo e ricreando drammaticamente la poesia, il poeta ci restituisce l’infinito che “non cape” nella forma, ovvero gran parte di ciò che avrebbe voluto o potuto dire. Ci comunica, usando linguaggi diversi dalla scrittura, i segnali e i sensi di ciò che la scrittura non dice, o dice oscuramente. Così facendo guida e controlla l’indirizzo della decodifica, introducendo un principio di determinazione già parecchio notevole rispetto alla libertà “aperta” del lettore solitario.
 Attenua dunque il principio ermetico della collaborazione attiva del lettore: il poeta stesso, ora, legge per lui. Il lettore-ascoltatore, divenuto oggetto di fascino, dovrà “limitarsi” a rielaborare segni già incanalati verso una certa direzione del senso (così leggere ad alta voce è, appunto, interpretare). Ungaretti, leggendo la propria poesia in un modo tanto scenografico e ammaliante, è come se volesse “suggerire”, se non imporre, la decodifica originaria del testo, avendo a cura che si comprenda entro il raggio di una certa direzione. La performance rappresenta una forma di comunicazione totale, sicché «nel modo della lettura di Ungaretti, molte di quelle cose che sono sempre sembrate caratteristiche tanto della sua personalità quanto della sua poesia vengono fuori. Si affaccia a un certo momento una ricomposizione di tutto in chiave di possibile auto-teatro, e tuttavia il teatro è anche rivolto agli altri» (Zanzotto). Egli torna al punto di partenza, rivive le premesse dell’atto creativo, si tuffa di nuovo nel magma da cui è emersa la poesia.
Attenua dunque il principio ermetico della collaborazione attiva del lettore: il poeta stesso, ora, legge per lui. Il lettore-ascoltatore, divenuto oggetto di fascino, dovrà “limitarsi” a rielaborare segni già incanalati verso una certa direzione del senso (così leggere ad alta voce è, appunto, interpretare). Ungaretti, leggendo la propria poesia in un modo tanto scenografico e ammaliante, è come se volesse “suggerire”, se non imporre, la decodifica originaria del testo, avendo a cura che si comprenda entro il raggio di una certa direzione. La performance rappresenta una forma di comunicazione totale, sicché «nel modo della lettura di Ungaretti, molte di quelle cose che sono sempre sembrate caratteristiche tanto della sua personalità quanto della sua poesia vengono fuori. Si affaccia a un certo momento una ricomposizione di tutto in chiave di possibile auto-teatro, e tuttavia il teatro è anche rivolto agli altri» (Zanzotto). Egli torna al punto di partenza, rivive le premesse dell’atto creativo, si tuffa di nuovo nel magma da cui è emersa la poesia.
Il testo scritto viene “fissato” dalla voce come textus ne varietur, come versione ideale e forma massima della potenza: la poesia risuona in armonia con le intenzioni originarie, sfiora il luminoso archetipo da cui la scrittura – pallida copia – proviene, de-finendosi in forma. E che la scrittura, forma immobile e incisa nello spazio, debba essere “fissata” dalla voce, mobile e vibratile nel tempo, testimonia sia la straordinaria potenza della voce (e non una voce qualsiasi, ma quella suggestiva di Ungaretti), sia la particolare qualità di questa scrittura, il suo essere preformata in vista della performance, scritta a mo’ di “partitura” da eseguire, dilatandosi ed esaltandosi nella voce. È una poesia che chiede giustizia alla voce, che insomma deve “suonare” per essere davvero se stessa. Nella lettura ad alta voce si produce dunque una forma di “variante assoluta”: la poesia vive autenticamente – nella pienezza delle sue potenzialità – attraverso un rito vocalico che la accende, e la fa palpitare all’unisono col ritmo interiore del poeta, mentre questi la rivive e la scandisce attimo per attimo, respiro dentro respiro, parola dopo parola. Non è difficile rendersi conto che questo è il modo del primo Ungaretti.
 Dopo i versicoli dell’Allegria, distillati per quintessenza dal simbolismo francese ed europeo, il poeta rientra nell’alveo accademico della tradizione italiana: un certo sentire barocco, che gli appartiene per istinto e anche per cultura (traduce da Gongora, Shakespeare, Racine), viene travasato entro le strutture ormai “archetipiche” del petrarchismo (dopo secoli di codificazioni stratificate e sbiadite imitazioni). La “restaurazione” operata con Sentimento del tempo determina un sovrappiù di forma che ingorga, offusca e, da ultimo, porta fuori strada il percorso aperto dalla scintillante e davvero creativa novità del Porto sepolto. Che il modo originario fosse il più conforme e congeniale alla sua verità di uomo e di poeta, lo si capisce dal fatto che Ungaretti lo conserva, nel corso degli anni, come metodo di lettura performativa. Talché anche il verso lungo (e l’endecasillabo, in particolare) delle raccolte successive, viene destrutturato, nell’atto della lettura ad alta voce, secondo il modello dell’Allegria. Come a dire che l’autentico Ungaretti è e resta il poeta dell’Allegria, anche quando scrive e poi legge pubblicamente testi che distorcono o contraddicono quelle originarie implicazioni. Si prenda ad esempio, da Il taccuino del vecchio, lo struggente e disperato appuntamento d’amore, oltre i confini del tempo, che è “Per sempre”, del 1959, in memoria della moglie Jeanne morta da un anno:
Dopo i versicoli dell’Allegria, distillati per quintessenza dal simbolismo francese ed europeo, il poeta rientra nell’alveo accademico della tradizione italiana: un certo sentire barocco, che gli appartiene per istinto e anche per cultura (traduce da Gongora, Shakespeare, Racine), viene travasato entro le strutture ormai “archetipiche” del petrarchismo (dopo secoli di codificazioni stratificate e sbiadite imitazioni). La “restaurazione” operata con Sentimento del tempo determina un sovrappiù di forma che ingorga, offusca e, da ultimo, porta fuori strada il percorso aperto dalla scintillante e davvero creativa novità del Porto sepolto. Che il modo originario fosse il più conforme e congeniale alla sua verità di uomo e di poeta, lo si capisce dal fatto che Ungaretti lo conserva, nel corso degli anni, come metodo di lettura performativa. Talché anche il verso lungo (e l’endecasillabo, in particolare) delle raccolte successive, viene destrutturato, nell’atto della lettura ad alta voce, secondo il modello dell’Allegria. Come a dire che l’autentico Ungaretti è e resta il poeta dell’Allegria, anche quando scrive e poi legge pubblicamente testi che distorcono o contraddicono quelle originarie implicazioni. Si prenda ad esempio, da Il taccuino del vecchio, lo struggente e disperato appuntamento d’amore, oltre i confini del tempo, che è “Per sempre”, del 1959, in memoria della moglie Jeanne morta da un anno:
Senza niuna impazienza sognerò,
mi piegherò al lavoro
che non può mai finire.
E a poco a poco in cima
alle braccia rinate
si riapriranno mani soccorrevoli.
Nelle cavità loro
riapparsi gli occhi, ridaranno luce.
E, d’improvviso intatta
sarai risorta, mi farà da guida
di nuovo la tua voce,
per sempre ti rivedo.
 Ecco come la poesia si trasforma, per una lettura televisiva, nella dizione ansimante e pausata di Ungaretti:
Ecco come la poesia si trasforma, per una lettura televisiva, nella dizione ansimante e pausata di Ungaretti:
Senza niuna impazienza
sognerò
mi piegherò
al lavoro
che non può mai
finire
e
a poco a poco
in cima
alle braccia
rinate
si riapriranno
mani
soccorrevoli
nelle
cavità loro
riapparsi
gli occhi
ridaranno luce
e d’improvviso
intatta
sarai
risorta
mi farà
da guida
di nuovo
la tua voce
per sempre
ti rivedo.
 Il metro viene spezzato dal respiro della voce, nella sua misura organica, perché emerga la verità profonda delle parole, incise – queste più che mai! – nella carne dell’esistenza, del dolore e della memoria. La pausa isola la parola nella sua densità semantica. Il silenzio accentua, per contrasto, il suono della voce: ne esalta la magia, la persuasività. La voce può così manifestare il percorso spirituale della parola, afferrandone l’eco remota. Ungaretti cerca di catturare, nella dizione franta, il ritmo nativo ed essenziale della sua poesia, lasciando affiorare il chiarore dei sottotesti e consentendo di significarne la “verità” (su tutte le possibili letture).
Il metro viene spezzato dal respiro della voce, nella sua misura organica, perché emerga la verità profonda delle parole, incise – queste più che mai! – nella carne dell’esistenza, del dolore e della memoria. La pausa isola la parola nella sua densità semantica. Il silenzio accentua, per contrasto, il suono della voce: ne esalta la magia, la persuasività. La voce può così manifestare il percorso spirituale della parola, afferrandone l’eco remota. Ungaretti cerca di catturare, nella dizione franta, il ritmo nativo ed essenziale della sua poesia, lasciando affiorare il chiarore dei sottotesti e consentendo di significarne la “verità” (su tutte le possibili letture).
Anni erano passati, e vicende e tragedie Ungaretti aveva oltrepassato, evolvendo nel proprio percorso. Nuove opere, nuove ispirazioni, nuovi orizzonti. Eppure l’Ungaretti che recitava versi restava ancorato al tempo dell’Allegria, al modo di quel capolavoro, al bagliore folgorante del suo avvio. Era quella la voce “nativa” del poeta, ed egli fin da allora l’aveva conquistata, definitivamente, per sempre. Conservare così la voce più chiara, la più limpida, di cui era capace, gli serviva anche per sciogliere i grumi, le opacità della forma, nella vita pulsante della voce, dispiegata attraverso il rito divulgativo della lettura. Leggendola ad alta voce, Ungaretti estrae la propria poesia dal nodo semantico che ne racchiude il senso, dentro la profondità delle strutture. La poesia ermetica si “dis-ermetizza” nel fuoco liquido della voce. La poesia di Ungaretti, ermetica nello spazio bianco della pagina, cessa di esserlo nell’espressione totale della performance, nell’urgenza della sua vocalità.
TRE POESIE – TRADUZIONI IN LINGUA SERBA di MILAN KOMNENIĆ (1940-2015) di EUGENIO MONTALE, GIUSEPPE UNGARETTI e CESARE PAVESE – a cura di Duška Vrhovac
Quando un poeta muore,
La morte dissolve la nebbia dai suoi versi. (Ljubomir Simović)
A Belgrado, si è spento di recente, il 24 luglio, il poeta e traduttore Milan Komnenić. La commemorazione si è svolta nell’aula dell’Assemblea della città di Belgrado (dell’Assemblea cittadina di Belgrado), in presenza degli amici, della famiglia e dei colleghi dell’Associazione degli scrittori della Serbia, e la tumulazione è avvenuta nel Nuovo cimitero di Belgrado, nel Viale dei cittadini illustri. Alla notizia della morte di Milan Komnenovic, l’attuale ministro della cultura ha indirizzato alla famiglia di Milan Komnenić un telegramma di condoglianze in cui si dice: “Ricorderemo Komnenić come eminente poeta, traduttore, e redattore, per lunghi anni, di riviste letterarie e, a suo tempo, anche ministro della cultura, che con la sua poesia, i saggi, il lavoro nel campo dell’editoria e l’impegno politico si è dedicato a trovare le risposte ai complessi interrogativi del destino storico del popolo. Inoltre considerevole è stato il suo contributo alla collaborazione internazionale nel campo della letteratura mediante un copioso lavoro di redattore e traduttore. Ora ci accomiatiamo da un uomo che con la sua attività ha contribuito in modo rilevante alla cultura serba e alla trasformazione democratica della società.” Tuttavia, anche se Komnenić ha svolto in due occasioni alte funzioni pubbliche, prima come segretario di stato per l’informazione e la cultura e poi anche come ministro della cultura, nessuno dei funzionari di stato ha partecipato né alla sua commemorazione né alle sue esequie funebri, che non hanno visto neppure la presenza di colleghi preposti al Movimento serbo di rinnovamento, partito di cui egli era stato cofondatore. La morte ha confermato che il poeta e traduttore, in questo caso, hanno prevalso sul politico.
Milan Komnenić era nato l’8 novembre 1940 a Pilatovac (Bileća) in Montenegro. Studente e laureato della Facoltà di Filologia di Belgrado, redattore della casa editrice „Prosveta“, nel cui ambito ha dato vita a tre edizioni di prestigio: „Erotikon“, „Prosveta“ e „ Hispanoamerički roman“/ “Il romanzo latinoamericano“/, ha redatto anche le riviste letterarie „Vidici“, „Delo“ e „Relations“; inoltre ha tenuto lezioni presso università di Francia, Italia e USA.
Alla produzione letteraria Komnenić cominciò a dedicarsi nel 1960. Ci ha lasciato un’opera ampia e varia: 21 raccolte di poesie, quattro libri di saggi, sei tra antologie e miscellanee, tre monografie, duecento tra articoli e testi specialistici, pubblicati in periodici di tutto il mondo. È stato insignito del riconoscimento per il sommo contributo dato alla cultura della Repubblica di Serbia e rimane destinatario di prestigiosi premi letterari per la poesia e per la traduzione.
Milan Komnenić, come traduttore, è stato instancabile. Ha tradotto cinquanta libri dall’ italiano, dal francese, dallo spagnolo e dal tedesco. Con queste sue traduzioni egli ha fatto conoscere alla giovane generazione i poeti italiani Ungaretti, Montale e Pavese, pubblicandone le opere presso rinomati editori della Jugoslavia. Nel 1975, per i tipi dell’allora grande casa editrice BIGZ, Komnenić ha curato e tradotto la raccolta di Ungaretti, Sentimento del tempo, per cui ha scritto la prefazione e le note. Nel 1977, la casa editrice Rad (Belgrado) nella sua edizione „Reč i misao“ /“Parola e pensiero“/ pubblicò la sua traduzione della raccolta Verrà la morte ed avrà i tuoi occhi di Cesare Pavese, mentre nel 1982 sarà ancora una volta l’editrice BIGZ a pubblicare Ossi di seppia di Eugenio Montale nella traduzione di Komnenić.
In omaggio al poeta e traduttore Milan Komnenić e ai suoi prediletti autori italiani riportiamo, nell’originale e nella traduzione, una poesia di ciascuno di questi tre libri.
Giuseppe Ungaretti, Sentimento del tempo
Selezione, traduzioni, note e prefazione di Milan Komnenić
Đuzepe Ungareti, Osećanje vremena, BIGZ, Beograd, 1975.
Izbor, prevod, predgovor.i napomene Milan Komnenić
L’Isola
A una proda ove sera era perenne
Di anziane selve assorte, scese,
E s’inoltrò
E lo richiamò rumore di penne
Ch’erasi sciolto dallo stridulo
Batticuore dell’acqua torrida,
E una larva (languiva
E rifioriva) vide;
Ritornato a salire vide
Ch’era una ninfa e dormiva
Ritta abbracciata a un olmo.
In sé da simulacro a fiamma vera
Errando, giunse a un prato ove
L’ombra negli occhi s’addensava
Delle vergini come
Sera appié degli ulivi;
Distillavano i rami
Una pioggia pigra di dardi,
Qua pecore s’erano appisolate
Sotto il liscio tepore,
Altre brucavano
La coltre luminosa;
Le mani del pastore erano un vetro
Levigato da fioca febbre.
Ostrvo
Na obalu gde vajkadašnje beše veče
Onih pradrevnih šuma, siđe
I ukaza se
Prizva ga lepet krila
Što se ote trpkom damaranju
Uzavrele vode,
I priviđenje (što je čilelo
I opet živelo) spazi;
Smotri, krenuvši naviše,
Da to beše nimfa i da je spila
Uspravna grleći brest.
Lutajući u sebi
Od privida do žežena plamena
Stiže na livadu
Gde se senka gusnula
U očima devica
Kao veče u maslinjaku;
Grane su cedile
Lenju kišu strela,
A ovce su dremale
U slatkastoj mlitavosti,
Druge su pasle
Svetli pokrovac;
Ruke pastira behu staklo
Brušeno potajnom groznicom.
***
Cesare Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
Selezione e traduzioni di Milan Komnenić
Česare Paveze, Doći će smrt i imaće tvoje oči
izbor i prevod Milan Komnenić, Beograd, Rad 1977
.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
questa morte che ci accompagna
dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso
o un vizio assurdo. I tuoi occhi
saranno una vana parola,
un grido taciuto, un silenzio.
Cosí li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi
nello specchio. O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi
che sei la vita e sei il nulla.
Per tutti la morte ha uno sguardo.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Sarà come smettere un vizio,
come vedere nello specchio
riemergere un viso morto,
come ascoltare un labbro chiuso.
Scenderemo nel gorgo muti.
(22 marzo ’50)
.
Doći će smrt i imaće tvoje oči
.
Doći će smrt i imaće tvoje oči-
ta smrt što nas saleće
od jutra do večeri,besana
i gluva,kao stara griža savesti
ili besmislena mana. Tvoje oči
biće uzaludna reč,
prigušen krik, muk.
Vidiš ih tako svakog jutra
kada se nadnosiš nad sobom u ogledalu.
O draga nado,
toga dana i mi ćemo znati
da jesi život i ništavilo.
Za svakoga smrt ima pogled.
Doći će smrt i imaće tvoje oči.
Biće poput ispravljanja mane,
kao zurenje u ogledalo
iz koga izranja mrtvo lice,
kao slušanje zatvorenih usta.
Sići ćemo u bezdane nemi.
Eugenio Montale, Ossi di seppia
Traduzione da italiano di Milan Komnenić
Euđenio Montale, Sipine kosti, BIGZ, Beograd, 1982.
Preveo sa italijanskog Milan Komnenić
Corno inglese
.
ll vento che stasera suona attento –
ricorda un forte scotere di lame –
gli strumenti dei fitti alberi e spazza
l’orizzonte di rame
dove strisce di luce si protendono
come aquiloni al cielo che rimbomba
(Nuvole in viaggio, chiari
reami di lassù! D’alti Eldoradi
malchiuse porte!)
e il mare che scaglia a scaglia,
livido, muta colore
lancia a terra una tromba
di schiume intorte;
il vento che nasce e muore
nell’ora che lenta s’annera
suonasse te pure stasera
scordato strumento,
cuore.
Engleski rog
Vetar što večeras smotreno svira
– nalikuje silnom lepetu limarije –
na instrumentu gustog borja
i mete bakarna obzorja
kuda se rojta svetlosti vije
poput zmajeva u ječećim nebesima
(Oblaci promiču, vedra
kraljevstva nebesna! Visokih Eldorada
kapije odškrinute!)
i more što, krljušt po krljušt,
olovno tre
i menja boju bacajući na hridi vrtloge
uzvitlane pene;
da hoće vetar, što se rađa i mre,
dok sumračja stiže čas,
zasvirati večeras
na tebi, razdešeni instrumente,
srce.
Duška Vrhovac, poeta, scrittrice, giornalista e traduttrice è nata nel 1947 a Banja Luka (Bagnaluca), nell’attuale Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina, e si è laureata in letterature comparate e teoria dell’opera letteraria presso la Facoltà di filologia di Belgrado, dove vive e lavora come scrittrice e giornalista indipendente, dopo aver lavorato per molti anni presso la Televisione di Belgrado (Radiotelevisione della Serbia).
Con 20 libri di poesia pubblicati, alcuni dei quali tradotti in 20 lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, tedesco, russo, arabo, cinese, rumeno, olandese, polacco, turco, macedone, armeno, albanese, sloveno, greco, ungherese, bulgaro, azero), è fra i più significativi autori contemporanei di Serbia e non solo. Presente in giornali, riviste letterarie, e antologie di valore assoluto, ha partecipato a numerosi incontri, festival e manifestazioni letterarie, in Serbia e all’estero.
È autrice di tre volumi di racconti per bambini e per la famiglia dal titolo Srećna kuća (La casa felice) e anche ha pubblicato sei libri in traduzione serba: due libri di prosa e quattro libri di poesia.
Membro, fra l’altro, dell’Associazione degli scrittori della Serbia, e dell’Associazione dei traduttori di letteratura della Serbia, è attuale vicepresidente per Europa del Movimento Poeti del Mondo e ambasciatore in Serbia. Ha ricevuto premi e riconoscimenti importanti per la poesia, tra cui:
Majska nagrada za poeziju – Maggio premio per la poesia – 1966, Yugoslavia;
Pesničko uspenije – Ascensione di Poesia – 2007, Serbia;
Premio Gensini – Sezione Poesia 2011, Italia;
Naji Naaman’s literary prize for complete works – Premio alla carriera – 2015, Libano e il Distintivo aureo assegnato dal massimo Ente per la Cultura e l’Istruzione della Repubblica di Serbia.
Ha pubblicato i seguenti libri di poesia:
San po san (Sogno dopo sogno), (Nova knjiga, Beograd 1986)
S dušom u telu (Con l’anima nel corpo), (Novo delo, Beograd 1987)
Godine bez leta (Anni senza estate) (Književne novine i Grafos, Beograd 1988)
Glas na pragu (Una voce alla soglia), (Grafos, Beograd 1990)
I Wear My Shadow Inside Me (Forest Books, London 1991)
S obe strane Drine (Sulle due rive della Drina), (Zadužbina Petar Kočić, Banja Luka 1995)
Žeđ na vodi (Sete sull’acqua), (Srempublik, Beograd 1996)
Blagoslov – stošest pesama o ljubavi (Benedizione, centosei poesie d’amore), (Metalograf, Trstenik 1996)
Knjiga koja govori (Il libro che racconta), (Dragoslav Simić, Beograd 1996)
Žeđ na vodi (Sete sull’acqua) edizione ampliata, (Srempublik, Beograd 1997)
Izabrane i nove pesme (Le poesie scelte e nuove), (Prosveta, Beograd 2002)
Zalog (Il pegno), (Ljubostinja, Trstenik 2003)
Zalog (Il pegno), edizione bibliofilo (Ljubostinja, Trstenik 2003)
Operacija na otvorenom srcu (L’ operazione a cuore aperto), (Alma, Beograd 2006)
Za sve je kriv pesnik (La colpa è di poeta), (elektronsko izdanje 2007)
Moja Desanka (Lа mia Desanka), (Udruženje za planiranje porodice i razvoj stanovništva Srbije, Beograd 2008)
Postoje ljudi (Ci sono persone), edizione dell’autore (Belgrado 2009)
Urođene slike / Immagini innati (edizione bilingue), (Smederevo, 2010)
Pesme 9×5=17 Poems (poesie scelte in 9 lingue), (Beograd 2011)
Savrseno ogledalo (Lo specchio perfetto), (Prosveta, Beograd 2013)
Quanto non sta nel fiato, poesie scelte, (FusibiliaLibri 2014)
Archiviato in Traduzione di poesia in serbo
Marco Onofrio Lettura di Giuseppe Ungaretti tra vocalità e immagine televisiva negli anni Sessanta. L’aspetto fonosimbolico della poesia di Giuseppe Ungaretti dalla “Allegria” al rientro nella Tradizione

29198b
Commento di Marco Onofrio
Le apparizioni in video di Ungaretti cominciano negli anni ’60. A quel tempo “televisione” in Italia significa monopolio esclusivo della Rai, e questa, in quanto Tv di Stato, non ancora condizionata dalla concorrenza delle reti private, è in grado di privilegiare criteri qualitativi nella gestione del palinsesto. Con il democristiano Ettore Bernabei al timone (1961), la Rai plasma il mezzo televisivo in senso pedagogico e politico, come opinion leader egemonico, utilizzabile a fini di consenso. L’assenza di strategie commerciali salvaguarda la durata del prodotto culturale. Caso emblematico il programma L’Approdo, curato da Leone Piccioni e trasmesso a cadenza settimanale dal 2 febbraio 1963 al 28 dicembre 1972. Si tratta della trasposizione televisiva di una rubrica radiofonica della Rai, già rivista cartacea trimestrale pubblicata dalla ERI. Ungaretti è membro di un comitato di redazione sontuoso, che annovera nomi del calibro di Bacchelli, Betocchi, Bo, Cecchi, De Robertis, Longhi, Valeri…
È soprattutto attraverso L’Approdo che passa l’apparizione in video di Ungaretti. Fin dalla seconda puntata (9 febbraio 1963: a poche ore dal sessantacinquesimo genetliaco), la trasmissione dedica tributi di attenzione ad uno dei suoi maggiori garanti di dignità culturale. E certo Ungaretti – grande poeta e già universalmente noto – sembra adatto quant’altri mai ad incarnare lo spirito di un programma che si propone di coniugare qualità e divulgazione: sostanzialmente perfetto, insomma, per l’“iperdimensione” pubblica che il mezzo televisivo si appresta con il tempo a veicolare. Ungaretti? Conosciuto dalla gente, non solo dai letterati. La sua fama pubblica già consolidata gli garantisce l’autorevolezza e la credibilità necessarie per proporsi alla platea televisiva come “il” poeta; la televisione finisce a sua volta per estendere e approfondire questa fama oltre il riverbero banalmente rimasticato del «M’illumino d’immenso», sino a farne una sorta di mito vivente. Egli può così ritagliarsi uno spazio nell’immaginario collettivo ed essere identificato anche da chi non lo conosce, o non conosce la sua poesia, o nutre scarso interesse per il fatto culturale. È anche grazie alla Tv che Ungaretti assurge, anno dopo anno, alla statura di personaggio. Nel 1968, per esempio, traduce e commenta l’Odissea in Rai, e la gente comune, incontrandolo, lo scambia per “quel grande attore della televisione”. Qualcuno, più fantasiosamente, potrebbe anche immaginare che Omero stesso sia stato catapultato a parlare dagli schermi televisivi, tanto ieratica e autorevole appare la figura del poeta. Si era fatto crescere una barba bianca alla Hemingway, da vecchio lupo di mare, pur mantenendo accesi i suoi celebri occhi da bambino, enigmatici come quelli d’un gatto: un appeal nobile e umano, austero e familiare, in grado perciò di guadagnare piuttosto naturalmente il centro della scena, assicurandosi non solo il rispetto ma anche l’affetto dei telespettatori.

Giuseppe Ungaretti
Ma la sua presenza nei programmi Rai non si limita a L’Approdo, giacché comprende anche diversi “specials” nel contesto di altre trasmissioni: sin dal “ritratto” di diciotto minuti che gli dedica Clemente Crispolti, trasmesso la sera del 7 luglio 1959. Sono appunto “ritratti”, “incontri”, “conversazioni” e “documentari” incentrati sull’uomo e sul poeta. Generalmente Ungaretti appare in video per recitare poesie, ma anche per esprimersi su certe questioni, rispondendo alle domande di un intervistatore; o per presiedere o ricevere un premio letterario; o per partecipare a un convegno o a un festival; o per incontrare gli studenti nelle scuole. Le riprese sono per lo più in interno. Ma l’occhio indiscreto della telecamera deve anche poter soddisfare le curiosità del pubblico, che vuole conoscere il poeta-personaggio nella totalità della sua sfera esistenziale. Ed ecco “Ungà” colto nel privato quotidiano, ripreso a passeggio per Roma, lungo il Tevere o tra le rovine di Caracalla, o nell’avita Lucca, o a parlare al tavolino di un bar, o a casa con accanto la nipotina… Il caso più tipico è offerto dal poeta nel suo studio mentre recita versi. Nelle immagini televisive lo si vede seduto in poltrona, inquadrato a mezzo busto, in primo piano. Non accompagna la lettura con gesti delle mani, che sono occupate a reggere il libro. La performance vocalica è doppiata da smorfie espressive e dal movimento degli occhi. Di tanto in tanto li alza dal libro verso un punto immaginario, in alto alla sua sinistra. Lo sguardo è intensamente visionario, inciso nelle rughe di sofferenza che lampeggiano sul volto per l’ansimante scansione sillabica dei versi. È come se scorgesse, fuori di sé, una sorta di oggettivazione simbolica delle parole che pronuncia; o le parole stesse gli nascessero spontanee, per la prima volta, dettate da ciò che “vede”.

eugenio montale e il picchio
Quando legge ad alta voce le sue poesie, in televisione, o in pubblico durante le presentazioni, Ungaretti può destare sospetti di istrionismo; in realtà non è un fine dicitore o un “attore” distanziato dalla materia, ma un uomo che soffre dal vivo, autenticamente –: che dona e spende tutto se stesso, e si ricapitola dalle origini, ancora una volta, ogni volta daccapo. Non risparmia nulla al “fratello umano” che lo ascolta: offre tutto ciò che può dare, anche ciò che ancora non sa di poter dare. La parola è vissuta nel sangue, in ogni sua fibra. Il pathos espressivo è autentico e per questo impressionante. Ungaretti arde all’improvviso come un tirso, e la sua fiammata non si lascia facilmente dimenticare. Sul viso gli si rende visibile una sofferenza, una pena effettiva, e a tratti un illuminarsi e vibrare che colpisce per sempre chi lo vede. È in definitiva un grande comunicatore, capace di bucare il silenzio o il teleschermo con i suoi sguardi profondissimi e la sua voce cavernosa e dolce, i suoi estri repentini e i suoi furori. Ricorda Francesco Paolo Memmo: «Aveva quegli occhi incredibili, scavati, che ti scavavano, quando lo vedevo in televisione; con una bellissima barba bianca, negli ultimi anni: lo ricordo, ad esempio, seduto accanto a un albero, su un prato, in un videoclip ante litteram, mentre Iva Zanicchi cantava una canzone evidentemente a lui dedicata» (ma Ungaretti stravedeva per Mina).
Della vocalità di Ungaretti si è occupato Emerico Giachery in un breve e magistrale saggio, Ungaretti a voce alta (2008). Occorre premettere che ogni voce, nella sua grana originaria, ha per natura incorporato un destino di credibilità. La voce non è mai neutra, ma ha significato di per sé: è portatrice di un “valore” che prescinde dal linguaggio. Questo spiega perché un bravo attore, dotato di bella voce, è in grado di far apparire valida una poesia mediocre; o, viceversa, perché una poesia valida, o anche splendida, può essere completamente rovinata da una lettura scadente. La vocalità (grazie a cui il testo poetico viene eseguito, a mo’ di partitura musicale) abbraccia i poteri del significante – intonazione, accento, ritmo, interpretazione delle figure foniche e metro-ritmiche del testo – che, secondo la distinzione di Émile Benveniste, consentono al registro semiotico-denotativo di espandersi negli “armonici” del livello semantico-connotativo: la pienezza del senso poetico (ovvero la “significanza” epifanica del testo) scaturisce dalla coesione strutturale che incorpora i poteri del significante, sondati dalla voce, ai messaggi convenzionali del significato.
 Il linguista Giuseppe Paioni ha descritto in modo assai preciso la fonetica ungarettiana: il celebre “sillabato”, la nettezza degli iati, la purezza delle vocali e la variabilità della loro durata, «la vibrante rinforzata se associata a dentale o velare (…), ma senza asprezza, quasi che il suo ruolo simbolico fosse quello di virilizzare la dolcezza, senza abbandonarla (…), la sibilante preconsonantica o geminata allungata, come accarezzata (…), le nasali marcate a delimitare il prefisso»… Il sillabato ungarettiano cerca «la letteralità, le articolazioni naturali della lingua. L’effetto di questi eccessi, di questi timbri marcati è quello di astrarli, come se la voce ne accentuasse l’idea, l’evidenza, cioè di allucinarli». È un recitativo che frantuma il continuum vocale in un “salmodiare” rotto e sofferto, modulato su variazioni di volume e di altezza. «Né meramente illustrativa o espressiva né enfatica o al limite isterica, la performance ungarettiana si definisce essenzialmente come una drammaturgia sottile della parola, una “mise-en-scène” puntuale e allo stesso tempo lussuosa del testo e delle modalità con cui il testo e la sua ritmicità “lavorano” la lingua e i suoi significanti».
Il linguista Giuseppe Paioni ha descritto in modo assai preciso la fonetica ungarettiana: il celebre “sillabato”, la nettezza degli iati, la purezza delle vocali e la variabilità della loro durata, «la vibrante rinforzata se associata a dentale o velare (…), ma senza asprezza, quasi che il suo ruolo simbolico fosse quello di virilizzare la dolcezza, senza abbandonarla (…), la sibilante preconsonantica o geminata allungata, come accarezzata (…), le nasali marcate a delimitare il prefisso»… Il sillabato ungarettiano cerca «la letteralità, le articolazioni naturali della lingua. L’effetto di questi eccessi, di questi timbri marcati è quello di astrarli, come se la voce ne accentuasse l’idea, l’evidenza, cioè di allucinarli». È un recitativo che frantuma il continuum vocale in un “salmodiare” rotto e sofferto, modulato su variazioni di volume e di altezza. «Né meramente illustrativa o espressiva né enfatica o al limite isterica, la performance ungarettiana si definisce essenzialmente come una drammaturgia sottile della parola, una “mise-en-scène” puntuale e allo stesso tempo lussuosa del testo e delle modalità con cui il testo e la sua ritmicità “lavorano” la lingua e i suoi significanti».
Peraltro, la lettura a voce alta di un testo è – già di per sé – un atto ermeneutico. Lettura e critica convergono: l’interpretazione vocale della poesia va intesa come «momento di sintesi e punto d’arrivo del processo interpretativo». E aggiunge, precisando, Giachery: «Si tratta, entro un certo limite, anche di una sorta di lettura-confessione, e certo», per ciò che riguarda Ungaretti, «di una lettura che aiuta non poco ad intendere il suo modo di sentire, di vivere l’esperienza della parola, di scandire, spaziare, scatenare la materia verbale». Orbene, che rapporto intercorre tra la vocalità dell’Ungaretti performer e il presunto ermetismo della sua poesia? E anzitutto: che cosa c’è di realmente ermetico in Ungaretti, prescindendo ovviamente dalla classificazione scolastica che lo assomma – nella comune cifra dell’ermetismo – a due poeti molto differenti (anche tra loro) come Quasimodo e Montale? La poesia di Ungaretti è “ermetica” in quanto rende ampio lo spettro del senso e si apre alla libertà delle interpretazioni. Il lettore è coinvolto attivamente nella produzione del senso (cioè nell’attuazione di una fra le tante letture possibili) della poesia. Si legga, ad esempio, l’attacco di “O notte” (da Sentimento del tempo, 1933):
Dall’ampia ansia dell’alba
svelata alberatura.
 Dove si noti il predominio fonosimbolico della [a], vocale di apertura cosmica a uno «smisurato orizzonte in ansia crescente di luce e di evento» (Giachery); ma anche l’ambivalenza di «alberatura», che può denotare sia (com’è più probabile) un intrico di fronde “svelato” dalla luce del nuovo giorno, sia gli alberi di una nave privata di vele, con gradienti simbolici successivi di identificazione del mondo (compatto divenire delle cose esistenti) in imbarcazione che attraversa gli «oceanici silenzi» del tempo, e a cui l’alba toglie le vele tenebrose della notte… Quanto più cresce, come in questo caso, la libertà interpretativa del lettore, tanto più il testo è “oscuro”, cioè ambiguo, polisemantico, non chiaramente determinato. La poesia di Ungaretti è “ermetica” anche nella misura in cui tiene nascosta la significanza, cioè il livello semantico globale che saprebbe – viceversa – renderla chiarissima. Per meglio dire: tiene la significanza accessibile soprattutto alla voce viva, attraverso l’operazione supplementare, successiva alla scrittura, della performance.
Dove si noti il predominio fonosimbolico della [a], vocale di apertura cosmica a uno «smisurato orizzonte in ansia crescente di luce e di evento» (Giachery); ma anche l’ambivalenza di «alberatura», che può denotare sia (com’è più probabile) un intrico di fronde “svelato” dalla luce del nuovo giorno, sia gli alberi di una nave privata di vele, con gradienti simbolici successivi di identificazione del mondo (compatto divenire delle cose esistenti) in imbarcazione che attraversa gli «oceanici silenzi» del tempo, e a cui l’alba toglie le vele tenebrose della notte… Quanto più cresce, come in questo caso, la libertà interpretativa del lettore, tanto più il testo è “oscuro”, cioè ambiguo, polisemantico, non chiaramente determinato. La poesia di Ungaretti è “ermetica” anche nella misura in cui tiene nascosta la significanza, cioè il livello semantico globale che saprebbe – viceversa – renderla chiarissima. Per meglio dire: tiene la significanza accessibile soprattutto alla voce viva, attraverso l’operazione supplementare, successiva alla scrittura, della performance.
La performance ungarettiana, in particolare. Come un testo magico che suppone la tradizione di un rito vocalico, e solo in esso e per esso accetta di rivelare o riflettere il proprio segreto. La voce è il passepartout che permette di aprire le gabbie del segno, di entrare nel testo, di chiarirlo nella sua verità originaria. Il suono performativo della voce è un imbuto che ci porta nell’utero della poesia, dentro la cuna del senso. Oltre quest’utero si spalanca l’abisso del silenzio infinito che contiene tutte le parole, e ogni parola è l’imboccatura di questo abisso. La voce scardina l’ordigno della poesia, ne spiega le pieghe, ne svela i sottotesti, laddove urgono i significati più profondi e veri. Capiamo allora che l’oscurità era solo apparente: si trattava in realtà di un bagliore nascosto dentro la tenebra opaca dei segni. Il “senso” della poesia ermetica è come una candela accesa: si vede appena in piena luce, alla superficie della “forma”, ma risplende come un piccolo sole nel buio cavernoso dei sottotesti. Leggendo e ricreando drammaticamente la poesia, il poeta ci restituisce l’infinito che “non cape” nella forma, ovvero gran parte di ciò che avrebbe voluto o potuto dire. Ci comunica, usando linguaggi diversi dalla scrittura, i segnali e i sensi di ciò che la scrittura non dice, o dice oscuramente. Così facendo guida e controlla l’indirizzo della decodifica, introducendo un principio di determinazione già parecchio notevole rispetto alla libertà “aperta” del lettore solitario.
 Attenua dunque il principio ermetico della collaborazione attiva del lettore: il poeta stesso, ora, legge per lui. Il lettore-ascoltatore, divenuto oggetto di fascino, dovrà “limitarsi” a rielaborare segni già incanalati verso una certa direzione del senso (così leggere ad alta voce è, appunto, interpretare). Ungaretti, leggendo la propria poesia in un modo tanto scenografico e ammaliante, è come se volesse “suggerire”, se non imporre, la decodifica originaria del testo, avendo a cura che si comprenda entro il raggio di una certa direzione. La performance rappresenta una forma di comunicazione totale, sicché «nel modo della lettura di Ungaretti, molte di quelle cose che sono sempre sembrate caratteristiche tanto della sua personalità quanto della sua poesia vengono fuori. Si affaccia a un certo momento una ricomposizione di tutto in chiave di possibile auto-teatro, e tuttavia il teatro è anche rivolto agli altri» (Zanzotto). Egli torna al punto di partenza, rivive le premesse dell’atto creativo, si tuffa di nuovo nel magma da cui è emersa la poesia.
Attenua dunque il principio ermetico della collaborazione attiva del lettore: il poeta stesso, ora, legge per lui. Il lettore-ascoltatore, divenuto oggetto di fascino, dovrà “limitarsi” a rielaborare segni già incanalati verso una certa direzione del senso (così leggere ad alta voce è, appunto, interpretare). Ungaretti, leggendo la propria poesia in un modo tanto scenografico e ammaliante, è come se volesse “suggerire”, se non imporre, la decodifica originaria del testo, avendo a cura che si comprenda entro il raggio di una certa direzione. La performance rappresenta una forma di comunicazione totale, sicché «nel modo della lettura di Ungaretti, molte di quelle cose che sono sempre sembrate caratteristiche tanto della sua personalità quanto della sua poesia vengono fuori. Si affaccia a un certo momento una ricomposizione di tutto in chiave di possibile auto-teatro, e tuttavia il teatro è anche rivolto agli altri» (Zanzotto). Egli torna al punto di partenza, rivive le premesse dell’atto creativo, si tuffa di nuovo nel magma da cui è emersa la poesia.
Il testo scritto viene “fissato” dalla voce come textus ne varietur, come versione ideale e forma massima della potenza: la poesia risuona in armonia con le intenzioni originarie, sfiora il luminoso archetipo da cui la scrittura – pallida copia – proviene, de-finendosi in forma. E che la scrittura, forma immobile e incisa nello spazio, debba essere “fissata” dalla voce, mobile e vibratile nel tempo, testimonia sia la straordinaria potenza della voce (e non una voce qualsiasi, ma quella suggestiva di Ungaretti), sia la particolare qualità di questa scrittura, il suo essere preformata in vista della performance, scritta a mo’ di “partitura” da eseguire, dilatandosi ed esaltandosi nella voce. È una poesia che chiede giustizia alla voce, che insomma deve “suonare” per essere davvero se stessa. Nella lettura ad alta voce si produce dunque una forma di “variante assoluta”: la poesia vive autenticamente – nella pienezza delle sue potenzialità – attraverso un rito vocalico che la accende, e la fa palpitare all’unisono col ritmo interiore del poeta, mentre questi la rivive e la scandisce attimo per attimo, respiro dentro respiro, parola dopo parola. Non è difficile rendersi conto che questo è il modo del primo Ungaretti.
 Dopo i versicoli dell’Allegria, distillati per quintessenza dal simbolismo francese ed europeo, il poeta rientra nell’alveo accademico della tradizione italiana: un certo sentire barocco, che gli appartiene per istinto e anche per cultura (traduce da Gongora, Shakespeare, Racine), viene travasato entro le strutture ormai “archetipiche” del petrarchismo (dopo secoli di codificazioni stratificate e sbiadite imitazioni). La “restaurazione” operata con Sentimento del tempo determina un sovrappiù di forma che ingorga, offusca e, da ultimo, porta fuori strada il percorso aperto dalla scintillante e davvero creativa novità del Porto sepolto. Che il modo originario fosse il più conforme e congeniale alla sua verità di uomo e di poeta, lo si capisce dal fatto che Ungaretti lo conserva, nel corso degli anni, come metodo di lettura performativa. Talché anche il verso lungo (e l’endecasillabo, in particolare) delle raccolte successive, viene destrutturato, nell’atto della lettura ad alta voce, secondo il modello dell’Allegria. Come a dire che l’autentico Ungaretti è e resta il poeta dell’Allegria, anche quando scrive e poi legge pubblicamente testi che distorcono o contraddicono quelle originarie implicazioni. Si prenda ad esempio, da Il taccuino del vecchio, lo struggente e disperato appuntamento d’amore, oltre i confini del tempo, che è “Per sempre”, del 1959, in memoria della moglie Jeanne morta da un anno:
Dopo i versicoli dell’Allegria, distillati per quintessenza dal simbolismo francese ed europeo, il poeta rientra nell’alveo accademico della tradizione italiana: un certo sentire barocco, che gli appartiene per istinto e anche per cultura (traduce da Gongora, Shakespeare, Racine), viene travasato entro le strutture ormai “archetipiche” del petrarchismo (dopo secoli di codificazioni stratificate e sbiadite imitazioni). La “restaurazione” operata con Sentimento del tempo determina un sovrappiù di forma che ingorga, offusca e, da ultimo, porta fuori strada il percorso aperto dalla scintillante e davvero creativa novità del Porto sepolto. Che il modo originario fosse il più conforme e congeniale alla sua verità di uomo e di poeta, lo si capisce dal fatto che Ungaretti lo conserva, nel corso degli anni, come metodo di lettura performativa. Talché anche il verso lungo (e l’endecasillabo, in particolare) delle raccolte successive, viene destrutturato, nell’atto della lettura ad alta voce, secondo il modello dell’Allegria. Come a dire che l’autentico Ungaretti è e resta il poeta dell’Allegria, anche quando scrive e poi legge pubblicamente testi che distorcono o contraddicono quelle originarie implicazioni. Si prenda ad esempio, da Il taccuino del vecchio, lo struggente e disperato appuntamento d’amore, oltre i confini del tempo, che è “Per sempre”, del 1959, in memoria della moglie Jeanne morta da un anno:
Senza niuna impazienza sognerò,
mi piegherò al lavoro
che non può mai finire.
E a poco a poco in cima
alle braccia rinate
si riapriranno mani soccorrevoli.
Nelle cavità loro
riapparsi gli occhi, ridaranno luce.
E, d’improvviso intatta
sarai risorta, mi farà da guida
di nuovo la tua voce,
per sempre ti rivedo.
 Ecco come la poesia si trasforma, per una lettura televisiva, nella dizione ansimante e pausata di Ungaretti:
Ecco come la poesia si trasforma, per una lettura televisiva, nella dizione ansimante e pausata di Ungaretti:
Senza niuna impazienza
sognerò
mi piegherò
al lavoro
che non può mai
finire
e
a poco a poco
in cima
alle braccia
rinate
si riapriranno
mani
soccorrevoli
nelle
cavità loro
riapparsi
gli occhi
ridaranno luce
e d’improvviso
intatta
sarai
risorta
mi farà
da guida
di nuovo
la tua voce
per sempre
ti rivedo.
 Il metro viene spezzato dal respiro della voce, nella sua misura organica, perché emerga la verità profonda delle parole, incise – queste più che mai! – nella carne dell’esistenza, del dolore e della memoria. La pausa isola la parola nella sua densità semantica. Il silenzio accentua, per contrasto, il suono della voce: ne esalta la magia, la persuasività. La voce può così manifestare il percorso spirituale della parola, afferrandone l’eco remota. Ungaretti cerca di catturare, nella dizione franta, il ritmo nativo ed essenziale della sua poesia, lasciando affiorare il chiarore dei sottotesti e consentendo di significarne la “verità” (su tutte le possibili letture).
Il metro viene spezzato dal respiro della voce, nella sua misura organica, perché emerga la verità profonda delle parole, incise – queste più che mai! – nella carne dell’esistenza, del dolore e della memoria. La pausa isola la parola nella sua densità semantica. Il silenzio accentua, per contrasto, il suono della voce: ne esalta la magia, la persuasività. La voce può così manifestare il percorso spirituale della parola, afferrandone l’eco remota. Ungaretti cerca di catturare, nella dizione franta, il ritmo nativo ed essenziale della sua poesia, lasciando affiorare il chiarore dei sottotesti e consentendo di significarne la “verità” (su tutte le possibili letture).
Anni erano passati, e vicende e tragedie Ungaretti aveva oltrepassato, evolvendo nel proprio percorso. Nuove opere, nuove ispirazioni, nuovi orizzonti. Eppure l’Ungaretti che recitava versi restava ancorato al tempo dell’Allegria, al modo di quel capolavoro, al bagliore folgorante del suo avvio. Era quella la voce “nativa” del poeta, ed egli fin da allora l’aveva conquistata, definitivamente, per sempre. Conservare così la voce più chiara, la più limpida, di cui era capace, gli serviva anche per sciogliere i grumi, le opacità della forma, nella vita pulsante della voce, dispiegata attraverso il rito divulgativo della lettura. Leggendola ad alta voce, Ungaretti estrae la propria poesia dal nodo semantico che ne racchiude il senso, dentro la profondità delle strutture. La poesia ermetica si “dis-ermetizza” nel fuoco liquido della voce. La poesia di Ungaretti, ermetica nello spazio bianco della pagina, cessa di esserlo nell’espressione totale della performance, nell’urgenza della sua vocalità.

 Dal 1901 al 2017 gli insigniti del premio sono stati 113,
Dal 1901 al 2017 gli insigniti del premio sono stati 113,





























































































































































La dimensione poetica della parola. Il suono che guarisce e che ricrea (Ariosto, Ungaretti, Zanzotto, d’Annunzio, Montale) Saggio di Marco Onofrio (Parte I)
Parnaso
I
Donde nasce la magia della parola poetica? Perché quelle parole, in quella sequenza, dentro quel verso, suonano in quel modo? Diversamente, cioè, da quando le troviamo isolate, a se stanti, sul vocabolario?
Prendiamo il celebre incipit leopardiano de La sera del dì di festa: «Dolce e chiara è la notte e senza vento». I due aggettivi donano un afflato rasserenante, rafforzato dalla congiunzione che chiude l’endecasillabo. Se proviamo a sostituire anche una sola parola, o a scompaginare l’ordine di quelle che ci sono, l’effetto non è più lo stesso: si spezza per sempre l’armonia melodica, la callida iunctura delle forme. Lo dice ad esempio Orazio Flacco, nell’Epistola ai Pisoni: una parola logora e pedestre riceve nuova luce a seconda delle virtù combinatorie cui è sottoposta, cioè della sua posizione nell’ordine della scrittura; così come una parola “nobile” può, per motivi opposti, infiacchirsi. Questione di alchimie, di energie che sprizzano dall’incontro sonoro delle parole, che sono vive, plastiche, malleabili come creta. La parola poetica, spesso avvincendo, avvolgendo sensualmente, cullando la percezione in termini di incanto, ci trasporta sotto il piano razionale della parola utilitaria, tipica del linguaggio-comunicazione. È un “massaggio acustico” che può liberare, come per una sorta di “regressione” freudiana, energie nascoste e associazioni latenti, comunicando l’inconoscibile e tentando di ristabilire l’armonia perduta: come una “lingua primordiale”.
LA GUERRA CHE VERRA’. Non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti.
La parola poetica s’iscrive in un sistema diverso da quello corrente. Il dire del poeta è ambiguo, irrazionale, evocativo. Talvolta neanche lui ha ben chiaro, se non a livello intuitivo, ciò che sta dicendo. Più che scrivere, è scritto dalla poesia che lo sceglie per manifestarsi. Ovviamente, dinanzi a contenuti così oscuri (l’altro, l’ignoto, il sublime), non gli basta più il linguaggio comune di stampo referenziale. Ha bisogno di inventarsi un’altra lingua, o almeno di forzare quella che già esiste. Una lingua con referente diminuito, o addirittura senza referente: che costruisce da sé altri e nuovi referenti. La poesia si produce, dunque, come “eversione” – voluta cercata organizzata dal poeta – rispetto al linguaggio di uso pratico. Il poeta trasforma dall’interno la parola, le fa dire e non dire e, in questo modo, esprimere più di quel che in prosa potrebbe. Egli oscilla di continuo fra due poli espressivi: la tentazione del canto (in cui le parole tendono a perdere il proprio valore significativo per suonare ed evocare attraverso un alone di suggestione sonora, ritagliandosi una frangia di senso che tocca più contenuti mentali non chiaramente comunicabili – l’istinto, l’inconscio, il preverbale – che l’intelletto) e la necessità del discorso (laddove deve emergere la chiarezza analitica dell’intelletto: necessaria ad esempio se vogliamo raccontare una storia in poesia).
Yeats and Eliot
Ciò che insomma distingue un testo poetico da un normale testo comunicativo, i Sepolcri di Foscolo dal bugiardino di un farmaco o dalla lista delle cose da comprare, è che nel testo poetico il “senso” nasce anche e soprattutto dal legame tra le unità che lo compongono, non solo dal loro significato. In poesia è più importante il “modo” che l’“oggetto”: più di cosa viene detto, come viene detto.
Precisa Gian Luigi Beccaria in un suo fondamentale saggio, L’autonomia del significante: «In poesia il significato del discorso non è mai in grado di accogliere tutto il senso (né lo è il significante da solo). Il senso poetico si compie nella combinazione di un significato calato in convenzioni ritmiche vincolanti e liberato in significazioni di suoni».
andrea zanzotto
Tutto è segno e senso in poesia: anche e soprattutto il suono. La poesia stessa è suono che produce conoscenza. Il suono e il ritmo della poesia hanno un valore iconico speciale, autonomo, determinante. Sono in grado di evocare e rappresentare essi stessi il significato della cosa. Ecco ad esempio come, in suoni scoppiettanti, rende il temporale Ariosto nel Furioso:
con tanti tuoni e tanto ardor di lampi
che par che ‘l ciel si spezzi e tutto avvampi
o, con lo sgusciar del ferro, il sibilo di una spada Pulci nel Morgante:
.
rizzossi in sulle staffe, e ‘l brando striscia
che lo facea fischiar come una biscia
zbigniev herbert
Così, senza ricalcare le suggestive arbitrarietà di Rimbaud, con la sua poesia sul colore delle vocali (e, per quella via, le astruse teorie dell’abbé Bremont), possiamo parlare di fonosimbolismo poetico, di significato referenziale dei suoni; per cui la [s], ad esempio, si presterebbe allo strisciare delle serpi, la [r] al fremito e al movimento, la [i] sembra più chiara di [u] e [o], ecc. Scrive Donatella Bisutti nel delizioso libro La poesia salva la vita: «una parola non è solo il significato di una cosa, ma anche un po’ l’immagine di quella cosa». Una parola come raffica, ad esempio, è veloce e turbina come un colpo di vento improvviso, grazie a quelle [f] che soffiano. Stuzzicare sembra qualcosa che punge, per via di quelle due [z] e di quella [i] sottile: come una zanzara. E ancora: farfalla, con quelle due [f] svolazzanti e quelle due [l] che la sostengono in volo, è «in realtà il perfetto ritratto di una farfalla». La poesia sa adoperare le parole come oggetti, come pennelli intrisi di colore, come tasti di un pianoforte. Ci sono parole «veloci o lente, leggere o pesanti, tenere o aspre, morbide o dure, carezzevoli o taglienti». Prescindendo dalla trascrizione onomatopeica dei suoni (si pensi a Pascoli e a Palazzeschi), leggiamo qualche magnifico esempio di significato rappresentato per vie irrazionali, anche e soprattutto attraverso il suono.
“La luna” di Andrea Zanzotto:
.
Luna puella pallidula,
Luna flora eremitica,
Luna unica selenita,
Distonia vita traviata,
Atonia vita evitata,
Mataia, matta morula,
Vampirisma, paralisi,
Glabro latte, polarizzato zucchero,
Peste innocente, patrona inclemente,
Protovergine, alfa privativo,
Degravitante sughero,
Pomo e potenza della polvere,
Phiala e coscienza delle tenebre,
Geyser, fase, cariocinesi,
Luna neve nevissima novissima,
Luna glacies-glaciei
Luna medulla cordis mei,
Vertigine
Per secanti e tangenti fugitiva
La mole della mia fatica
Già da me sgombri
La mia sostanza sgombri
A me cresci a me vieni a te vengo
Luna puella pallidula.
Eugenio Montale
Giuseppe Ungaretti
Il mare slavato e disilluso di Ungaretti:
.
Più non muggisce, non sussurra il mare,
Il mare.
Senza i sogni, incolore campo è il mare,
Il mare.
Fa pietà anche il mare,
Il mare.
Muovono nuvole irriflesse il mare,
Il mare.
A fumi tristi cedé il letto il mare,
Il mare.
Morto è anche lui, vedi, il mare,
Il mare.
W.H. Auden
(si noti l’eco del “mare”, ripetuta in a capo, che equivale all’inerzia stanca della risacca sul bagnasciuga, quando il mare è plumbeo, inerte, quasi fermo). La freschezza spumeggiante dell’onda di d’Annunzio:
Nasce l’onda fiacca,
subito s’ammorza.
Il vento rinforza.
Altra onda nasce,
si perde,
come agnello che pasce
pel verde:
un fiocco di spuma
che balza!
Ma il vento riviene
rincalza, ridonda.
Altra onda s’alza,
nel suo nascimento
più lene
che ventre virginale!
Palpita, sale,
si gonfia, s’incurva,
s’alluma, procede.
Il dorso ampio splende
come cristallo;
la cima leggiera
s’arruffa
come criniera
nivea di cavallo.
Il vento la scavezza.
L’onda si spezza,
precipita nel cavo
del solco sonora;
spumeggia, biancheggia,
s’infiora, odora,
travolge la cuora,
trae l’alga e l’ulva;
s’allunga,
rotola, galoppa;
intoppa
in altra cui ‘l vento
diè tempra diversa;
l’avversa,
l’assalta, la sormonta,
vi si mesce, s’accresce.
Di spruzzi, di sprazzi,
di fiocchi, d’iridi
ferve nella risacca;
par che di crisopazzi
scintilli
e di berilli
viridi a sacca,
O sua favella!
Sciacqua, sciaborda,
scroscia, schiocca, schianta,
romba, ride, canta,
accorda, discorda,
tutte accoglie e fonde
le dissonanze acute
nelle sue volute
profonde,
libera e bella
numerosa e folle,
possente e molle,
creatura viva
che gode
del suo mistero
fugace.
E lo sconquasso simbolico della “bufera” di Montale:
… e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere
dei tamburelli sulla fossa fuia,
lo scalpicciare del fandango, e sopra
qualche gesto che annaspa…
Nel messaggio poetico risulta dunque determinante l’aspetto fonico-timbrico della lingua. La poesia è, in questo senso, la risultanza dell’incontro-incrocio degli elementi metrici, ritmici e metaforici. Il piano dei significanti e quello dei significati sono i due poli entro cui oscilla mutevolmente l’ago della comunicazione poetica. Lo stesso ritmo si gioca nel conflitto perenne tra metro e sintassi: il discorso non coincide puntualmente con i versi, tende a forzarne la misura orizzontale in strutture foniche verticali, tessute di corrispondenze e bilanciamenti.
Condividi:Twitter
28 commenti
Archiviato in critica dell'estetica, il bello, poesia italiana del novecento
Con tag andrea zanzotto, Ariosto, Commento di Marco Onofrio, eugenio montale, Gabriele d'Annunzio, Giuseppe Ungaretti, il significante nel discorso poetico, La dimensione poetica della parola, Marco Onofrio