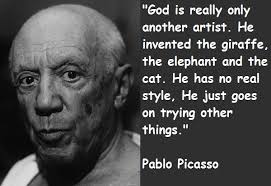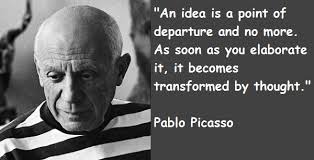“Veri sono solo i pensieri che non comprendono se stessi.”
“la pagliuzza nel tuo occhio è la migliore lente di ingrandimento.”
“L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità.”
“Il compito attuale dell’arte è di introdurre caos nell’ordine.”
Caro Mimmo Pugliese,
Questi aforismi di Adorno, tratti da Minima moralia del 1951, sono il miglior introibo che io possa fare alla tua poesia. Ai quali ci aggiungerei quest’altro di mia produzione: «Le parole hanno dimenticato le parole».
Mi chiedo come è possibile sostenere che il soggetto fondatore è indicibile (e quindi la parola è impronunciabile) e fare di questo indicibile il senso stesso del discorso poetico? Non si continua in tal modo a pensare a partire dagli stessi termini, ma capovolti?
La «traccia dell’origine», in Derrida, funzionerà esattamente come un che di originario: essa si produce occultandosi e diventa effetto; lo spostamento qui è produzione e riproduzione. La «traccia dell’origine» del linguaggio pascoliano che ha dato luogo al minimalismo maggioritario dei giorni nostri funzionerà esattamente come un «che» di originario, che si produce occultandosi, con il risultato di diventare effetto, lo spostamento qui è produzione e riproduzione di significazioni.
La non-adeguazione dell’originario a sé stesso attraverso un logos dell’originario è d’altronde una vecchia idea del proposizionalismo che si trova già in Descartes agli albori del Moderno, poiché la ratio cognoscendi non può porre in primo luogo ciò che è realmente primo; di qui il ritorno all’origine di certa poesia elegiaca che è sempre confortevolmente adeguata a se stessa. È qui che Mimmo Pugliese introduce uno scarto, una inadeguazione, una distanza.
È questo lo scotto che paga la poesia kitchen, di una permanente «inadeguazione» del discorso poetico ad approssimarsi ad un originario posto e/o supposto.
Il discorso poetico di Mimmo Pugliese non è più un voler/poter dire, un atto di potenza e di rappresentazione. È il discorso sotteso alla «Muta» di Raffaello: lei ci parla meglio e con più chiarezza di quanto possano parlarci le più belle parole dei poeti del suo tempo; mi chiedo: è possibile raffigurare in parole, o tramite i colori un soggetto che non può più parlare? È dicibile l’indicibile? È rappresentabile l’irrappresentabile? È questo il paradosso nel quale nuota la poiesis del moderno, il paradosso dell’Urlo di Munch, ma è un paradosso necessario alla poiesis.
Con concetti come quelli di «traccia» o di «differenza», si traduce lo scollamento del soggetto dall’enunciato, dal discorso stesso, di cui diventa impensabile che possa esserne il «Governatore». La «differenza» è questo scarto, questo recupero impossibile del soggetto da parte del soggetto incessantemente differito nel movimento del discorso rispetto a quello dell’originario. Il soggetto sarà parlato e significato in una catena di significanti, in una rete che lo dispiega e, nello stesso tempo, lo allontana. Lacan dirà il celebre motto secondo cui «il significante è ciò che rappresenta il soggetto per un altro significante»,1 che consacra la scissione del soggetto da sé stesso, come in Barthes, dove il soggetto non aderisce più al testo, di cui è solo «porta-voce» e non «autore» in senso teologico. Lacan fa del soggetto questa «presenza assente», questa rottura che fa sì che l’uomo non sia più segno, con un significante che si libera dal rapporto fisso col significato, e si indirizza dal suo luogo verso un altro luogo. Il soggetto è in questa traccia, nascosto in questo solco, che si sposta, che pronuncia quelle parole «mute».
Il soggetto è abilitato dal significante, dal segno che rimanda ad un altro segno. Nella misura in cui la poesia fa un uso logologico dell’io, la semantica diventa una mantica e la poesia si riduce a magia bianca. Quando invece è magia nera. Così, l’io prende il piffero e diventa un pifferaio magico, diventa altro da sé, avanza con la maschera dell’io che stabilisce la propria mono identità mediante la rimozione dell’altro da sé che egli è. La mono identità dell’io si realizza al prezzo del rimosso, o meglio, di quella parte del «sottosuolo» che è «il sottosuolo del sottosuolo». In tal modo risulta rimosso lo scarto retorico rispetto al sé, retorico perché l’identità è letterale più che figurata, quella letteralità che una posizione di poetica maggioritaria fa rientrare nel circolo dell’io positivizzato e privatizzato.
Gli adulti italiani del primo novecento educati alla poesia del Pascoli di Myricae (1891- 1903) avevano della poesia una rappresentazione illibata e intonsa, posizione che il Croce ha poi eternizzato nella famosa forbice dicotomica: o è poesia o non lo è, risolvendo a suo modo, in modo semplicistico e al modo del liberalismo italiano post-ottocentesco una questione che avrebbe dovuto comportare una ben altra problematizzazione. Quegli adulti poi sarebbero andati come ufficiali cadetti e soldati a invadere la Libia nel 1911 e poi nel 1936 in Spagna e a compiere massacri senza falsa coscienza e senza colpo feìrire… ammesso e concesso che le poesie del Pascoli avessero la funzione sanatoria di silenziare rimorsi (semmai ve ne fossero stati) e i dubbi sui massacri che gli italiani stavano compiendo. In modo analogo, gli adulti italiani del secondo novecento, senza compiere massacri e senza colpo ferire hanno raggiunto la dimensione del «dolore» privatizzato e pubblicizzato da mettere in vetrina su Facebook, su Twitter, su Istagram, su il Grande Fratello con un linguaggio bonificato, anestetizzato e lubrificato.
La poesia di Mimmo Pugliese è un binocolo che osserva da molto lontano il mondo ridotto a fumo e cenere che il minimo alito di vento farebbe volare via se non ci fosse il ferro di cavallo della colonna sonora della griglia pascoliana ma così scolorita da renderla, per fortuna, irriconoscibile e impalpabile; e infatti irriconoscibile lo è la poesia di Pugliese, proprio come tutta la poesia della natura de-naturata e della natura contro-formattata della migliore e consapevole poesia di oggidì che fa capo alla nuova fenomenologia del poetico, ovvero, la poetry kitchen.
Quanto appare nel discorso poetico di Mimmo Pugliese come evidenza è questo aver superato le resistenze che il soggetto (je) pone all’oggetto e al soggetto; lavorando ad assottigliare le difese del soggetto Pugliese ha incentivato la possibilità di recepire il discorso poetico come discorso dell’Altro, discorso di un Estraneo che è entrato nella tradizione e la rilegge a suo modo e con i suoi occhiali. È questo che caratterizza la libertà del discorso poetico di Pugliese, il suo non prestare più il fianco alla vulnerabilità del soggetto, l’aver reso il soggetto (je) un Altro che rilegge la poesia della tradizione.
L’io (moi), l’ego dell’immagine speculare, cioè quello del discorso poetico si oppone al soggetto (je) della parola degli altri, quello della tradizione; per dirla con Jacques-Alain Miller, «l’ombelico dell’insegnamento di Lacan».2 «L’io è», afferma Lacan, «letteralmente un oggetto – un oggetto che adempie una certa funzione che chiamiamo funzione immaginaria».3
Sappiamo che l’io costituisce un ostacolo al discorso del soggetto, che è il luogo in cui si esprime il desiderio. Lacan non cessa di sottolinearlo: il soggetto è un’interruzione, un oggetto inerte che si oppone alla tenace insistenza del flusso di parola inconscio che rischia di disturbare, mistificare, inquinare il discorso locutorio. Nella misura in cui il soggetto trae godimento, l’asse immaginario è pensato da Lacan come un ostacolo che perturba l’elaborazione simbolica, di cui l’io non ne vuole sapere. Il linguaggio poetico avviene sempre e soltanto allorquando si verifica una smagliatura nell’ordine del Simbolico, smagliatura attraverso la quale può fluire il linguaggio poetico.
Il discorso locutorio della poesia kitchen di Mimmo Pugliese è la voce dell’Estraneo che fa ingresso nel discorso poetico con le sue maschere, i suoi sosia, i suoi avatar e i suoi travestimenti. La tradizione è ciò che si oppone al soggetto (je), che fa resistenza… fino al punto di cedimento in cui accade una rottura delle resistenze del soggetto (je). Solo in questo momentum il discorso poetico può fluire.
La poesia di Mimmo Pugliese sembra partorita come dopo una esplosione di una bomba nucleare sporca, i significati antichi sono stati sporcificati e dissolti in una miriadi di equipollenze insignificanti… direi che la vera differenza tra la poesia Dada e la Poetry kitchen è la consapevolezza che i poeti kitchen hanno di essere insignificanti e di annunciare con i loro testi la venuta di un’età di coimplicazioni e di insignificanze gravemente negative per le conseguenze che queste caratteristiche possono avere sull’intera umanità.
Dal punto di vista della «bomba sporca» il linguaggio poetico appare come saltato in aria, dissolto in entità corpuscolari estreme; dal punto di vista della «bomba» il linguaggio umano e quello poetico hanno poco o nessun senso, dal nostro punto di vista invece: le cose del mondo di oggi si inscrivono all’interno di un collasso del simbolico, ma di tutto ciò sarebbe risibile e privo di senso accusare la poesia di esser diventata quello che è, la poesia è quello che è, punto e basta, non c’è una ragione oltre la ragione di essa. Nell’epoca contrassegnata dalla fine della metafisica la poesia viene respinta verso l’Esterno, la periferia dei linguaggi, i linguaggi in stato di relittualità e di luttuosità perdono le caratteristiche, diciamo, comunitarie, sociali per assolvere le funzioni proprie degli idioletti, a seguito di ciò i poeti vengono spinti e respinti verso le propaggini periferiche dei linguaggi e tendono a non essere più comunicativi… non comunicano più, e, in specie questo accade per i linguaggi poetici.
Heidegger in Essere e tempo (1927), instaura una vicinanza fra Stimmung (stato d’animo) e Stimme (la voce). Per Heidegger il Dasein viene richiamato dalla Stimme (la voce della coscienza) e dall’Angst alla Erschlossenheit (apertura), al suo “Da”.
La poetry kitchen è quell’evento che rende visibile come e quando si è infiltrata una estraneazione nel “Da”, uno spaesamento; una Spaltung che prende opera tra la Stimmung e la Stimme: la Stimmung non riconosce più la sua Stimme e va errando alla ricerca di una voce nella quale atterrare come un elicottero in avaria.
Giorgio Agamben annota che il pronome tedesco “Da” viene considerato nella linguistica di Emile Benveniste e di Roman Jakobson come uno shifter («indicatore dell’enunciazione», quelle speciali unità grammaticali contenute in ogni codice che non possono essere definite al di fuori del riferimento alla proposizione che li contiene). Per esso shifter non è possibile trovare un referente oggettivo poiché il suo significato si definisce solo in riferimento all’istanza di discorso che lo contiene. Questo indicatore, nel suo passaggio dalla indeterminatezza semantica alla significazione determinata, opera una articolazione dal piano della langue a quello della parole. Indica, innanzitutto, «che il linguaggio ha luogo». Dasein (letteralmente è il “Da”) vorrà allora dire l’«aver-luogo del linguaggio».
Nel punto in cui la possibilità che il “Da”, abbia la sua casa nel proprio luogo, questa possibilità viene assunta attraverso l’esperienza della morte nel modo più autentico, il “Da” si rivela allora essere il luogo da cui minaccia una «negatività radicale». L’interpretazione che ne dà Agamben è che per Heidegger la negatività entra nell’uomo attraverso l’«in-fanzia» in quanto l’uomo ha da essere questo «aver-luogo», questo fondamentale «evento del linguaggio», ciò a seguito del rapporto che lega la Stimme e la Stimmung nella forma dell’Angst; sono esse che intrattengono con il “Da” un rapporto di vicinanza. Per Agamben la Stimme rappresenta la modalità mediante la quale la tradizione ha pensato il linguaggio, ad essa si contrappone la Stimmung la sola che può invece dispiegare una dimensione linguistica nuova, autentica mediante l’esercizio storico della poiesis, infatti, nella poiesis non è scindibile la Stimme dalla Stimmung, l’una senza l’altra sono monche, ed entrambe, insieme e contemporaneamente, si ritrovano soltanto nell’evento del linguaggio poetico.
(Giorgio Linguaglossa)
.
1 Jacques Derrida, Della grammatologia, trad. di Rodolfo Balzarotti, Francesca Bonicalzi, Giacomo Contri, Gianfranco Dalmasso, Angela Claudia Loaldi, Milano, Jaca Book, 1969, p. 69.
2 J. A. Miller, Lettura critica dei complessi familiari di Jacques Lacan (2005), in J. Lacan, I complessi familiari nella formazione dell’individuo, Einaudi, Torino, 2005. p. 86.
3 J. Lacan, Seminario II, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2006 p. 56.
da Domani il giorno comincia un’ora prima (Progetto Cultura, 2023, pp. 100 € 12.00)
SANGUE DI PRUGNA
Dal sangue della prugna esce
sperduto uovo di aquila
Sepolta sul tombolo dalle gambe secche
conquistate dai ragni adesso che il giorno è ieri.
Ha scalato piramidi sentito ruggire il vulcano
visto navi salpare.
Sui tuoi gomiti c’è la lampada della sera,
ai bimbi presta i suoi dittonghi
Su ciniche scale musicali. Dondola sull’amaca,
Incanta le foglie dei gelsi rivolti al mare
Quando arriva primavera suona la banda,
perfora la luna una eco di aghi. Continua a leggere


















 Alcyone: la storia compositiva
Alcyone: la storia compositiva





 La condizione di poeta è perciò una condizione privilegiata: è il poeta il solo che può instaurare un rapporto confidenziale con la natura:
La condizione di poeta è perciò una condizione privilegiata: è il poeta il solo che può instaurare un rapporto confidenziale con la natura: