
Foto della collezione autunno-inverno 2021 che rappresenta Venere in paillettes
.
Le radici della poesia
di Marco Tabellione
Studiare la poesia rappresenta sempre un’avventura della mente, ma anche dello spirito e dell’emotività, come se l’arte delle parole riuscisse da sé a dare vita ad un universo globale e complesso, come se la poesia potesse davvero assurgere ad essere tra le arti la più capace a testimoniare l’integrità dell’essere umano, e il significato più profondo di ciò che è precipuamente umano. Del resto l’esaltazione di cui essa gode presso tutte le civiltà, ma anche il blasone che continua a conservare nella contemporaneità testimoniano appieno la sacralità di cui spesso l’arte poetica è rivestita. Per comprenderne le ragioni si può cercare di individuare alcuni autori che hanno tentato di evidenziare il percorso della poesia dalle sue origini, e di chiarirsi i motivi della sua nascita.-
Definire l’arte poetica è impresa a dir poco titanica, perché essa fa parte dei misteri dell’essere umano, in quanto ha accompagnato l’origine e lo sviluppo della civiltà. Giambattista Vico nella sua immensa opera La nuova scienza, tra le facoltà culturali umane pone la sapienza poetica al primo posto in ordine di nascita, molto prima delle altre discipline umanistiche o addirittura delle scienze esatte. L’idea di Vico è che il linguaggio poetico nasca contemporaneamente alla facoltà verbale dell’essere umano, o meglio ancora che il linguaggio nasca con caratteristiche poetiche. Lui immagina i primitivi, che chiama giganti (ma il riferimento è probabilmente alla mitologia greca, ad Esiodo per esempio che indica giganti e titani tra i primi nati dall’unione di Urano e Gaia) alle prese con i misteri e le paure del mondo, li immagina mentre fantasticano su dei e divinità per spiegare i pericoli e le difficoltà delle vite, mentre inventano svariate divinità attraverso cui sentirsi protetti, dalle quali anche farsi punire, nel tentativo di dare vita alle prime forme di organizzazione comunitaria e dunque di legge (Vico nota che Iovis il genitivo di Iuppiter, Giove in latino, ha la stessa radice di ius-iuris cioè legge o giustizia presso i romani). Li immagina passare dal linguaggio gestuale ai primi monosillabi, e successivamente alle prime parole con cui nominare le cose del mondo, sia esistenti sia non esistenti, li vede infine mentre fantasticano e creano l’idea di una trascendenza che possa indirizzarli e guidarli. Ed ecco il miracolo, il passaggio alla base delle culture: dall’ignoranza dei primitivi al sorgere delle prime curiosità, dalla paura e dal mistero suscitati dal mondo naturale alle prime idee di oltre, dimostrate dalla pratica della sepoltura, fino alla creazione delle prime religioni e delle prime cosmogonie. Nasce così non tanto la religione o la metafisica, quanto la poesia, e la poesia nasce come conoscenza, come prima forma di conoscenza che spalanca il campo appunto alla religione e alla metafisica.
È evidente in questa ricostruzione vichiana la presenza di una particolare idea di poesia, ciò la poesia come creazione, come fare, come dare vita dal nulla. Il linguaggio umano cioè diventa per i primitivi la dimensione dei primi significati da attribuire all’esistenza. Le idee sorgono innanzitutto come parole; è, cioè, il linguaggio, nella sua origine poetica, che dà vita ai significati, i quali non preesistono al linguaggio; e ciò diversamente da come sosterrà Husserl, padre della fenomenologia, secondo il quale invece i significati sarebbero indipendenti dal linguaggio, come dimostra il caso ricorrente in cui sosteniamo che abbiamo l’idea ma non ci viene la parola. Altri filosofi, al contrario di Husserl, proseguiranno sul solco di Vico, fino al caso estremo di Jacques Derrida che sosteneva che “tutto è linguaggio”. Per Vico indubbiamente se non tutto è linguaggio, sicuramente vale il principio espresso nel vangelo di san Giovanni, secondo il quale come è noto “In principio era il verbo, e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio”. Sappiamo che per Vico tale impostazione (di significato primariamente teologico) vale nel senso del carattere iniziatico che il linguaggio avrebbe nella sua origine appunto poetica, tanto che la lingua costituirebbe lo scopo stesso del pensare umano, o meglio pensiero e linguaggio sarebbero in sostanza la stessa cosa, come è anche nell’idea dei greci che utilizzano la parola logos per indicare entrambi.
Gli stessi greci inoltre ci offrono etimologicamente la parola che noi utilizziamo per indicare poesia, cioè poiesis, che vuol dire appunto creare, e che ci permetterebbe di vedere nel poeta soprattutto il creatore, come creatori di linguaggio e pensiero furono i primi parlanti. Il poeta, cioè, secondo questa visione sarebbe un creatore, e creatori di linguaggio e dunque di poesia furono gli arcaici uomini preistorici che diedero vita alle prime forme verbali, probabilmente per costruzione onomatopeica.
Vico, a questo proposito, addirittura sostiene che le idee non nascono prima del linguaggio, sarebbero piuttosto conseguenti al linguaggio, perché la concretezza fisica, a cui i giganti primitivi erano legati, li avrebbe portati a creare prima il verbo fisico e poi le idee spirituali, i concetti. Va detto però che tale idea di poesia non è la sola avvallata dalle tradizioni e dalle civiltà che si sono susseguite nei secoli. Il romanticismo, ad esempio, ha sì mantenuto l’esaltazione della creatività del poeta, ma lo ha considerato come una specie di invasato, di posseduto dal linguaggio poetico, che sorge nella sua mente per servirsi di essa quasi come strumento, secondo una visione che tende a considerare il poeta come un mezzo della lingua e non viceversa. In base a questa interpretazione, la visione del poeta muove sempre da una ispirazione; è il sorgere misterioso e spontaneo dell’empito creativo che determina il primo germe del fare poetico, e l’ispirazione non nasce dalla individualità cosciente del poeta, da una sua volontarietà, piuttosto gli viene regalata.
Non per niente, Dante nel primo canto del Paradiso chiede ad Apollo di ispirarlo, di offrigli una sorta di apporto divino, la vocazione profonda dell’arte delle parole di cui Apollo è protettore. Lo invoca perché Dante sa che da solo non è affatto in grado di dare un resoconto seppur sommario della sua estatica esperienza paradisiaca, poiché, dice in sostanza l’Alighieri, con le sole armi della poesia come arte, come tecnica (l’un giogo di Parnaso) non si potrebbe dare inizio a questo, per altro inutile e fallito in partenza, tentativo di dire l’esperienza del divino. A monte della creatività poetica, c’è dunque l’ispirazione, non sono l’abilità creativa, anzi la sorgente stessa dell’afflato poetico non è che in questo monito linguistico e immaginativo che sembra nascere indipendentemente al di fuori.
Ma che cos’è allora questo originario germoglio poetico? Difficilissimo dirlo, a meno che non ci si rivolga ad Heidegger, il quale, come ha ricordato Massimo Cacciari in molte conferenze dedicate all’unicità del linguaggio poetico, per le ragioni sopra esposte non utilizza il termine di origine greca poesie, ma quello latino di Dichtung, che potremmo tradurre con “dettato”. Il poeta cioè ubbidisce ad un dettato interiore, e ciò è lo stesso Dante ad affermarlo quando, dopo aver incontrato nel Purgatorio il poeta pre-stilnovista Bonagiunta Orbicciani, che gli chiede da dove derivi il suo “dolce stil novo”, risponde facendo proprio riferimento ad un dettato interiore “Io sono uno che come detta il cuore scrive” (alla lettera: “I’ mi son un che, quando Amor mi spira, noto, e a quel modo ch’e’ ditta dentro vo significando”).
Scrivere o meglio ancora poetare, secondo questa visione non vuol dire tanto creare, cioè plasmare, mettere in atto un’abilità, un fare (poiesis appunto), ma vuol dire seguire un dettato, ubbidirgli addirittura, e non per niente il temine Dichtung etimologicamente si ricollega anche a quello di dictator, che a Roma designava la carica temporanea di sei mesi assunta in caso di pericolo per le istituzioni, termine dal quale poi deriva quello spregiato di “dittatore”. Per Heidegger la Dchtung è innanzitutto linguaggio, linguaggio però che si detta, si dà all’ascolto del poeta, per cui essere poeta vuol dire primariamente ascoltare e non parlare, vuol dire cioè ascoltare un linguaggio interiore. L’idea di linguaggio interiore fu formulato tra i primi da Vygotskij, linguista russo vissuto durante la dittatura staliniana e affidato allo studio di bambini problematici, il quale mise in relazione l’acquisizione dall’ambiente culturale di stimoli linguistici, da rielaborare individualmente, con i progressi dell’apprendimento. Su un versante ancora più misterioso e ovviamente metafisico Heidegger giunse ad individuare addirittura una completa identità tra il linguaggio interiore e l’essere stesso, vedendo nel linguaggio “la casa dell’essere”.
Nella visione di Heidegger il linguaggio, e ancor più il linguaggio poetico, non sarebbe solo uno strumento di comunicazione o espressione, ma sarebbe la fonte stessa delle idee, la forma materica che permette la nascita delle idee, le quali non preesistono al linguaggio e, rappresentando la fonte stessa della coscienza, sarebbero collegate con l’essere profondo dell’uomo fino ad influenzarlo radicalmente. Poetare dunque non vorrebbe dire solo fare, creare (poiesis) vuol dire innanzitutto immaginare il linguaggio, cioè rispondere alla Dichtung che abita ognuno di noi, e dunque in ultima istanza poetare vuol dire essere contattando l’essere. È probabilmente lo stesso tipo di identità tra linguaggio ed essere che spingeva Rimbaud ad affermare “io non penso ma sono pensato”. Come è noto Rimbaud appena adolescente paragonò il poeta ad un veggente, sottolineando la necessità di un’azione poetica che fosse innanzitutto aperta all’ascolto, e successivamente dialogo della ragione con questa matrice profonda dell’essere umano. Le Illuminations già dal titolo sottolineano questa specie di accensione di luce che la poesia comporta, in un senso che non coincide ovviamente con l’amissione razionalistica dell’illuminismo, il quale utilizzò la metafora già religiosa della luce, in un’accezione laica se non addirittura ateistica, per indicare la funzione totalizzante della ragione. In Rimbaud torna il significato mistico dell’illuminazione, nella quale però la ragione non è abolita, ma dialoga con le profondità dell’essere umano.
Dunque Poiesis o Dichtung? Entrambi si dovrebbe dire, nel senso che, essendo artista, anche il poeta si muove in un ambito di abilità, linguistiche o metriche o musicali, le quali abilità richiedono talento ed estro. Pur tuttavia è evidente che senza l’ispirazione originaria l’arte diventerebbe ben poca cosa; in fondo è lo stesso Dante a riconoscerlo, quando nel citato primo canto del Paradiso chiede ad Apollo di assisterlo con entrambi “i gioghi del Parnaso”, perché ora l’autore della Divina Commedia confessa di aver bisogno soprattutto dell’ispirazione per poter proseguire.
L’esistenza di un monumento linguistico letterario nel profondo di ogni essere umano, per cui essere poeti e scrittori vuol dire appunto attingere da questo spazio di ricchezza, può essere comprovata dalla teoria di Jung sull’inconscio collettivo. Jung chiama in causa gli archetipi, e li riprendi da quelli che Freud invece tratta come simboli arcaici. Si tratta di componenti psichici collettivi, derivati da sedimenti che non interessano le individualità in quanto tali, ma in quanto individualità appartenenti al genere umano. Il modo che l’inconscio ha di rivelare tali archetipi assomiglia moltissimo al linguaggio simbolico della poesia, tanto da autorizzare a dire che si tratta dello stesso tipo di meccanismo psicologico e linguistico.
Jung sostiene che molti simboli onirici, i quali si rivelano nei sogni delle persone, non possono essere spiegati solo con le vicissitudini del singolo, ma rimandano ad un sostrato collettivo, dal quale il nostro inconscio attinge per le sue formazioni simboliche. Questa comune radice linguistico-simbolica, che risiede nell’uomo un po’ come gli istinti che agiscono negli animali – istinti il cui sorgere misterioso è utilizzato da Jung per motivare il sorgere altrettanto misterioso degli archetipi umani – questa radice archetipica, si diceva, non solo ha anche fare con le formazioni mitologiche dei popoli arcaici, ma appare vicina alla radice stessa della poesia. In un certo senso Vico anticipa Jung, quando descrive la nascita della propensione linguistica nell’essere umano definendola poetica a priori, e probabilmente il filosofo napoletano si riferisce inconsapevolmente ad un motivo arcaico, una tendenza simbolica e immaginativa, non lontana dalla dimensione psichica in cui si formarono gli archetipi collettivi junghiani.
Fase generativa, misteriosa e arcana, la quale ha a che fare con esperienze che Vico definisce divinatorie, e che investono le prime due età della storia umana individuate dall’autore della Scienza nuova, vale a dire quella sacra e quella eroica, dominate rispettivamente dalla percezione sensoriale e da quella sentimentale e passionale, mentre raziocinio e consapevolezza logica sarebbero state acquisite dall’uomo solo durante un terzo stadio. In definitiva nel secondo periodo quando l’uomo è già immerso in una configurazione passionale e sentimentale della propria visione del mondo, la necessità relazionale avrebbe spinto i nostri antenati ad elaborare la dimensione linguistica grazie alla quale sarebbero giunti a nominare e a significare la realtà, a determinare la coscienza – cioè una consapevolezza sempre più progredita sul mondo – e a produrre quell’incredibile creazione affabulatoria che darà vita alla mitologia e alle religioni, che a loro volta contribuiscono a rimpinguare la coscienza stessa.
Ma, lo ripetiamo, questa straordinaria sequenza sorge da un atteggiamento iniziale e iniziatico che è già poetico, è già poesia. Ecco perché Heidegger sosterrà che la poesia prima di creare ascolta; dal silenzio, come direbbe Ungaretti, essa tira fuori le parole e i loro connotati simbolici per offrirli alla collettività, e riesce a farlo perché attinge da un tesoro che è a sua volta collettivo, se ha ragione Jung quando parla di inconscio collettivo e va a riscoprire i miti antichi per avere conferma delle sue intuizioni. Scrivere poesia, adagiarsi sul linguaggio interiore, farlo parlare, non vuol dire solo dare vita ad un’esperienza artistica o estetica, o peggio semplicemente culturale, vuol dire contattare l’essere nella sua forma più pura, secondo quelle coordinate che Karl Jaspers, forse più di Heidegger, ha proposto. In Metafisica Jaspers sostiene che se l’esser-ci, la nostra sola sola possibilità di vivere l’essere, cioè essere qui e ora, viene vissuto nella consapevolezza della resa al mondo, cioè nella forma della contemplazione, allora l’essere, che è trascendenza ma anche immanenza, può davvero rivelarsi a noi, possiamo davvero cogliere “la meraviglia dell’essere” nonostante la nostra condanna alla consunzione, cioè al vivere per morire, ciò che il filosofo tedesco chiama “naufragio”. Ma questo cammino finale, questo incontro con l’essere è appunto la grande tentazione della poesia e del linguaggio, è la sua finalità fin dagli albori linguistici; è l’obiettivo di “dire l’essere”, che la poesia continua a perseguire da sempre, fallendo ogni volta e ogni volta ricominciando, come “Adamo che dà il nome alle cose”.
.







 Marco Tabellione (5.5.1965), laureato nel ’91 in lettere moderne all’università “G. D’Annunzio” di Chieti, con una tesi sulle avanguardie poetiche degli anni Sessanta, specializzato alla LUISS di Roma in giornalismo. Collabora con quotidiani e riviste letterarie nazionali e insegna materie letterarie. Vincitore a Perugia nel 1990 del premio di poesia intitolato a Sandro Penna, nel 1998 ha vinto il premio “Giovani autori” curato dalla Fondazione Caripe di Pescara, mentre nel 1999 il premio “Palazzo Grosso” di Riva presso Chieri (Torino) con il volume di poesie Incanti. Nel 2003 con la raccolta Tra cielo e mare è stato tra i vincitori del concorso “Adottiamo uno scrittore” indetto dalla provincia di Pescara, e nel 2004 si è classificato secondo al premio abruzzese Sant’Egidio indetto dalla cooperativa Tracce di Pescara. Per le edizioni Tracce di Pescara ha pubblicato nel 1995 la raccolta di poesie Gli uni e gli altri bui e il saggio sul giornalismo televisivo L’immagine che uccide. Nel 1998 è stata pubblicata la raccolta di poesie InCanti, sempre per le edizioni Tracce, mentre nel 2000 le edizioni Samizdat di Pescara hanno curato la raccolta di versi, L’alba e l’ala. Nel 2001 è uscito il suo primo romanzo Il riso dell’angelo per le edizioni Tracce, mentre risale all’anno 2002 il saggio di letteratura La cura dell’attimo edito da Samizdat di Pescara. Nel 2003 è uscita l’ultima raccolta di poesie intitolata Tra cielo e mare e pubblicata anch’essa da Tracce. Nel 2009 è uscito il romanzo L’isola delle crisalidi per le edizioni Runde Taarn, che nel 2010 ha vinto il premio Zenone riservato alla narrativa. Lo stesso romanzo L’isola delle crisalidi nel 2010 è risultato finalista al premio Lamerica e ha vinto il premio speciale della giuria al premio De Lollis. Nel 2011 ha vinto il premio di poesia Spinea e nel 2012 è giunto secondo al premio “Liliana Bragaglia” con il racconto inedito La bottega del libraio. Infine nel 2013 ha vinto il premio di giornalismo sezione ambiente “Vivi l’Abruzzo”. Nel 2015 è uscito il suo ultimo libro, il saggio Il canto silenzioso, viaggio nei segreti della poesia (edizioni Solfanelli) premiato nello stesso anno al premio di saggistica Città delle Rose di Roseto e finalista al premio Roccamorice. Nel 2016 il racconto L’uomo che decise di morire sulla Maiella ha ottenuto il premio speciale della giuria al premio sulla Letteratura paesaggistica. Nel 2017 è giunto terzo al premio nazionale di poesia di Civitaquana e la raccolta inedita Ogni voce si è classificata seconda al premio Pablo Neruda. Nel 2018 il volume di versi L’eternità dell’acqua (2017) è risultato vincitore del primo premio per la poesia alla rassegna dell’editoria abruzzese e nel 2019 ha conseguito il premio Maiella per la poesia, con la raccolta inedita Ogni voce il primo premio al concorso Il parco di Antonino. Nel 2021 è uscito il suo ultimo romanzo La vita che non muore per le edizioni Il viandante.
Marco Tabellione (5.5.1965), laureato nel ’91 in lettere moderne all’università “G. D’Annunzio” di Chieti, con una tesi sulle avanguardie poetiche degli anni Sessanta, specializzato alla LUISS di Roma in giornalismo. Collabora con quotidiani e riviste letterarie nazionali e insegna materie letterarie. Vincitore a Perugia nel 1990 del premio di poesia intitolato a Sandro Penna, nel 1998 ha vinto il premio “Giovani autori” curato dalla Fondazione Caripe di Pescara, mentre nel 1999 il premio “Palazzo Grosso” di Riva presso Chieri (Torino) con il volume di poesie Incanti. Nel 2003 con la raccolta Tra cielo e mare è stato tra i vincitori del concorso “Adottiamo uno scrittore” indetto dalla provincia di Pescara, e nel 2004 si è classificato secondo al premio abruzzese Sant’Egidio indetto dalla cooperativa Tracce di Pescara. Per le edizioni Tracce di Pescara ha pubblicato nel 1995 la raccolta di poesie Gli uni e gli altri bui e il saggio sul giornalismo televisivo L’immagine che uccide. Nel 1998 è stata pubblicata la raccolta di poesie InCanti, sempre per le edizioni Tracce, mentre nel 2000 le edizioni Samizdat di Pescara hanno curato la raccolta di versi, L’alba e l’ala. Nel 2001 è uscito il suo primo romanzo Il riso dell’angelo per le edizioni Tracce, mentre risale all’anno 2002 il saggio di letteratura La cura dell’attimo edito da Samizdat di Pescara. Nel 2003 è uscita l’ultima raccolta di poesie intitolata Tra cielo e mare e pubblicata anch’essa da Tracce. Nel 2009 è uscito il romanzo L’isola delle crisalidi per le edizioni Runde Taarn, che nel 2010 ha vinto il premio Zenone riservato alla narrativa. Lo stesso romanzo L’isola delle crisalidi nel 2010 è risultato finalista al premio Lamerica e ha vinto il premio speciale della giuria al premio De Lollis. Nel 2011 ha vinto il premio di poesia Spinea e nel 2012 è giunto secondo al premio “Liliana Bragaglia” con il racconto inedito La bottega del libraio. Infine nel 2013 ha vinto il premio di giornalismo sezione ambiente “Vivi l’Abruzzo”. Nel 2015 è uscito il suo ultimo libro, il saggio Il canto silenzioso, viaggio nei segreti della poesia (edizioni Solfanelli) premiato nello stesso anno al premio di saggistica Città delle Rose di Roseto e finalista al premio Roccamorice. Nel 2016 il racconto L’uomo che decise di morire sulla Maiella ha ottenuto il premio speciale della giuria al premio sulla Letteratura paesaggistica. Nel 2017 è giunto terzo al premio nazionale di poesia di Civitaquana e la raccolta inedita Ogni voce si è classificata seconda al premio Pablo Neruda. Nel 2018 il volume di versi L’eternità dell’acqua (2017) è risultato vincitore del primo premio per la poesia alla rassegna dell’editoria abruzzese e nel 2019 ha conseguito il premio Maiella per la poesia, con la raccolta inedita Ogni voce il primo premio al concorso Il parco di Antonino. Nel 2021 è uscito il suo ultimo romanzo La vita che non muore per le edizioni Il viandante.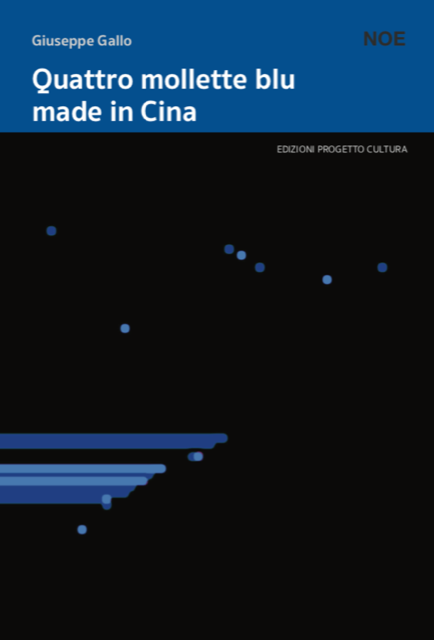






























 Care amiche, cari amici che mi seguite sempre con interesse e affetto, oggi vorrei parlarvi di un progetto a cui ho pensato di recente, un progetto a cui tengo molto, perché si propone di riunire in sé due arti, cinema e poesia, apparentemente diverse tra loro, ma in realtà, come vedremo, assai affini.
Care amiche, cari amici che mi seguite sempre con interesse e affetto, oggi vorrei parlarvi di un progetto a cui ho pensato di recente, un progetto a cui tengo molto, perché si propone di riunire in sé due arti, cinema e poesia, apparentemente diverse tra loro, ma in realtà, come vedremo, assai affini.















 Giorgio Linguaglossa
Giorgio Linguaglossa














 Tomas Tranströmer
Tomas Tranströmer
 Commento di Giorgio Linguaglossa
Commento di Giorgio Linguaglossa
















 2
2


















































 Psicoanalisi, Sociologismo e Neoempirismo nel XX sec. hanno dato il colpo di grazia ad una concezione unitaria del Soggetto, nonostante che la Critica kantiana avesse recuperato a livello trascendentale il primato del Soggetto (“L’io penso” legislatore), smontando la critica humiana come affrettata e incauta. Non si tratta più del soggetto individuale ma di una Soggettività trascendentale. Le forme del conoscere (e poi dell’agire) sono a priori, operano indipendentemente dall’esperienza e ne costituiscono la precondizione universale e necessaria. Il trascendentale (da non confondere con il trascendente) della Soggettività è un modo di conoscere gli oggetti, i fenomeni, grazie alle intuizioni di spazio e di tempo e a categorie (attività a priori) comuni a tutti gli individui. Il Soggetto si rivela ancora una volta, dopo Cartesio “legislatore della natura”, una Volontà, un “Volo”, più che un “Cogito”. Da questa radice, cioè a partire dalla Rivoluzione scientifica, nasce quindi il carattere impositivo della tecno-scienza e della cultura occidentale tout court. Cosa che, se pure in altri termini, è stata evidenziata da Heidegger, con il concetto di Gestell, da Nietzsche con la “volontà di potenza”.
Psicoanalisi, Sociologismo e Neoempirismo nel XX sec. hanno dato il colpo di grazia ad una concezione unitaria del Soggetto, nonostante che la Critica kantiana avesse recuperato a livello trascendentale il primato del Soggetto (“L’io penso” legislatore), smontando la critica humiana come affrettata e incauta. Non si tratta più del soggetto individuale ma di una Soggettività trascendentale. Le forme del conoscere (e poi dell’agire) sono a priori, operano indipendentemente dall’esperienza e ne costituiscono la precondizione universale e necessaria. Il trascendentale (da non confondere con il trascendente) della Soggettività è un modo di conoscere gli oggetti, i fenomeni, grazie alle intuizioni di spazio e di tempo e a categorie (attività a priori) comuni a tutti gli individui. Il Soggetto si rivela ancora una volta, dopo Cartesio “legislatore della natura”, una Volontà, un “Volo”, più che un “Cogito”. Da questa radice, cioè a partire dalla Rivoluzione scientifica, nasce quindi il carattere impositivo della tecno-scienza e della cultura occidentale tout court. Cosa che, se pure in altri termini, è stata evidenziata da Heidegger, con il concetto di Gestell, da Nietzsche con la “volontà di potenza”.



















































































































































Poesie e Commenti di Andrea Emo, Donatella Giancaspero, Letizia Leone, Gino Rago, Giuseppe Gallo, Lorenzo Pompeo, Alfonso Cataldi, Francesco Paolo Intini, Giorgio Linguaglossa
Donatella Giancaspero
Alla fine di aprile
L’intenzione di dire. Il fenomeno nuovo. L’evento.
Ma, di colpo, cade dalle mani la tazzina di porcellana.
Attraversando un flash, tocca il fondo.
Una lesione sul bordo per gli anni a venire.
A pranzo, in cucina, la sedia occupa il posto estraneo.
Sfilano i bar di passaggio. Le arance spremute nei vetri opachi.
Da un isolato all’altro, le parole sbirciano vetrine
– “per caso, senza l’idea di comprare qualcosa.
Cercando, magari una volta soltanto
e fuori stagione, un gelato al limone…”
Alla fine di aprile, i gabbiani qua intorno. Tanti.
Sui tetti. In cima ai comignoli. Appollaiati.
Chi punta il dito, in un ritaglio tondo di cielo
.
Letizia Leone
Epopea di cose solide e impermeabili al canto.
Le scale al buio fino al terzo piano. L’interruttore della luce del 1944.
Ecco la stanza. È una notte a pendolo di lampadina nuda e fogli di quaderno
Non numerati con la fossa in un rigo. Se leggi:un pensiero ti cade dall’occhio.
Alla parete un segno, un rosso, il tocco vermiglio di un frutto
Illividito tra le pere. La stagione della semina dei morti…da mano a mano
Da esiliato a esiliato.
.
Andrea Emo
Il pensiero e l’immagine
Non è vero che la poesia sia pura fantasia, pura immagine, che la filosofia sia puro pensiero. L’immagine senza pensiero è vuota, il pensiero senza immagine è muto. Ciò che non si saprà mai è questo: quale dei due sia l’origine o la speranza dell’altro. Ma questo è forse necessario. Poiché se il pensiero, guardandosi non vedesse in sé, come suo fine, l’immagine, e l’immagine, guardandosi, non vedesse in sé, come suo fine, il pensiero, forse all’uno e all’altra potrebbe sembrare di essere fondamento, costruzione o conclusione del tutto. Ma questo loro reciproco esser fondati sull’altro fa a noi intendere come pensiero e immagine siano la forma umana della contemplazione, che muta volto e delude se stessa.
(Q. 7, 1929)
Ogni immagine è immagine del nulla. E in questo senso l’immagine è ontologica.
(Q. 214, 1959)
In principio era l’immagine, e per mezzo di essa tutte le cose furono fatte. L’immagine è in principio (creatrice e creatura della propria negazione) quale può essere la causa dell’immagine? Forse soltanto la sua negazione; tutto ciò che è originato dalla sua negazione (come l’individuo, l’attualità) è originario, è in principio, ed è un principio. L’espressione non può essere poetica quando è originata da una causa o da un’intenzione. L’espressione deve essere originata soltanto dalla rinuncia ai suoi fondamenti, ad ogni fondamento, ad ogni causa e ad ogni effetto.
(Q. 288, 1965)
L’immagine è per definizione pallida, diafana, trasparente, ma essa non è astratta.
(Q. 306, 1967)
L’immagine, come la vita, è Ifigenia e Fenice – è sacrificio e resurrezione – un mistero che celebriamo in ogni istante con la respirazione, con il fuoco interiore che ci brucia. (Q. 319, 1968/1969)
Andrea Emo, In principio era l’immagine (A cura di Massimo Donà, Romano Gasparotti e Raffaella Toffolo), Bompiani, 2019.
Gino Rago
“Se vuoi sapere
qualcosa dei pini –
vai dai pini.”
Era solito dire Matsuo Bashō; così è mi pare per i versi di Mauro Pierno.
Se vuoi sapere qualcosa della poesia di Mauro Pierno devi andare nei suoi intimi interstizi fra silenzio primordiale e parola di poesia, silenzio e parola che nelle spighe e nei papaveri rossi dell’ultimo distico trovano i loro simboli o meglio i loro eliotian-montaliani correlativi oggettivi. Il tutto, ha pienamente ragione l’amico Linguaglossa quando lo sottolinea nella sua ermeneutica,
confrontato, misurato con un tempo proposto sempre come ‘presente’.
Se Mauro Pierno decidesse infine di eliminare i numeri, da 1 a 10, questo suo lavoro che riproposto in distici ha una resa estetica travolgente potrebbe essere letto come un poema per omogeneità di lingua, di ritmi, di sillabazione stessa dei versi. Un poema, per omogeneità fono-prosodica dei distici. Se vuoi sapere qualcosa dei pini vai dai pini…
.
Giuseppe Gallo
Il problema, carissimo Gino Rago, è che io non voglio più “sapere qualcosa dei pini…”, e ritengo che nemmeno a Pierno interessino, in prima istanza, né la “Primavera!”, né le “spighe… accorte” e tanto meno i “papaveri rossi”… ma solo il loro lato oscuro: il loro “esaurimento”. Segnalo una serie di sintagmi tratti dai versi di Mauro: “Improponibile”, “Stento la
mia”, “Sbarramenti”, “Poco sangue”, “Saranno rimasti in dieci…”, “Liberi di frenare”, “un vortice di consolanti nubi”, “un antefatto”, “Un apriscatole che gira nelle mani e non affonda…” e così via di seguito. In ogni concetto e in ogni immagine c’è qualcosa di non concluso… il vuoto si restringe sempre di più, ma il cerchio non si chiude mai! Né nell’Essere, né nel nichilismo. C’è sempre una percentuale di “residua commutazione”. Direi di più… Mauro Pierno afferma che di questa “batteria esausta”, che è l’uomo, e questa metafora sì, che mi interessa, sopravvive “solo l’8 %”. Soltanto un elemento fuoriesce dall’ambiguità, la pulvis, di cristiana memoria, la polvere… soltanto questa è “esattamente” quello che è, sia nello scorrere che nel diventare: il presente dell’uomo!
Grazie, Pierno! Continua a leggere →
Condividi:Twitter
15 commenti
Archiviato in critica dell'estetica, critica della poesia, Senza categoria
Con tag Alfonso Cataldi, Derrida, Donatella Giancaspero, Francesco Paolo Intini, Gianni godi, Gino Rago, giorgio linguaglossa, Giuseppe Gallo, letizia leone, Lorenzo Pmpeo, nuova poesia polittico, poesia polittico, Poesie e Commenti di Andrea Emo