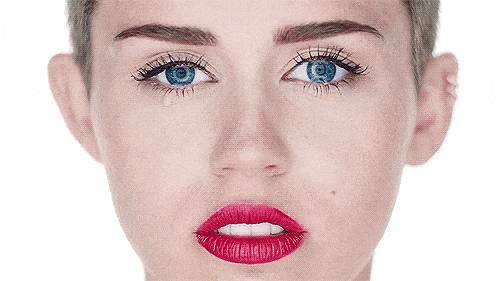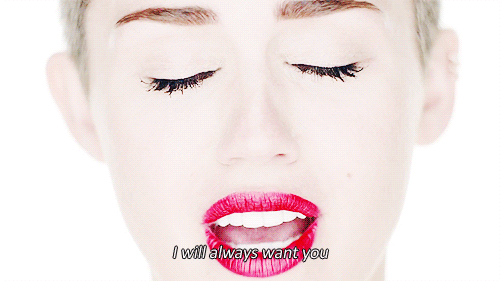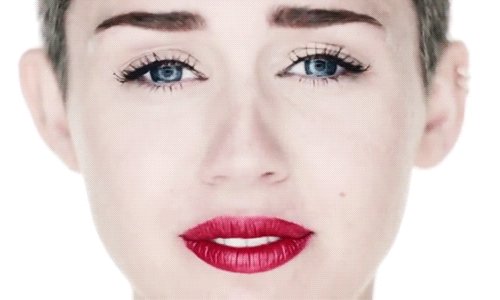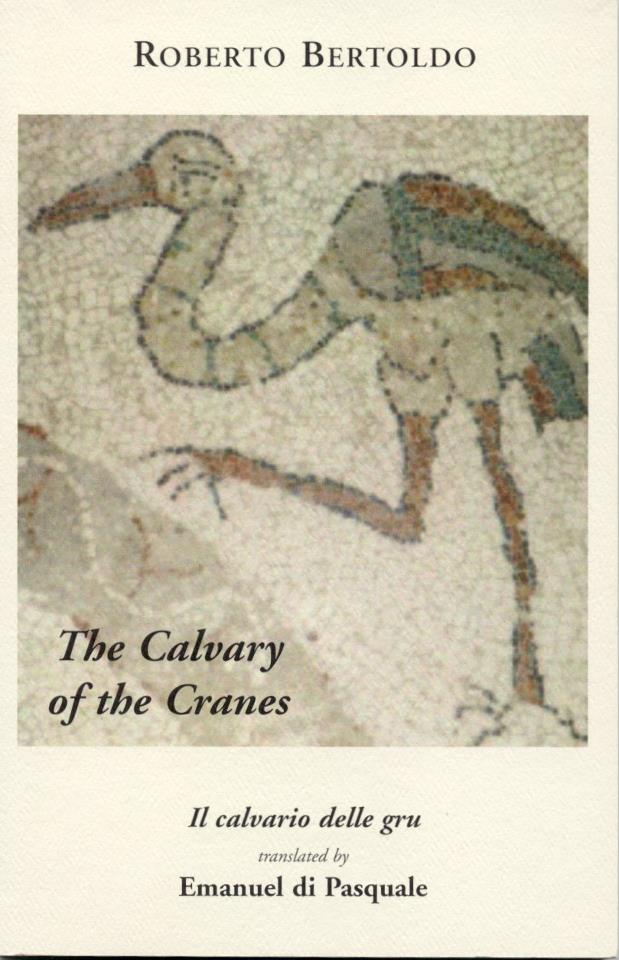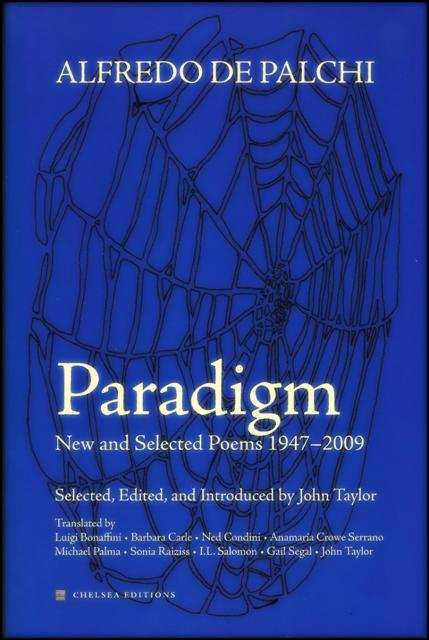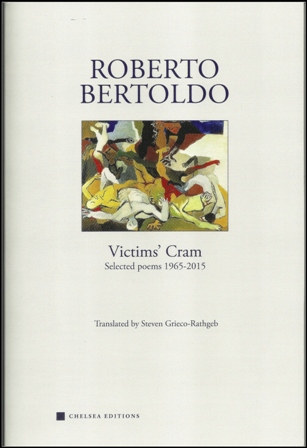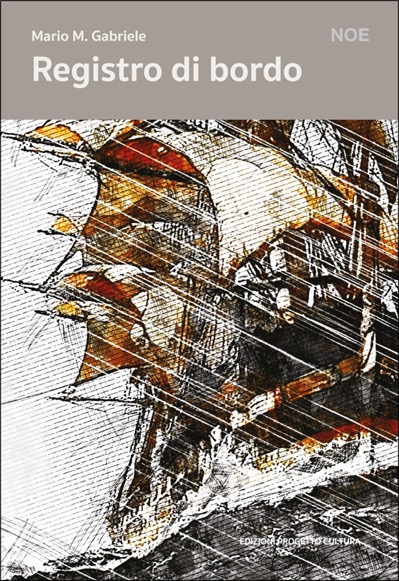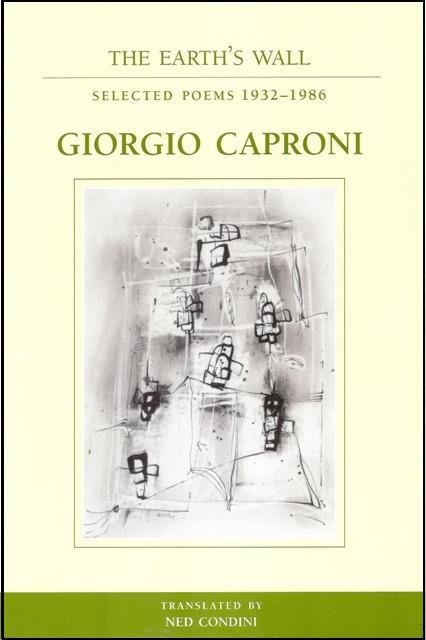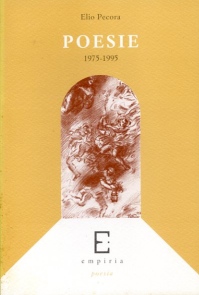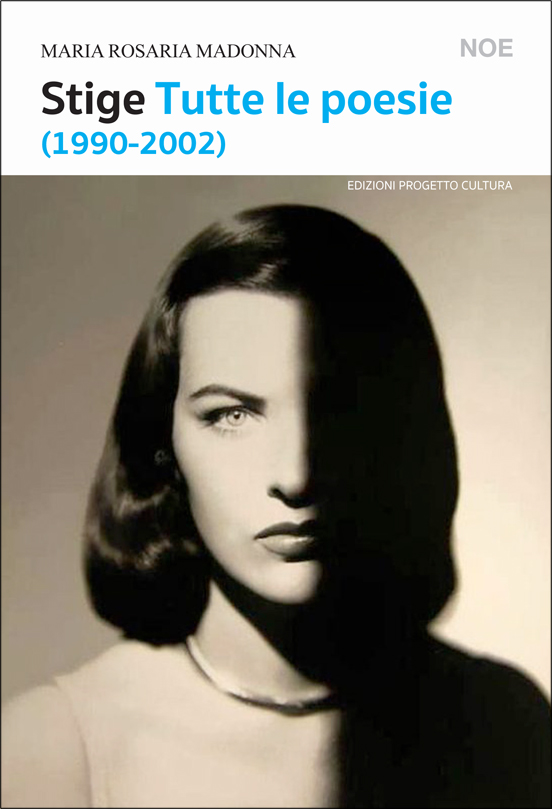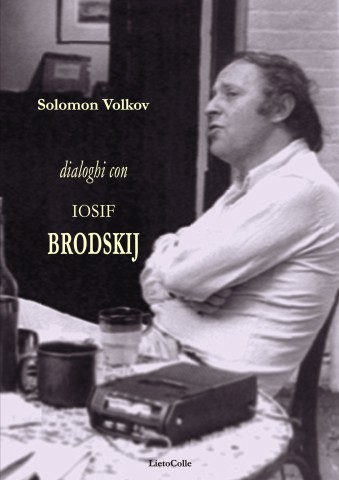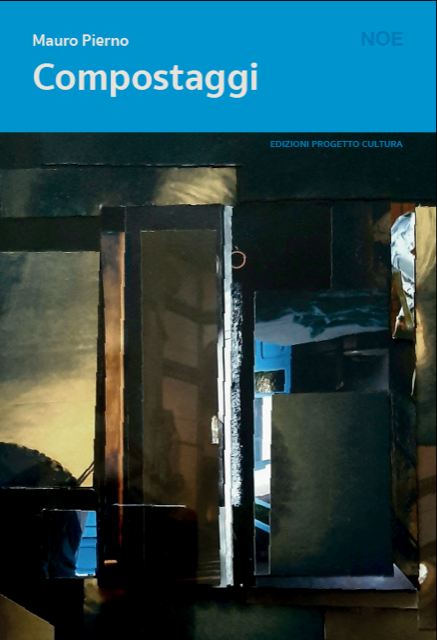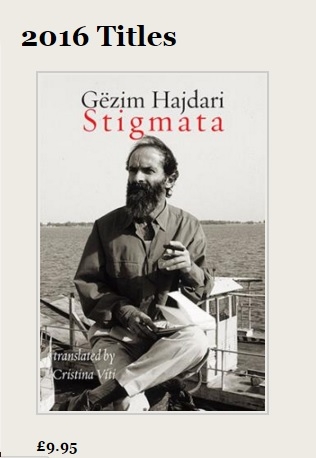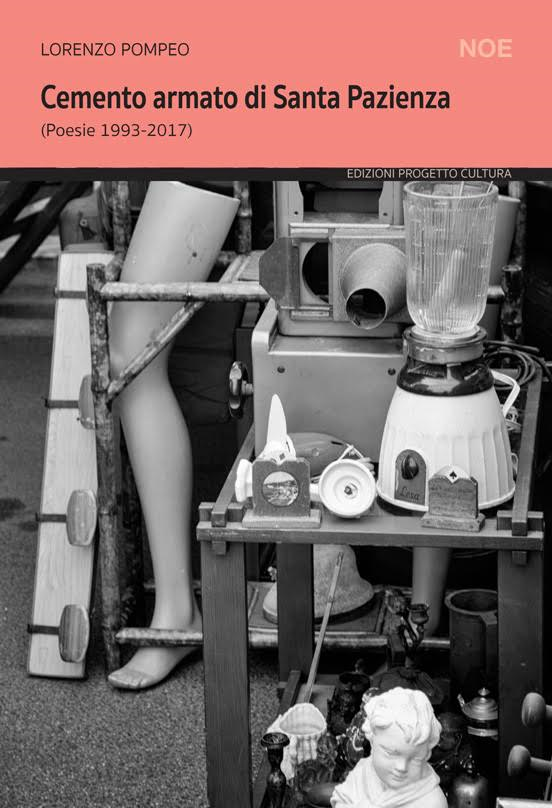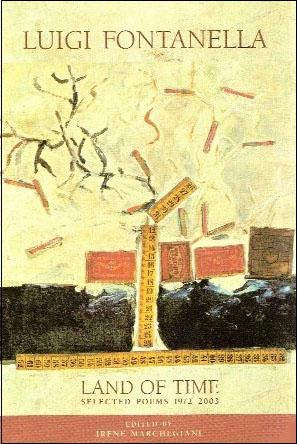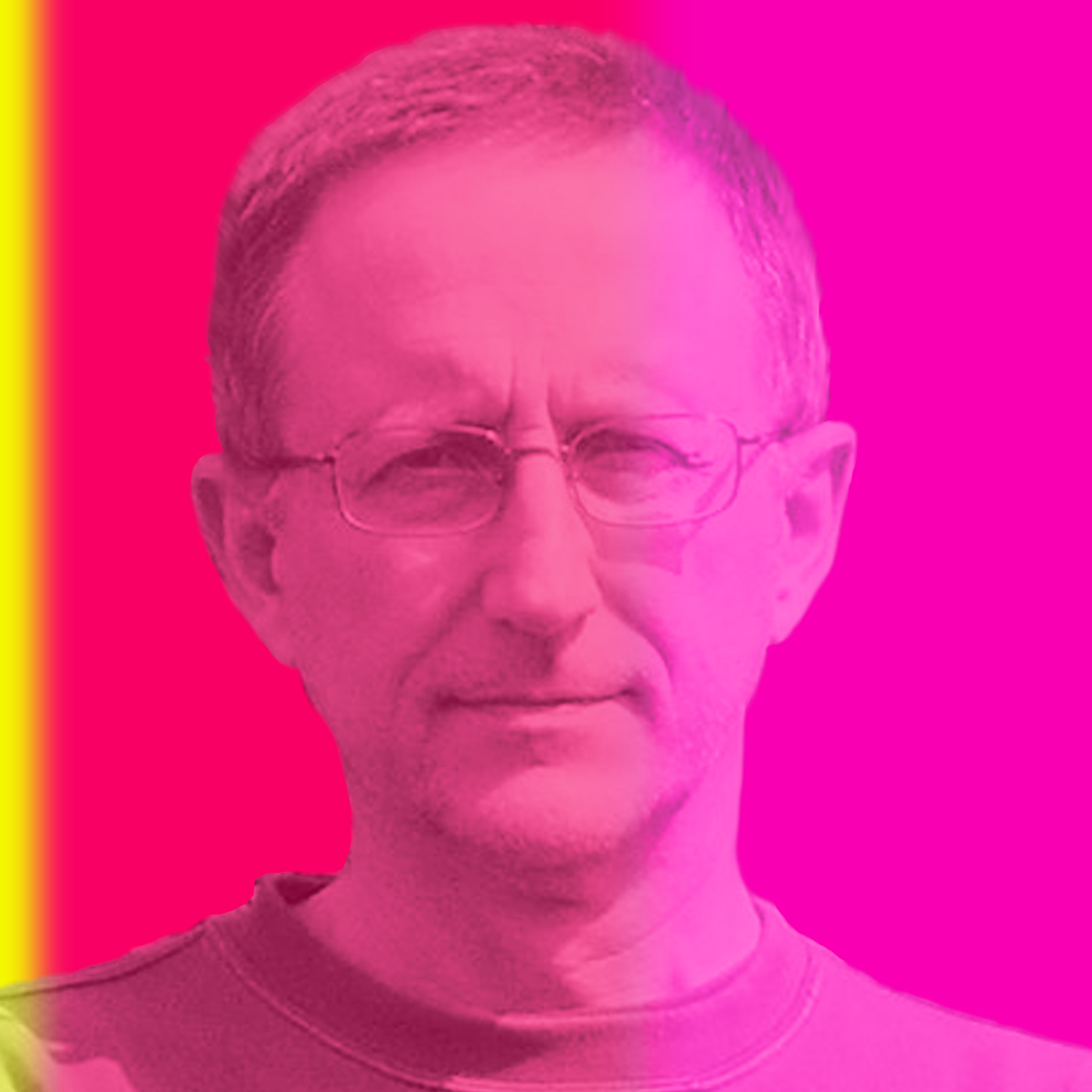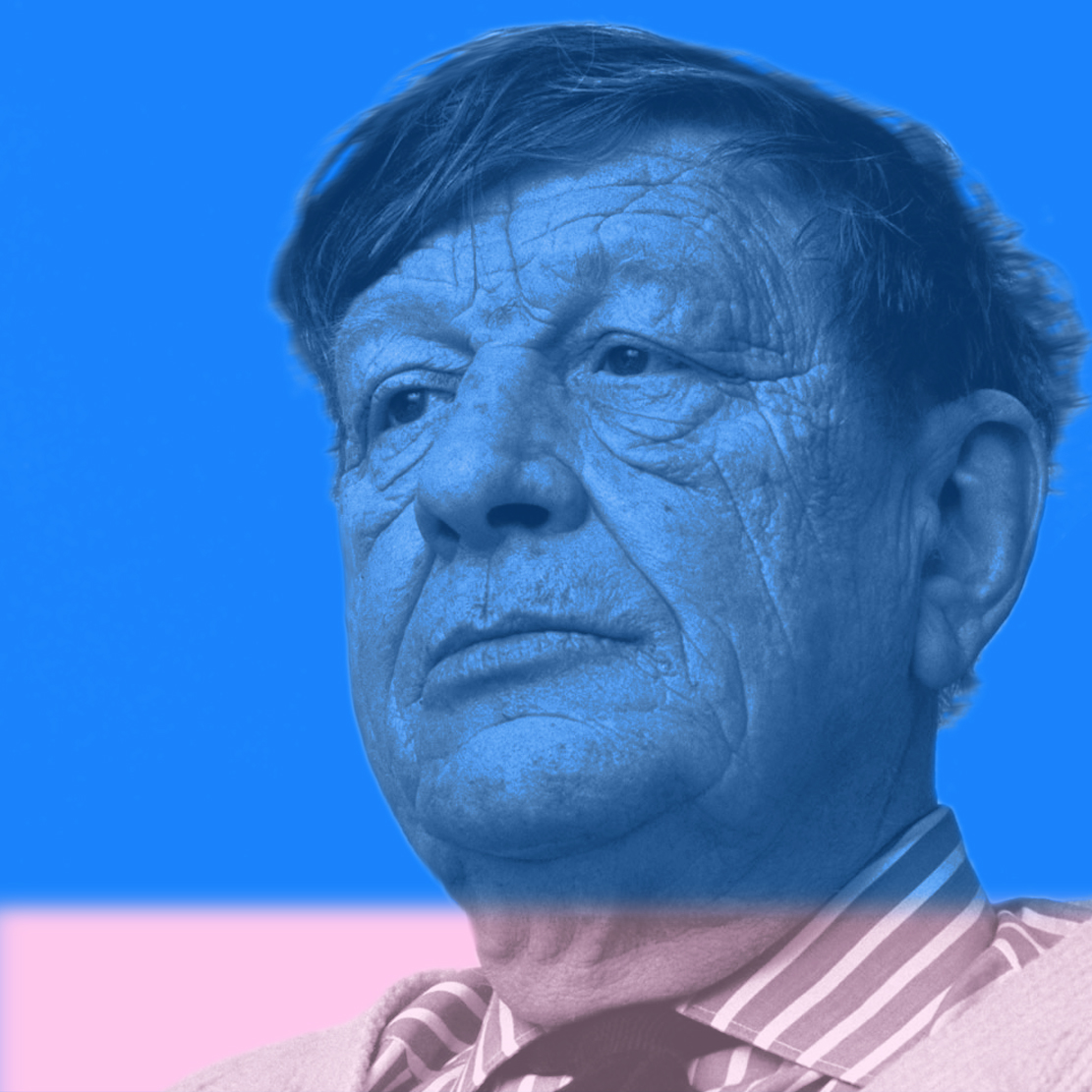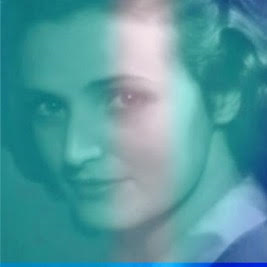Czeslaw Milosz Wislawa Szymborska
Commento impolitico di Giorgio Linguaglossa
Basta così è il titolo della raccolta postuma di Wisława Szymborska curata da Ryszard Krynicki e tradotta da Silvano De Fanti per Adelphi. Poche poesie prima che sopraggiungesse la morte della poetessa polacca avvenuta il 1 febbraio del 2012.
Ho letto con curiosità l’episodio della pubblicazione di una poesia della giovanissima Wisława sulla rivista più prestigiosa del suo paese. Aveva spedito alla nota rivista alcune poesie che furono subito bocciate dalla redazione perché giudicate «banali e superficiali». Poi, però, uno dei redattori propose alla Szymborska numerosi tagli ad una sua poesia ed insistette affinché venisse pubblicata. Fu così che apparve la prima poesia della Szymborska sulla prestigiosa rivista di letteratura. Quello fu il battesimo letterario della poetessa polacca.
Ecco qui queste poche poesie che il curatore presenta nella forma autografa: foglietti scritti a mano con una grafia attenta e minuta, attraversata da correzioni e ripensamenti. Piccoli versi che non hanno nulla di prezioso, dove non c’è nessun struggimento dell’anima ma una precisissima attenzione per i dettagli delle situazioni e degli oggetti (i dettagli degli oggetti sono molto più importanti degli oggetti), gli spiragli del quotidiano che ci aprono abissi di senso, cose che vediamo tutti i giorni senza farci caso. Il viaggio nel mondo della poetessa polacca è il nostro viaggio, quello che noi tutti ogni giorno facciamo attorno al nostro dito e attorno al nostro «io». Traduzione in semplici frasi dell’assurdo del mondo quotidiano. L’assurdo di chi mette «tutto in ordine dentro e attorno a lui», di chi crede di avere la risposta pronta per tutti i problemi e «appone il timbro a verità assolute, / getta i fatti superflui nel tritadocumenti/, e le persone ignote/ dentro appositi schedari».
E poi ci sono quelle esilaranti composizioni rivolte come frecce acuminate contro gli intellettuali che si nutrono di «parole» inutili e superflue: «parole per spiegare le parole», «cervelli intenti a studiare il cervello», «boschi ricoperti di bosco fino al ciglio», «occhiali per cercare gli occhiali».
«Nulla è cambiato.
Il corpo trema, come tremava
prima e dopo la fondazione di Roma,
nel ventesimo secolo prima e dopo Cristo,
le torture c’erano, e ci sono, solo la terra è più piccola
e qualunque cosa accada, è come dietro la porta» |
| (Wisława Szymborska, Torture) |

Wisława Szymborska
Credo che la lettura della poesia della Szymborska abbia una funzione ecologica e profilattica della intelligenza, è una difesa della singolarità dell’uomo minacciato dalla invasione di massa del pensiero normalizzato. La poetessa polacca segue uno schema indiretto di esposizione, racconta un evento, magari trascurabile, che tutti abbiamo notato ma che abbiamo dimenticato perché ci è sembrato ovvio, appunto, normale; va per la via più breve attraverso il metro libero verso la cosa che vuole dire, ma poi accade che perde il filo di ciò che sta dicendo e cambia registro, parla di altro, apparentemente, per poi ricordarsi di quel filo lasciato in sospeso e lo riprende, lo riannoda, lo accorcia, lo allunga, lo mette sotto la lente di ingrandimento, lo abbandona di nuovo e lo riprende. Fa ad un tempo una poesia populistica e intellettualistica, minimalistica e antiminimalistica, ironica e autoironica, antifilosofica e filosofica, ermeneutica e antiermeneutica. In una parola, fa una poesia del nostro tempo nichilistico, accetta del Nihil il Nihil senza rimpianti religiosi o filosofici, senza inutili struggimenti, senza contorcimenti; sa che nel nostro mondo di oggi non c’è religione o filosofia che tenga; non c’è religione affatto, e forse non c’è neanche una filosofia che possa consolarci. Religio nel senso di stare insieme, non è più una cosa del nostro tempo. In realtà, la Szymborska minimizza ciò che va minimizzato e mette sotto la lente di ingrandimento i nostri piccoli tic quotidiani, le nostre contraddizioni, le nostre manie, le nostre piccole normalità quotidiane. È il suo modo di trattare il «quotidiano», il suo particolarissimo periscopio. È stato anche detto che la Szymborska è una poetessa minimalista. Nulla di più falso e fuorviante, la sua è una poesia che mette al centro del proprio fare il problema dell’Interrogazione.
È una poesia che si interroga su tutto, che chiede lumi al lettore, che lo convoca, che lo sfida, che lo provoca ad interrogarsi sulle sue medesime interrogazioni, che lo fa sentire importante. Non è una poesia che dice al lettore: «Vieni qui, guardami, guarda quanto sono bella!»; è una poesia che dice al lettore: «Vieni, conducimi, dimmi tu che cosa devo fare in mezzo al ginepraio del mondo». È una poesia di grande responsabilità estetica. Si diceva una volta, una poesia umanistica. Non so se è esatto, io mi contento di dire che è una poesia che si aggrappa al dubbio come all’ultima delle certezze. Forse in ciò è davvero umanistica in quanto problematica, e problematica in quanto umanistica. È una poesia modernistica nel senso più alto del termine, e problematica come lo può essere una poesia umanistica.
Per la Szymborska la poesia non è come una seconda pelle, come un abito che ti sta stretto alla vita, che non ti lascia respirare ma che sei costretto a portare per superiore costrizione, per educazione, per convenzione condivisa, ma un abito libero, abitabile, largo, elastico, comodo. Sappiamo da Wittgenstein che l’abito non è fatto per coprire il corpo nudo, non è quello il suo compito, altrimenti tutto sarebbe fin troppo semplice, ma per ben altri scopi che nulla hanno a che vedere con il freddo o il caldo da cui l’abito dovrebbe fornire protezione. Così, il linguaggio poetico è fatto per ben altri scopi che non per comperare un biglietto quando si sale sull’autobus. Si può prendere l’autobus o la metro senza aver mai letto un rigo di poesia. E la cosa riesce assai meglio dice la Szymborska che ci rivela che lei preferisce leggere prosa anziché poesia. Si vive meglio senza aver mai frequentato la Musa, dice la Szymborska. La Musa della poesia ama essere dimenticata, abbandonata in un angolo e dimenticata. Chi vuole risvegliarla dal suo letargo, spesso la fa fuggire. E per sempre. Così chi vuole comprarla con similori o con gioielli posticci. La Musa preferisce abiti lisi e trasandati. E, a volte, anche anime semplici. Abitate dal dubbio, però.

Wisława Szymborska
Intervista a Wislava Szymborska pubblicata su “L’espresso” il 31 ottobre 1996
Signora Szymborska, perché scrive poesie?
Io proprio non lo so. Mi sembra che la risposta sia da ricercare fra i lettori, non fra gli autori. L’autore segue un impulso quasi vitale: e la risposta del lettore tiene in vita quell’impulso, che si perpetua. Perché il lettore d’un tratto ama una poesia? Forse qualcosa colpisce la sua memoria: qualcosa non lo lascia tranquillo tanto da dover tornare più volte su quel testo. A me capita questo quando leggo delle poesie. Come poeta scrivo perché si legga quello che scrivo: e scrivo perché ho bisogno di scrivere.
Spieghi ai lettori italiani, che la conoscono poco, qual è la sua poesia da cui sarebbe meglio partire per avvicinarsi alle sue opere, al suo lavoro.
Non sono in grado di farlo. C’è un filo conduttore che unisce tutto quel che ho scritto, ma per me è veramente impossibile esaminare in questo modo la mia poesia. però è una risposta che certamente un traduttore o un lettore attento sono in grado di dare molto meglio di me.
Ma come vorrebbe fosse interpretata la sua poesia?
A me piace quando un lettore o un attore legge i miei versi come se pensasse a voce alta. Vorrei fosse interpretata così la mia poesia. La cosa peggiore è la meta interpretazione, e iperinterpretazione: il volere a tutti i costi aggiungere qualcosa in più, qualcosa di troppo, che non c’è, alla poesia. Invece, sempre riferendomi ai miei versi, mi piace quando vengono letti guardando in faccia il pubblico, come in un discorso, con «nonchalance», come si stesse riflettendo ad alta voce.
Come scrive le sue poesie? Di getto o invece sono il frutto di una lunga riflessione?
L’ispirazione è sempre necessaria. La si può chiamare in modi diversi: estro, impulso… La mia poesia viene in genere descritta come «poesia riflessiva»: e lo è. Ma questo non ne fa una poesia fredda, programmatica, un lavoro a tavolino da burocrate. O almeno spero! Io traggo ispirazione da tantissime cose, ma tendo a scrivere poco: rifletto su quel che provo, non accetto facilmente tutte le prime parole «ispirate» che saltano in mente. Il problema è anche terminologico: da noi si tende ancora ad associare l’ispirazione solo e soltanto alla poesia, oppure la si riferisce solo a certi movimenti letterari delle epoche passate. A me sembra che ogni attività che richieda riflessione, ogni compito al quale ci si dedichi completamente, richieda un’ispirazione. L’ispirazione non è sconosciuta al medico, al chirurgo, all’avvocato, all’insegnante, allo studente e così via. È quel qualcosa che all’improvviso ti penetra il cervello con una chiarezza e evidenza tali da far vedere ciò che prima non c’era. Per la mia poesia è vitale: quando manca questo non scrivo più.
Lei ha sempre odiato i circoli letterari. Teorizza la solitudine del poeta. Ama far sapere che è inaccessibile, che le piace stare in disparte. Perché?
All’inizio è naturale che i giovani poeti si riuniscano in gruppi. Il poeta solitario, fuori del mondo, deve avere una gran fortuna per riuscire a emergere e farsi sentire se non ha nessun contatto con gli altri poeti. Il gruppo all’inizio è necessario e naturale. Infonde anche una buona dose di coraggio. Ma può durare a lungo e certo non per tutta la vita. È di cattivo gusto e brutto segno quando, dopo una vita, ci sono ancora vecchi poeti che si tengono stretti al proprio circolo. E allora credo sia un disastro per entrambi, poeta e poesia.
L’ironia è uno degli elementi che fondano il suo lavoro di poeta. In tutte le sue opere l’ironia è un elemento fondamentale. Perché?
L’ironia è un concetto talmente vasto: le pagine più belle sull’ironia le ha scritte Thomas Mann, che pure ne distingue vari tipi. Spesso la gente confonde l’ironia col dileggio, lo scherno, il disprezzo per l’altro, e a volte diviene altezzosità che mette chi ironizza su un piano più elevato rispetto all’oggetto dell’ironia. Ma non bisogna dimenticare che nell’ironia c’è anche l’elementto della compassione. Io rido un po’ di me e un po’ di voi. Non dimentico mai di ridere prima di tutto di me stessa. Questa è l’ironia che preferisco e spero ogni tanto mi riesca così come la intendo.
Anche come antidoto contro il sentimentalismo
Sicuramente. La nostra è un’epoca che ha una paura folle dei sentimentalismi. Così l’ironia è una maschera dietro la quale ci si cela per dire qualcosa sinceramente, ma evitandoci l’imbarazzo del sentimento o della sincerità.
Cosa legge più volentieri?
Se parliamo delle mie letture, non quelle obbligatorie per lavoro o altro, allora più volentieri leggo prosa.
Non poesia?
No, affatto. Ho sempre amato tanto la prosa. Ho sempre letto prosa e quando ho iniziato a scrivere, quando pensavo che sarei stata una scrittrice all’età di dodici, tredici anni era per me inconcepibile la scrittura poetica. «Dio ce ne scampi dalle poesie», dicevo, «io scriverò enormi romanzi, in più volumi, grassi, massicci, intere biblioteche di romanzi!»

Wisława Szymborska
È così che ha incominciato a scrivere quelle recensioni sui libri più strani e bizzarri che escono ancora periodicamente sul quotidiano ‘Gazeta Wyborcza’?
Anni fa mi buttarono fuori dalla redazione del giornale per motivi politici – scrivevo una rubrica sulla poesia all’epoca. Poi qualcuno mi propose di aprire una rubrica tutta mia su qualsiasi argomento preferissi. E allora mi venne in mente di recensire o di trattare in un mucchietto di righe libri di tutte le specie, di botanica, pesca, culinaria, diari di donne sconosciute ecc. Tutti libri dei quali nessuno sa nulla, ma che esistono, che possono essere persino leggibili.
E funzionò?
erano tempi politicizzati nel senso meno salutare del termine e io feci del mio meglio perché la gente potesse per un attimo prender fiato da tutta quella propaganda. Credo mi sia riuscito, dal momento che la rubrica veniva largamente letta: la leggevano sapendo che in essa non si nascondevano dogmi ideologici. Sapevano che da me non avrebbero ricevuto il solito pappone propagandistico.
Nella sua opera manca l’elemento corporeo. Al punto che la sua poesia viene definita «asessuata».
Manca un certo grado di fisicità perché è una poesia riflessiva, cerebrale. e se si intende per fisicità la descrizione dell’amore fra un uomo e una donna, allora non la si troverà nella mia poesia, per il semplice fatto che ritengo l’amore fra l’uomo e la donna assolutamente indescrivibile. Io non ho mai letto un solo verso assolutamente passabile su questo argomento. Certamente fra le mie raccolte si possono rintracciare un paio di poesie scritte per una donna, o che hanno un punto di vista femminile… ma niente di più. Ma le donne non devono scrivere poesie d’amore…

Wisława Szymborska
Epitaffio
Qui giace come la virgola obsoleta
l’autrice d’un paio di versi. La terra l’ha degnata
dell’ultimo riposo, sebbene in vita lo spettro
non abbia mai aderito a gruppi letterari di rispetto.
E anche sulla tomba di meglio non si trova
di questa filastrocca, un gufo e la bardana.
estrai dalla valigetta il cervello elettronico, passante
e medita sul destino di Szymborska un solo istante.
Nel sonno
.
Ho sognato che cercavo una cosa,
nascosta chissà dove oppure persa
sotto il letto o le scale,
all’indirizzo vecchio.
.
Rovistavo in armadi, scatole e cassetti,
inutilmente pieni di cose senza senso.
.
Tiravo fuori dalle mie valigie
gli anni e i viaggi compiuti.
.
Scuotevo fuori dalle tasche
lettere secche e foglie scritte non a me.
.
Correvo trafelata
per ansie e stanze
mie e non mie.
.
Mi impantanavo in gallerie
di neve e nell’oblio.
Mi ingarbugliavo in cespugli di spine
e congetture.
.
Spazzavo via l’aria
e l’erba dell’infanzia.
.
Cercavo di fare in tempo
prima del crepuscolo del secolo trascorso,
dell’ora fatale e del silenzio.
.
Alla fine ho smesso di sapere
cosa stessi cercando così a lungo.
.
Al risveglio
ho guardato l’orologio.
Il sogno era durato due minuti e mezzo.
.
Ecco a che trucchi è costretto il tempo
dacché si imbatte
nelle teste addormentate.
.
Monologo per Cassandra
Sono io, Cassandra.
E questa è la mia città sotto le ceneri.
E questi i miei nastri e la verga di profeta.
E questa è la mia testa piena di dubbi.
E’ vero, sto trionfando.
I miei giusti presagi hanno acceso il cielo.
Solamente i profeti inascoltati
godono di simili viste.
Solo quelli partiti con il piede sbagliato,
e tutto poté compiersi tanto in fretta
come se non fossero mai esistiti.
Ora lo rammento con chiarezza:
la gente vedendomi si interrompeva a metà.
Le risate morivano.
Le mani si scioglievano.
I bambini correvano dalle madri.
Non conoscevo neppure i loro effimeri nomi.
E quella canzoncina sulla foglia verde –
nessuno la finiva in mia presenza.
Li amavo.
Ma amavo dall’alto.
Da sopra la vita.
Dal futuro. Dove è sempre vuoto
e da dove nulla è più facile del vedere la morte.
Mi dispiace che la mia voce fosse dura.
Guardatevi dall’alto delle stelle – gridavo –
guardatevi dall’alto delle stelle.
Sentivano e abbassavano gli occhi.
Vivevano nella vita.
Permeati da un grande vento.
Con sorti già decise.
Fin dalla nascita in corpi da commiato.
Ma c’era in loro un’umida speranza,
una fiammella nutrita del proprio luccichio.
Loro sapevano cos’è davvero un istante,
oh, almeno uno, uno qualunque
prima di –
È andata come dicevo io.
Però non ne viene nulla.
E questa è la mia veste bruciacchiata.
E questo è il mio ciarpame di profeta.
E questo è il mio viso stravolto.
Un viso che non sapeva di poter essere bello.
(da “Sale” 1962)

Possibilità
Preferisco il cinema.
Preferisco i gatti.
Preferisco le querce sul fiume Warta.
Preferisco Dickens a Dostoevskij.
Preferisco me che vuol bene alla gente
a me che ama l’umanità.
Preferisco avere sottomano ago e filo.
Preferisco il colore verde.
Preferisco non affermare
che l’intelletto ha la colpa su tutto.
Preferisco le eccezioni.
Preferisco uscire prima.
Preferisco parlar d’altro coi medici.
Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio.
Preferisco il ridicolo di scrivere poesie
al ridicolo di non scriverne.
Preferisco in amore gli anniversari non tondi,
da festeggiare ogni giorno.
Preferisco i moralisti,
che non mi promettono nulla.
Preferisco una bontà avveduta a una credulona.
Preferisco la terra in borghese.
Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori.
Preferisco avere delle riserve.
Preferisco l’inferno del caos all’inferno dell’ordine.
Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine.
Preferisco foglie senza fiori che fiori senza foglie.
Preferisco i cani con la coda non tagliata.
Preferisco gli occhi chiari, perché li ho scuri.
Preferisco i cassetti.
Preferisco molte cose che qui non ho menzionato
a molte pure qui non menzionate.
Preferisco gli zeri alla rinfusa
che non allineati in una cifra.
Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale.
Preferisco toccar ferro.
Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando.
Preferisco considerare persino la possibilità
che l’essere abbia una sua ragione.
Conversazione con una pietra
Busso alla porta della pietra
– Sono io, fammi entrare.
Voglio venirti dentro,
dare un’occhiata,
respirarti come l’aria.
– Vattene – dice la pietra.
– Sono ermeticamente chiusa.
Anche fatte a pezzi
saremo chiuse ermeticamente.
Anche ridotte in polvere
non faremo entrare nessuno.
Busso alla porta della pietra.
– Sono io, fammi entrare.
Vengo per pura curiosità.
La vita è la sua unica occasione.
Vorrei girare per il tuo palazzo,
e visitare poi anche la foglia e la goccia d’acqua.
Ho poco tempo per farlo.
La mia mortalità dovrebbe commuoverti.
– Sono di pietra – dice la pietra
– E devo restare seria per forza.
Vattene via.
Non ho i muscoli per ridere.
Busso alla porta della pietra.
– Sono io, fammi entrare.
Dicono che in te ci sono grandi sale vuote,
mai viste, belle invano,
sorde, senza l’eco di alcun passo.
Ammetti che tu stessa ne sai poco.
.
***
Terrorista che guarda, 1974:
La bomba scoppierà nel bar alle tredici e venti.
Adesso sono solo le tredici e sedici.
Alcuni faranno in tempo ad entrare,
Altri a uscire.
Il terrorista ha già attraversato la strada.
Questa distanza lo tiene in salvo dal pericolo,
e la visuale è proprio come al cinema.
Una donna con la giacca gialla, ecco entra.
Un uomo con gli occhiali scuri, lui esce.
Dei ragazzi in blue jeans se ne stanno a chiacchierare.
Le tredici diciassette minuti e quattro secondi.
Il più basso ha fortuna e salta sullo scooter,
quello più alto entra dentro.
Ore tredici e diciassette e quaranta secondi.
C’è una ragazza col nastro verde tra i capelli.
Ma ecco che l’autobus ne impedisce la vista.
Ore tredici e diciotto.
Non c’è più la ragazza.
Ma se è stata così sciocca da entrare,
lo si vedrà quando li porteranno fuori.
Ore tredici e diciannove.
Beh, non esce nessuno.
Ma ecco che esce ancora un uomo grasso e calvo.
Però, così, come se stesse cercando qualcosa per le tasche e
alle tredici e venti meno dieci secondi
rientra a veder se trova quei suoi miseri guanti.
Sono già le tredici e venti.
Ma come va piano il tempo.
Ecco, forse ora.
No, non ancora.
Sì, adesso.
È la bomba che scoppia.
.
Prospettiva
Si sono incrociati come estranei,
senza un gesto o una parola,
lei diretta al negozio,
lui alla sua auto.
Forse smarriti
O distratti
O immemori
Di essersi, per un breve attimo,
amati per sempre.
D’altronde nessuna garanzia
Che fossero loro.
Sì, forse, da lontano,
ma da vicino niente affatto.
Li ho visti dalla finestra
E chi guarda dall’alto
Sbaglia più facilmente.
Lei è sparita dietro la porta a vetri,
lui si è messo al volante
ed è partito in fretta.
Cioè, come se nulla fosse accaduto,
anche se è accaduto.
E io, solo per un istante
Certa di quel che ho visto,
cerco di persuadere Voi, Lettori,
con brevi versi occasionali
quanto triste è stato.

Nasce nel 1923, nel 1931 Wisława Szymborska si trasferisce con la famiglia a Cracovia, città alla quale è stata sempre legata: vi ha studiato, vi ha lavorato e vi ha sempre soggiornato, da allora fino alla morte. Allo scoppio della guerra nel 1939, continua gli studi liceali sotto l’occupazione tedesca, seguendo corsi clandestini e conseguendo il diploma nel 1941. A partire dal 1943, lavora come dipendente delle ferrovie e riuscì a evitare la deportazione in Germania come lavoratrice forzata. In questo periodo comincia la sua carriera di artista, con delle illustrazioni per un libro di testo in lingua inglese. Comincia inoltre a scrivere storie e, occasionalmente, poesie.
Sempre a Cracovia, Szymborska comincia nel 1945 a seguire in un primo momento i corsi di letteratura polacca, per poi passare a quelli di sociologia, presso l’Università Jagellonica, senza però riuscire a terminare gli studi: nel 1948 fu costretta ad abbandonarli a causa delle sue scarse possibilità economiche. Ben presto viene coinvolta nel locale ambiente letterario, dove incontra Czesław Miłosz, che la influenzò profondamente.
Nel 1948 sposa Adam Włodek, dal quale divorziò nel1954. In quel periodo, lavorava come segretaria per una rivista didattica bisettimanale e come illustratrice di libri. Nel 1969 si sposa con lo scrittore e poeta Kornel Filipowicz, che muore nel1990. La sua prima poesia, Szukam słowa (Cerco una parola), fu pubblicata nel marzo 1945 sul quotidiano «Dziennik Polski». Le sue poesie vengono pubblicate con continuità su vari giornali e periodici per parecchi anni; la prima raccolta Dlatego żyjemy (Per questo viviamo) venne pubblicata molto più tardi, nel1952, quando la poetessa aveva 29 anni.
In effetti, negli anni quaranta la pubblicazione di un suo primo volume venne rifiutata per motivi ideologici: il libro, che avrebbe dovuto essere pubblicato nel1949, non superò la censurain quanto «non possedeva i requisiti socialisti». Ciò nonostante, come molti altri intellettuali della Polonia post-bellica, nella prima fase della sua carriera Szymborska rimase fedele all’ideologia ufficiale della PRL: sottoscrisse petizioni politiche ed elogiò Stalin, Lenin e il realismo socialista. Anche la poetessa-Szymborska cercò in seguito di adattarsi al realismo socialista: il primo volume di poesie del 1952 contiene infatti testi dai titoli come Lenin oppure Młodzieży budującej Nową Hutę (Per i giovani che costruiscono Nowa Huta), che parla della costruzione di una città industriale stalinista nei pressi di Cracovia. Aderì anche al PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, «partito operaio unito polacco»), del quale fu membro fino al1960.
Tuttavia, in seguito la poetessa prese nettamente le distanze da questo «peccato di gioventù», come da lei stesso definito, al quale è da ascrivere anche la seguente raccolta Pytania zadawane sobie (Domande poste a me stessa) del 1954. Anche se non si distaccò dal partito fino al 1960, cominciò ben prima a instaurare contatti con dissidenti. Successivamente Szymborska ha preso le distanze dai suoi primi due volumi di poesie.
Dal 1953 al 1966 fu redattrice del settimanale letterario di Cracovia «Życie Literackie» («Vita letteraria»), al quale ha collaborato come esterna fino al1981. Sulle pagine di questa pubblicazione è apparsa la serie di saggi Lektury nadobowiązkowe (Letture facoltative), che sono state successivamente pubblicate, a più riprese, in volume. Nel 1957 fece amicizia con Jerzy Giedroyc, editore dell’influente giornale degli emigranti polacchi «Kultura», pubblicato a Parigi, al quale contribuì anche lei. Il successo letterario arrivò con la terza raccolta poetica, Wołanie do Yeti (Appello allo Yeti), del 1957.
Dal 1981 al 1983 Wisława Szymborska è stata redattrice del mensile di Cracovia «Pismo». Negli anni ottanta intensificò le sue attività diopposizione, collaborando al periodico samizdat «Arka» con lo pseudonimo «Stanczykówna» e a «Kultura». Si impegnò per il sindacato clandestino Solidarność. Dal 1993 pubblica recensioni sul supplemento letterario del «Gazeta Wyborcza», importante quotidiano polacco. Nel 1996 è stata insignita del Premio Nobel per la letteratura «per una poesia che, con ironica precisione, permette al contesto storico e biologico di venire alla luce in frammenti d’umana realtà». Ha anche tradotto dal francese al polacco alcune opere del poeta barocco francese Théodore Agrippa d’Aubigné. Le sue opere sono state tradotte in numerose lingue. Pietro Marchesani ha tradotto la maggior parte delle sue raccolte poetiche in italiano; La sua più recente raccolta poetica, Dwukropek (Due punti), apparsa in Polonia il 2 novembre 2005, ha riscosso uno strepitoso successo, vendendo oltre quarantamila copie in meno di due mesi. Dopo diversi mesi di malattia, il 1º febbraio 2012, Szymborska è scomparsa nel sonno presso la sua casa a Cracovia. Dopo essere stata cremata è stata sepolta nella tomba di famiglia.