
Gruppo 63 a Palermo
Alfonso Berardinelli
Fonte (MicroMega online)
Le avanguardie culturali sono quasi tutte stupide. Non cascateci
Ecco un vecchio tema che non invecchia come meriterebbe: le gloriose avanguardie culturali (nonché politiche) novecentesche, sia quelle 1910-1930 che quelle 1950-1960. Parlando di narrativa e di pensiero politico dell’Ottocento con un’amica assai colta e poco sensibile alle mode, a un certo punto, non so se prima lei o prima io, siamo arrivati a dire che in arte, in letteratura e in filosofia il Novecento è stato un secolo piuttosto stupido.
Il primo sintomo di questa stupidità è stato l’immaginario “rivoluzionario”, la mania della tabula rasa, del ricominciare da zero, di rifare tutto da capo, di mettere sotto accusa non solo l’Ottocento ma tutto il passato, l’intera tradizione culturale, come cosa vecchia, opprimente, noiosa, di cui liberarsi in nome di un’assoluta, soggettiva libertà senza limiti né remore: una libertà, cioè, stupida.
Primo motore e prima fabbrica di stupidità sono state le avanguardie, con i loro manifesti e i loro gruppi, la loro gestualità, i loro happening, il loro esibizionismo, il loro credere di andare sempre più avanti e in fondo, coerentemente, cancellando e devastando le forme, eliminando i contenuti, scandalizzando il pubblico, rifiutando infine il mercato con lo scopo di conquistarlo: in letteratura, nel teatro, nelle arti visive, nella musica, in architettura, in politica è avvenuto questo.
Rivoluzione a sinistra e a destra, “opere aperte” e non-opere sperimentali. Marinetti (futuristicamente) inventò che la guerra è la sola igiene del mondo. Breton (surrealisticamente) proclamò che il più esemplare atto surrealista era scendere in strada e sparare sulla folla. Sanguineti, più modestamente, disse a metà anni settanta che bisognava mettere una bomba sotto l’edificio della tradizione letteraria. Tra anni cinquanta e sessanta i francesi, non sapendo più che scrivere, inventarono “l’écriture” e “la scuola dello sguardo”: cioè lo scrivere e basta senza chiedersi che cosa e il romanzo in cui si può parlare solo di ciò che gli occhi vedono, senza un perché. Proibito pensare e interpretare.
La beat generation americana riprese mezzo secolo dopo le avanguardie europee di primo Novecento e a forza di droghe e di malinteso buddismo zen teorizzò che meno si pensa e più si è geniali: tutti siamo geni e non lo sappiamo, per diventarlo basta liberare se stessi “fino in fondo”, anzi (e non è poco) liberarsi di se stessi. Nel corso di un party in America Allen Ginsberg si spogliò nudo (nudità uguale verità!) lasciando perplesso perfino il lì presente John Lennon. Molto peggio Stockhausen, il campione della musica seriale astratta, il quale disse che l’attacco alle Torri Gemelle era una grande opera d’arte.
Tutte le arti furono colonizzate e travolte dalla spettacolarità inconsulta e gratuita, se possibile distruttiva. Arte come gesto e nonopera. Spontaneità psichica senza perizia tecnica. La filosofia dell’“atto puro” di Giovanni Gentile, il passo di marcia dei totalitarismi, il leader ebbro o isterico che dall’alto ipnotizza e fanatizza le folle e le masse. Più tardi fu l’azione e il gesto rivoluzionario memorabili in sé. La pittura tautologicamente pubblicitaria di Andy Warhol, che consacra il già noto e consacrato e lo reimmette di nuovo nel mercato, con la sua firma e incassando i proventi. La furbizia degli stupidi e degli inetti ha fatto epoca. Il Novecento ha inventato la figura del genio cretino, che proliferò e prolifera.
Su Repubblica di domenica scorsa, si annuncia e commenta, in un articolo a due pagine di Chiara Gatti, una mostra di Bologna con centottanta opere in arrivo dall’Israel Museum di Gerusalemme, le quali “raccontano una stagione unica che cambiò la storia dell’arte” (ci si chiede: in meglio o in peggio?).
Titolo dell’articolo: “I rivoluzionari del ’900”, cioè Duchamp, Magritte, Dalì. In apertura la Gatti cita il famoso passo nel quale Tristan Tzara insegna a scrivere una poesia dadaista, ritagliando le singole parole di un qualunque articolo di giornale, mescolandole in un sacchetto e poi mettendole in fila come viene viene: “Copiate scrupolosamente. La poesia vi somiglierà. Eccovi divenuto uno scrittore infinitamente originale e di squisita sensibilità, sebbene incompreso dal volgo”.
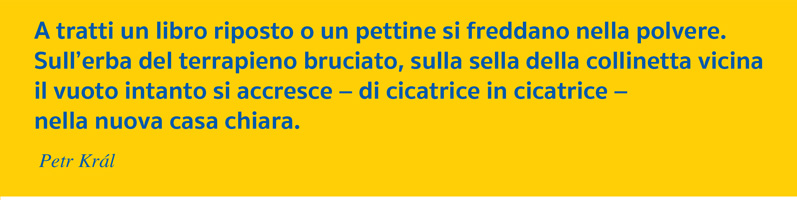

Tzara fu un genio nel dire in poche righe tutta la verità sulle avanguardie: andare scrupolosamente a caso, non farsi capire, fare stupidaggini con metodo, ecco la nuova arte.
Fu un’epidemia. Non si salvò quasi nessuno, perché nessuno voleva passare per “passatista”, ottocentesco, tradizionale. Solo Giorgio De Chirico prendeva in giro i surrealisti e le loro riunioni, mentre loro pretendevano di considerarlo uno dei loro.
Tutti democraticamente riconosciuti artisti di un’arte di tutti. Ma come è noto, i più esemplari, rivelatori, o se volete “rivoluzionari”, gesti artistici estremi di denuncia e autodenuncia dell’arte-non-arte, li ha compiuti Piero Manzoni all’inizio degli anni Sessanta, con i suoi quadri completamente bianchi, i suoi palloncini gonfiati con “fiato d’artista” e infine con il barattolo contenente la famosa “merda d’artista”. Provate voi ad andare oltre, se ci riuscite. Eppure, dopo mezzo secolo, molti critici d’arte credono ancora nella Provocazione. E’ il loro mestiere, ci campano.
Gli artisti veri, nati nelle avanguardie e nei loro dintorni, non sono mancati: da Boccioni a Carrà e Palazzeschi, a Picasso, Schönberg, Stravinskij, Majakovskij, Bunuel… Si fa presto a riconoscerli: non rinunciano alla tecnica, anzi la sviluppano, la pensano di nuovo per afferrare più significati, non per abolirli.
La loro era una fuga dalla stupidità, proprio quando la mettevano in scena. Solo che la critica e il pubblico sono stupidamente caduti nell’equivoco.
*Alfonso Berardinelli (Roma, 1943), è saggista e critico letterario. Collabora con i quotidiani nazionali Avvenire, Il Sole 24 Ore e Il Foglio. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: L’eroe che pensa. Disavventure dell’impegno (Einaudi, 1997), Nel paese dei balocchi. La politica vista da chi non la fa (Donzelli, 2001). Con Casi critici (Quotlibet, 2007) è stato vincitore del Premio Napoli nel 2008, anno in cui ha ricevuto anche il Premio Tarquinia Cardarelli per la Critica letteraria italiana. Con La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere letterario (Marsilio, 2002) ha vinto il Premio Viareggio-Rèpaci nella sezione Saggistica. Vive a Tuscania.
[L’articolo è stato pubblicato da Il Foglio, il 20 ottobre 2017]

Accettura, agosto 2017, da sx Maria Grazia Trivigno, Alfredo Rienzi e Giorgio Linguaglossa
Giorgio Linguaglossa
31 ottobre 2017
Vorrei fare un distinguo,
accetto volentieri la «provocazione» di Berardinelli, critico troppo intelligente per la poesia italiana e, direi, anche sprecato visto la pochezza della poesia italiana maggioritaria di questi ultimi decenni. Di fatto, la poesia è rimasta senza critica (per critica intendo una critica intelligente e libera).
La nuova ontologia estetica, almeno questo è il mio pensiero, non è né una avanguardia né una retroguardia, è un movimento di poeti che ha detto BASTA alla deriva epigonica della poesia italiana che durava da cinque decenni. Deriva da un atto di sfiducia (adoperiamo questo gergo parlamentare), abbiamo deciso di sfiduciare il governo parlamentare che durava da decenni nella sua imperturbabile deriva epigonica. Occorreva dare una svolta, imprimere una accelerazione agli eventi. E deriva da un atto di fiducia, fiducia nelle possibilità di ripresa della poesia italiana.
È proprio questo uno dei punti nevralgici di distinguibilità della Nuova Ontologia Estetica: abbiamo introdotto la «rottura». Anche se sappiamo bene che il tempo non si azzera mai e la storia non può mai ricominciare dal principio. Tuttavia, in certi momenti storici, dobbiamo mettere da parte un concetto estatico e normalizzato del tempo e ricominciare da principio, il che non equivale alla parola d’ordine di porsi in posizione di avanguardia; sia l’avanguardia che la retroguardia sono concetti della domenica delle Palme; bisogna invece spezzare il tempo, introdurre delle rotture, delle distanze, sostare nello Jetztzeit, il «tempo-ora», spostare, lateralizzare i tempi, moltiplicare i registri linguistici, diversificare i piani del discorso poetico, temporalizzare lo spazio e spazializzare il tempo…
Occorre una nuova poesia, una poesia che abbia alle spalle una serrata critica dell’economia estetica…
“Vorrei rispondere a Berardinelli che l’acmeismo ha battezzato poeti come Mandel’stam, Pasternak, Achmatova, Chodasevich, Gumilev e altri… e che la sua importanza va molto oltre il valore dei singoli poeti protagonisti di quella stagione letteraria, quindi anche qui non bisogna fare di tutte le erbe un fascio. Senza Mandel’stam non ci sarebbe stato un Milosz, un Celan, un Ripellino… il modernismo europeo senza i poeti russi dell’acmeismo perderebbe il 50 per cento della sua influenza.



Antonio-Sagredo con Majakovskij
[Antonio Sagredo in compagnia di Vladimir Majakovskij]
Antonio Sagredo
1 novembre 2017 alle 7:52
Giorgio Linguaglossa scrive:
è vero Pasternak non ha fatto parte dell’acmeismo, questo lo sanno tutti, ma è indubbio che, per contraccolpo, la sua poesia abbia scelto una direzione propria e originale in risposta a quella presa dai poeti acmeisti. Molto spesso gli artisti e i poeti prendono una strada come replica alle strade intraprese dai loro contemporanei. Dall’angolo visuale della innovazione della forma-poesia, Pasternak è un poeta di formazione tradizionale, attento a cogliere e valorizzare il lato fono simbolico della poesia. Invece Mandel’stam dichiarava che bisogna mettere al primo posto la morfologia, «la fonetica verrà da sola», scriveva (cito a memoria). Non c’è dubbio che la poesia del novecento, la migliore, intendo, quella di Milosz, Herbert, Brodskij, Celan, Derek Walcott ha citato Mandel’stam quale capostipite della poesia modernista europea. Il fatto che la poesia di Mandel’stam in Italia non abbia avuto influenza malgrado le ottime traduzioni di Ripellino, Serena Vitale e altri, dimostra semmai il provincialismo della poesia italiana. Se si toglie dall’angolo visuale della poesia del novecento europeo un poeta come Mandel’stam, ci si limita ad una concezione di una poesia dell’orecchio, poesia della «orchestrazione sonora» (dizione di Mandel’stam), propria del «laboratorio di impagliatura» del simbolismo (dizione di Mandel’stam). Senza il concetto di metafora tridimensionale di Mandel’stam, si resta nell’orbita di un concetto di poesia come espressione della linearità sintattica, unilineare e unitemporale.
Quanto al modernismo europeo, l’influenza di Mandel’stam è stata sotterranea ma bisogna avere degli occhiali di qualità per individuarla. Certo, per la poesia italiana del novecento, Mandel’stam è un perfetto sconosciuto, lo si conosce come prodotto esotico, perché è morto in un lager staliniano…
Quanto a Berardinelli, io non lo definirei «furbastro», anzi è stato l’unico intellettuale italiano che ha preso posizione contro tutta la poesia italiana post anni settanta bollandola come prodotto di «poeti di fede», di «poeti di professione». Conseguentemente a questo assunto, si è disinteressato della poesia italiana degli ultimi decenni. Come dargli torto?
È chiaro quindi, almeno nelle mie intenzioni, che la lezione della poesia e della teoresi di Mandel’stam, sia stata ed è fondamentale per lo sviluppo della poesia della nuova ontologia estetica.

B. Pasternàk, grafica di Lucio Mayoor Tosi
Risposta di Antonio Sagredo :
dall’elenco togliere il nome di Pasternàk che non fece parte dell’acmeismo.
“Senza Mandel’stam non ci sarebbe stato… Ripellino…”: affermazione azzardata; nelle poesie di Ripellino non si trova traccia alcuna di Mandel’stam, se non come citazione, e come citazione decine di poeti russi e non russi.
“il 50 per cento della sua influenza” : anche questa quantificazione è azzardata, e non trova riscontri qualitativi e quantitativi: Mandel’stam ha di certo influenzato, ma non più di tanti grandi poeti del secolo scorso. Dire 50 o 20 o 70 non ha senso.
Ma il poeta-critico ecc. Berardinelli di abbagli ne ha presi molti: questo è indubbio; ma secondo noi è meglio metterlo in disparte: non è certo un termine di paragone né poetico e né critico: è stato soltanto un furbastro intellettuale che ha colto il momento giusto per mettersi in vista.
Antonio Sagredo
1 novembre 2017 alle 8:16

Roma, caffè Rosati, fine anni sessanta
Pasternak e l’Acmeismo
Unico punto di contatto con l’acmeismo è una certa influenza della poesia achmatoviana su quella di Pasternàk ed è detto nel commento di Ripellino
che riporto più sotto, e subito dopo una mia nota. Intanto questa poesia di Boris Pasternàk dedicata alla poetessa… :
Boris Pasternàk
a Anna Achmatova
Mi sembra che io sceglierò le parole,
simili alla vostra eternità.
E se sbaglierò, – m’importa un poco,
comunque, io non mi separerò dallo sbaglio.
Io sento il chiacchierio di umidi tetti,
le ecloghe smorzate delle piastrelle di legna.
Una certa città, chiara sin dalle prime righe,
cresce e risuona in ogni sillaba.
Intorno è primavera, ma non si può uscir fuori città.
Ancora severa la cliente taccagna.
Facendo lacrimare gli occhi mentre cuce accanto alla lampada,
brilla l’aurora, senza raddrizzare la schiena.
Aspirando la superficie da Ladoga della lontananza
si affretta verso l’acqua, vincendo la stanchezza.
Da tali passatempi non si può prendere nulla.
I canali odorano di tanfo di imballaggi.
Lungo di essi si tuffa, come una noce vuota,
il vento ardente, e culla le palpebre
dei rami e delle stelle, dei lampioni e delle biffe,
e della cucitrice di bianco che guarda lontano dal ponte.
Suole essere l’occhio in vario modo acuto,
in modo diverso suole esser precisa l’immagine.
Ma l’apertura della più terribile fortezza –
è la lontananza notturna sotto lo sguardo di una bianca notte.
Tale io vedo il vostro aspetto e sguardo.
Esso mi è ispirato non da quella statua di sole,
con cui voi cinque anni addietro
avete attaccato alla rima la paura di voltarsi indietro.
Ma, muovendo dai vostri primi libri,
dove si sono rafforzati i granelli di una prosa attenta,
esso in tutti i libri, come conduttore di scintilla,
costringe gli avvenimenti a pulsare come una storia vera.
(1928, trad. di A. M. Ripellino)

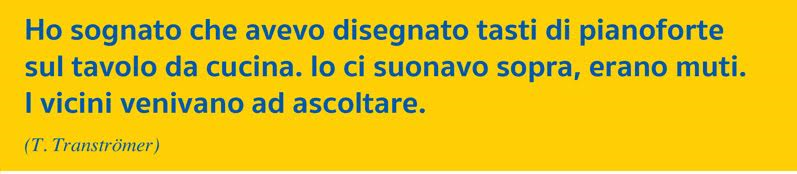
(commento di A. M. Ripellino – Corso su Pasternàk del 1972-73)
[È un compendio (questa poesia) dei motivi di Anna Achmatova poetessa dell’Acmeismo; ed è anche il tentativo di dare un’immagine di lei. L’impostazione della poesia vuole riflettere quella colloquialità, quel senso di dialogo prosastico e raziocinato che la Achmatova inserì nel tessuto della poesia russa. Alla solennità, alla aulicità del simbolismo, la Achmatova, come molti acmeisti, sostituì un linguaggio più piano, più ragionato e più colloquiale e quindi lievemente prosastico, e con questo linguaggio, influì su molti poeti tra cui Pasternàk. ]
Dal Corso su Pasternàk del 1972, traggo questa una mia nota 274, pag. 112.
( “…l’Achmatova mostra una lettera ricevuta da Pasternàk a Lidija Čukovskaja. dove il poeta cita alcune sue poesie del passato; la Čukovskaja è perplessa, ma la poetessa dice: ”Ora vi spiego tutto. Semplicemente. Ha letto [Pasternàk] per la prima volta le mie poesie. Ve lo assicuro. Quando io ho cominciato a scrivere, lui faceva parte di Centrifuga [gruppo futurista di cui fecero parte oltre che a Pasternàk, Aseev e Sergej Bobrov]: era naturalmente ostile nei mie confronti, e i miei versi non li leggeva, punto e basta. Ora li ha letti per la prima volta e, vedete, ha fatto una scoperta: gli è piaciuta molto >La piuma sfiorò il tetto della vettura…< Caro, ingenuo, adorabile Boris Leonidovic!”; p. 208.
Sui futuristi: “Prendete Majakovskij. Adesso [1940] dicono e scrivono che amava le mie poesie. Ma in pubblico mi copriva sempre di insulti”… [Majakovskij insultò aspramente anche la Cvetaeva] …”
Lottavano contro tutte le persone allora famose per farsi largo loro. Chlebnikov se la prende anche con Kornej Čukovskij… guerra alle celebrità. Avevano un bosco da abbattere, e tagliavano le cime più alte”; p. 259. L’Achmatova conosce Pasternàk nel

 Giorgio Linguaglossa
Giorgio Linguaglossa
È sempre da un punto preciso che bisogna partire, nel romanzo come anche in poesia. In queste ultime decadi romanzo e poesia si sono avvicinati, e non del tutto a scapito della poesia, la poesia di livello elevato ha fatto tesoro di questo principio. E del resto non è stato Mandel’stam che con la sua lotta contro i simbolisti russi i quali amavano e prediligevano il sognante, l’astrazione, la musica sublime… ha aperto la strada alla poesia del novecento?
Leggiamo ad esempio il padre della nuova poesia europea, Tomas Tranströmer:
Entrammo. Un’unica enorme sala,
silenziosa e vuota, dove la superficie del pavimento era
come una pista da pattinaggio abbandonata.
Tutte le porte chiuse. L’aria era grigia.
Qui abbiamo una esemplificazione di come il lessico e la sintassi della poesia sia stato ridotto alle sue componenti minime ed essenziali. Qui non è possibile togliere nulla, neanche una parola, una sillaba senza compromettere tutto l’insieme. Si tratta di un «interno», là ci sono degli oggetti precisi e concreti: non c’è nulla, infatti il poeta ci dice che la sala era «silenziosa e vuota». Nella poesia non c’è nient’altro. Un’altra annotazione annota: «Tutte le porte erano chiuse».
Magnifico esempio di essenzialità.
(1922).
1 novembre, 2017
Osip Mandel’stam
Solòminka II
Io vi ho insegnato parole beate –
Leonora, Solòminka, Ligeia, Serafita.
Nell’enorme stanza la pesante Nevà,
e sangue azzurro scorre dal granito.
Dicembre solenne splende sopra la Nevà.
Dodici mesi cantano di un’ora mortale.
No, non Solòminka in un raso trionfale
assapora la lenta, e stremante pace.
Nel mio sangue vive la dicembrina Ligeia,
il cui beato amore dorme nel sarcofago,
ma quella solòminka, forse Salomè,
è uccisa dalla compassione e non potrà più tornare.
1916
—————————
(trad. di AMR)
————————————————————————
mia nota 132, pag 46. (sulla metafora di Mandel’stam – Corso di AMR del 1974-75)
“Scrive Ripellino:”Mandel’štam, il maggiore degli acmeisti, poeta d’ispirazione classica, nelle sue liriche nitide e cesellate si avvicinò alla maniera ellittica e immaginosa dei cubo-futuristi. Lo si vede, ad esempio, dal breve componimento Solòminka del 1916, in cui allucinate e sconnesse metafore si vanno accumulando in una lenta progressione, come tasselli in un intarsio. E i calembours, la passione per le parole beate (blažennye slovà) scelte per il puro suono, l’assenza di nessi logici: tutto ciò pone l’arte di Mandel’štam in un’area contigua a quella del futurismo. Né va dimenticato che Mandel’štam scrisse righe di calda ammirazione per l’opera di Chlebnikov”, in A.M. Ripellino, “Letteratura come itinerario del meraviglioso”, Einaudi 1957 (1968), pgg.219-220. Lo slavista nelle stesse pagine si sofferma sugli accostamenti di Esenin, Cvetaeva, Zabolockij, Pasternàk al futurismo, compresi, è ovvio, Majakovskij ed Aseev… ma tutti questi poeti derivarono da Chlebnikov. Pagine di ammiratissima stima di Mandel’štam per Chlebnikov sono nel saggio Della natura della parola (del 1922, op. cit.), specie quando paragona il suo lavoro di scavo nella lingua russa a quello d’una talpa! (di Blok dirà che è stato un tasso! – vedi nota 40. p. 15). “.
————————————————
dalla mia prefazione a questo Corso 1974-75 :
“Ho ritenuto opportuno non dover indicare nelle note tutte le fonti citate da A.M.R., visto il tono colloquiale – gli affastellamenti continui e la spontaneità del suo discorrere colmo di associazioni e metafore fulminanti. Ho citato solo le fonti nei casi di alcune citazioni più importanti, e non tutte, e quelle di più o meno facile reperibilità. Ho curato tutte le annotazioni poco dopo l’epoca del Corso in oggetto; poi una lunghissima pausa; ho ripreso all’inizio del 2010 secondo i tempi e le modalità di cui disponevo, e l’umore e l’ipocondria a cui ero assoggettato. L’urgenza del commentare era per me più importante della stessa ricerca di varie fonti: alcune ho soddisfatto, altre no; d’altra parte il cercare e trovare le fonti per me sono eventi relativi che non devono mettere a repentaglio quel commentare, che ha come scopo il sentire la mente dei poeti e chiarire i loro intendimenti. Questo vale per me come metodo, per qualsiasi poeta o scrittore; nello specifico vale particolarmente per i tre poeti su menzionati, cioè dei rispettivi Corsi di A.M. Ripellino. C’è sempre tempo per trovare le fonti (non è difficile!), e rimando ad altri studiosi il cercarle e il trovarle, se lo desiderano, altrimenti si accontentino.

Mariella Colonna, grafica di Lucio Mayoor Tosi
Mariella Colonna
Un’altra volta
l’ ho incontrato au Mond des chimères
a l’Ile St. Louis sur la Seine
ma “lui” non ricorda. “Lui”, il mio mondo a parte
(ma non tra parentesi); da quando ho scoperto,
da bambina, che il tempo non è dentro l’orologio,
non fa muovere le lancette, ho deciso che il tempo non esiste,
che è un’illusione dei sensi, come lo spazio.
“Lui” sa che ho ragione, che mi conosce da sempre,
perché, se non c’è il tempo, l’eternità esiste
anche senza di noi, ma con noi acquista significato.
Adesso gli dico una cosa che finalmente lo farà sorridere:
“L’ombra delle parole” trova conferma scientifica nella
“Materia – ombra”.
La materia per il novantaquattropercento è invisibile
quindi inconoscibile perché non esaminabile
in laboratorio, neppure al MIT Media Lab di Boston.
Per inevitabile analogia, l’Ombra delle parole ha in sé
ogni significato: immagine grido suono gioia, i colori della speranza
e quelli dell’oblio, lo splendore delle tenebre e, infine,
l’onnipotenza della parola di Dio.
Dio: l’Innominabile.
Dio che esiste nell’ombra
e non vuole farsi scoprire prima del “Tempo”
perché questo è il solo tempo che certamente verrà.
Tutto ciò non si vede ma esiste ontologica-mente.
Je vais jouer avec toi, mon poète,
je vais te donner mes paroles,
mais tu ne joues pas bien avec moi
Parce que tu es un enfant terrible.
Mon chèr ami, je suis toi, tu es moi.
Que ce miracle se réalize en tout le monde
c’est la grande espoir de la paix universelle.









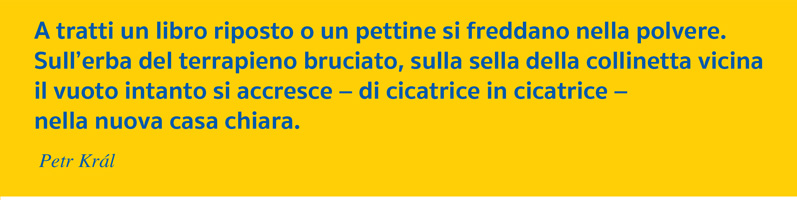









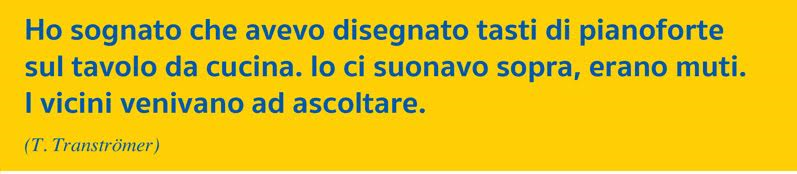

 Giorgio Linguaglossa
Giorgio Linguaglossa





































































































































.
La pittura istantanea (la Instant picture) dello scimpanzé Congo
Pittura gestuale, mirabile composizione coloristica, sfondo piatto, gesti radiali. È la pittura dello scimpanzé Congo. Un suo dipinto è al Musée de l’Homme di Parigi. La Mayor Gallery di Londra ha curato una sua personale nel 2012.
Le opere dello scimpanzé Congo (morto prematuramente di tubercolosi all’età di dieci anni, nel 1965) sono esposte in vari musei, tra i quali anche il Museo d’arte moderna di Roma. Il Natural History Museum di Londra ne ha una, ma anche il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino può vantare un suo lavoro. Suoi collezionisti sono il principe Filippo d’Edimburgo, Picasso, Miró, Dalí, Penrose…
In una settimana metà delle 55 opere (dipinti e pastelli su carta) esposte alla Mayor Gallery sono andate vendute in tutto il mondo, anche in Italia (prezzi dalle 1500 alle 6 mila sterline). All’asta del 2005, da Bonhams, una sua tela fu battuta a 14 mila sterline, mentre quelle di Renoir e Warhol rimasero invendute. La Mayor Gallery aveva esposto sempre nel 2005 anche i dipinti dello scimpanzé femmina Betsy.
L’etologo Desmond Morris si limitava a scegliere il colore della carta, Congo, con il pennello in verticale, praticava con gesti netti e precisi una pittura gestuale. Il risultato è uno stile composito, riconoscibile, ottenuto mediante una gestualità a “ventaglio”. Nei filmati su youtube si nota Congo che dipinge con passione e precisione non certo casuali; ad esempio, decide il momento iniziale e il momento finale dell’opera, facendo supporre di avere in mente una precisa idea del suo lavoro.