
[foto Dino Ignani], Jonathan Rizzo, radici elbane, studi storici fiorentini, formazione poetica parigina. Ha pubblicato un romanzo poetico sperimentale, una raccolta di racconti saggi e poesie di viaggio, due raccolte poetiche ed un romanzetto giallo. È in diverse antologie poetiche e di racconti di narrativa. È stato pubblicato su diverse riviste e tradotto in francese, spagnolo ed inglese. Conduce una trasmissione radiofonica sulla poesia e sulle piattaforme web. Organizza eventi poetici in tutta Italia.
.
Una lettera al lettore ignoto
Ho sempre considerato il lettore come un nemico per il poeta. Non il solo, ma tra i più insidiosi. Subdolo punto di arrivo per quei versificatori che battono con l’ammorbidente la penna sul foglio col pensiero ansioso di arrivare a chi inciamperà nelle loro parole, sogno caldo neanche troppo segreto di fare una carezza tenera a più persone possibili. L’ho pensata così a lungo e continuo a pensarla ancora in toni di grigio. Ancora oggi m’imbarazza sentirmi dire/dare complimenti sul poetare e lo scrivere che incespico. M’imbarazzano mortalmente al di là della puerile vanità umana dello scrittore. Il tempo e le sue passeggiate mi hanno educato ad avere una faccia da “poker” davanti al lettore e che nemici più maligni per un poeta sono i critici, gli accademici ed i giovani tirapiedi di questi ultimi. Poetini mai usciti dal parco giochi dell’Università confortevole e non ancora svezzati da madri troppo melliflue nei loro baci a figli rimatori baciati, che mai hanno visto una pistola puntatagli sotto il naso ad urlare il dolore e smarrimento dell’essere umano. Lo scontro con il buco nero della realtà poetica italiana contemporanea fuori dalla mia dolce bolla da flâneur parigino mi ha corrotto l’anima ponendo totale rifiuto alla natura d’inchiostro che mi scorreva nelle vene e spingendo questo derelitto “uomolibro” verso una salvifica oasi fatta di letture mai contemporanee, sempre dei classici moderni, come si usa dire. L’onestà intellettuale pone di ammettere che per il poeta il lettore è un nemico, ma che per il lettore il poeta è un caro amico con cui vive, cresce, cambia, matura fino alle retoriche foglie d’autunno. Praticamente amare con tutto il fiato nel petto un cretino disadattato perché specchio intimo del personale sé disadattato e cretino, cioè la parte migliore di noi, quella senza maschere. La verità è che sono più felice da lettore che da scrittore. Non nemico di me stesso, ma sintesi finalmente raggiunta tra l’infelicità esistenziale necessaria dello scrivere e lo gioia egoista della lettura.
Caro amico lettore ignoto diffida dalle parole che sembrano state scritte per te.
Jonathan Rizzo
.
«In definitiva, però, bisogna sempre tenere presente che la realtà della quale possiamo parlare non è mai la realtà in sé, ma è una realtà filtrata dalla nostra conoscenza, persino, in molti casi, da noi configurata. Se a quest’ultima formulazione si obietta che dopo tutto c’è un mondo oggettivo, completamente indipendente da noi e dal nostro pensiero, che procede o può procedere senza il nostro apporto e al quale in realtà ci riferiamo con la ricerca,a quest’obiezione a prima vista così ovvia si deve opporre il fatto che già l’espressione “c’è” appartiene al linguaggio umano e non può quindi significare qualcosa che non sia in relazione alla nostra capacità conoscitiva. Per noi “c’è” appunto solo il mondo nel quale l’espressione“c’è” ha un senso».1
.
L’estraneazione è l’introduzione dell’Estraneo nel discorso poetico. Lo spaesamento è l’introduzione di un Avatar nel Paese del linguaggio poetico. Il mixage di instantgrammi e di shifter, la deviazione improvvisa e a zig-zag sono gli altri strumenti in possesso della musa di Jonathan Rizzo. Queste sono le categorie sulle quali il poeta elbano costruisce il suo discorso in segmentazione progressiva. Il verso è spezzato, segmentato, interrotto, segnato dal punto e dall’a-capo è uno strumento chirurgico che introduce nei testi le istanze «vuote», i simulacri di ciò che è stato agitato nella poesia del novecento, nella vita quotidiana, non esclusi i film, anche quelli a buon mercato, le long story… flashback a cui seguono altri flashback che magari preannunciano flashback di film visti… non ci sono domande, ma solo constatazioni. C’è il vuoto, però.
Altra categoria centrale è il traslato, mediante il quale l’io parla mediante un retro pensiero o un pensiero interconnesso con quello; l’io così viene ridotto ad una intelaiatura vuota, vuota di emozionalismo e di simbolismo. Questo «metodo» di lavoro introduce nei testi una fibrillazione sintagmatica spaesante, nel senso che il senso non si esaurisce nella proposizione dichiarativa ma in altre proposizioni magari sottintese che correggono quelle dichiarative. L’eloquio fintamente conviviale è in realtà spaesante.
Lo stile è quello della didascalia fredda che accompagna i prodotti commerciali e farmacologici, quello delle dichiarazioni di voto al Parlamento, quello delle notifiche degli atti giudiziari e amministrativi mischiato alle proposizioni autoironiche e ironiche sull’io e sul contemporaneo. Jonathan Rizzo sa scrivere alla stregua delle circolari della Agenzia delle Entrate, o delle direttive della Unione Europea ricche di frastuono interlinguistico con vocaboli raffreddati dal senso chiaro e distinto. Questa severa concisione referenziale non esclude interferenze, fraseologie spaesanti e stranianti.
Tutto questo armamentario retorico era già in auge nel lontano novecento; qui, nella poesia del poeta elbano risulta nuovo, anzi, nuovissimo risulta il modo con cui viene pensato il discorso poetico dei nostri giorni dove il «lettore» viene definito un «nemico».
Ci sono la leggerezza e la destrezza di Apollinaire in certe rientranze e giocolerie stilistiche di Rizzo: («la gente che gioca alla vita leggera», « Le auto attendono, le barche galleggiano, tu scrivi»); certi andanti larghi descrittivi («Uomini, donne, bambini che vi fate saltare in aria, nemici ed amici»), shakerati con sintagmi da confessione («Amo la vita e non me la toglieranno più»), certi stacchi autoironici («Sono solo. Aspetto/ la mia donna ed il suo portafortuna tra le gambe»), certi spot della pubblicità della Buitoni («La campagna toscana con abito gentile»), mottetti irriverenti («Non conosco gelaterie in Francia»), sintagmi strappalacrime («Io urlavo lacrime e poesie»), sintagmi assiomatici («Dio è il concetto con il quale misuriamo il nostro dolore»), mini proposizioni constatative («Io non fumo. Dovrei iniziare a fumare»), sintagmi aristocratici («L’unica persona viva dorme»). Il tutto compostato in uno sketch stilistico di ottima fattura autoironica. Jonathan Rizzo immagina la sua condizione come quella di quell’umano che si mette nella condizione della cosa, anzi, che si offre allo sguardo delle cose; la sua è, propriamente, una poesia della mancanza e dello sguardo delle cose sull’io.
Qual è il significato del distacco della poesia di Jonathan Rizzo dalle fonti novecentesche? Il fatto è che quelle fonti si erano da lunghissimo tempo disseccate, producevano polinomi frastici, dumping culturale, elegie mormoranti, chiacchiere da bar dello spot culturale. La tradizione (lirica e antilirica, elegia e antielegia, neoavanguardie e post-avanguardie) non produceva più nulla che non fosse epigonismo, scritture di maniera, manierate, magari ben lubrificate e lucidate. Jonathan Rizzo dà uno scossone all’immobilismo della poesia italiana degli ultimi due tre decenni delle generazioni precedenti la sua, e la rimette in moto. È un risultato eccellente, che mette in discussione tutto il quadro normativo della poesia della sua generazione.
(Giorgio Linguaglossa)
1 Werner Heisenberg, Indeterminazione e realtà, Guida Editore, p 2002, p. 123.
 A Fabrizio
A Fabrizio
L’unica persona viva dorme
mentre i poeti,
quelli veri,
parlano di metrica con logica acida matematica.
senza guardarsi negli occhi
ché il piedistallo di plastica
non concede che li si tocchi.
Ma l’unica persona vera russa
sdraiato per terra
con la custodia della pianola
a fargli da giaciglio
dopo pranzo, dopo il vino, rosso camino.
Riposa tra i fili l’erba nell’attesa perla
di sfiorare tasti neri
per farli divenire bianchi,
accarezzare chiari
per volo e dispetto
da mutare scuri.
Gioco d’ali
di colombe e falchi
nel tiepido meriggio Giunone
di fine primavera,
amica lieve, amante breve.
La campagna toscana con abito gentile
splende in un abbraccio di luce senza fine,
nuvole sconfinate,
un poco vicine, un poco lontane.
Ma i poeti, quelli veri, non hanno tempo per godere
della bellezza che il cielo ricama
a scherno degli uomini
briciole distratte.
Lamentarsi dello schifo che circondi i loro versi
è più importante
che masticare una spiga di grano controluce,
o fermarsi sulle nuvole persi.
Ma tutto questo inferno d’animo non scuote
l’unica persona normale
che sogna note e colori
da donare
come fanno i bambini alle bambine
con i fiori.
Ed io?
Ed io sono fortunato ad essere amico tuo
ed ancora
non come loro.
BESTIARIO PARIGINO
Sgattaiola nel calpestio de li uomini,
anime in contrabbando fragile.
Io non fumo. Dovrei iniziare a fumare.
Compro da bere. Io bevo. Dovrei smettere.
Sono solo. Aspetto
la mia donna ed il suo portafortuna tra le gambe.
Arriveranno con le strade lavate di fine estate.
Scrivo così bene a Parigi, solo per me stesso.
Non c’è fretta che il tempo cambi.
Filtro assenzio e pastis coi miei oi parei.
Occhi francesi,
passaporto al tricolore.
Non conosco gelaterie in Francia.
Altro cuscino in questo square fiorellino
tra il cicalare umano del caldo agostano.
Amico mio dammi la mano.
Passeggia da professionista
senza direzione tra i pensieri
e la loro corrotta memoria di orgogliosa miseria,
carne e sangue, piaghe di poesia ed isteria.
La muette freccia.
Non conta per dove.
Vola sopra la gente che gioca alla vita leggera.
Refrigerio canino,
esempio all’umano
bestiario.
Il ponte che passa.
Le auto attendono, le barche galleggiano, tu scrivi.
I ricordi di un sorriso vengono smantellati
dall’ineluttabilità del tempo.
Un nuovo passato ogni giorno da seminare.
Nascosta dal filo spinato
la vita perduta di alcune persone,
ma non, né rimangono impigliate tra le virgole pendule il nome.
Pare sempre domenica quando piove sulle luci di Parigi.
La festa di pace non si concluderà questa notte.
Nel seccarsi dell’inchiostro tra il foglio e la punta lenta
spunta il sole dietro le nuvole serie.
Si porge lieve come carezza di profumi gentili
per le persone sole.
Amore siamo in ritardo?
In ritardo per cosa?
I morti aspetteranno!
CANTO LA VITA. ODE A PARIGI
Parigi è viva,
ed io con lei.
Non abbiate paura.
Non regalategli voi stessi.
I mostri meritano pietà,
ma non il dono prezioso della paura.
Parigi è ancora viva, respira.
Io l’ho vista con questi miei occhi di uomo.
Non abbiate paura di farlo anche voi.
La paura è lo scudo di chi si fa forte con la violenza.
Noi siamo immortali
perché sorridiamo ed amiamo la vita,
le sue figlie ed i suoi figli.
Io sono uscito a petto nudo
per le strade spezzate dal pianto,
foglie morte al mio fianco.
Ed ho sentito sulla pelle
la chiara impotenza del derubato,
pensando debole
a tutte le vite che ho perduto,
pensando fragile
possono spararmi,
ma non spaventarmi.
Amo la vita
e non me la toglieranno più.
La condivido con voi,
tutti voi.
Uomini, donne, bambini che vi fate saltare in aria, nemici ed amici.
Non temo nessuno.
Amo e sono fatto di carne.
Abbraccio ogni volto stanco,
frustrato dall’odio e dall’ignoranza.
Più sarete lontani e più la mia mano si tenderà verso di voi.
Parigi vive ed io sono suo figlio.
Non moriremo mai,
perché nel petto abbiamo forte
l’amore e la fratellanza tra gli uomini ed i popoli tutti.
Odi mondo
alto si leva ancora il nostro canto,
siamo vivi e teneri tuoi amici,
io e la sorella Parigi.
Gli odi di uomini bruciati dalla paura non ci possono ferire più.
Amiamo disperatamente anche loro,
perché nessuno lo fa.
DEDICATO A JACK KEROUAC
Eravamo al solito su un placo scalcagnato,
rimediato facendo gli occhi dolci
ad una giovane ed ingenua Dea.
Il contrabbasso spingeva fiamme i pedali
cercando la fuga sui Pirenei del Jazz.
Io urlavo lacrime e poesie
ad una sala vuota di umanità e sorrisi.
La carta del Caffè letterario universitario
si stava rivelando un flop velleitario.
A vederci non era chiaro
se fossimo stati più ipocriti noi
a porci ad un pubblico sordo che sotto sotto disprezzavamo,
o chi a vent’anni non legge se non per obbligo d’esame.
Io ingenuo come un bambino
avevo preparato la performance a puntino,
importunando le muse delle arti maggiori,
ingaggiando maestri e leggende di uomini rari,
affittando sogni scritti meglio dei miei vuoti paroloni.
Pierangelo divino come un airone
volava leggero sopra le nuvole
incurante di come stessi perdendo per k.o. tecnico
quel match di pugilato chiamato poesia e vita.
La sala vuota rendeva ancora più ridicolo
quel mio agitarmi dinoccolato,
sottolineandolo con tono crepuscolare e disperato.
Per pietà una dolce farfalla aprì il portone sulla strada
sperando che i miei fuochi d’artificio gutturali
riuscissero ad impressionare i viandanti per la rada.
Era lei che avevo sedotto di fiore in fiore
e mi aveva staccato l’ingaggio per poche lire
e molto, troppo, esageratamente da bere.
Così mi piace farmi pagare,
qualche pompino e molto vino.
Da Marte responsabile ansiosa
per il mio fallimento marchiato d’infamia
sulla sua pelle graziosa.
Ai giovani universitari non interessa la cultura.
Ai fiorentini non piace la poesia.
Secoli alle spalle ce l’hanno dimostrato plurime volte.
Mentre i fantasmi di Dante Alighieri e Dino Campana
guardandomi teneramente mi suggerivano verità inevitabili,
il mio fedele pubblico si affacciò sulla strada,
unica amica reale rimasta gentile
per chi abbia attraversato lo specchio e sia divenuto favola da ricamare.
Io e Piero ci guardammo
e finalmente sorridemmo.
Non eravamo più soli.
Ardevamo scintillanti oscurando l’eclissi.
Un uomo,
una persona vera,
un clochard
si era fermato ad ascoltarci
accarezzando ogni nostro dolore,
note e parole.
Lui capiva quello che le corde pizzicate e quelle graffiate
stessero urlando e bruciando.
Vivi al mondo eravamo solamente noi tre,
stelle danzanti.
Ho sbagliato
e non mi giustifica il fatto che fossi così rapito e sospeso dalla sua bellezza.
Avrei dovuto scendere dal palco
ed elevarmi a livello dell’uomo.
Andare da lui, fuori nella realtà.
Abbracciarlo,
anzi meglio, ciò che conta,
offrirgli da bere,
pagargli da respirare.
Rubare una bottiglia di vino,
scappare dalla commedia e scolarla assieme fino al mattino.
Il resto erano puttanate.
Ho proprio intrapreso strade sbagliate,
ma sto imparando la differenza tra bene e male.
Quella sera per aver sputato sangue e sudato sperma,
ci pagarono una miseria.
Zero applausi di plastica nelle orecchie,
ma vino defraudato tra le viscere
e qualche sogno di morbide cosce
a porsi specchio sorridente d’orgoglio
alla presa di coscienza
di come il mio pubblico sia un esercito di barboni e puttane.
Unici esseri umani reali di cui valga la pena d scrivere,
con cui abbia senso brindare
a questo inferno pazzo che è il vivere.
Almeno finché Piero suonerà il contrabbasso al mio fianco
a scherno del resto,
scimmia idiota che non fa neanche ridere.
EPITAFFIO DAL PIÙ GRANDE POETA MORENTE
Dio è il concetto con il quale misuriamo il nostro dolore.
Non credo in Jonathan Lennon, pur citandolo.
Non credo alle stelle, pur usandole per portarmi a letto le belle ragazze,
alla loro luce morta milioni di fa.
Non credo al decalogo del poeta,
pur trasudandolo dalla pelle stanca
che ricorda e conosce solo l’urlo come affermazione di sé.
Non credo a voi gente per bene
Dai buoni consigli sterili.
Non credo all’uomo italiano e mediterraneo,
fascista vecchio, post, neo, borghese, padronale, legaiolo ed a 5 stelle, di cui ho già detto di non credere.
Non c’è resurrezione né speranza alcuna più.
Non credo nei populismi dell’homo homini lupus.
Non credo ai sacri confini degli stati
da difendere ciecamente con lo spauracchio della paura del diverso.
Credo al nomadismo,
credo al viaggio come unico senso della vita,
la ricerca di sé, di un perché
ad un’esistenza da trascinare tra la bellezza della natura e le storture dell’umana miseria.
Credo negli zingari,
il vero popolo eletto.
Gli unici rimasti seri e coerenti nel “belpaese”.
Non credo alla democrazia italiana,
mercato del posto fisso
in parlamento o in televisione,
che in questo paese malato se non appari non esisti.
Credo a chi si alza all’alba per portare il pane a casa ai figli.
E lo dico io guardandovi negli occhi,
io che sono sterile per fortuna,
una casa non ce l’ho
e non mi alzo mai prima di mezzogiorno
perché mi da fastidio il rumore della gente onesta che va a lavorare,
mi mette a disagio con la mia vigliaccheria.
Non credo più nel bene e nel male,
l’uomo non è all’altezza di entrambi.
Siamo fatti della stessa pasta della mediocrità che sta nel mezzo.
Non credo in Dio,
nel vostro Dio,
in qualsiasi Dio.
Mi ha abbandonato tempo fa.
L’uomo è solo in questo scarto di universo.
Non credo nella Dea,
Lorenza non merita una goccia del mio inchiostro di carne,
figuriamoci sperma e sangue.
Mi ha ucciso tante di quelle notti
che non so più morire.
Eterno poeta dell’inutile cantilenante,
eternamente errante errante.
Non credo nell’amore,
non credo più nella poesia.
Credo nell’eroina e nel whisky.
Non credo a te, padre, maestro, professore, direttore, generale, presidente, re, imperatore e pontefice massimo
che non sai neanche che esista.
Difficile chiedere il mio voto con queste premesse.
Credo nell’Anarchia,
unico volo di libertà
che l’uomo trova in se stesso,
animale armonia.
Non credo nella legge
che punisce il debole
e si fa ammansire dal potere.
L’uomo non è la proiezione di Dio,
ne è la scorreggia,
il lascito di seme
sulle lenzuola del cosmo.
Di un Dio in cui comunque non credo.
Non credo a Napoleone.
Dovevi distruggere la perfida Albione
e liberare l’umanità dalle catene
invece di rimirarti pingue
in specchi dorati
nel tuo mantello ali di aquila.
Non credo nei miti rivoluzionari del ’48, del ’17, del ’68, del ’77.
Tutti questi antenati da album di famiglia non credono in me.
Non credo al mio padre morale Charles Bukowski.
Devo combattere la mia battaglia,
non ricamare a bassa voce quella di qualcun altro.
E questo vale per me come per chiunque di voi.
Non credo in voi che amate ed odiate e cambiate sentimenti ed opinioni con la superficialità
di chi non conosce cosa sia l’amore e l’odio, il tormento e l’estasi,
ma pretendete d’imporre la vostra truffa a chi innocente crede
o credeva ancora.
Quando domani mi tirerò il collo
resterete solo la polvere che siete,
ombre di uomini e donne.
Credo solo in me stesso.
Il sogno è finito, Dio non esiste e l’abbiamo tutti al culo.















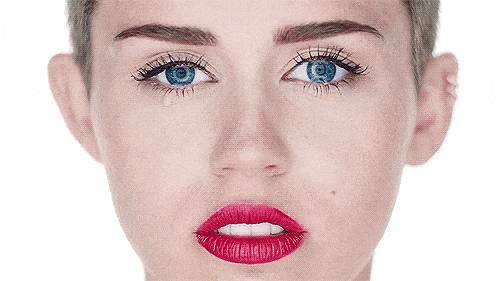
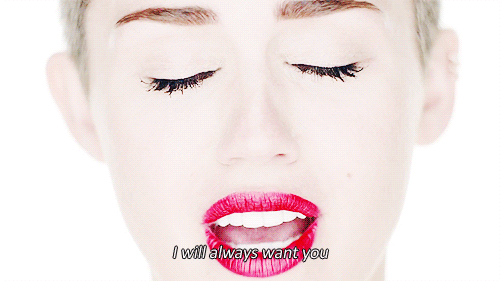


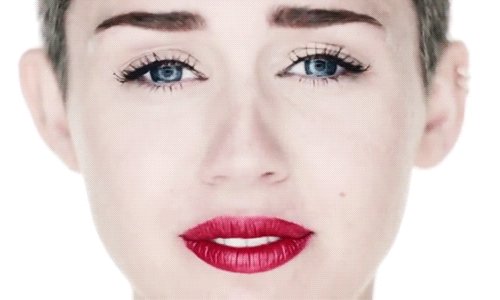








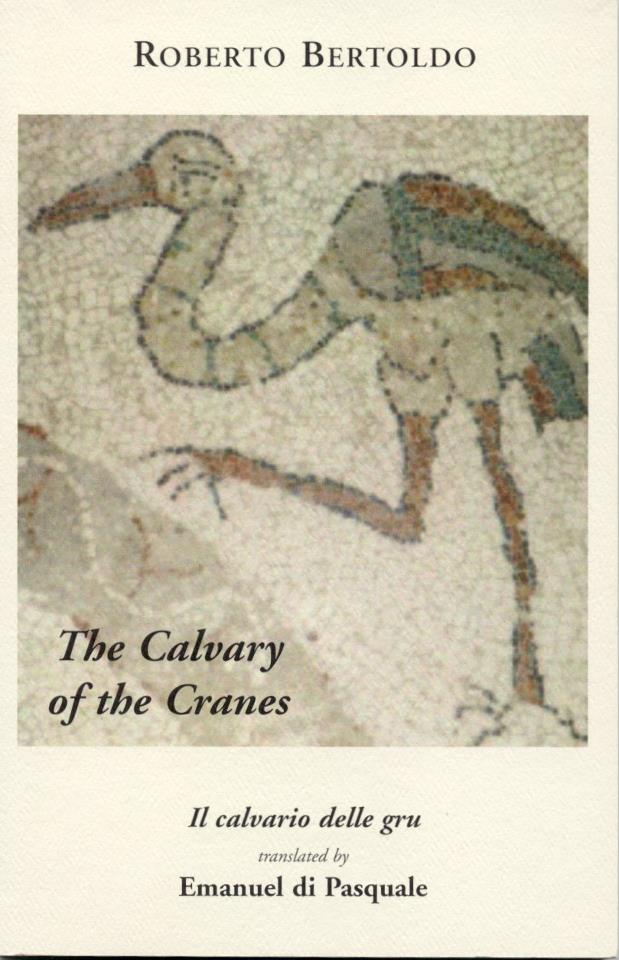
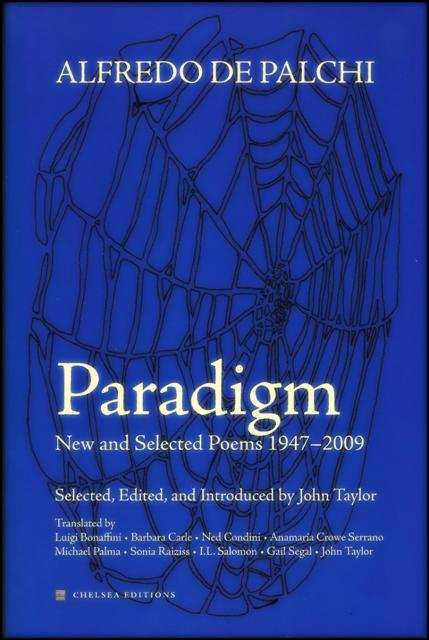


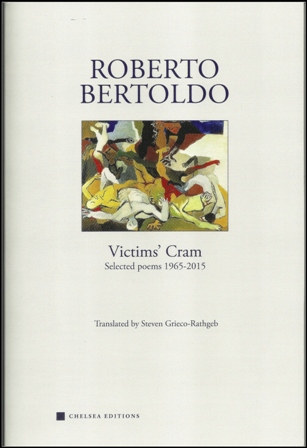





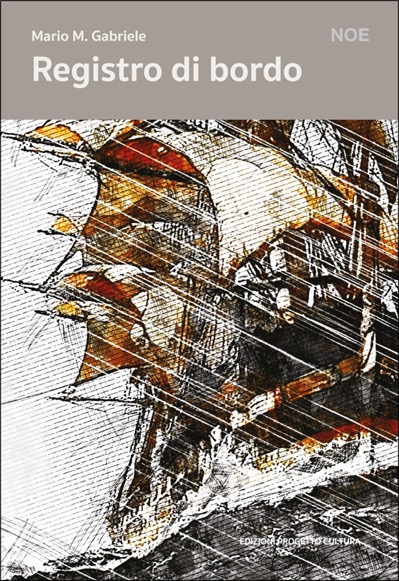

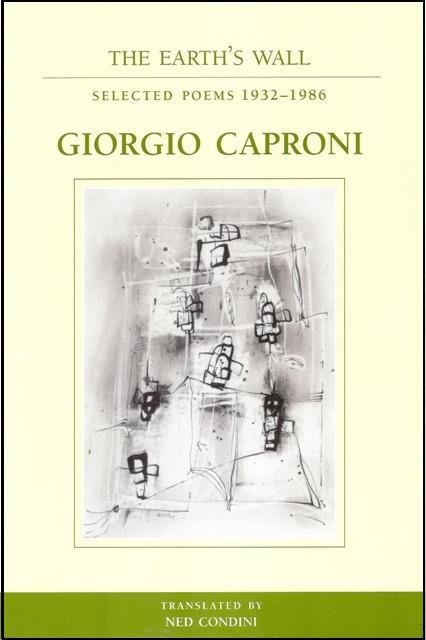
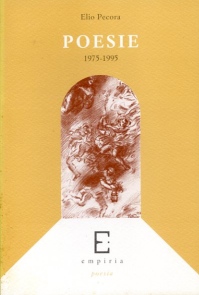

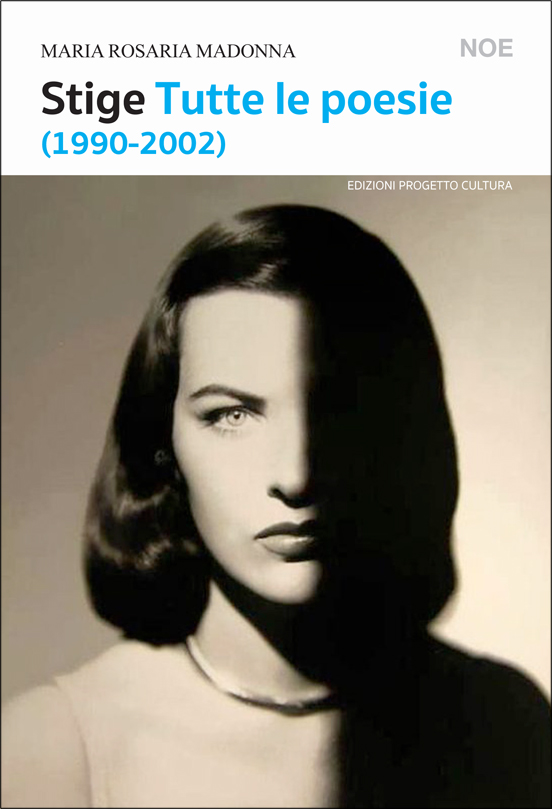

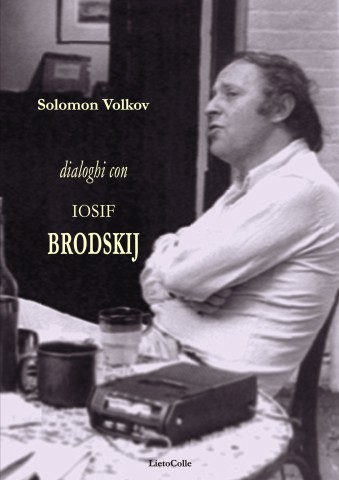




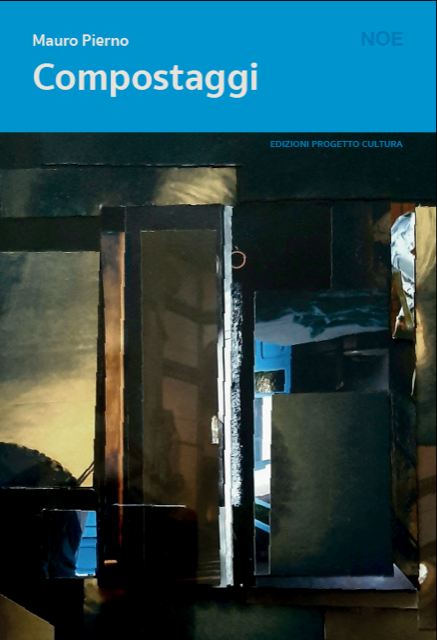




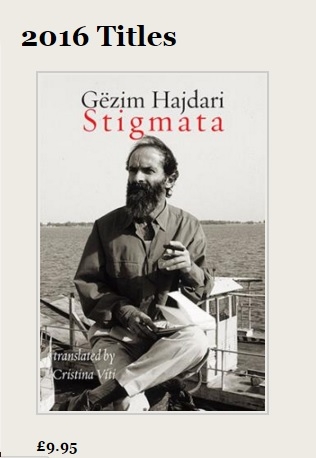






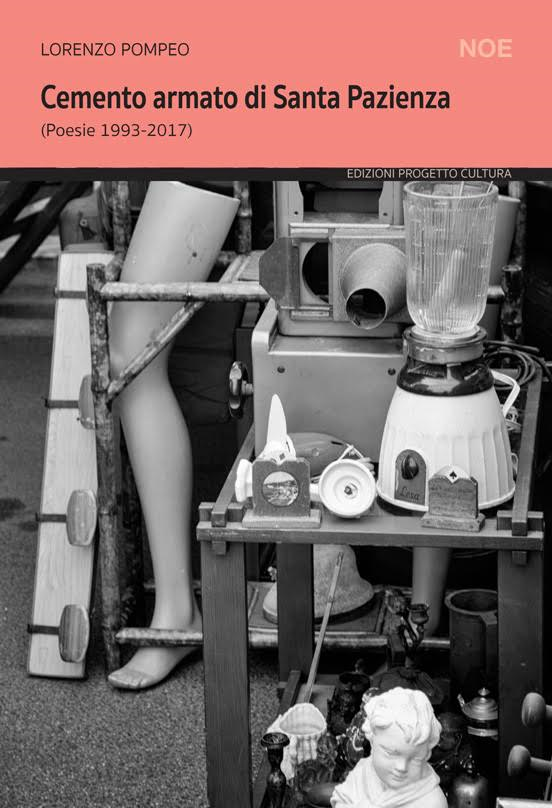







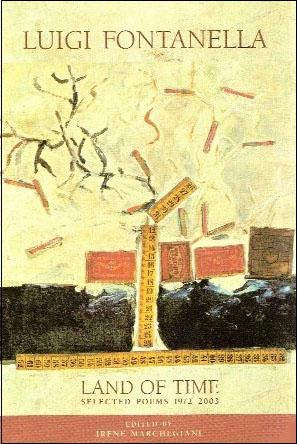








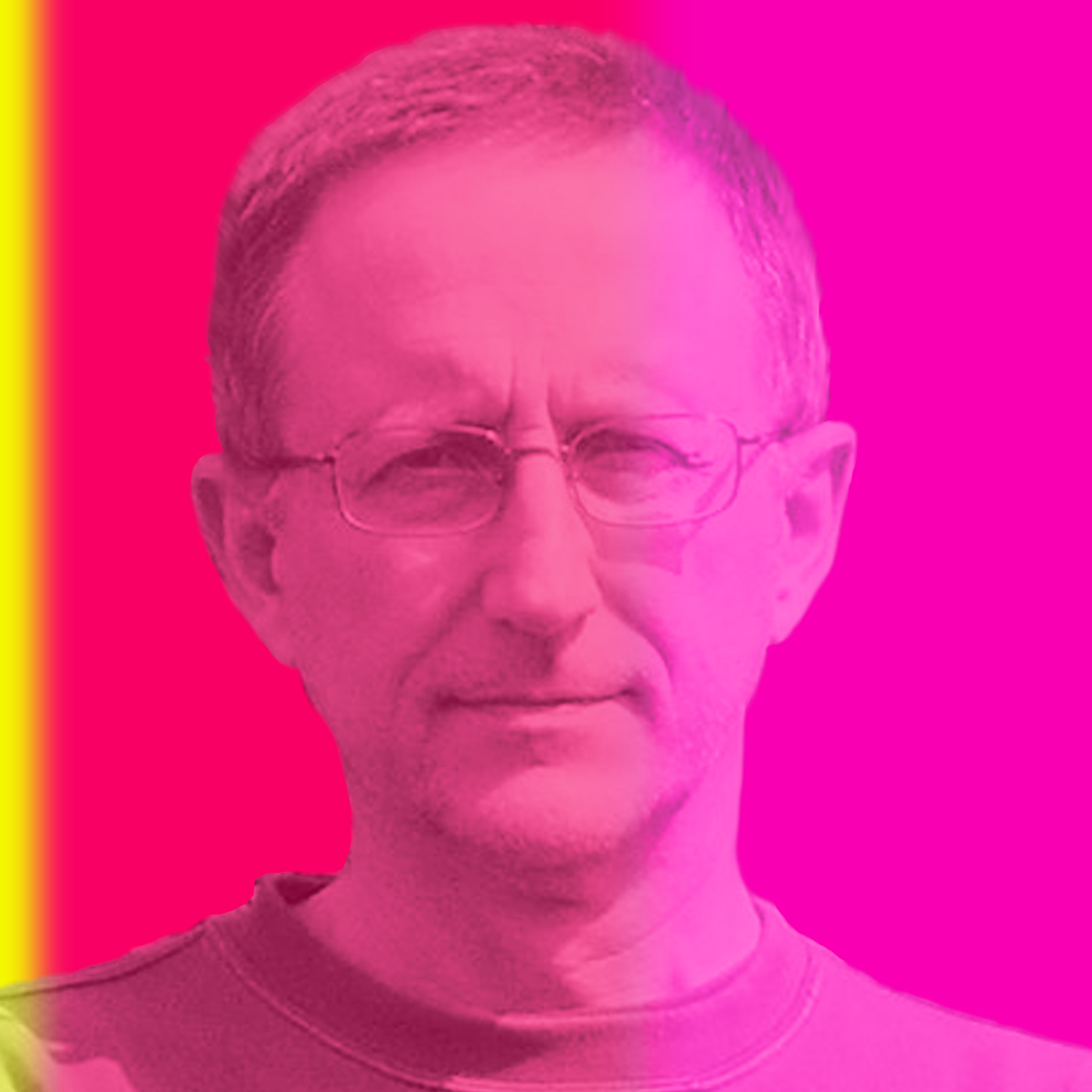







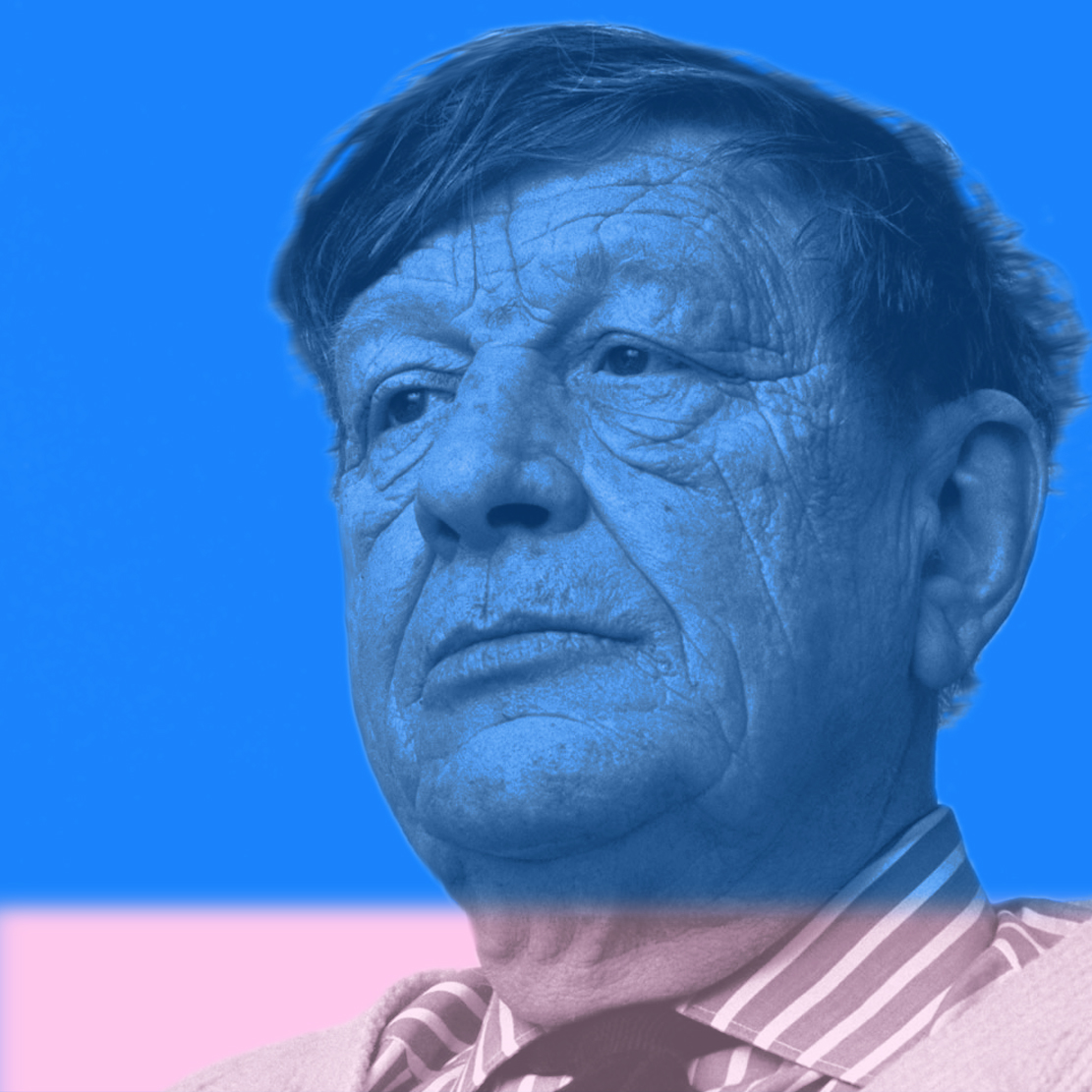





















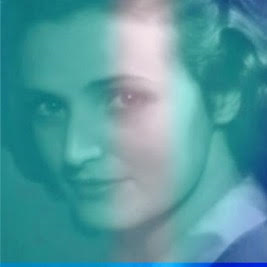































Giorgina Busca Gernetti legge Asfodeli foto di Massimo Bertari
Mirza Asadullah Ghalib affascina il lettore per la freschezza, quasi ingenuità, nel contempo profondità filosofica dei suoi versi, strutturati in distici rimati nel modo illustrato con precisione da Steven Grieco.
I veri poeti della fascinosa India, almeno per le mie scarse conoscenze, hanno questo nucleo ispirativo: il cielo notturno, le stelle, l’alba, la natura, gli uccellini, i fiori, l’amore, la sofferenza dell’uomo e la pazienza nel sopportarla. Mi riferisco anche a Rabindranath Tagore, benché l’epoca, la regione indiana, la lingua, la struttura delle poesie siano diverse da quelle di Mirza Asadullah Ghalib.
Forse è l’anima dell’India che sa creare poeti così grandi.
Mi piace riportare alcuni distici veramente pregevoli (quattro Ghazal e uno Sher):
.
“non tutti, solo alcuni apparvero nei fiori e nelle foglie –
chissà i volti che rimangono nascosti nella polvere”
.
“le figlie dell’Orsa rimasero celate nel velo diurno –
perché mai ascesero nude, radiose nella notte?”
.
“”suo è il sonno, suo l’animo, sue le notti
fra le cui braccia si sciolgono inquiete le tue chiome”
.
“al mio entrare in giardino, il coro di gorgheggi si fece attento
ascoltando i miei lamenti gli usignoli divennero poeti”
.
“non sono né il fiore del canto, né il mistero della cetra:
io sono la voce del mio stesso spezzarsi”
(Giorgina Busca Gernetti)
Giorgio Linguaglossa 2012
È che oggi forse si dovrebbe ritornare a scrivere in distici, in ritornelli di distici… riprendere le antiche formule e ripartire da lì; scrivere pensieri conchiusi in immagini nell’arco di un distico, e poi nel distico seguente percorrere di nuovo il solito schema (magari con una variante), ovvero, provare ad introdurre un altro verso (la strofe caudata di tre versi) etc., e così via.
Il fatto è che oggi si è persa la manualità della scrittura, si scrive senza far riferimento a nessun genere o sotto genere, e i risultati si vedono purtroppo! – Il parallelismo cui costringe un distico è una forza magnetica, un binario che soltanto chi sa e ha la poesia nella propria pelle può capire; il parallelismo implicito in un distico, è cosa diversa da un distico con una coda (aggiunta di un terzo verso), a volte (anzi, sempre) basta una variante a cambiare il centro di gravità di tutto il componimento.
Quindi io consiglierei chi vuole fare poesia a studiare le antiche formule, di scrivere in distici, per esempio, e in immagini di distici…
Chiedo ad Antonio Sagredo e a Steven Grieco di farci conoscere la loro dotta opinione.
Rilucono le stelle in un frammento
d’immenso nella notte senza vento.
.
L’assenza dell’amata squassa l’animo
dell’uomo che la invoca in un lamento.
.
Acceca il sole con la luce d’oro
i mietitori curvi sul frumento.
.
Prestami la tua arte, sacro vate,
perché possa cantare il mio tormento.
.
Foglie frementi nel bosco armonioso
di canti d’uccelli in festoso concento.
.
GBG
Steven Grieco_A Shilp Gram, Udaipur India
Certo, la questione della forma a cui accenna Giorgio sarà sempre un problema per la poesia e per i poeti. Ma è proprio, e in modo sovrano, la struttura aperta o libera a valere oggi come forma poetica “tradizionale”. Quella che più ci impone un rigore. (Per il domani, chissà.)
A proposito, sembra che i giovani giapponesi usino spesso il haiku o il waka per messaggiarsi tramite telefonino… O allora è stata solo una moda qualche anno fa, che è già tramontata.
In questi tempi spietati, ma anche incredibili e entusiasmanti, in cui ogni tradizione è stata ridotta all’assurdo, sembra che un vero poeta (ma, se è per quello, anche un vero artista con i suoi dipinti e le sue installazioni) debba mettere tutto il rigore e la disciplina proprio nella forma aperta, la forma per eccellenza che ti dà tutte le possibilità, ma poi ti castiga se di essa hai fatto cattivo uso.
Lo stesso Ghalib lamentò verso la fine della sua vita, in un suo distico (che adesso non ho a portata di mano), il fatto che la forma del ghazal e le immagini convenzionali ad esso associato (rosa, usignolo, giardino, candela, rugiada, etc.) imprigionassero troppo la sua vena creativa. Più moderno dei moderni, già alla metà dell’Ottocento, quando i poeti francesi iniziavano solo vagamente a muoversi in questa direzione, Ghalib sognava la possibilità di esprimersi con una forma espressiva aperta.
Tanti anni fa ho visto le bozze originali di diverse poesie di Shelley. Aveva già deciso il metro e la rhyming scheme, il tipo di rima, ponendo sopra il rigo gli accenti tonici (8, o 10, a seconda). Gli accenti tonici c’erano già tutti, ma qua e là ancora mancava la parola prescelta per completare quel verso (di solito all’interno del verso, per ovvie ragioni). Ecco, questo ti fa capire che il poeta che usa una forma poetica specifica deve comunque già avere nel cuore e nell’orecchio il ritmo – voglio dire la musica – del verso, prima ancora della scelta di tutte, tutte le parole. Per un poeta di secondo ordine potremmo dire: ah, ecco, la musichetta a scapito del senso, ma le bozze delle poesie di Shelley invece ci mostrano quanto la musica già contenga il senso profondo del dire, e quanto in poesia musica e significato non possono proprio scindersi.
Ed ecco che mi vien da pensare che quindi anche il poeta oggi deve imporsi una grandissima disciplina con la forma aperta: perché una poesia senza musicalità e comunicazione di un significato (quale che sia e in qualsiasi modo lo si faccia, anche a testa in giù), be’, non so, forse non si tratterebbe più di poesia. Penso ad esempio, in musica, a uno Stockhausen o uno Scelsi, che hanno lavorato con forme in qualche modo aperte ma dandosi una disciplina immensa, lo senti in ogni nota, e quel rigore è proprio una delle cose che ti entusiasma, ti fa pensare che è solo con la forma (se anche per ritrarre il chaos), che possiamo comunicare, comunicando perfino realtà, immagini, concetti sublimi.
Detto questo, faccio posto a tutte le definizioni possibili della parola poesia, ovviamente. Ancora oggi vale quello che disse Montale una volta, “in poesia tutto fa brodo.”
Questo anche per la forma della poesia.
foto di Steven Grieco
Caro Steven,
è vero quello che tu dici, che condivido al 100%. Tu scrivi che già «Ghalib sognava la possibilità di esprimersi con una forma espressiva aperta», perché si era reso conto che la forma chiusa tradizionale del distico era troppo costrittiva per la sua poesia.
Ecco, siamo arrivati al punto. Nel Novecento siamo passati attraverso una rivoluzione delle forme espressive, siamo passati dalla forma-chiusa alla forma-aperta (U. Eco L’opera aperta, 1962), fenomeno che ha investito il romanzo, la poesia, la pittura, la scultura, la musica, l’architettura etc., quindi un fenomeno globale, come si dice oggi. Ma per la poesia è poi intervenuto un fenomeno, al tempo, ancora più vistoso e più misterioso: la caducazione del verso tradizionale per il verso libero e la caducazione del verso libero per il verso arbitrario, dove ciascun autore è libero di adottare il verso (nel senso della lunghezza) che più gli aggrada. Se oggi apriamo un libro di poesia di un autore contemporaneo, troviamo appunto il verso arbitrario(non so quanti autori ne siano consapevoli), dove l’arbitro del verso è deciso dallo stesso autore, dove è l’autore che dà legittimità alla lunghezza e alle intensità (foniche e toniche e ritmiche) del verso. Siamo arrivati alla Babele del verso arbitrario, e i risultati sono piuttosto evidenti. Siamo arrivati al punto che non esistono più le differenze tra la forma-poesia e la forma-prosa, addirittura non si ha più cognizione di quella cosa chiamata un tempo laforma-poesia.
Ma torniamo al verso-arbitro o arbitrario e veniamo ad esso, esaminiamo la sua struttura interna ed esterna. Vorrei invitare i lettori ad andare a rileggersi una poesia di un poeta contemporaneo che abbiamo pubblicato su questo blog: Gezim Hajdari nella poesia “Il contadino della poesia”
https://lombradelleparole.wordpress.com/2014/12/15/fare-il-contadino-della-poesia-di-gezim-hajdari-con-una-nota-di-armando-gnisci/
È chiaro che qui ci troviamo davanti ad un sistema aperto dove ciascuna frase raddoppia e ripete la struttura semantica della frase precedente mediante una variatio del significato e del ritmo interno ed esterno dei versi. Siamo davanti alla forma più elementare e primordiale del linguaggio poetico, il verso singolo che viene ripetuto con varianti all’infinito, la repetitio. Qui dunque il sistema è aperto, apertissimo, e permette al’autore di introdurre le varianti che crede opportune al fine di ottenere un effetto moltiplicatore dell’intensità orchestrale.
E fin qui ci siamo. Esaminiamo (per semplicità di ipotesi) adesso un effetto di moltiplicazione interna di un singolo verso di una, perdonatemi, mia poesia:
Kinder Nacht. Kinderschreck. Kinderspiel.*
Un cane rabbioso abbaiava.
Ma tu non c’eri. Guardai indietro.
C’era un corridoio con tante stanze chiuse. L’hotel Astoria.
(*Notte di bambini. Spauracchio. Gioco infantile.)
Come si vede, la ripetizione di parole (composte, in tedesco) che iniziano con una medesima parola (Kinder, ovvero, bambini), serve ad introdurre un effetto moltiplicatore (e straniante) della forza semantica, inoltre i punti introducono delle cesure, degli stop. Così che si ha: moltiplicazione della ripetizione + cesure = Ritmo a singhiozzo, ritmo interrotto, interruzione e ripresa = effetto di straniamento. I tre versi che seguono (sono frasi nominali e dichiarative) sono spezzati da punti. Con l’ovvio effetto di concentrazione e di spezzatura interna dove il lettore è costretto a fermare l’occhio e la lettura a voce (o silenziosa). Qui mi sono permesso di impiegare il verso-arbitrario nel senso che sono io l’autore ed io soltanto posso intervenire sul dove e sul come interrompere l’ordine del discorso e riprenderlo a mio gradimento. Ho scelto una mia composizione per non fare torto a nessuno. È chiaro che nelle mie intenzioni definire un verso verso arbitrario non c’è alcuna connotazione negativa o spregiativa, è semplicemente un dato di fatto, un evento. Ed è una procedura che io utilizzo spessissimo nelle mie composizioni in vista di un determinato fine; cioè è una procedura consapevole, filtrata però da quella particolarissima cosa chiamata sensibilità verso la Lingua e i suoi linguaggi letterari.
Ecco, io ritengo che l’italiano di oggi abbia in sé DELLE ENORMI POSSIBILITA’ DI ESPRESSIONE, È UNA LINGUA MATURA…
Dimenticavo: altra cosa dal verso arbitrario è il verso inventato, cioè quella entità che non si distingue in nulla dalla prosa. E allora non si capisce perché in tanti ci si ostina ad andare a capo (dal punto di vista narrativo e metrico) quando non c’è alcuna ragione di andare a capo. Potrei, di ciò, portare migliaia di esempi, ma diventerebbe un gioco al massacro che non mi diverte, anzi, che mi deprime.
Giorgio, vado subito all’ultima cosa che dici nel tuo commento più sopra. Sì, hai perfettamente ragione. Poesia è poesia, prosa è prosa. E’ anche vero che la linea di demarcazione è molto vaga, ma mai così tanto da permettere una totale confusione fra i due generi. E allora Baudelaire, che scriveva i poèmes en prose? Perché ricorrere a un ritmo totalmente prosaico quando grandi poeti del passato hanno indicato come si potrebbe “usare la prosa nella poesia?” – e cioè una forma più attuale, che può dare maggiore libertà nell’esprimere concetti e realtà che inevitabilmente finirebbero per straripare dalle forme poetiche tradizionali (e forse anche dalla forma libera con verso spezzato sul lato destro della pagina). Anche altri, più di recente, l’hanno fatto, Transtroemer è un esempio. Ma poi c’è René Char, e tantissimi altri.
Quando scrivo una poesia in inglese, non dimentico mai la metrica interna della lingua, è una cosa naturale. Forse è più difficile per un italiano pensare in endecasillabi (eccezion fatta per Dante) che per un inglese pensare in versi giambici di quattro-cinque piedi. La prosa inglese tende già di per se stessa a scomporsi abbastanza spontaneamente in versi giambici di questo tipo. E quindi quando scriviamo un verso, molto spesso il nostro pensiero già ci offre questa forma, questa soluzione. Che però nel mondo odierno talvolta suona piuttosto scontata, old-fashioned, soprattutto quando viene coltivata di proposito, come fanno migliaia di poeti di lingua inglese oggi che non hanno molto da dire.
Nemmeno Shakespeare rispettò sempre quel metro, spesso i suoi versi sono endecasillabi, o versi di nove sillabe – eventualmente con una compensazione nel verso precedente o successivo, ma si tratta di giochetti inventati principalmente da critici e filologi: Shakespeare non pensava in questo modo, solo in casi precisi e specifici ebbe forse un reale bisogno di contare (per infondere quella inaudita musicalità ai sonetti, per es.). Anzi, egli è più di tutti colui che infranse le regole linguistiche eppure seppe rispettarle, che optò per un pensiero aperto, dettato dalla sua dinamica interna, eppure seppe rimanere dentro le forme tradizionali poetiche, espandendole e nobilitandole.
Dobbiamo sforzarci oggi di “sentire” il verso prima di scriverlo, di “far succedere” il proprio pensiero dentro una forma in bilico fra “chiusa” e “aperta”, dentro un verso più dinamico, continuo o spezzato, se vogliamo veicolare il mondo in cui viviamo.
L’esempio che tu, Giorgio, dai nel tuo commento citando un brano di una tua poesia è quello che ho in mente io. Mi rende felice che altri la pensino, almeno in parte, come me. (A proposito, bel ritmo dinamico, repentino, complimenti!)
Zeitgeist: ci sono soluzioni che ci fornisce proprio il tempo in cui viviamo.
Vado avanti: penso a uno dei più grandi poeti russi della seconda metà del Novecento, Gennady Aygi, messo nel dimenticatoio dai letterati del suo paese perché era ciuvascio, e perché nei suoi versi non rispettò la metrica e le convenzioni tradizionali della poesia russa. Peter France, suo amico storico e traduttore in inglese da sempre, individua nel verso di Aygi, totalmente “libero”, una metrica interna prevalentemente giambica, che comunque finisce per rispettare il ritmo della lingua e della poesia russa.
Vedete l’ironia? Certo, Aygi era troppo grande per non saperlo: ma sentì forte il bisogno di scarcerare il verso russo da quei versi troppo regolari, troppo inamidati e incravattati, creando invece sulla pagina linee di parole più lunghe, di colpo spezzate, riprese al rigo successivo, con spazi vuoti, parentesi, tutto quello che gli serviva per esprimere quel suo pensiero così forte, così lacerato e profondo.
In Italia oggi è raro lo slavista che abbia anche soltanto tradotto una poesia di Aygi. Assenza macroscopica, che ha dell’incredibile ma dice tutto sulla pavidità e sul conservatorismo degli studi letterari. Sarà un grande giorno quando qualcuno si deciderà a compiere quest’opera.
E quindi, la forma “arbitraria” è ben diversa dalla forma aperta secondo il rigore che questa esige. Quando questa è ricercata fortemente, dinamicamente, anche dolorosamente per dire la realtà che ci sta davanti, e non per dire una nostra idealizzata riduzione e privatizzazione del mondo, ecco che salta fuori quello che cerchiamo – il verso veicolante, illuminante.
Non è un sogno, oggi ci sono poeti in tutte le lingue che riescono a fare questo.
Vorrei ricordare, caro Steven, l’acutissima notazione di Fenollosa della poesia come «arte del tempo» e delle immagini come «idee in movimento». Questo è stato il contributo fondamentale di Fenollosa alla poesia occidentale di cui il solo Pound comprese appieno la sua novità. La possibilità di creare una poesia incentrata su una «immagine in movimento» precorreva la dottrina poundiana del vortex e ne permetteva il superamento. La poetica dell’ideogramma di Fenollosa consentiva una spiegazione ottimale della immagine come sintesi di staticità e dinamismo.
Fenollosa aprì a Pound la possibilità di fare un tipo di poesia in cui l’elemento fondamentale è l’«azione», la quale altro non era che la rappresentazione di due immagini in movimento. Per Fenollosa l’ordine della frase è appreso dalla natura: ogni atto non è che un «trasferimento di potere» e il fulmine – che scocca tra le nubi (a quo) e la terra (ad quem) ne è la migliore illustrazione. Il processo della natura è lineare e si svolge attraverso tre elementi essenziali: «termine dal quale», «trasmissione di forza», «termine al quale». La frase linguistica rappresenta la struttura fondamentale della natura. Per Fenollosa l’«azione» ha un termine da cui parte (a quo) e un termine a cui arriva (ad quem), e quindi la «cosa» è sempre una «relazione» di cose, non si dà mai la cosa in sé. Infatti per l’ideogramma cinese l’entità elementare espressa nel linguaggio è l’azione, la quale è unione di due simboli. (Fenollosa)
Per Fenollosa il linguaggio ideogrammatico è forte perché ricco di verbi transitivi, capaci di esprimere il principio fondamentale della realtà, il moto, l’azione; in una parola, è forte perché è concreto, e un linguaggio forte è anche naturalmente poetico.
Per tornare alla poesia, la poesia è una rappresentazione verbale di un moto, di una azione, di una relazione, e tanto più questo fatto è evidente quanto più essa conserva in sé la struttura fondamentale del linguaggio che è l’immagine (statica e/o dinamica); ma non dobbiamo dimenticare che l’immagine è una «funzione del tempo», è un elemento essenziale di ogni linguaggio umano. Forse i super umani di una civiltà di tipo 3 avranno a disposizione altri strumenti linguistici più precisi, noi questo non lo sappiamo e non lo sapremo mai, ma è una possibilità da non sottovalutare.
Per esempio tu, in una tua poesia, nel tuo linguaggio ripeti mimeticamente la struttura elementare dell’universo. Mi spiego:
Giravo le spalle all’orto, immerso
nel grigio smisurato del cielo
una voce chiarissima risuonò:
“non hai visto?”
con fatica alzai gli occhi, vidi un albero sconosciuto
in una nuvola di fiori
“Ah, sì, il susino…”
È chiaro che qui siamo davanti ad una macro immagine che contiene al suo interno altre immagini minori in relazione reciproca; anche la «voce» che risuona viene trattata come se fosse una immagine che si collega alla immagine di un «io» visto di spalle il quale alza gli occhi e.. scopre «il susino». La poesia così prende vita dalla relazione tra le cose e tra le immagini riprodotte nel contesto linguistico, piuttosto che dal discorso lessemico fonetico di matrice lineare che viene utilizzato da poeti di minore consapevolezza critica della cosa chiamata poesia. Tutto il complesso cinetismo di questa strofe si situa entro un tempo brevissimo che passa dal momento del richiamo al momento in cui il protagonista scopre il «susino».
Una poesia come la tua, che potrebbe sembrare astratta ad un occhio poco educato a questa concezione della lingua e dell’immagine, è invece, qualcosa di quanto più concreto si possa immaginare
Questo discorso, che spesso, teniamo privatamente io e Giorgio Linguaglossa è fondamentale. Il verso libero va preso con cautela. Come la forma rima e le metriche. Giorgio con Uccelli (1992), scritto in endecasillabi, mostra una padronanza totale del verso. E la mostra poi anche con il verso libero sperimentale in Blumenbilder (2013). Altri poeti che hanno la padronanza metrica e libera sono primo fra tutti Antonio Sagredo o Alfredo De Palchi, Maria Rosaria Madonna. Quanto è utile tornare al distico? Potrebbe essere utilissimo, come puntare all’haiku, solo che i temi andrebbero variati, in modo che avessero un’attinenza sociologica maggiore. Il problema è che non li si evolve e penso sia gravoso per la poesia. Il verso libero è diventato una grande piaga, come la rima. Così, il verso libero a volte rischia di creare solo confusione, ho letto ultimamente poesie scritte da sedicenti poeti incapaci di capire che i loro versi erano goffi, degli a capo fatti a caso. Mentre la rima è un problema perché rischia di cadere nella scontatezza. e se non la si maneggia bene, diventa fumo. Ed è singolare che una giovanissima poetessa come Siria Eva Comite abbia compreso tutto ciò e scriva una poesia razionalissima, studiatissima, precisissima, senza perdere di intensità ma aumentandola, rispetto ad alcuni suoi precedenti tentativi di verso libero goffi.