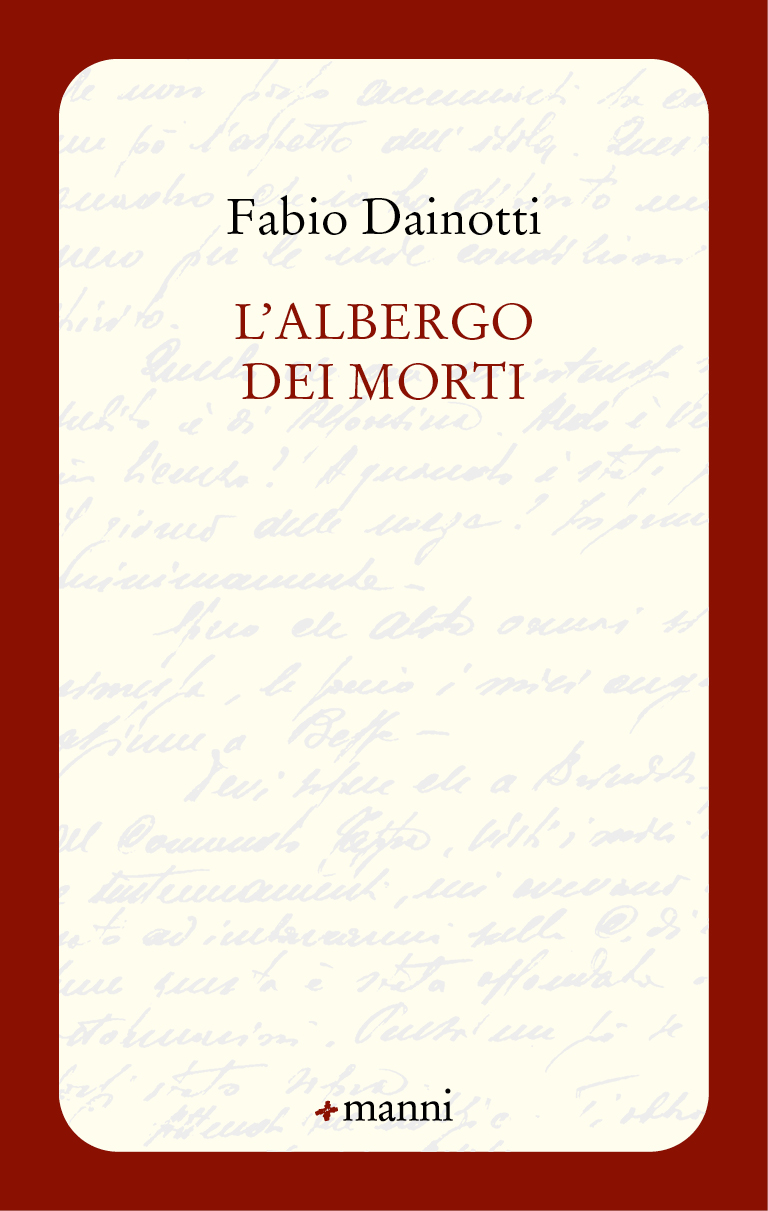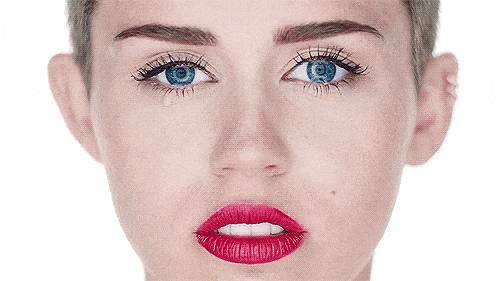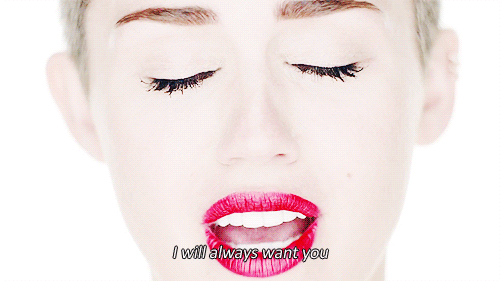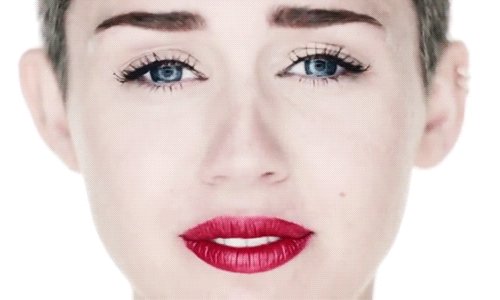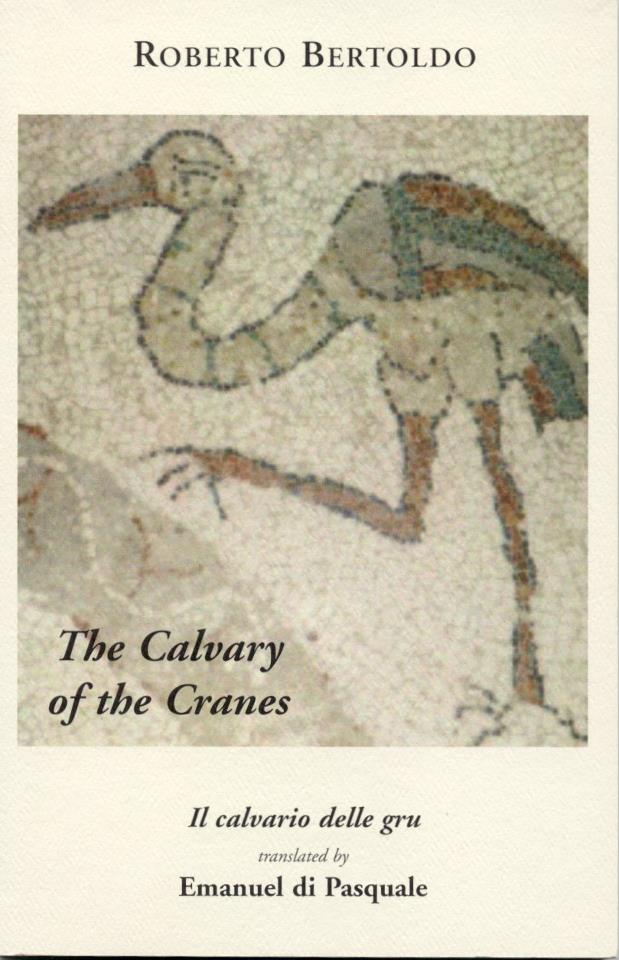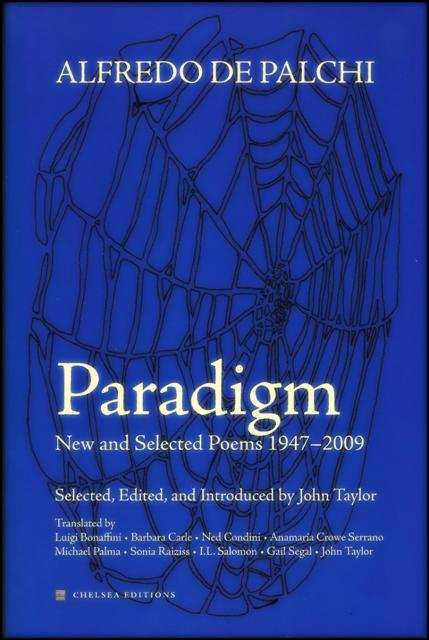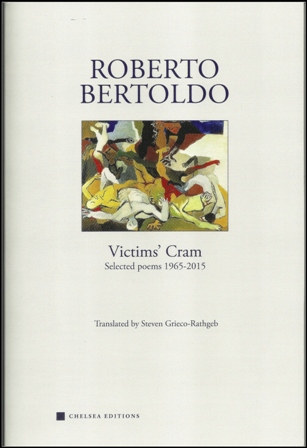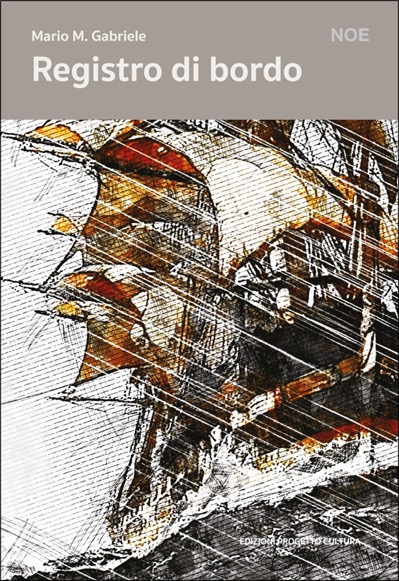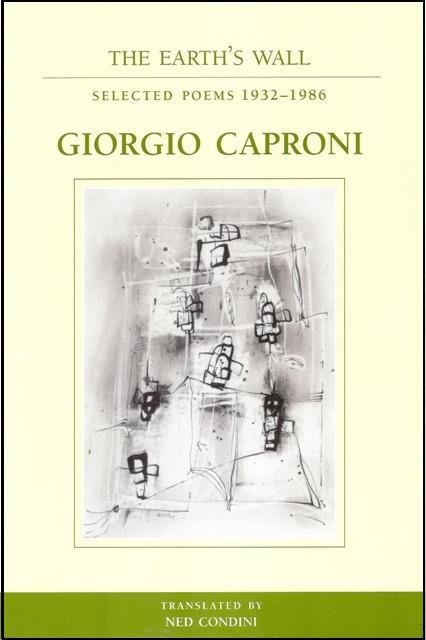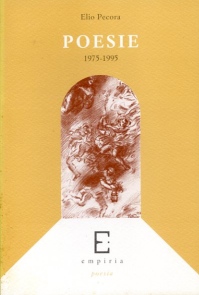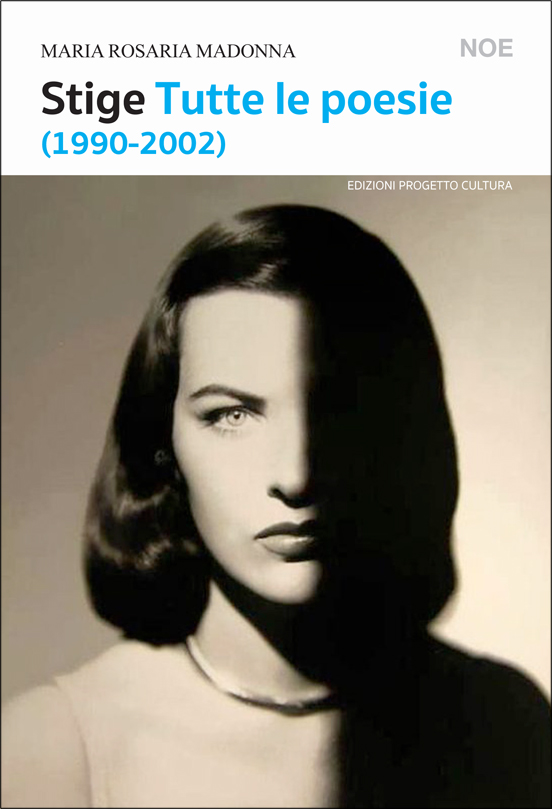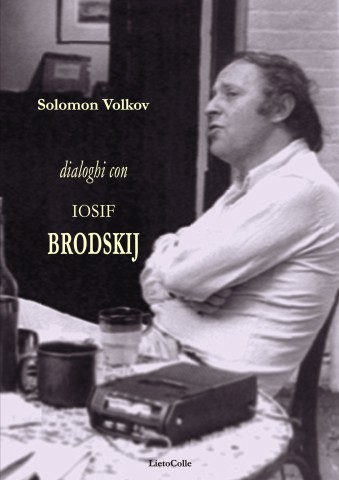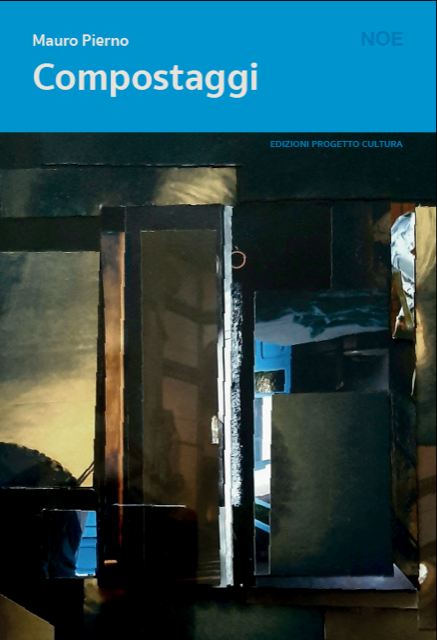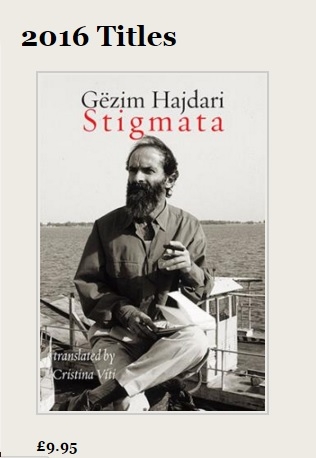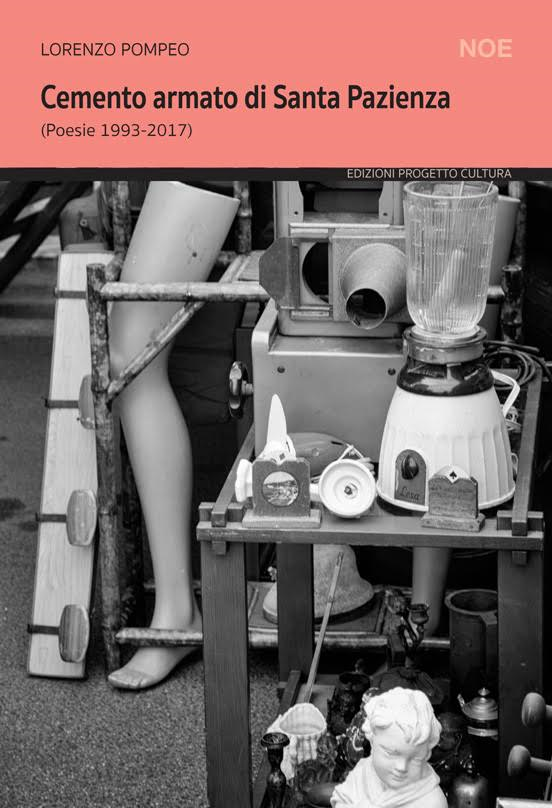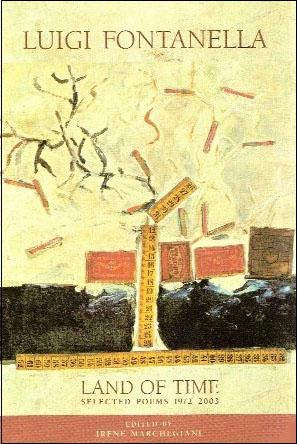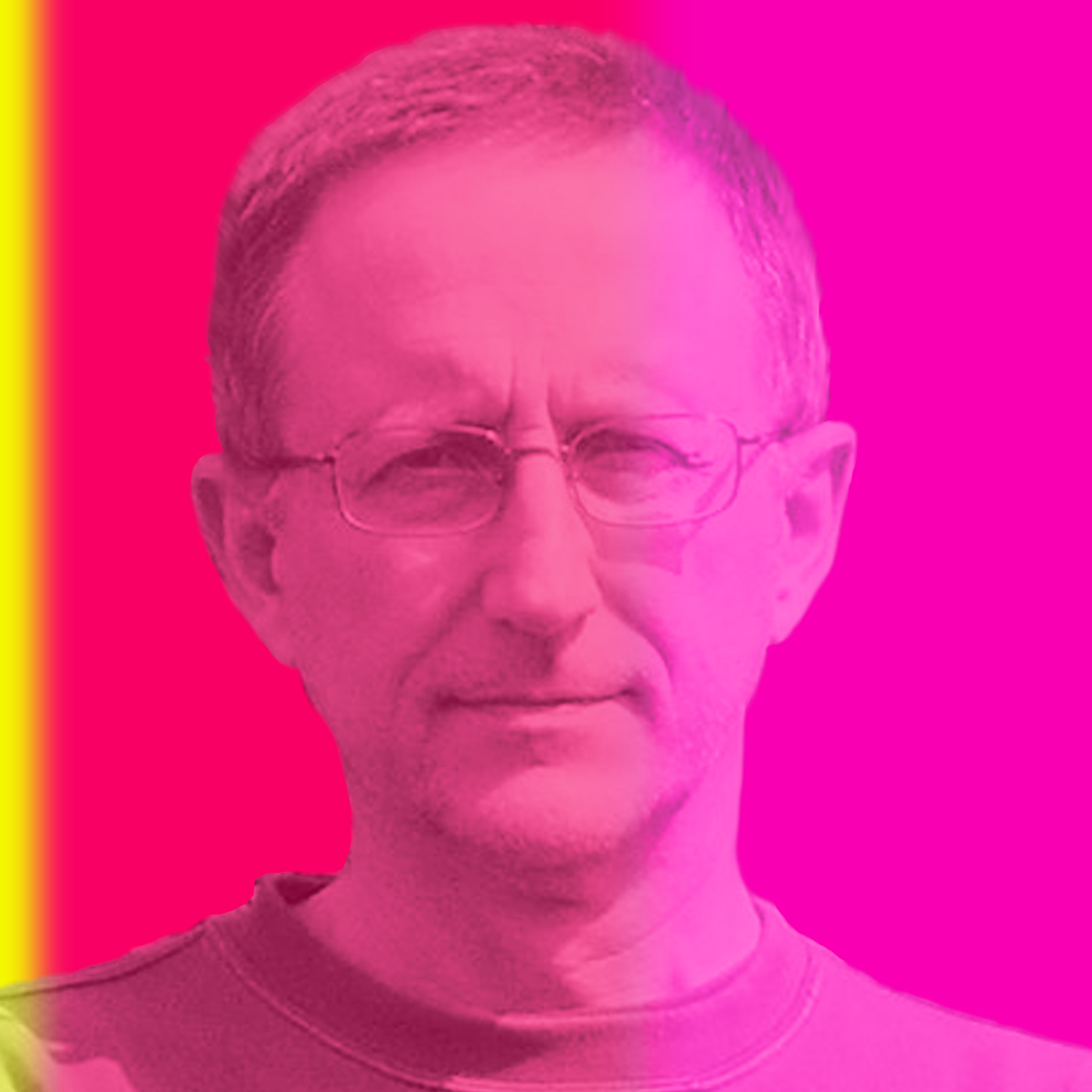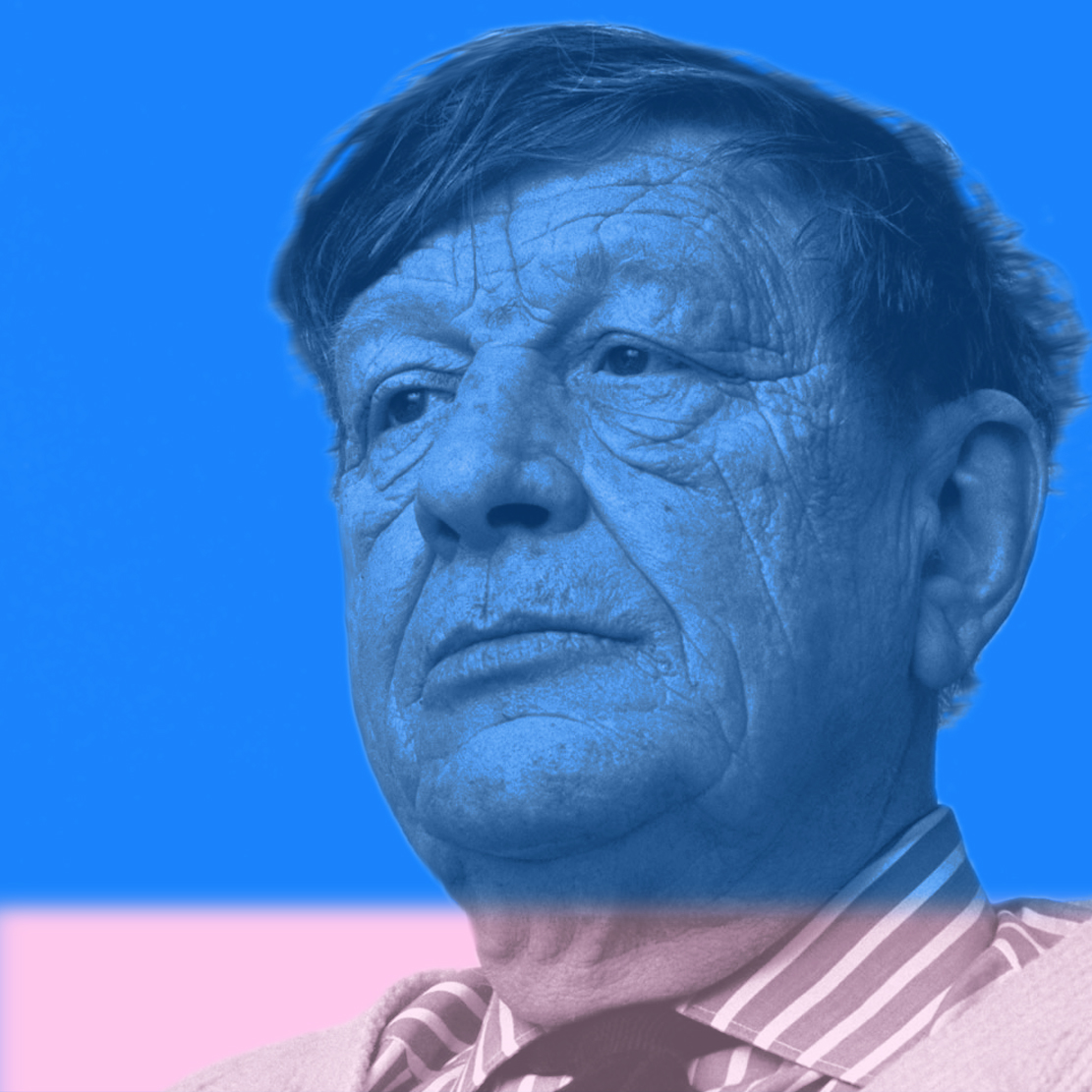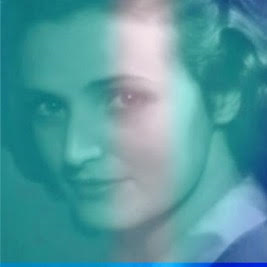[foto Dino Ignani], Jonathan Rizzo, radici elbane, studi storici fiorentini, formazione poetica parigina. Ha pubblicato un romanzo poetico sperimentale, una raccolta di racconti saggi e poesie di viaggio, due raccolte poetiche ed un romanzetto giallo. È in diverse antologie poetiche e di racconti di narrativa. È stato pubblicato su diverse riviste e tradotto in francese, spagnolo ed inglese. Conduce una trasmissione radiofonica sulla poesia e sulle piattaforme web. Organizza eventi poetici in tutta Italia.
.
Una lettera al lettore ignoto
Ho sempre considerato il lettore come un nemico per il poeta. Non il solo, ma tra i più insidiosi. Subdolo punto di arrivo per quei versificatori che battono con l’ammorbidente la penna sul foglio col pensiero ansioso di arrivare a chi inciamperà nelle loro parole, sogno caldo neanche troppo segreto di fare una carezza tenera a più persone possibili. L’ho pensata così a lungo e continuo a pensarla ancora in toni di grigio. Ancora oggi m’imbarazza sentirmi dire/dare complimenti sul poetare e lo scrivere che incespico. M’imbarazzano mortalmente al di là della puerile vanità umana dello scrittore. Il tempo e le sue passeggiate mi hanno educato ad avere una faccia da “poker” davanti al lettore e che nemici più maligni per un poeta sono i critici, gli accademici ed i giovani tirapiedi di questi ultimi. Poetini mai usciti dal parco giochi dell’Università confortevole e non ancora svezzati da madri troppo melliflue nei loro baci a figli rimatori baciati, che mai hanno visto una pistola puntatagli sotto il naso ad urlare il dolore e smarrimento dell’essere umano. Lo scontro con il buco nero della realtà poetica italiana contemporanea fuori dalla mia dolce bolla da flâneur parigino mi ha corrotto l’anima ponendo totale rifiuto alla natura d’inchiostro che mi scorreva nelle vene e spingendo questo derelitto “uomolibro” verso una salvifica oasi fatta di letture mai contemporanee, sempre dei classici moderni, come si usa dire. L’onestà intellettuale pone di ammettere che per il poeta il lettore è un nemico, ma che per il lettore il poeta è un caro amico con cui vive, cresce, cambia, matura fino alle retoriche foglie d’autunno. Praticamente amare con tutto il fiato nel petto un cretino disadattato perché specchio intimo del personale sé disadattato e cretino, cioè la parte migliore di noi, quella senza maschere. La verità è che sono più felice da lettore che da scrittore. Non nemico di me stesso, ma sintesi finalmente raggiunta tra l’infelicità esistenziale necessaria dello scrivere e lo gioia egoista della lettura.
Caro amico lettore ignoto diffida dalle parole che sembrano state scritte per te.
Jonathan Rizzo
.
«In definitiva, però, bisogna sempre tenere presente che la realtà della quale possiamo parlare non è mai la realtà in sé, ma è una realtà filtrata dalla nostra conoscenza, persino, in molti casi, da noi configurata. Se a quest’ultima formulazione si obietta che dopo tutto c’è un mondo oggettivo, completamente indipendente da noi e dal nostro pensiero, che procede o può procedere senza il nostro apporto e al quale in realtà ci riferiamo con la ricerca,a quest’obiezione a prima vista così ovvia si deve opporre il fatto che già l’espressione “c’è” appartiene al linguaggio umano e non può quindi significare qualcosa che non sia in relazione alla nostra capacità conoscitiva. Per noi “c’è” appunto solo il mondo nel quale l’espressione“c’è” ha un senso».1
.
L’estraneazione è l’introduzione dell’Estraneo nel discorso poetico. Lo spaesamento è l’introduzione di un Avatar nel Paese del linguaggio poetico. Il mixage di instantgrammi e di shifter, la deviazione improvvisa e a zig-zag sono gli altri strumenti in possesso della musa di Jonathan Rizzo. Queste sono le categorie sulle quali il poeta elbano costruisce il suo discorso in segmentazione progressiva. Il verso è spezzato, segmentato, interrotto, segnato dal punto e dall’a-capo è uno strumento chirurgico che introduce nei testi le istanze «vuote», i simulacri di ciò che è stato agitato nella poesia del novecento, nella vita quotidiana, non esclusi i film, anche quelli a buon mercato, le long story… flashback a cui seguono altri flashback che magari preannunciano flashback di film visti… non ci sono domande, ma solo constatazioni. C’è il vuoto, però.
Altra categoria centrale è il traslato, mediante il quale l’io parla mediante un retro pensiero o un pensiero interconnesso con quello; l’io così viene ridotto ad una intelaiatura vuota, vuota di emozionalismo e di simbolismo. Questo «metodo» di lavoro introduce nei testi una fibrillazione sintagmatica spaesante, nel senso che il senso non si esaurisce nella proposizione dichiarativa ma in altre proposizioni magari sottintese che correggono quelle dichiarative. L’eloquio fintamente conviviale è in realtà spaesante.
Lo stile è quello della didascalia fredda che accompagna i prodotti commerciali e farmacologici, quello delle dichiarazioni di voto al Parlamento, quello delle notifiche degli atti giudiziari e amministrativi mischiato alle proposizioni autoironiche e ironiche sull’io e sul contemporaneo. Jonathan Rizzo sa scrivere alla stregua delle circolari della Agenzia delle Entrate, o delle direttive della Unione Europea ricche di frastuono interlinguistico con vocaboli raffreddati dal senso chiaro e distinto. Questa severa concisione referenziale non esclude interferenze, fraseologie spaesanti e stranianti.
Tutto questo armamentario retorico era già in auge nel lontano novecento; qui, nella poesia del poeta elbano risulta nuovo, anzi, nuovissimo risulta il modo con cui viene pensato il discorso poetico dei nostri giorni dove il «lettore» viene definito un «nemico».
Ci sono la leggerezza e la destrezza di Apollinaire in certe rientranze e giocolerie stilistiche di Rizzo: («la gente che gioca alla vita leggera», « Le auto attendono, le barche galleggiano, tu scrivi»); certi andanti larghi descrittivi («Uomini, donne, bambini che vi fate saltare in aria, nemici ed amici»), shakerati con sintagmi da confessione («Amo la vita e non me la toglieranno più»), certi stacchi autoironici («Sono solo. Aspetto/ la mia donna ed il suo portafortuna tra le gambe»), certi spot della pubblicità della Buitoni («La campagna toscana con abito gentile»), mottetti irriverenti («Non conosco gelaterie in Francia»), sintagmi strappalacrime («Io urlavo lacrime e poesie»), sintagmi assiomatici («Dio è il concetto con il quale misuriamo il nostro dolore»), mini proposizioni constatative («Io non fumo. Dovrei iniziare a fumare»), sintagmi aristocratici («L’unica persona viva dorme»). Il tutto compostato in uno sketch stilistico di ottima fattura autoironica. Jonathan Rizzo immagina la sua condizione come quella di quell’umano che si mette nella condizione della cosa, anzi, che si offre allo sguardo delle cose; la sua è, propriamente, una poesia della mancanza e dello sguardo delle cose sull’io.
Qual è il significato del distacco della poesia di Jonathan Rizzo dalle fonti novecentesche? Il fatto è che quelle fonti si erano da lunghissimo tempo disseccate, producevano polinomi frastici, dumping culturale, elegie mormoranti, chiacchiere da bar dello spot culturale. La tradizione (lirica e antilirica, elegia e antielegia, neoavanguardie e post-avanguardie) non produceva più nulla che non fosse epigonismo, scritture di maniera, manierate, magari ben lubrificate e lucidate. Jonathan Rizzo dà uno scossone all’immobilismo della poesia italiana degli ultimi due tre decenni delle generazioni precedenti la sua, e la rimette in moto. È un risultato eccellente, che mette in discussione tutto il quadro normativo della poesia della sua generazione.
(Giorgio Linguaglossa)
1 Werner Heisenberg, Indeterminazione e realtà, Guida Editore, p 2002, p. 123.
 A Fabrizio
A Fabrizio
L’unica persona viva dorme
mentre i poeti,
quelli veri,
parlano di metrica con logica acida matematica.
senza guardarsi negli occhi
ché il piedistallo di plastica
non concede che li si tocchi.
Ma l’unica persona vera russa
sdraiato per terra
con la custodia della pianola
a fargli da giaciglio
dopo pranzo, dopo il vino, rosso camino.
Riposa tra i fili l’erba nell’attesa perla
di sfiorare tasti neri
per farli divenire bianchi,
accarezzare chiari
per volo e dispetto
da mutare scuri.
Gioco d’ali
di colombe e falchi
nel tiepido meriggio Giunone
di fine primavera,
amica lieve, amante breve.
La campagna toscana con abito gentile
splende in un abbraccio di luce senza fine,
nuvole sconfinate,
un poco vicine, un poco lontane.
Ma i poeti, quelli veri, non hanno tempo per godere
della bellezza che il cielo ricama
a scherno degli uomini
briciole distratte.
Lamentarsi dello schifo che circondi i loro versi
è più importante
che masticare una spiga di grano controluce,
o fermarsi sulle nuvole persi.
Ma tutto questo inferno d’animo non scuote
l’unica persona normale
che sogna note e colori
da donare
come fanno i bambini alle bambine
con i fiori.
Ed io?
Ed io sono fortunato ad essere amico tuo
ed ancora
non come loro.
BESTIARIO PARIGINO
Sgattaiola nel calpestio de li uomini,
anime in contrabbando fragile.
Io non fumo. Dovrei iniziare a fumare.
Compro da bere. Io bevo. Dovrei smettere.
Sono solo. Aspetto
la mia donna ed il suo portafortuna tra le gambe.
Arriveranno con le strade lavate di fine estate.
Scrivo così bene a Parigi, solo per me stesso.
Non c’è fretta che il tempo cambi.
Filtro assenzio e pastis coi miei oi parei.
Occhi francesi,
passaporto al tricolore.
Non conosco gelaterie in Francia.
Altro cuscino in questo square fiorellino
tra il cicalare umano del caldo agostano.
Amico mio dammi la mano.
Passeggia da professionista
senza direzione tra i pensieri
e la loro corrotta memoria di orgogliosa miseria,
carne e sangue, piaghe di poesia ed isteria.
La muette freccia.
Non conta per dove.
Vola sopra la gente che gioca alla vita leggera.
Refrigerio canino,
esempio all’umano
bestiario.
Il ponte che passa.
Le auto attendono, le barche galleggiano, tu scrivi.
I ricordi di un sorriso vengono smantellati
dall’ineluttabilità del tempo.
Un nuovo passato ogni giorno da seminare.
Nascosta dal filo spinato
la vita perduta di alcune persone,
ma non, né rimangono impigliate tra le virgole pendule il nome.
Pare sempre domenica quando piove sulle luci di Parigi.
La festa di pace non si concluderà questa notte.
Nel seccarsi dell’inchiostro tra il foglio e la punta lenta
spunta il sole dietro le nuvole serie.
Si porge lieve come carezza di profumi gentili
per le persone sole.
Amore siamo in ritardo?
In ritardo per cosa?
I morti aspetteranno!
CANTO LA VITA. ODE A PARIGI
Parigi è viva,
ed io con lei.
Non abbiate paura.
Non regalategli voi stessi.
I mostri meritano pietà,
ma non il dono prezioso della paura.
Parigi è ancora viva, respira.
Io l’ho vista con questi miei occhi di uomo.
Non abbiate paura di farlo anche voi.
La paura è lo scudo di chi si fa forte con la violenza.
Noi siamo immortali
perché sorridiamo ed amiamo la vita,
le sue figlie ed i suoi figli.
Io sono uscito a petto nudo
per le strade spezzate dal pianto,
foglie morte al mio fianco.
Ed ho sentito sulla pelle
la chiara impotenza del derubato,
pensando debole
a tutte le vite che ho perduto,
pensando fragile
possono spararmi,
ma non spaventarmi.
Amo la vita
e non me la toglieranno più.
La condivido con voi,
tutti voi.
Uomini, donne, bambini che vi fate saltare in aria, nemici ed amici.
Non temo nessuno.
Amo e sono fatto di carne.
Abbraccio ogni volto stanco,
frustrato dall’odio e dall’ignoranza.
Più sarete lontani e più la mia mano si tenderà verso di voi.
Parigi vive ed io sono suo figlio.
Non moriremo mai,
perché nel petto abbiamo forte
l’amore e la fratellanza tra gli uomini ed i popoli tutti.
Odi mondo
alto si leva ancora il nostro canto,
siamo vivi e teneri tuoi amici,
io e la sorella Parigi.
Gli odi di uomini bruciati dalla paura non ci possono ferire più.
Amiamo disperatamente anche loro,
perché nessuno lo fa.
DEDICATO A JACK KEROUAC
Eravamo al solito su un placo scalcagnato,
rimediato facendo gli occhi dolci
ad una giovane ed ingenua Dea.
Il contrabbasso spingeva fiamme i pedali
cercando la fuga sui Pirenei del Jazz.
Io urlavo lacrime e poesie
ad una sala vuota di umanità e sorrisi.
La carta del Caffè letterario universitario
si stava rivelando un flop velleitario.
A vederci non era chiaro
se fossimo stati più ipocriti noi
a porci ad un pubblico sordo che sotto sotto disprezzavamo,
o chi a vent’anni non legge se non per obbligo d’esame.
Io ingenuo come un bambino
avevo preparato la performance a puntino,
importunando le muse delle arti maggiori,
ingaggiando maestri e leggende di uomini rari,
affittando sogni scritti meglio dei miei vuoti paroloni.
Pierangelo divino come un airone
volava leggero sopra le nuvole
incurante di come stessi perdendo per k.o. tecnico
quel match di pugilato chiamato poesia e vita.
La sala vuota rendeva ancora più ridicolo
quel mio agitarmi dinoccolato,
sottolineandolo con tono crepuscolare e disperato.
Per pietà una dolce farfalla aprì il portone sulla strada
sperando che i miei fuochi d’artificio gutturali
riuscissero ad impressionare i viandanti per la rada.
Era lei che avevo sedotto di fiore in fiore
e mi aveva staccato l’ingaggio per poche lire
e molto, troppo, esageratamente da bere.
Così mi piace farmi pagare,
qualche pompino e molto vino.
Da Marte responsabile ansiosa
per il mio fallimento marchiato d’infamia
sulla sua pelle graziosa.
Ai giovani universitari non interessa la cultura.
Ai fiorentini non piace la poesia.
Secoli alle spalle ce l’hanno dimostrato plurime volte.
Mentre i fantasmi di Dante Alighieri e Dino Campana
guardandomi teneramente mi suggerivano verità inevitabili,
il mio fedele pubblico si affacciò sulla strada,
unica amica reale rimasta gentile
per chi abbia attraversato lo specchio e sia divenuto favola da ricamare.
Io e Piero ci guardammo
e finalmente sorridemmo.
Non eravamo più soli.
Ardevamo scintillanti oscurando l’eclissi.
Un uomo,
una persona vera,
un clochard
si era fermato ad ascoltarci
accarezzando ogni nostro dolore,
note e parole.
Lui capiva quello che le corde pizzicate e quelle graffiate
stessero urlando e bruciando.
Vivi al mondo eravamo solamente noi tre,
stelle danzanti.
Ho sbagliato
e non mi giustifica il fatto che fossi così rapito e sospeso dalla sua bellezza.
Avrei dovuto scendere dal palco
ed elevarmi a livello dell’uomo.
Andare da lui, fuori nella realtà.
Abbracciarlo,
anzi meglio, ciò che conta,
offrirgli da bere,
pagargli da respirare.
Rubare una bottiglia di vino,
scappare dalla commedia e scolarla assieme fino al mattino.
Il resto erano puttanate.
Ho proprio intrapreso strade sbagliate,
ma sto imparando la differenza tra bene e male.
Quella sera per aver sputato sangue e sudato sperma,
ci pagarono una miseria.
Zero applausi di plastica nelle orecchie,
ma vino defraudato tra le viscere
e qualche sogno di morbide cosce
a porsi specchio sorridente d’orgoglio
alla presa di coscienza
di come il mio pubblico sia un esercito di barboni e puttane.
Unici esseri umani reali di cui valga la pena d scrivere,
con cui abbia senso brindare
a questo inferno pazzo che è il vivere.
Almeno finché Piero suonerà il contrabbasso al mio fianco
a scherno del resto,
scimmia idiota che non fa neanche ridere.
EPITAFFIO DAL PIÙ GRANDE POETA MORENTE
Dio è il concetto con il quale misuriamo il nostro dolore.
Non credo in Jonathan Lennon, pur citandolo.
Non credo alle stelle, pur usandole per portarmi a letto le belle ragazze,
alla loro luce morta milioni di fa.
Non credo al decalogo del poeta,
pur trasudandolo dalla pelle stanca
che ricorda e conosce solo l’urlo come affermazione di sé.
Non credo a voi gente per bene
Dai buoni consigli sterili.
Non credo all’uomo italiano e mediterraneo,
fascista vecchio, post, neo, borghese, padronale, legaiolo ed a 5 stelle, di cui ho già detto di non credere.
Non c’è resurrezione né speranza alcuna più.
Non credo nei populismi dell’homo homini lupus.
Non credo ai sacri confini degli stati
da difendere ciecamente con lo spauracchio della paura del diverso.
Credo al nomadismo,
credo al viaggio come unico senso della vita,
la ricerca di sé, di un perché
ad un’esistenza da trascinare tra la bellezza della natura e le storture dell’umana miseria.
Credo negli zingari,
il vero popolo eletto.
Gli unici rimasti seri e coerenti nel “belpaese”.
Non credo alla democrazia italiana,
mercato del posto fisso
in parlamento o in televisione,
che in questo paese malato se non appari non esisti.
Credo a chi si alza all’alba per portare il pane a casa ai figli.
E lo dico io guardandovi negli occhi,
io che sono sterile per fortuna,
una casa non ce l’ho
e non mi alzo mai prima di mezzogiorno
perché mi da fastidio il rumore della gente onesta che va a lavorare,
mi mette a disagio con la mia vigliaccheria.
Non credo più nel bene e nel male,
l’uomo non è all’altezza di entrambi.
Siamo fatti della stessa pasta della mediocrità che sta nel mezzo.
Non credo in Dio,
nel vostro Dio,
in qualsiasi Dio.
Mi ha abbandonato tempo fa.
L’uomo è solo in questo scarto di universo.
Non credo nella Dea,
Lorenza non merita una goccia del mio inchiostro di carne,
figuriamoci sperma e sangue.
Mi ha ucciso tante di quelle notti
che non so più morire.
Eterno poeta dell’inutile cantilenante,
eternamente errante errante.
Non credo nell’amore,
non credo più nella poesia.
Credo nell’eroina e nel whisky.
Non credo a te, padre, maestro, professore, direttore, generale, presidente, re, imperatore e pontefice massimo
che non sai neanche che esista.
Difficile chiedere il mio voto con queste premesse.
Credo nell’Anarchia,
unico volo di libertà
che l’uomo trova in se stesso,
animale armonia.
Non credo nella legge
che punisce il debole
e si fa ammansire dal potere.
L’uomo non è la proiezione di Dio,
ne è la scorreggia,
il lascito di seme
sulle lenzuola del cosmo.
Di un Dio in cui comunque non credo.
Non credo a Napoleone.
Dovevi distruggere la perfida Albione
e liberare l’umanità dalle catene
invece di rimirarti pingue
in specchi dorati
nel tuo mantello ali di aquila.
Non credo nei miti rivoluzionari del ’48, del ’17, del ’68, del ’77.
Tutti questi antenati da album di famiglia non credono in me.
Non credo al mio padre morale Charles Bukowski.
Devo combattere la mia battaglia,
non ricamare a bassa voce quella di qualcun altro.
E questo vale per me come per chiunque di voi.
Non credo in voi che amate ed odiate e cambiate sentimenti ed opinioni con la superficialità
di chi non conosce cosa sia l’amore e l’odio, il tormento e l’estasi,
ma pretendete d’imporre la vostra truffa a chi innocente crede
o credeva ancora.
Quando domani mi tirerò il collo
resterete solo la polvere che siete,
ombre di uomini e donne.
Credo solo in me stesso.
Il sogno è finito, Dio non esiste e l’abbiamo tutti al culo.