 Abbiamo deciso di ripubblicare questo articolo di Alfonso Berardinelli, scritto e pubblicato venti anni fa, perché riteniamo che, da allora, nulla è cambiato nella poesia italiana, e che anzi certi difetti storici si siano aggravati e approfonditi. (n.d.r)
Abbiamo deciso di ripubblicare questo articolo di Alfonso Berardinelli, scritto e pubblicato venti anni fa, perché riteniamo che, da allora, nulla è cambiato nella poesia italiana, e che anzi certi difetti storici si siano aggravati e approfonditi. (n.d.r)
(“Poesia ’94”, Annuario a cura di Giorgio Manacorda, Castelvecchi, Roma, pp. 190, Lire 15.000)
1. In poesia si può parlare di tutto. Quando si tratta di letteratura, e in particolare di poesia, è sempre pericoloso parlare di “doveri” comunicativi. Certo, la letteratura comunica. E uno scrittore, un artista della parola ha capacità comunicative potenziate. Ma nel caso specifico della poesia contemporanea quello che importa è ormai rompere con certe convenzioni stilistiche di tipo gergale, auto-referenziale che si sono stabilite all’interno di una cerchia sempre più ristretta. Il fatto che questa cerchia sia da troppo tempo il solo pubblico della poesia, un pubblico fatto di gente che scrive o vuole scrivere poesie e di studiosi, ha debilitato questo genere letterario.

alfonso berardinelli
La debolezza, l’opacità comunicativa, l’oscurità o, più precisamente, l’inconsistenza semantica di molta poesia di oggi deriva dal fatto che quella piccola cerchia di lettori fa finta di capire, o accetta il fatto che non venga detto quasi niente e che non ci sia quasi niente da capire.
Il paradosso è questo: la fuga dal significato viene accettata dogmaticamente come significativa, e così l’oscurità e problemi comunicativi interessanti, anzi li annulla, li scavalca.
Eliminando dal linguaggio poetico tutta una serie di funzioni linguistiche legate al significato e alla comunicazione, la poesia non corre più nessun rischio. La sua diventa un’esistenza ipotetica, virtuale, larvale, non reale. E il codice del non-significato è diventato ormai un codice fissato rigidamente. Lo svuotamento semantico è oggi e da tempo una delle regole fondamentali che creano fra cosiddetti poeti e critici una specie di complicità, di omertà.
La poesia non si confronta con niente che stia al di fuori di essa: con nessun altro linguaggio e ambito culturale. Il valore della produzione poetica degli ultimi vent’anni (parlo degli autori che hanno fra i trenta e i cinquant’anni) è assai scarso proprio per questa mancanza di coraggio e di energia comunicativa. Si tratta per lo più di poeti (simil-poeti) che cercano di farsi accettare semplicemente non facendo niente che possa farli rifiutare.
 Certo, nella poesia possono esserci delle zone di oscurità e di difficoltà, perché la letteratura è anche una sfida ai significati stabiliti e accettati. Ma credo che ora il gergalismo poetico abbia toccato limiti intollerabili, ridicoli e si tratta di tornare, se si è in grado di farlo, a parlare in poesia di tutto, senza limitazioni preliminari. Del resto, la migliore poesia delle generazioni precedenti lo aveva fatto: da Pasolini e Caproni a Sereni… Sarebbe il caso di ripartire da zero, senza escludere a priori nessun tipo di linguaggio e nessun ambito di esperienza.
Certo, nella poesia possono esserci delle zone di oscurità e di difficoltà, perché la letteratura è anche una sfida ai significati stabiliti e accettati. Ma credo che ora il gergalismo poetico abbia toccato limiti intollerabili, ridicoli e si tratta di tornare, se si è in grado di farlo, a parlare in poesia di tutto, senza limitazioni preliminari. Del resto, la migliore poesia delle generazioni precedenti lo aveva fatto: da Pasolini e Caproni a Sereni… Sarebbe il caso di ripartire da zero, senza escludere a priori nessun tipo di linguaggio e nessun ambito di esperienza.
2. Modernità da rileggere. Il dibattito sul post-moderno ha fatto più confusione che altro. In un certo senso però esistevano dei chiari sintomi che in questa seconda metà del Novecento era avvenuto qualcosa di veramente nuovo e che alla Modernità era successo qualcosa: di questa categoria teorica e di una serie di opere si sapeva o si credeva di sapere quasi tutto. La Modernità non era più un’esperienza traumatica, era stata riassorbita o metabolizzata dalla critica accademica, era diventata luogo comune, convenzione, regola.
Credo d’altra parte che invece, al di là delle tante etichette e teorizzazioni, la Modernità sia ancora un problema aperto. I libri sono ancora lì da leggere e da rileggere al di là degli schemi. La Modernità è ancora il nostro orizzonte. Se lo dimentica, se si dimentica che il nostro mondo, il nostro modo di vivere e pensare, tutta la nostra cultura viene anzitutto dalla seconda metà del Settecento – perché è un prodotto dell’Illuminismo e della rivoluzione industriale – se si dimentica questo, allora si finisce in quelle grottesche mascherature che vorrebbero farci credere contemporanei della Grecia classica o del Medioevo. Tutto ciò che siamo in grado di capire e assimilare delle culture pre-moderne, ci viene dalla Modernità: la filologia, il senso della Storia, il relativismo culturale, la mancanza di fede, l’esigenza critica, il bisogno di mettere insieme culture eterogenee. Non possiamo tornare ai filosofi pre-socratici, non possiamo tornare al pensiero mitico, non possiamo recuperate Tommaso D’Aquino o la mistica. Sono tutte cose che ci interessano, ma se crediamo di potercene appropriare direttamente, dimenticando la situazione della Modernità, allora finiamo nel kitsch, nella mascheratura.
Il mercato della cultura, l’industria della cultura, la produzione e il commercio dei contenuti di coscienza, la presenza delle grandi istituzioni culturali statali come la scuola e le università, è tutto questo che dà forma ai nostri rapporti con altre e diverse culture.

Yeats and Eliot
Come ho detto, si tratta di liberare la modernità dalla vulgata, dallo scolasticismo, che tendono a disinnescare l’esperienza culturale moderna: la sdrammatizzano e fanno dimenticare che molta della letteratura e della filosofia, da due secoli a questa parte, è stata una lotta contro lo Stato e contro il Mercato, contro la riduzione della cultura a merce e a materia di studio.
3. Funzionari della cultura. La Modernità non si identifica con le avanguardie, con la liberazione ludica degli istinti e dell’immaginazione, con una pedagogia estetica da asilo infantile. I maggiori scrittori moderni, come Kafka, Svevo, Proust, Eliot, Céline, Gadda, Montale, non hanno niente a che fare con le avanguardie di gruppo, con i manifesti letterari. Sono dei solitari, vanno controcorrente da soli, con le loro sole forze. E rischiano il fallimento come individui. Non si mettono in gruppo per sentirsi protetti come i futuristi, i surrealisti eccetera.
Oggi a volte ci si chiede come mai gli intellettuali abbiano perso autorità e peso culturale. Credo che sia perché sono diventati degli impiegati della cultura, dei funzionari che lavorano per far girare (magari a vuoto) la macchina istituzionale e produttiva. Non elaborano le loro idee e immagini del mondo rischiando di persona di scontrarsi con la società in cui vivono. O almeno questo avviene sempre più raramente. Anche perché dalla maggior parte degli intellettuali di oggi (ma lo stesso termine intellettuali andrebbe ridiscusso) la cultura non viene vissuta come una dimensione realmente impegnativa. In Italia poi gli intellettuali sono spesso arroganti socialmente, ma sul piano intellettuale e culturale in senso proprio sono timidi, vili: non osano formulare qualcosa se non sanno che quella cosa ha già avuto successo altrove. C’è poco coraggio, e quasi nessun rapporto fra ricerca intellettuale e comportamento reale. Si è mai visto da noi un intellettuale che cambia vita perché ha capito qualcosa di nuovo? Così, non c’è solo una “fine delle utopie”, ma c’è una vera e propria pacificazione nel rapporto fra Cultura e Società, e una conseguente diminuita autorevolezza degli intellettuali, perché il novanta per cento della loro elaborazione è semplicemente una risposta alle richieste delle istituzioni e del mercato. Secondo alcune interpretazioni il postmoderno è proprio questo: la fine del conflitto fra arti e società.
4. Oscurità programmata. Non credo che le riflessioni di T. W. Adorno siano del tutto “superate”. Adorno è stato un grande pensatore, uno dei maggiori del secolo, e uno straordinario critico della società. Nella sua Teoria estetica, che spesso è contraddittoria, c’è un’interpretazione dell’arte moderna come difesa e rivendicazione dell’oscurità, di ciò che non è immediatamente comunicabile, «commerciabile» e socializzabile nelle nostre esperienze più profonde, esperienze che la società rifiuta o tende a neutralizzare e occultare. Adorno difende l’arte moderna contro l’ipocrisia e il filisteismo borghese e contro le filosofie ottimistiche dell’universale umano e del progresso. Questo non vuol dire, come molti credono, che Adorno sia un difensore delle avanguardie, che, come ho detto, sono un’altra cosa, un fenomeno più limitato: militante, pedagogico e prescrittivo.
Io tendo sempre a distinguere nettamente fra Arte Moderna e Avanguardia: intendo quest’ultima come un prodotto dell’autodifesa e dell’autorganizzazione direi “corporativa” degli artisti, che promuovono e divulgano il significato delle loro attività inaccettabili dal pubblico e dalla critica. Insomma, apprestano una specie di preinterpretazione garantita di tutto quello che faranno.

zbigniev herbert
Ciò che fino alla metà dell’ottocento dalle filosofie idealistiche e umanistiche borghesi veniva considerato «universalmente umano», secondo Adorno nel Novecento diventa estraneo alla totalità sociale, sprofonda nell’individuazione, diventa oscuro, incomprensibile, inaccettabile, mostruoso. È insomma proprio l’umano ciò che il Sistema sociale reprime e rifiuta, facendolo passare per insignificante.
Da questo punto di vista, molte opere d’arte moderna sono risultate di fatto “oscure” non perché la loro lingua fosse tale, ma perché il loro contenuto veniva socialmente rifiutato. I poeti linguisticamente più chiari, in Italia, Saba e Penna per esempio, sono stati quelli più a lungo rimasti incompresi. Erano proprio la loro chiarezza a risultare incomprensibile ai critici, ai lettori. Il problema allora non è quello dell’oscurità o della chiarezza linguistica, ma di ciò che una cultura e un pubblico accettano o rifiutano, capiscono e non capiscono. Il problema dell’oscurità è un problema di rapporti fra opere letterarie e ambiente culturale. Oggi è l’oscurità programmata che rende pacifici i rapporti tra poesia e ambiente.

martin heidegger a passeggio
5. No, Heidegger no. Io non apprezzo affatto Heidegger. Credo che sia un autore sopravvalutato, un autore che con il proprio lnguaggio ha contribuito alla formazione di una specie di kitsch filosofico: come se alzasse di continuo una bandierina per dire: «Attenzione, qui profondità filosofica». Ha mitizzato l’atto del pensare facendone qualcosa di solenne, una sorta di attività eccezionale e del tutto non comune, svincolata dalle esperienze comuni, cioè condivise, e dal linguaggio attraverso il quale queste esperienze vengono fatte. Anche qui, lo stesso paradosso. Mentre un filosofo spesso oscuro (inutilmente, manieristicamente oscuro) come Heidegger ha un successo straordinario, ipnotizza mezzo mondo e crea innumerevoli imitatori, viceversa un pensatore di straordinaria forza, attualità e limpidezza come Simone Weil stenta tuttora a farsi capire. Forse perché la sua chiarezza impegna più a fondo e più direttamente il lettore.
Comunque, semplificando molto il ragionamento, mi sembra innanzitutto che Heidegger, che ha fatto del linguaggio uno dei punti centrali della sua riflessione, abbia una consapevolezza linguistica confusa e usi spesso un gergo barbaro. Inoltre non capisco come si possa considerare grande un filosofo che ha ridotto tutto il problema della modernità al problema della tecnica, senza nominare i regimi politici, il capitalismo, la divisione di classe, le trasformazioni nella funzione sociale della cultura ecc. Crea seguaci e piace tanto ai filosofi, credo, perché è uno specialista della reductio ad unum. Per lui pensare è il contrario di osservare. Heidegger è riuscito ad assistere alla nascita del nazismo senza capire che era il nazismo…

Martin Heidegger in campagna
Non voglio neppure insistere sul fatto che il nazismo inizialmente lo ha entusiasmato: questo potrebbe capitare a un filosofo molto distante dalla politica. Ma poi non è riuscito né a ricredersi né a compiere un’analisi di eventi che hanno segnato l’intero secolo; eventi non marginali, ma rivelatori di quello che covava nel grembo della società moderna (e delle cultura tedesca). Heidegger è proprio l’esempio di come certa filosofia impegnata a pensare non abbia occhi per vedere ciò che è evidente. E questo è successo non solo a destra, ma anche a sinistra. La cosiddetta essenza dei fenomeni sociali non è affatto così «profonda» e invisibile come credono i filosofi di quel tipo. È invece osservabile: è un insieme di fatti empirici, di piccoli sintomi che molti scrittori avevano capito e descritto.
Si ritiene generalmente che Heidegger abbia posto la questione della natura del linguaggio – che non può essere inteso solo come strumento di comunicazione. Vorrei precisare che questa idea non l’ha inventata lui, e una delle cose che mi sorprende è che si attribuiscano ad Heidegger cose che scrittori e critici sapevano benissimo, almeno a partire dal romanticismo. La riflessione di Heidegger sul linguaggio e la poesia si limita a Hölderlin e Trakl, non è particolarmente originale né è in grado di cogliere la grande varietà della letteratura moderna, con i suoi diversissimi linguaggi. Tutta la poesia moderna, con Leopardi, Coleridge, Baudelaire, e innumerevoli altri, è una critica in atto della strumentalità del linguaggio, del suo impoverimento nella società borghese. Questa critica viene poi anche dai romanzieri (per esempio Flaubert). Heidegger fissa tutto questo in una formulazione filosofica che di fatto riduce e impoverisce la varietà e vivacità di quelle esperienze letterarie. Mentre, se si impara dagli scrittori, il senso della varietà e pluralità delle esperienze viene mantenuto.
La letteratura aumenta il nostro grado di attenzione per la varietà delle esperienze reali per gli individui hanno della loro condizione personale e sociale: solo così capiamo meglio dove siamo e cosa possiamo fare, cosa che quasi mai avviene con le formulazioni di tipo teorico e filosofico. Questo lo ammette ormai anche qualche filosofo: Rorty per esempio dice che se dovesse scegliere tra Dickens e Heidegger butterebbe subito Heidegger e si terrebbe Dickens, che è uno scrittore, come si sa, poco teoretico e apparentemente superficiale, non certo fatto per ipnotizzare i filosofi, come Hölderlin…
6. Leggere e scrivere: pratiche magiche. Il linguaggio verbale è qualcosa di molto prezioso, magari poco appariscente, ma ci è molto vicino, molto intimo. Non richiede particolari e costose tecnologie per essere usato. Basta un foglio e una penna, si può scrivere ovunque.
La tradizione scritta ha poi nella nostra cultura un valore particolare, e io forse la apprezzo anche per una certa sua inattualità crescente: la considero come un punto di resistenza nei confronti di tecnologie comunicative più potenti. Però non ne faccio una questione di valore: la scrittura non è un valore in sé, e anzi molto spesso mi accorgo di accusare molti letterati odierni che non sentono abbastanza la sfida comunicativa che il presente pone al linguaggio scritto.
Certo scrivendo non si può sperare di avere l’impatto comunicativo di una rock-star o di registi come Spielberg. Ma proprio perché la lettura diventa sempre più un atto solitario, ostinato, individualistico, controcorrente, è tanto più importante non moltiplicare la massa dei messaggi scritti, ma diminuirla, essere più selettivi: non stampare tutto, ma stampare cose che valga la pena di leggere e rileggere. Bisogna essere efficaci, sintetici, tenere desta l’attenzione, perché non si può pensare che scrivendo si è garantiti da un privilegio, da un diritto all’ascolto, tutt’altro.
La poesia è stata inventata proprio per curare la qualità, essenzialità, densità e perfezione tecnica del linguaggio. È stata creata come messaggio memorabile, da imparare a memoria, da rileggere. Invece oggi la maggior parte delle poesie non solo non possono essere rilette, ma perfino impossibile leggerle. Sono labili, effimere.
La letteratura è qualcosa che ci tiene in contatto con una lunga tradizione, con qualcosa di arcaico. C’è perfino qualcosa di magico in questo, una specie di partecipazione per contatto, perché anche se non ci penso, ogni volta che mi siedo e comincio a scrivere o a leggere facendo attenzione a ogni frase e parola, in un certo senso entro in comunicazione con tutti quelli che hanno scritto e letto.
È come quando, se mi sveglio per esempio alle cinque di mattina, sento che entro in comunicazione con tutti i pendolari che si sono alzati a quell’ora, anche se non li vedo. E se mi inginocchiassi a pregare, cosa che non faccio, entrerei in comunicazione con tutti coloro che nel mondo si inginocchiano a pregare o lo hanno fatto per secoli… Ecco, in un certo senso ci sono delle attività che ci mettono ancora in comunicazione diretta con parti della cultura umana che altrimenti tendono a sparire e morire.
Forse è questa la ragione per cui io scrivo ancora preferibilmente a mano, o uso la vecchia macchina da scrivere, cioè tecnologie un po’ vecchie, quelle che c’erano quando ho imparato a scrivere. Certe condizioni fisiche della scrittura tendo a conservarle così come le ho imparate, perché evidentemente sono un po’ superstizioso: temo che le nuove tecniche rubino e sottraggano all’atto di leggere e scrivere la sua forza magica…!
7. Almanacchi, antologie. Ci deve pur essere qualche criterio di oggettività che ostacoli la tendenza dei poeti di oggi ad auto-consolarsi nel loro piccolo ghetto, nel quale niente e nessuno li contraddice. I poeti si sono ritagliati una zona protetta, si accontentano di poco, pretendono poco da se stessi, sono suscettibili e vanitosi ma non hanno vera ambizione. Non hanno più le grandi ambizioni che hanno sempre avuto i poeti – che possono anche non avere successo, ma contano sul valore e sul potere dei loro versi: la forza dei poeti è sempre stata questa.
Oggi tutto il sistema culturale tende a privilegiare il libro come merce piuttosto che come valore. Questo è inevitabile, sappiamo in che tipo di società viviamo. Ma la poesia è particolarmente sfavorita in questa lotta di mercato. D’altra parte esiste una specie di ingenuo feticismo dell’Autore, per cui anche chi scrive poesie ed è isolato e timido, è ipnotizzato dal miraggio di pubblicare il Libro.
Tra pubblicare con un grosso editore e pubblicare con una casa editrice minima la differenza è quasi nulla, perché non si viene quasi letti. I lettori sono in media qualche centinaio, se va bene: la critica quasi non reagisce, ormai non reagisce neppure alla pubblicazione di grandi poeti e di nomi famosi. E quindi per ritrovare una dimensione comunicativa, magari ristretta ma reale, bisogna liberarsi da questo feticismo dell’involucro libro, perché i libri di singoli autori vanno persi, annegano nella massa delle pubblicazioni.
C’è poi anche un’altra ragione: sono veramente pochi, sono pochi addirittura nell’intero Novecento, i libri di poesia che veramente reggano in quanto libri. Anche autori molto importanti si leggono bene in antologie: figuriamoci oggi che molti tendono a riempire di zavorra e a ripetersi, pur di avere materia sufficiente per fare il sognato libro. Sarebbe meglio trovare strumenti editorialmente più efficaci, come almanacchi e antologie periodiche che contengano il meglio di ciò che è stato pubblicato qua e là in un anno…
Insomma, quando un autore nella propria vita ha scritto una decina di belle poesie può essere soddisfatto, può essere definito poeta, lo è senz’altro. Ma se ha pubblicato dieci brutti libri che non si leggono e non si ricordano perché non contengono neppure una poesia da ricordare, allora è stato tutto uno spreco.
8. Prima i lettori e poi i critici. Penso che la sola cosa utile sia dare forza al primo ed elementare atto della critica: distinguere coloro che sono poeti da coloro che non lo sono. Questo può apparire un atto brutale, crudele, ruvido, presuntuoso: ma una categoria pletorica, affollata di gente che si illude di scrivere poesia e scrive invece cosette avvilenti è quanto di più lontano dalla poesia.
Molti di costoro si consolano con l’idea che la poesia è difficile e che la verità è perdente: ma è come pensare che, dal momento che molti grandi scrittori sono stati nevrotici o isterici, ogni isterico e nevrotico è un poeta. Si è scrittori e poeti per la straordinaria energia verbale, per lo “spirito” e perfezione di quello che si scrive, non per altro.
Distinguere è anche ciò che dovrebbe fare un pubblico reale di lettori: va bene, questi lettori saranno pochi, ma che almeno abbiano il senso della poesia e siano esigenti. Una critica non può fare quello che non fanno già da sè i lettori: perché un genere letterario sia vitale ci vuole certo anche la critica, ma anzitutto è necessario un pubblico, anche piccolo ma reale.
I veri lettori di poesia hanno delle reazioni vivaci, forti. Invece non se ne hanno, prevale una forma di auto-consolazione, perché chi legge brutte poesie a sua volta scrive poesie brutte e così non c’è via d’uscita. Chi scrive poesie lo si tratta come un bambino che non va inibito, a cui non si può dire mai la verità, anche perché oggi c’è una gran confusione sul talento artistico: è cortese e democratico riconoscere che tutti ce ne hanno un po’ o potrebbero avercelo con un piccolo sforzo in più. I gruppi di poeti sono diventati come degli asili infantili dove si deve incoraggiare, si deve sempre dire a tutti «come sei bravo».
Il fatto è che certe arti, come la poesia e la pittura o anche il teatro, la situazione è arrivata a questo punto perché sono arti che non interessano molto, vengono ignorate e lasciate sopravvivere stancamente. Se la poesia interessasse come la musica classica, o anche come il rock, ci sarebbe un pubblico che vuole qualcosa e rifiuta qualcos’altro, distinguerebbe fra prodotti buoni e prodotti scadenti.
Ciò che interessa non è la poesia, ma un certo aroma, l’etichetta: interessa entrare in qualche modo, non importa come, a far parte di qualcosa che conserva un residuo di prestigio, crea identità, magari identità fittizie, dà un piccolo status symbol culturale. Ma allora la qualità di quello che si scrive e si pubblica passa in secondo piano, diventa irrilevante. Così la poesia si è resa irrilevante, è un nome vuoto…
Alfonso Berardinelli
*


















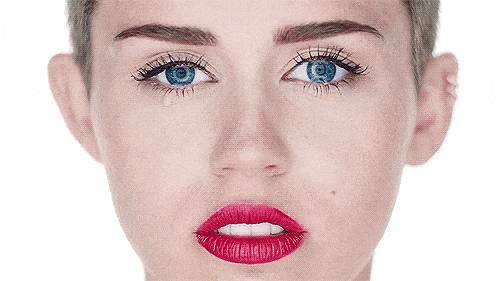
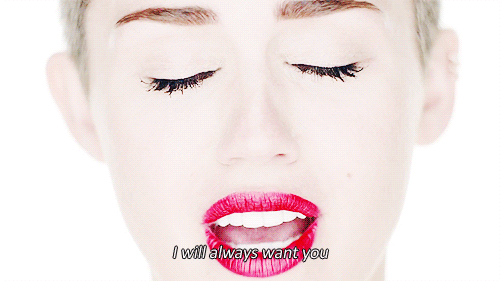


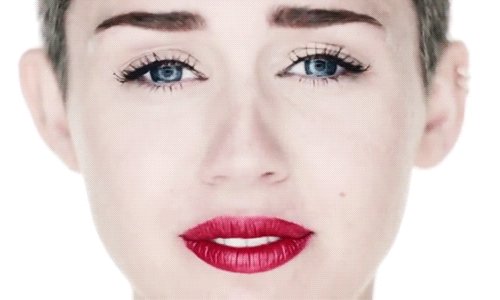








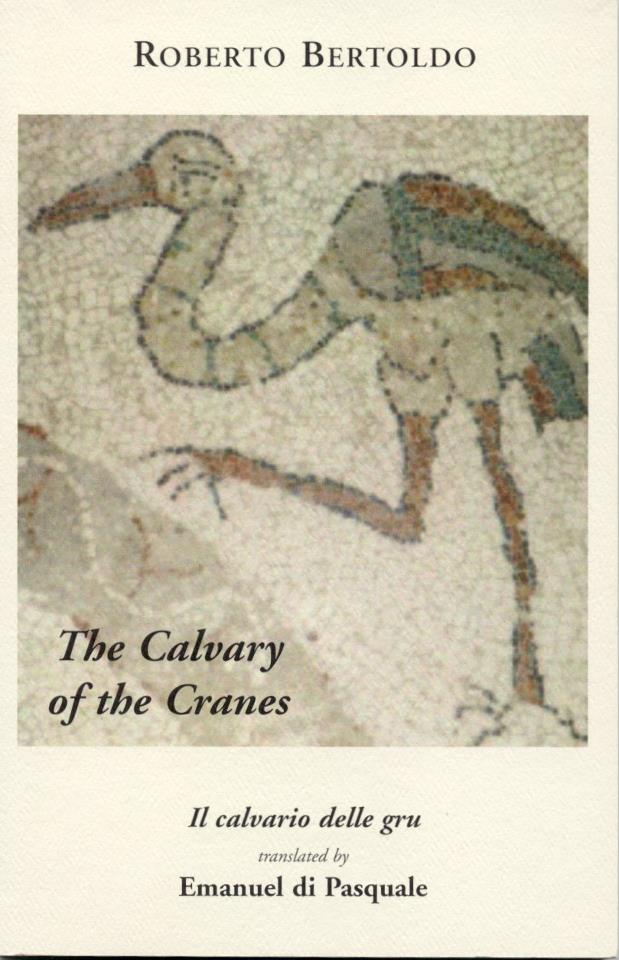
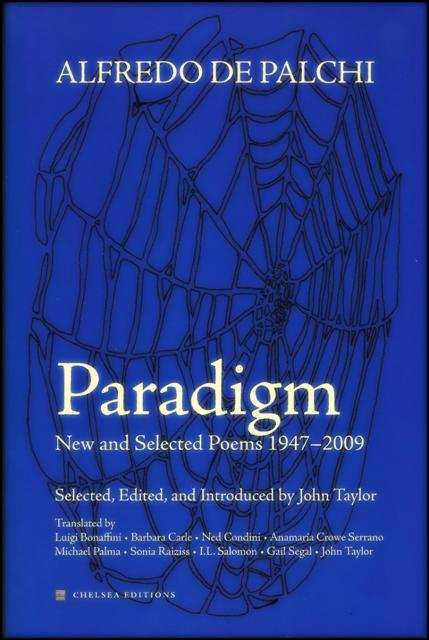


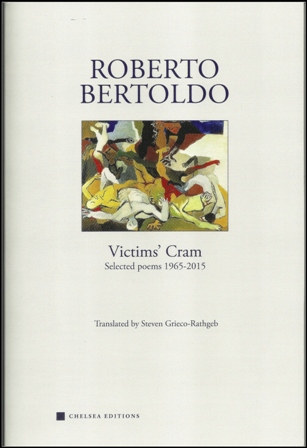





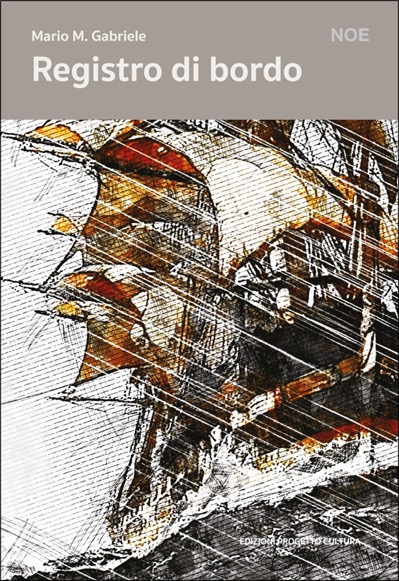

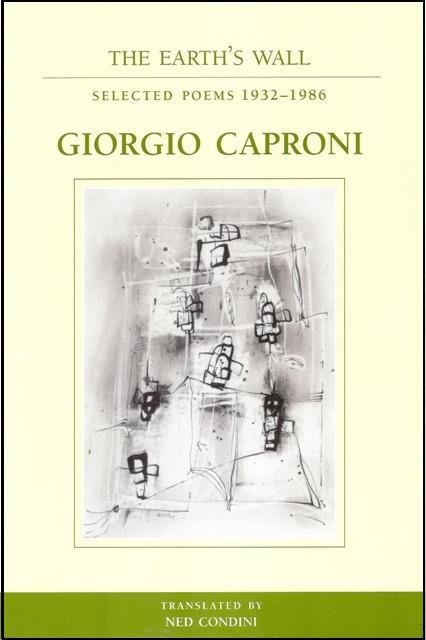
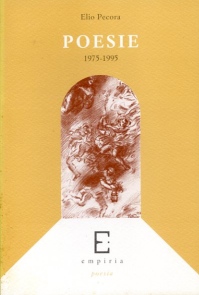

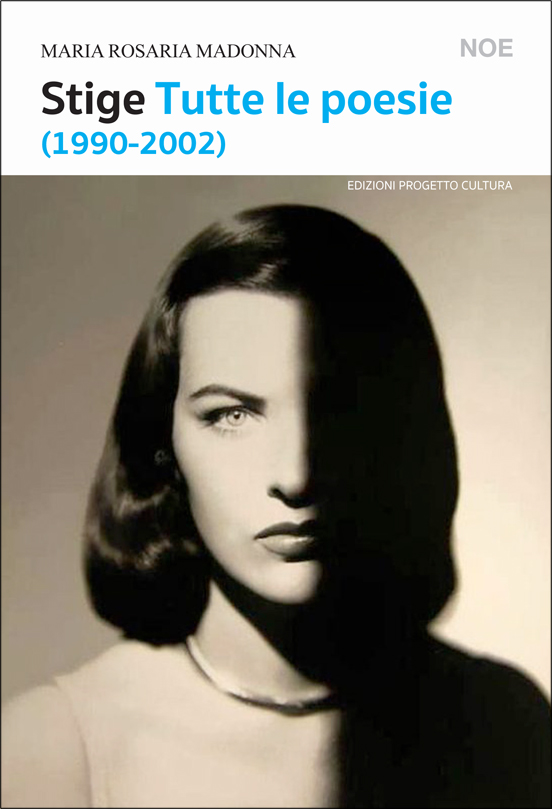

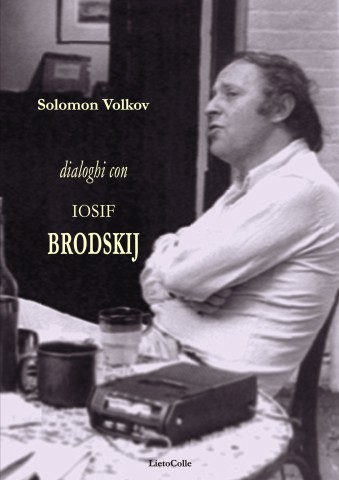




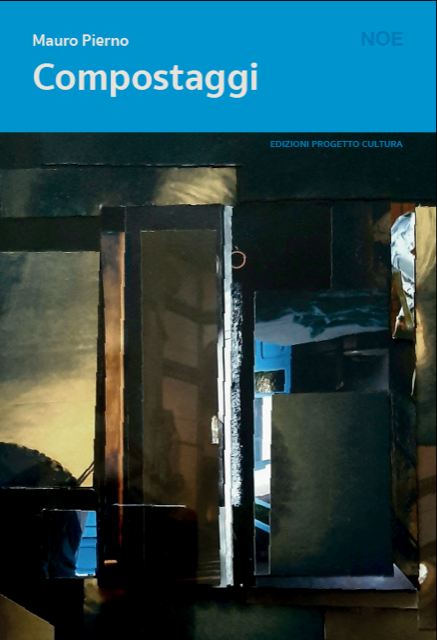




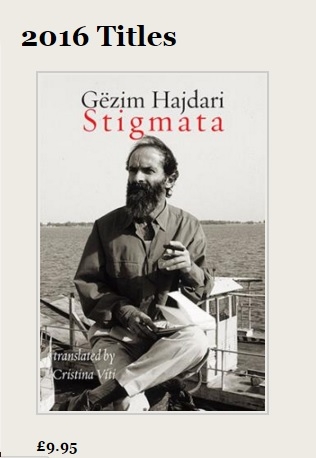






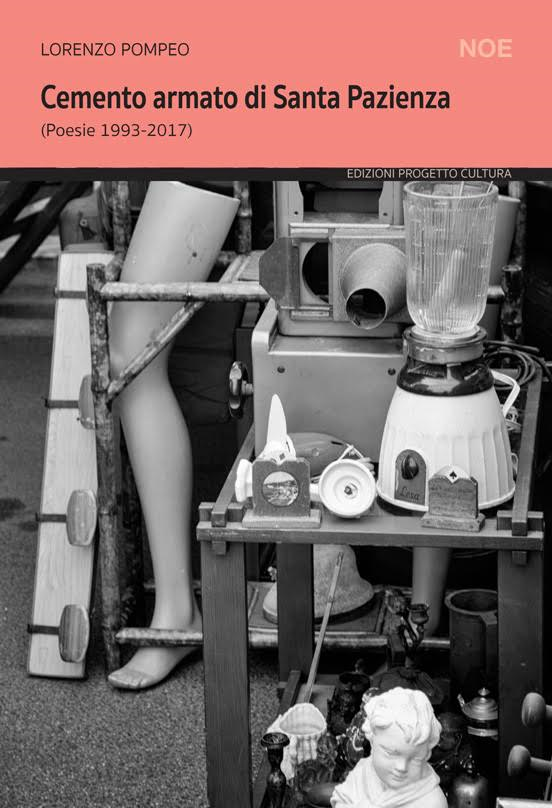







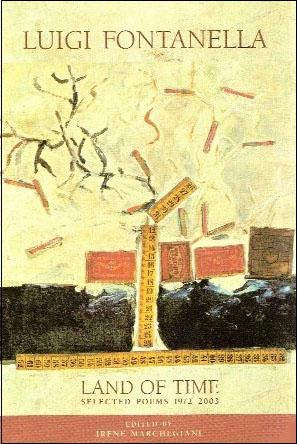








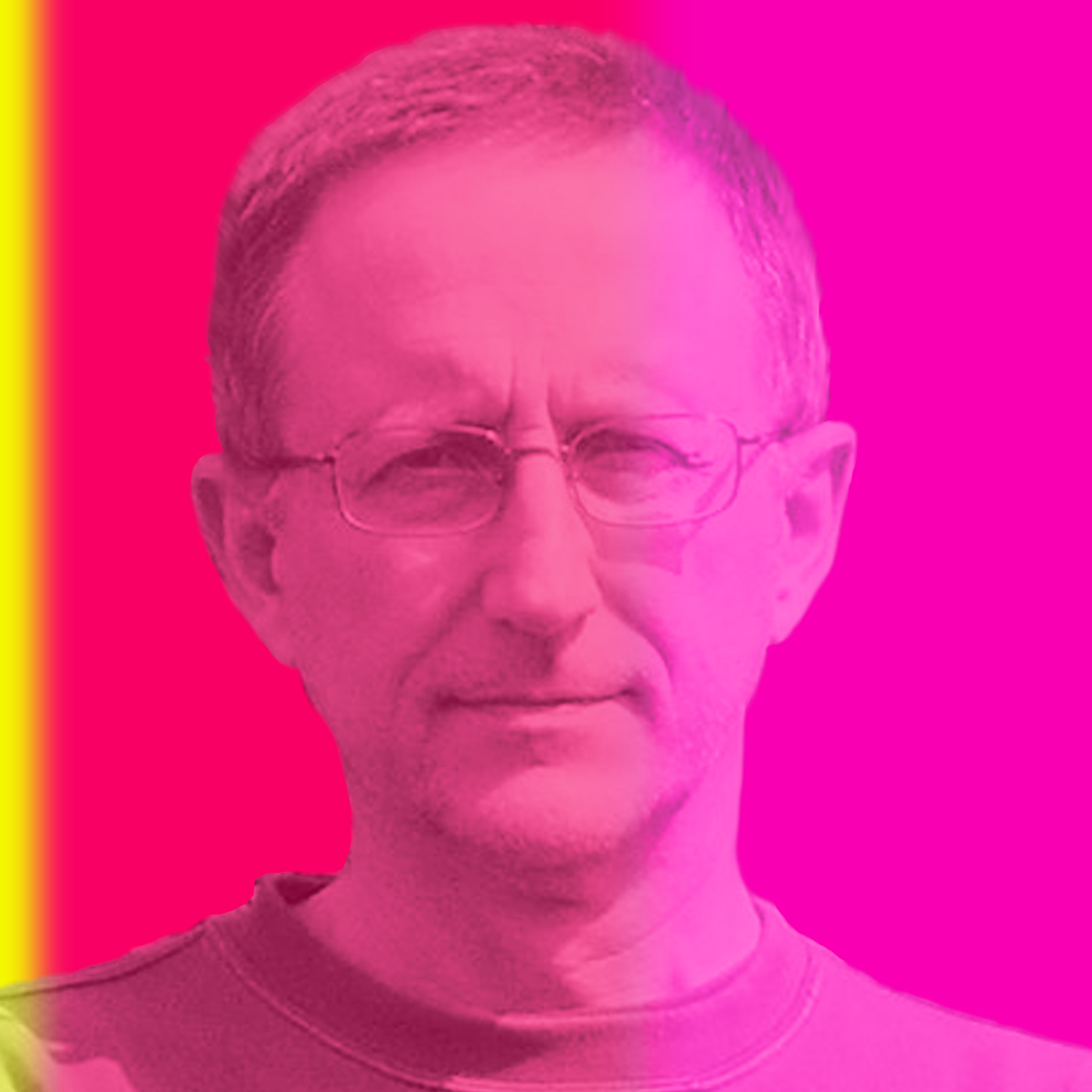







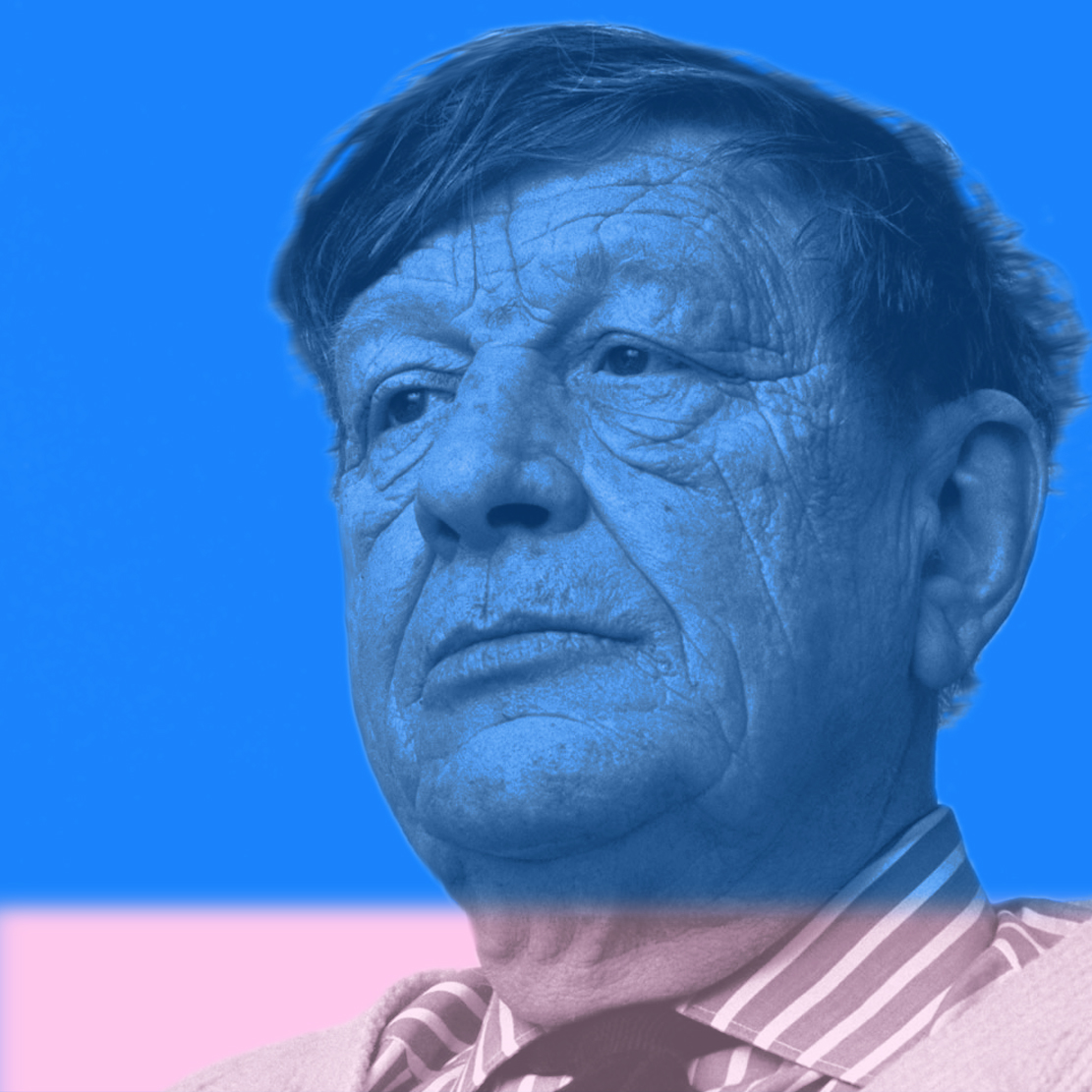





















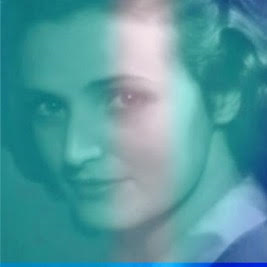































” I gruppi di poeti sono diventati come degli asili infantili dove si deve incoraggiare , si deve sempre dire a tutti ” come sei bravo” ”
leopoldo attolico –
"Mi piace""Mi piace"
In poesia si può parlare di tutto?
Ma è Berardinelli che parla di tutto da vero tuttologo. Ci trovo tante rimasticature di cose scritte in quegli anni da Fortini, da cui poi ha preso le distanze in modi intellettualmente pornografici annacquandone la lezione nei modi adatti al mutamento di clima politico.
Non vedo cosa ci sia da imparare da questo vecchio articolo perché il suo autore ballonzola sulla stessa melma culturale che disprezza.
P.s.
Rimando chi trovasse la mia idiosincrasia per il berardinellismo troppo viscerale a questa mia più meditata critica:
http://www.backupoli.altervista.org/article.php3?id_article=134&var_recherche=berardinelli
"Mi piace""Mi piace"
Mi sembra che non ci sia nulla da commentare, l’articolo di Berardinelli, che data più di venti anni or sono, è come il vino: più passano gli anni più la sua qualità migliora. Una analisi lucida, oggettiva, ragionata. Direi un addio alla poesia. E se la poesia italiana è nelle attuali condizioni ciò è dovuto anche al fatto che i migliori intelletti si sono allontanati dalla poesia.
"Mi piace""Mi piace"
Più che altro, a mio avviso, i migliori intelletti si sono allontanati da quegli inutili conglomerati, cerchi chiusi di persone che ritengono di possedere il verbo incarnato, che stanno uccidendo, e sono a buon punto, molta buona poesia italiana. E se non passi di là non diventi nessuno.
"Mi piace""Mi piace"
La posta in gioco è alta. Si tratta di affrontare la questione del Logos dal punto di vista della Modernità, dal punto di vista della forma-poesia. Ne va del pensiero del linguaggio, nella misura in cui esso è il linguaggio del pensiero.
Pensare il linguaggio significa anzitutto aprire il pensiero al proprio linguaggio. Il pensiero del linguaggio mette in moto un linguaggio specifico che è quello del linguaggio poetico. In ciò risiede il carattere fondamentale della meditazione sul Logos.
Significa rileggere la tradizione (italiana ed europea) dal punto di vista del proprio linguaggio. Ma come si fa a pensare un proprio linguaggio sulla base di forme abusate di precedenti organizzazioni poetiche?
Sta di fatto che senza pensiero del linguaggio, il linguaggio di un nuovo pensiero poetico si dissolve di fatto, se non di diritto, in guise che rendono il pensiero poetico estraneo a se stesso. E l’alienazione inghiotte quel linguaggio che non ha pensato a sufficienza se stesso.
Occorre dunque porre la questione del Logos all’interno del problema del Moderno.
"Mi piace""Mi piace"
“Non vi presterò mai la mia inquietudine, i miei doni, la regalità che mi fu negata!”.
"Mi piace""Mi piace"
caro Antonio,
non mi sento di stigmatizzare Alfonso Berardinelli per la sua disillusione nei confronti del mondo poetico italiano. Ho profondo rispetto per il critico romano e per le sue scelte fatte nel passato; anch’io sento sulle mie spalle una profonda disillusione, in quanto dopo venti anni e più di militanza in poesia mi trovo circondato da una fitta boscaglia di recriminazioni, di rivendicazioni e di ostracismi. Ultimamente, ho molto ridotto la mia attività, diciamo, di critica leggera, di quella fatta con la mano sinistra, quella che viene fatta nei confronti degli innumerevoli poetanti presenti in tutte le latitudini. E’ una fatica di Sisifo, è come tentare di svuotare il mare con una tazzina da caffè.
Di fatto la cosiddetta critica, quella che viene fatta dagli stessi poetanti, è priva di qualsiasi spessore culturale, priva di un discorso. le prefazioni, le recensioni che dilagano sono in realtà nient’altro che attività amicali. E’ questa la ragione per cui su questo blog le scritture critiche devono passare attraverso un filtro rigorosissimo in base ad un semplice criterio: non devono essere sfacciatamente amicali e di parte.
La critica deve essere un atto di libertà, di indipendenza, altrimenti non ha senso neanche chiamarla critica, dovremmo chiamarla apologia, un tipo di scrittura che rientra tra le attività delle scritture apologetiche…
"Mi piace""Mi piace"
Pingback: Ieri mi è arrivato per posta un libretto di Cesare Viviani, La poesia è finita. Diamoci pace. A meno che… il melangolo, 2018, pp. 76 € 7 pp. 45 e segg. – Risposta di Alfonso Berardinelli, da Poesia non poesia, Einaudi, 2008 | L'Ombra del
L’ha ribloggato su RIDONDANZE.
"Mi piace""Mi piace"