
Yeats and Eliot
A proposito di T. S. Eliot, Czesław Miłosz scrisse esattamente questo:
«Certe scene dei film di Fellini e di Antonioni sembrano la traduzione di una poesia, spesso di una poesia di Eliot: basti citare la stanza dell’intellettuale ne la Dolce Vita di Fellini, che sembra tratta da “Il canto d’amore di J. Alfred Prufrock” (In the room the women come and go / Talking of Michelangelo); e poco importa che autore o regista abbiano preso in prestito il tema direttamente o indirettamente. In tal modo anche le persone più digiune di poesia finiscono per riceverla, in forma facilitata, dal teatro o dal cinema…».
Il canto d’amore di J. Alfred Prufrock (The Love Song of J. Alfred Prufrock) non è una poesia d’amore, né tanto meno un canto d’amore. Fu composto da Eliot tra il 1910 e il 1911 con il titolo Prufrock tra le donne, ma pubblicato per la prima volta solo nel 1917 nella raccolta Prufrock and Other Observations, dedicata all’amico Jean Verdenal, ucciso nel 1915 nella spedizione anglofrancese dei Dardanelli.
È scritto in forma di monologo drammatico. Il personaggio è una controfigura del poeta e dell’intellettuale in genere, è una “maschera” narrante. Nel soliloquio, questa si esprime liberamente come se il proprio parlare fosse rivolto soltanto a se stessa. In tale discorrere solitario i pensieri emergono e si strutturano senza obbedire alle esigenze di compiutezza proprie di un racconto; essi piuttosto vengono regolati nel loro concatenarsi dal flusso variabile ed imprevedibile delle emozioni.
Come epigrafe alla poesia, Eliot ha posto alcuni versi di Dante tratti dalla Commedia, che narrano dell’incontro tra Dante e Guido da Montefeltro, condannato all’ottavo cerchio dell’Inferno.
È interessante notare come questa poesia di T. S. Eliot abbia ispirato, nel 1967, al regista e sceneggiatore Nico D’Alessandria, la realizzazione di un mediometraggio sperimentale, nel quale le immagini scorrono deviate, accompagnate dalla recitazione del testo e da suoni distorti. La voce narrante è di Carmelo Bene, le musiche di Luciano Berio.
*
T.S. Eliot
The lovesong of J. Alfred Prufrock
S’io credesse che mia risposta fosse
A persona che mai tornasse al mondo,
questa fiamma staria senza piu scosse.
Ma perciocchè giammai di questo fondo
Non tornò vivo alcun, s’i’odo il vero,
Senza tema d’infamia ti rispondo.
.
Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherized upon a table;
Let us go, through certain half-deserted streets,
The muttering retreats
Of restless nights in one-night cheap hotels
And sawdust restaurants with oyster-shells:
Streets that follow like a tedious argument
Of insidious intent
To lead you to an overwhelming question. . .
Oh, do not ask, “What is it?”
Let us go and make our visit.
In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.
The yellow fog that rubs its back upon the window-panes
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes
Licked its tongue into the corners of the evening
Lingered upon the pools that stand in drains,
Let fall upon its back the soot that falls from chimneys,
Slipped by the terrace, made a sudden leap,
And seeing that it was a soft October night
Curled once about the house, and fell asleep.
And indeed there will be time
For the yellow smoke that slides along the street,
Rubbing its back upon the window-panes;
There will be time, there will be time
To prepare a face to meet the faces that you meet;
There will be time to murder and create,
And time for all the works and days of hands
That lift and drop a question on your plate;
Time for you and time for me,
And time yet for a hundred indecisions
And for a hundred visions and revisions
Before the taking of a toast and tea.
In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.
And indeed there will be time
To wonder, “Do I dare?” and, “Do I dare?”
Time to turn back and descend the stair,
With a bald spot in the middle of my hair—
[They will say: “How his hair is growing thin!”]
My morning coat, my collar mounting firmly to the chin,
My necktie rich and modest, but asserted by a simple pin—
[They will say: “But how his arms and legs are thin!”]
Do I dare
Disturb the universe?
In a minute there is time
For decisions and revisions which a minute will reverse.
For I have known them all already, known them all;
Have known the evenings, mornings, afternoons, I have measured out my life with coffee spoons;
I know the voices dying with a dying fall
Beneath the music from a farther room.
So how should I presume?
And I have known the eyes already, known them all—
The eyes that fix you in a formulated phrase,
And when I am formulated, sprawling on a pin,
When I am pinned and wriggling on the wall,
Then how should I begin
To spit out all the butt-ends of my days and ways?
And how should I presume?
And I have known the arms already, known them all—
Arms that are braceleted and white and bare
[But in the lamplight, downed with light brown hair!]
Is it perfume from a dress
That makes me so digress?
Arms that lie along a table, or wrap about a shawl.
And should I then presume?
And how should I begin?
. . . . .
Shall I say, I have gone at dusk through narrow streets
And watched the smoke that rises from the pipes
Of lonely men in shirt-sleeves, leaning out of windows? . . .
I should have been a pair of ragged claws
Scuttling across the floors of silent seas.
. . . . .
And the afternoon, the evening, sleeps so peacefully!
Smoothed by long fingers,
Asleep . . . tired . . . or it malingers,
Stretched on the floor, here beside you and me.
Should I, after tea and cakes and ices,
Have the strength to force the moment to its crisis?
But though I have wept and fasted, wept and prayed,
Though I have seen my head (grown slightly bald) brought in upon a platter,
I am no prophet–and here’s no great matter;
I have seen the moment of my greatness flicker,
And I have seen the eternal Footman hold my coat, and snicker,
And in short, I was afraid.
And would it have been worth it, after all,
After the cups, the marmalade, the tea,
Among the porcelain, among some talk of you and me,
Would it have been worth while,
To have bitten off the matter with a smile,
To have squeezed the universe into a ball
To roll it toward some overwhelming question,
To say: “I am Lazarus, come from the dead,
Come back to tell you all, I shall tell you all”
If one, settling a pillow by her head,
Should say, “That is not what I meant at all.
That is not it, at all.”
And would it have been worth it, after all,
Would it have been worth while,
After the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets,
After the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor—
And this, and so much more?—
It is impossible to say just what I mean!
But as if a magic lantern threw the nerves in patterns on a screen:
Would it have been worth while
If one, settling a pillow or throwing off a shawl,
And turning toward the window, should say:
“That is not it at all,
That is not what I meant, at all.”
. . . . .
No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be;
Am an attendant lord, one that will do
To swell a progress, start a scene or two
Advise the prince; no doubt, an easy tool,
Deferential, glad to be of use,
Politic, cautious, and meticulous;
Full of high sentence, but a bit obtuse;
At times, indeed, almost ridiculous—
Almost, at times, the Fool.
I grow old . . . I grow old . . .
I shall wear the bottoms of my trousers rolled.
Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach?
I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach.
I have heard the mermaids singing, each to each.
I do not think they will sing to me.
I have seen them riding seaward on the waves
Combing the white hair of the waves blown back
When the wind blows the water white and black.
We have lingered in the chambers of the sea
By sea-girls wreathed with seaweed red and brown
Till human voices wake us, and we drown.
*
S’io credesse che mia risposta fosse
A persona che mai tornasse al mondo,
Questa fiamma staria senza più scosse.
Ma perciocché giammai di questo fondo
Non tornò vivo alcun, s’i’ odo il vero,
Senza tema d’infamia ti rispondo.
.
Allora andiamo, tu ed io,
Quando la sera si stende contro il cielo
Come un paziente eterizzato disteso su una tavola;
Andiamo, per certe strade semideserte,
Mormoranti ricoveri
Di notti senza riposo in alberghi di passo a poco prezzo
E ristoranti pieni di segatura e gusci d’ostriche;
Strade che si succedono come un tedioso argomento
Con l’insidioso proposito
Di condurti a domande che opprimono…
Oh, non chiedere “Cosa?”
Andiamo a fare la nostra visita.
Nella stanza le donne vanno e vengono
Parlando di Michelangelo.
La nebbia gialla che strofina la schiena contro i vetri,
Il fumo giallo che strofina il suo muso contro i vetri
Lambì con la sua lingua gli angoli della sera,
Indugiò sulle pozze stagnanti negli scoli,
Lasciò che gli cadesse sulla schiena la fuliggine che cade dai camini,
Scivolò sul terrazzo, spiccò un balzo improvviso,
E vedendo che era una soffice sera d’ottobre
S’arricciolò attorno alla casa, e si assopì.
E di sicuro ci sarà tempo
Per il fumo giallo che scivola lungo la strada
Strofinando la schiena contro i vetri;
Ci sarà tempo, ci sarà tempo
Per prepararti una faccia per incontrare le facce che incontri;
Ci sarà tempo per uccidere e creare,
E tempo per tutte le opere e i giorni delle mani
Che sollevano e lasciano cadere una domanda sul tuo piatto;
Tempo per te e tempo per me,
E tempo anche per cento indecisioni,
E per cento visioni e revisioni,
Prima di prendere un tè col pane abbrustolito.
Nella stanza le donne vanno e vengono
Parlando di Michelangelo.
E di sicuro ci sarà tempo
Di chiedere, “Posso osare?” e, “Posso osare?”
Tempo di volgere il capo e scendere la scala,
Con una zona calva in mezzo ai miei capelli —
(Diranno: “Come diventano radi i suoi capelli!”)
Con il mio abito per la mattina, con il colletto solido che arriva fino al mento,
Con la cravatta ricca e modesta, ma asserita da un semplice spillo —
(Diranno: “Come gli son diventate sottili le gambe e le braccia!”)
Oserò
Turbare l’universo?
In un attimo solo c’è tempo
Per decisioni e revisioni che un attimo solo invertirà
Perché già tutte le ho conosciute, conosciute tutte: —
Ho conosciuto le sere, le mattine, i pomeriggi,
Ho misurato la mia vita con cucchiaini da caffè;
Conosco le voci che muoiono con un morente declino
Sotto la musica giunta da una stanza più lontana.
Così, come potrei rischiare?
E ho conosciuto tutti gli occhi, conosciuti tutti —
Gli occhi che ti fissano in una frase formulata,
E quando sono formulato, appuntato a uno spillo,
Quando sono trafitto da uno spillo e mi dibatto sul muro
Come potrei allora cominciare
A sputar fuori tutti i mozziconi dei miei giorni e delle mie abitudini?
Come potrei rischiare?
E ho già conosciuto le braccia, conosciute tutte —
Le braccia ingioiellate e bianche e nude
(Ma alla luce di una lampada avvilite da una leggera peluria bruna!)
È il profumo che viene da un vestito
Che mi fa divagare a questo modo?
Braccia appoggiate a un tavolo, o avvolte in uno scialle.
Potrei rischiare, allora?—
Come potrei cominciare?
. . . . . . . . . . . .
Direi, ho camminato al crepuscolo per strade strette
Ed ho osservato il fumo che sale dalle pipe
D’uomini solitari in maniche di camicia affacciati alle finestre?…
Avrei potuto essere un paio di ruvidi artigli
Che corrono sul fondo di mari silenziosi.
. . . . . . . . . . . .
E il pomeriggio, la sera, dorme così tranquillamente!
Lisciata da lunghe dita,
Addormentata… stanca… o gioca a fare la malata,
Sdraiata sul pavimento, qui fra te e me.
Potrei, dopo il tè e le paste e i gelati,
Aver la forza di forzare il momento alla sua crisi?
Ma sebbene abbia pianto e digiunato, pianto e pregato,
Sebbene abbia visto il mio capo (che comincia un po’ a perdere i capelli) portato su un vassoio,
lo non sono un profeta — e non ha molta importanza;
Ho visto vacillare il momento della mia grandezza,
E ho visto l’eterno Lacchè reggere il mio soprabito ghignando,
E a farla breve, ne ho avuto paura.
E ne sarebbe valsa la pena, dopo tutto,
Dopo le tazze, la marmellata e il tè,
E fra la porcellana e qualche chiacchiera
Fra te e me, ne sarebbe valsa la pena
D’affrontare il problema sorridendo,
Di comprimere tutto l’universo in una palla
E di farlo rotolare verso una domanda che opprime,
Di dire: “lo sono Lazzaro, vengo dal regno dei morti,
Torno per dirvi tutto, vi dirò tutto” —
Se una, mettendole un cuscino accanto al capo,
Dicesse: “Non è per niente questo che volevo dire.
Non è questo, per niente.”
E ne sarebbe valsa la pena, dopo tutto,
Ne sarebbe valsa la pena,
Dopo i tramonti e i cortili e le strade spruzzate di pioggia,
Dopo i romanzi, dopo le tazze da tè, dopo le gonne strascicate sul pavimento
E questo, e tante altre cose? —
È impossibile dire ciò che intendo!
Ma come se una lanterna magica proiettasse il disegno dei nervi su uno schermo:
Ne sarebbe valsa la pena
Se una, accomodandosi un cuscino o togliendosi uno scialle,
E volgendosi verso la finestra, dicesse:
« Non è per niente questo,
Non è per niente questo che volevo dire. »
. . . . . . . . . . . .
No! lo non sono il Principe Amleto, né ero destinato ad esserlo;
Io sono un cortigiano, sono uno
Utile forse a ingrossare un corteo, a dar l’avvio a una scena o due,
Ad avvisare il principe; uno strumento facile, di certo,
Deferente, felice di mostrarsi utile,
Prudente, cauto, meticoloso;
Pieno di nobili sentenze, ma un po’ ottuso;
Talvolta, in verità, quasi ridicolo —
E quasi, a volte, il Buffone.
Divento vecchio… divento vecchio…
Porterò i pantaloni arrotolati in fondo.
Dividerò i miei capelli sulla nuca? Avrò il coraggio di mangiare una pesca?
Porterò pantaloni di flanella bianca, e camminerò sulla spiaggia.
Ho udito le sirene cantare l’una all’altra.
Non credo che canteranno per me.
Le ho viste al largo cavalcare l’onde
Pettinare la candida chioma dell’onde risospinte
Quando il vento rigonfia l’acqua bianca e nera.
Ci siamo troppo attardati nelle camere del mare
Con le figlie del mare incoronate d’alghe rosse e brune
Finché le voci umane ci svegliano, e anneghiamo.
Traduzione di Roberto Sanesi
da T. S. Eliot, Poesie, a cura di Roberto Sanesi, Bompiani, Milano, 1996/2011
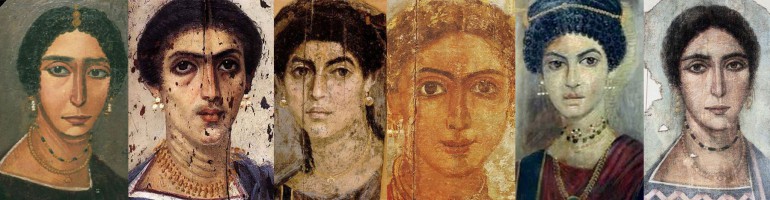

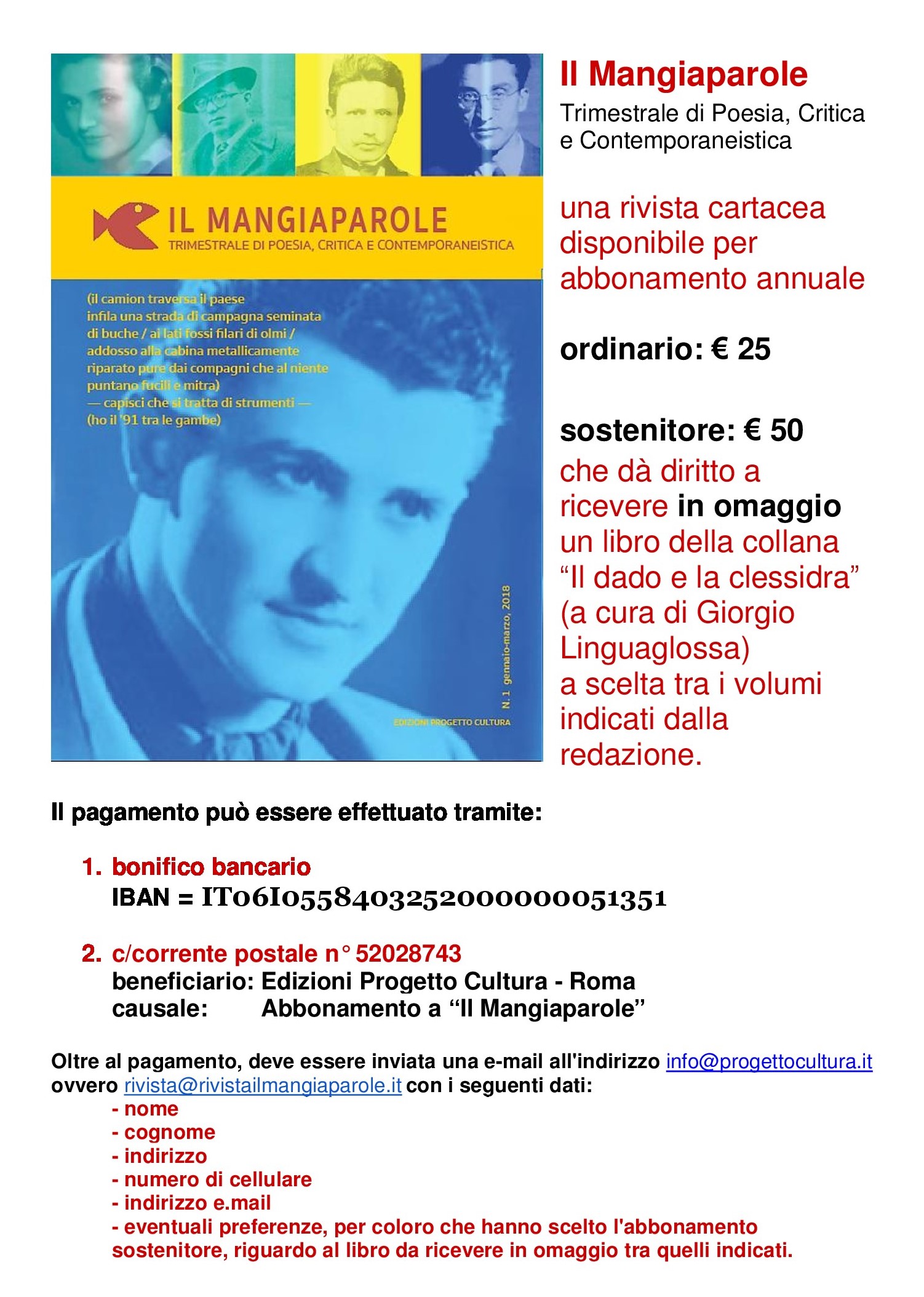
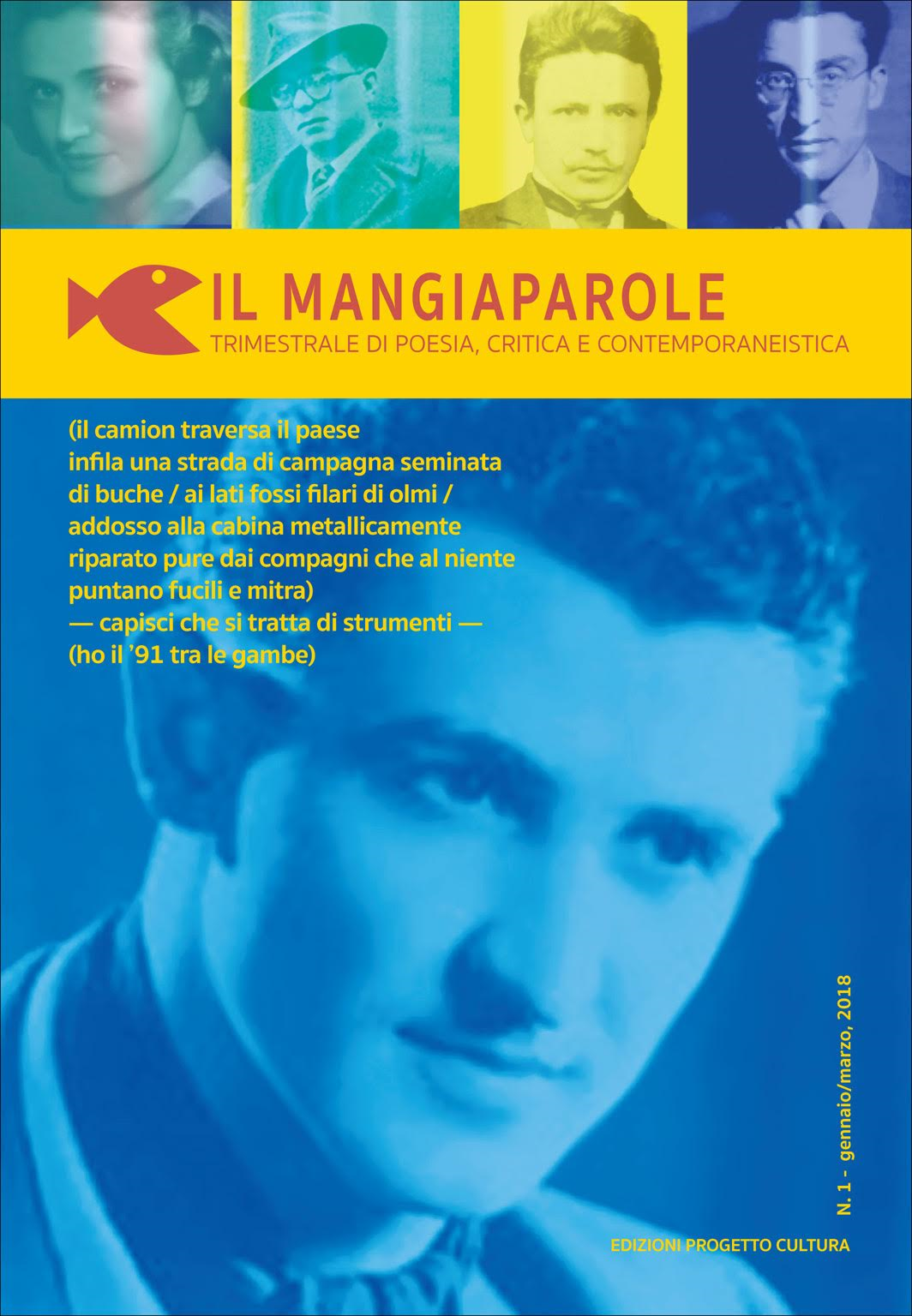

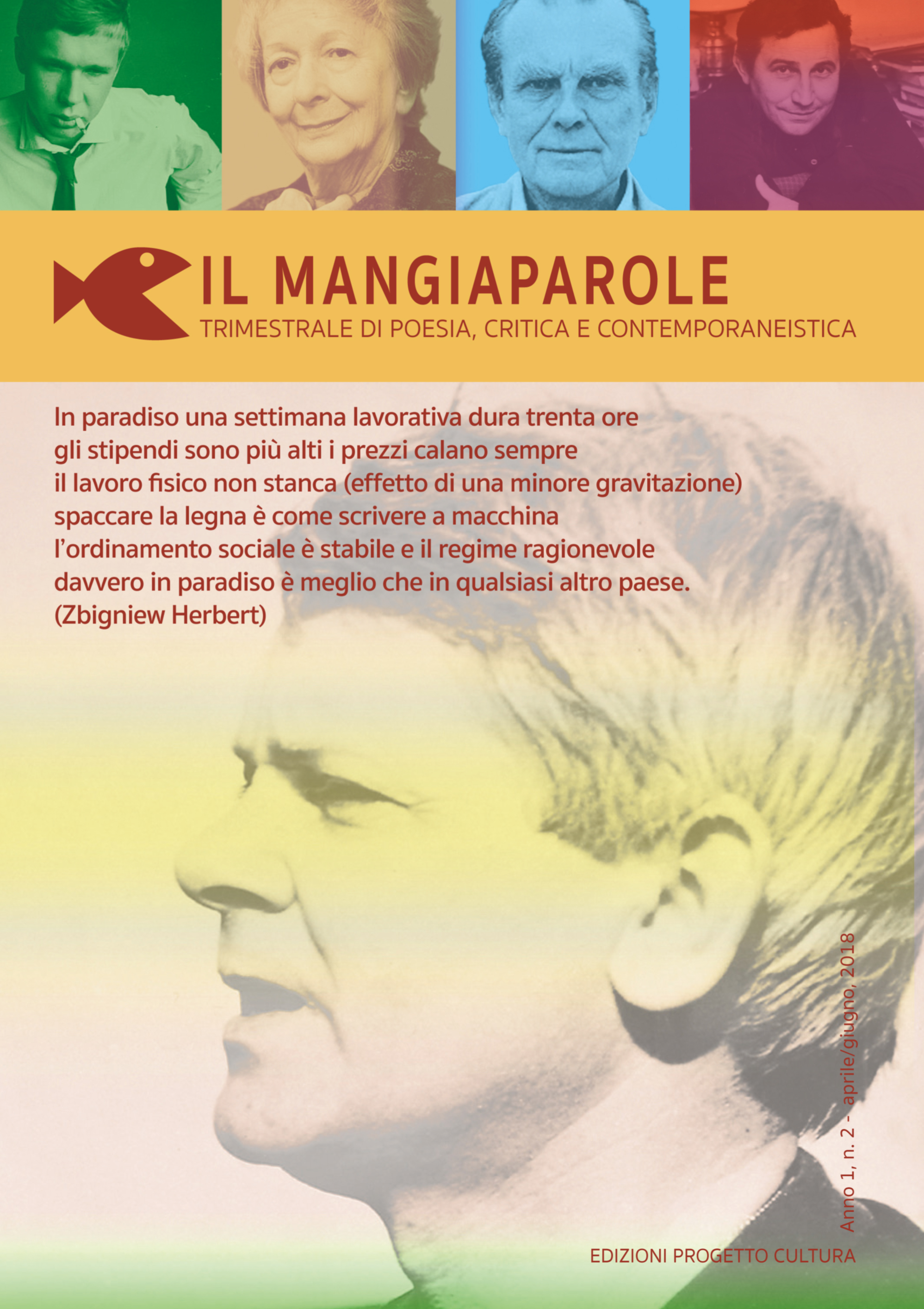



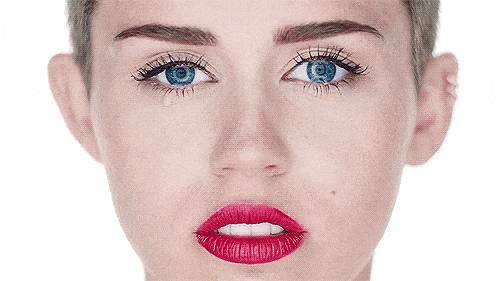
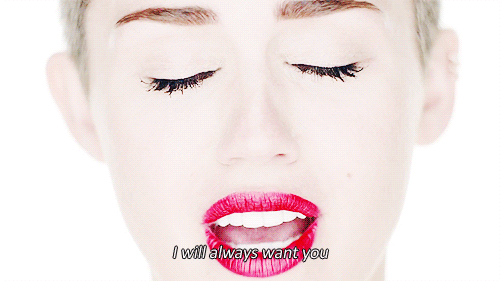
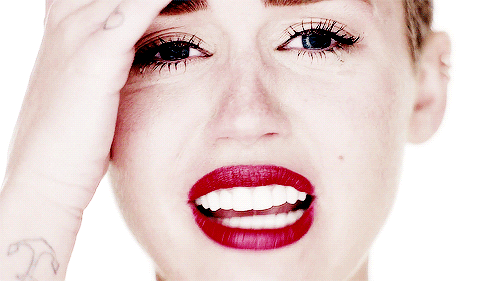
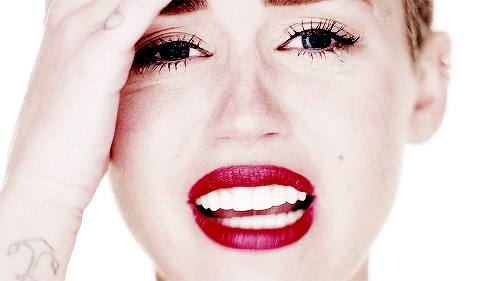
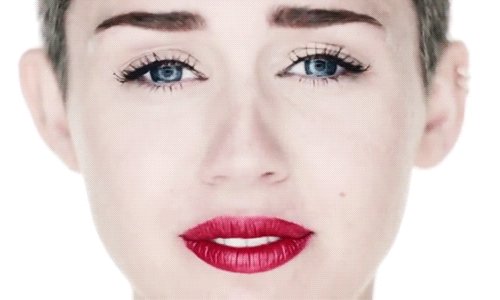



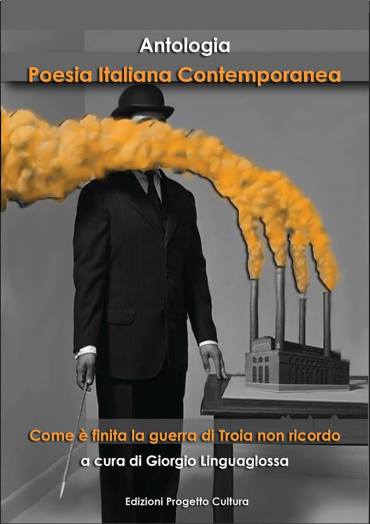




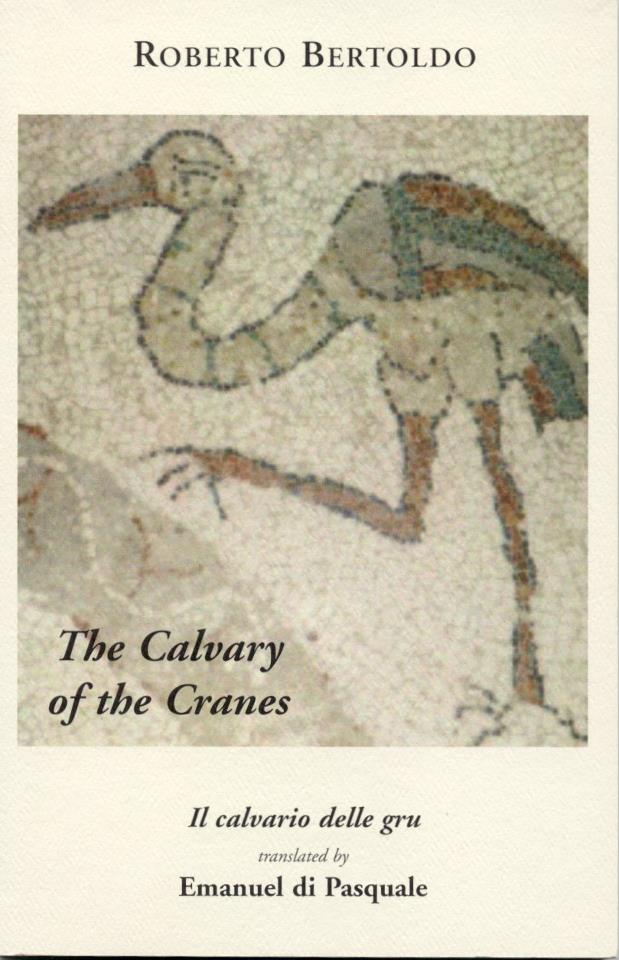
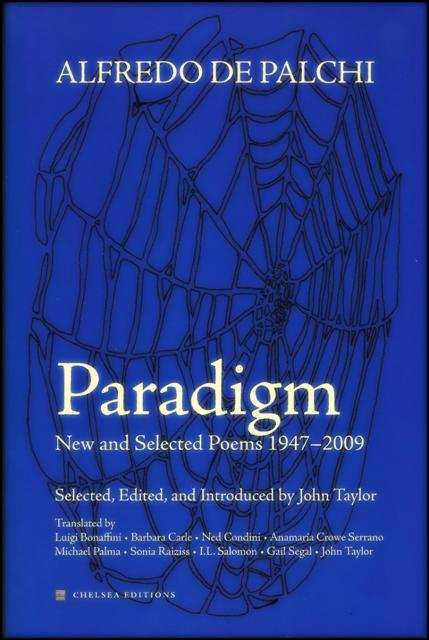


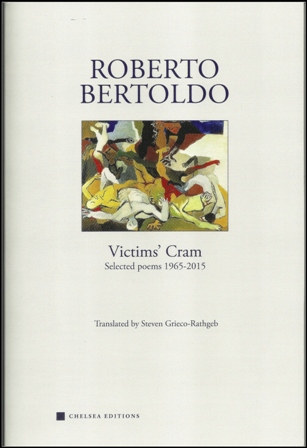





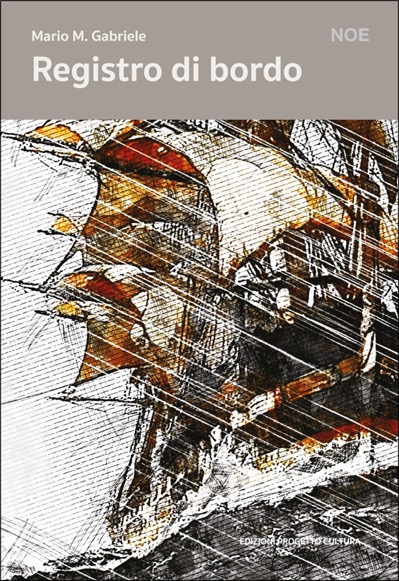

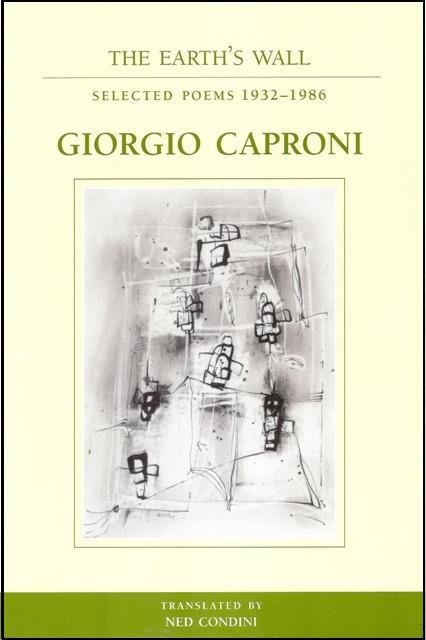
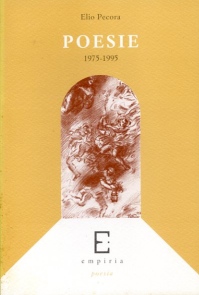

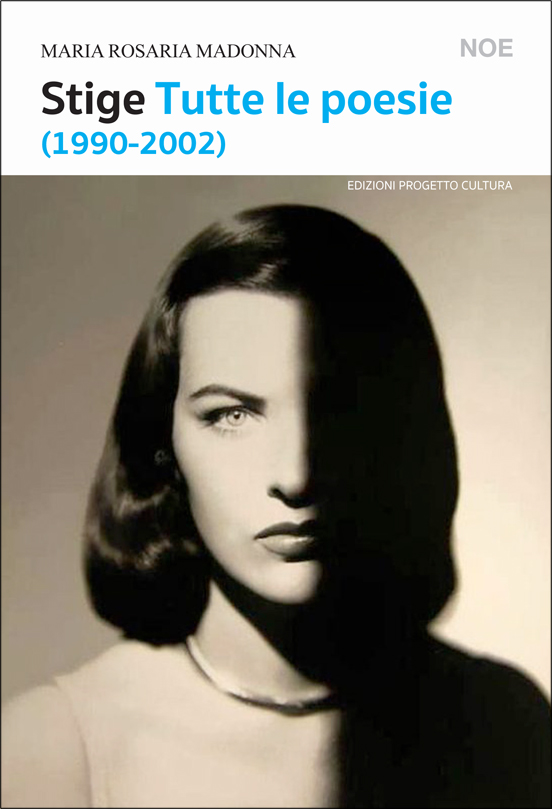

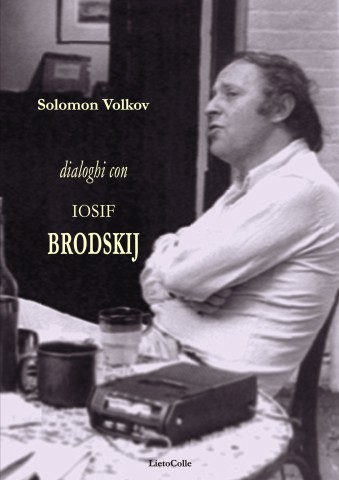




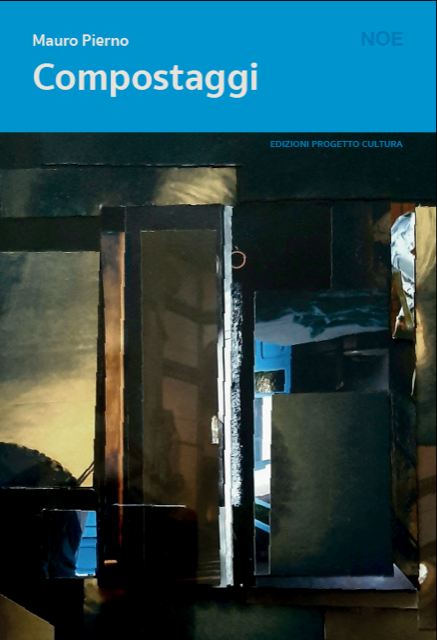
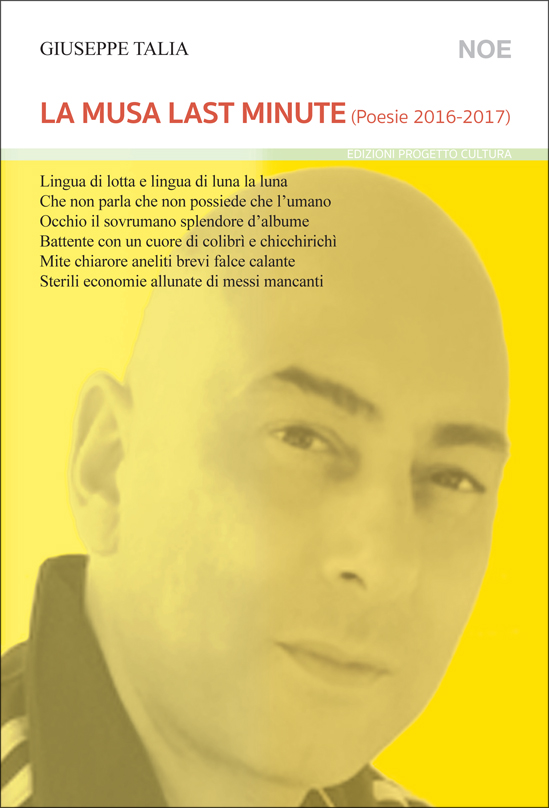


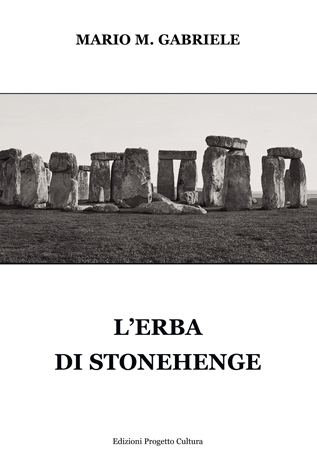
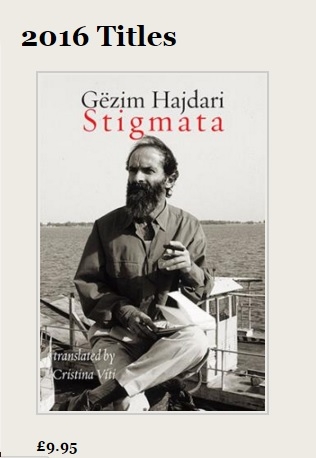
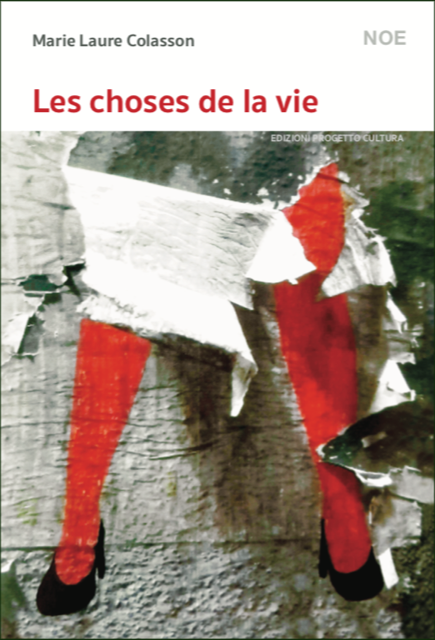




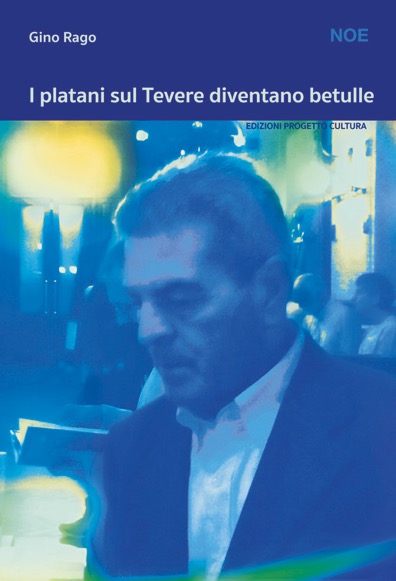
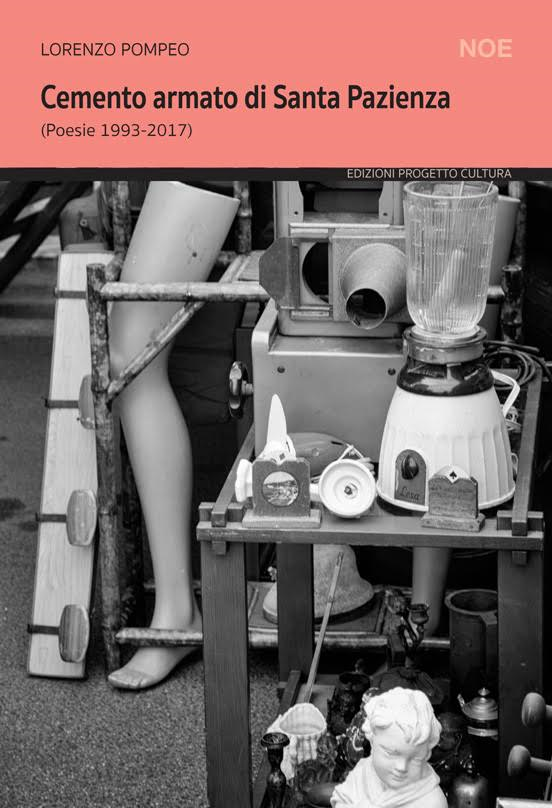
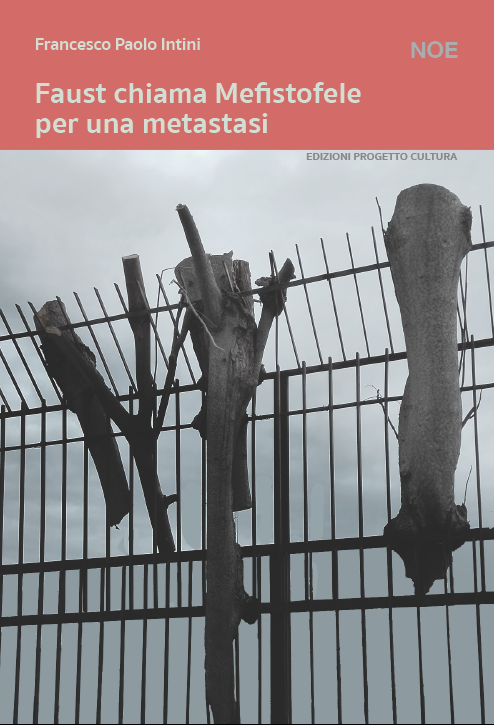

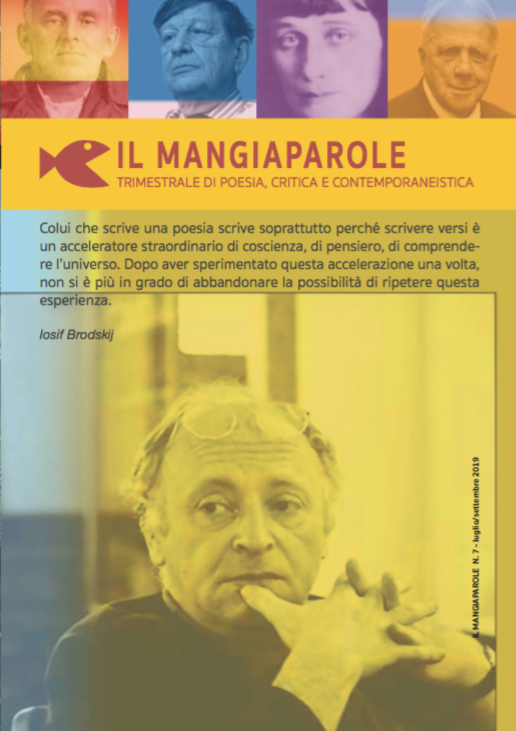




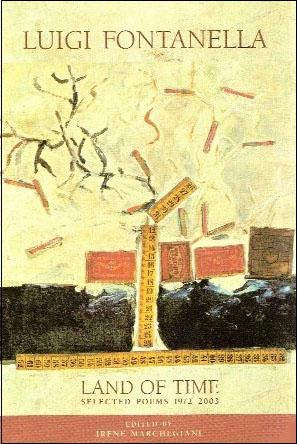








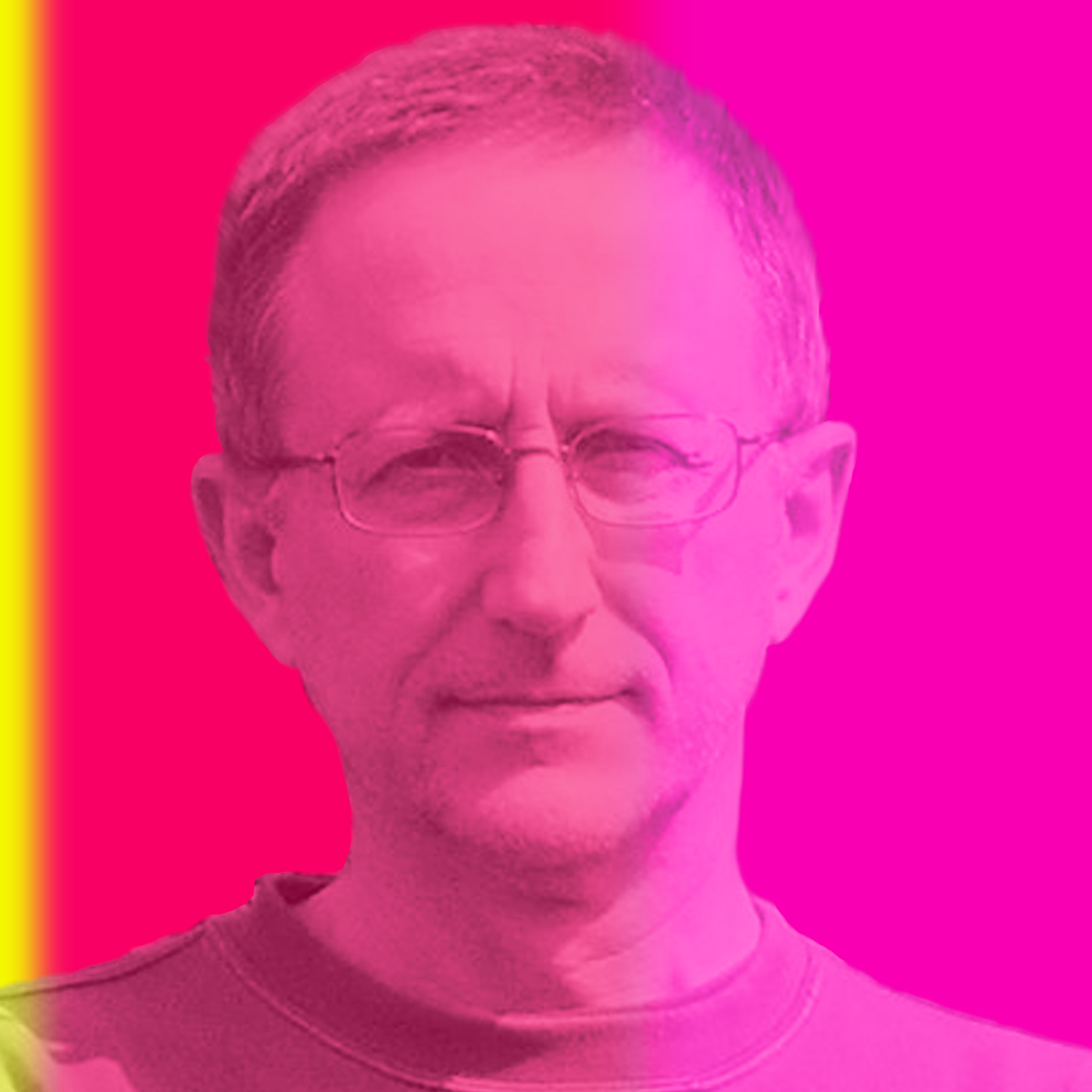







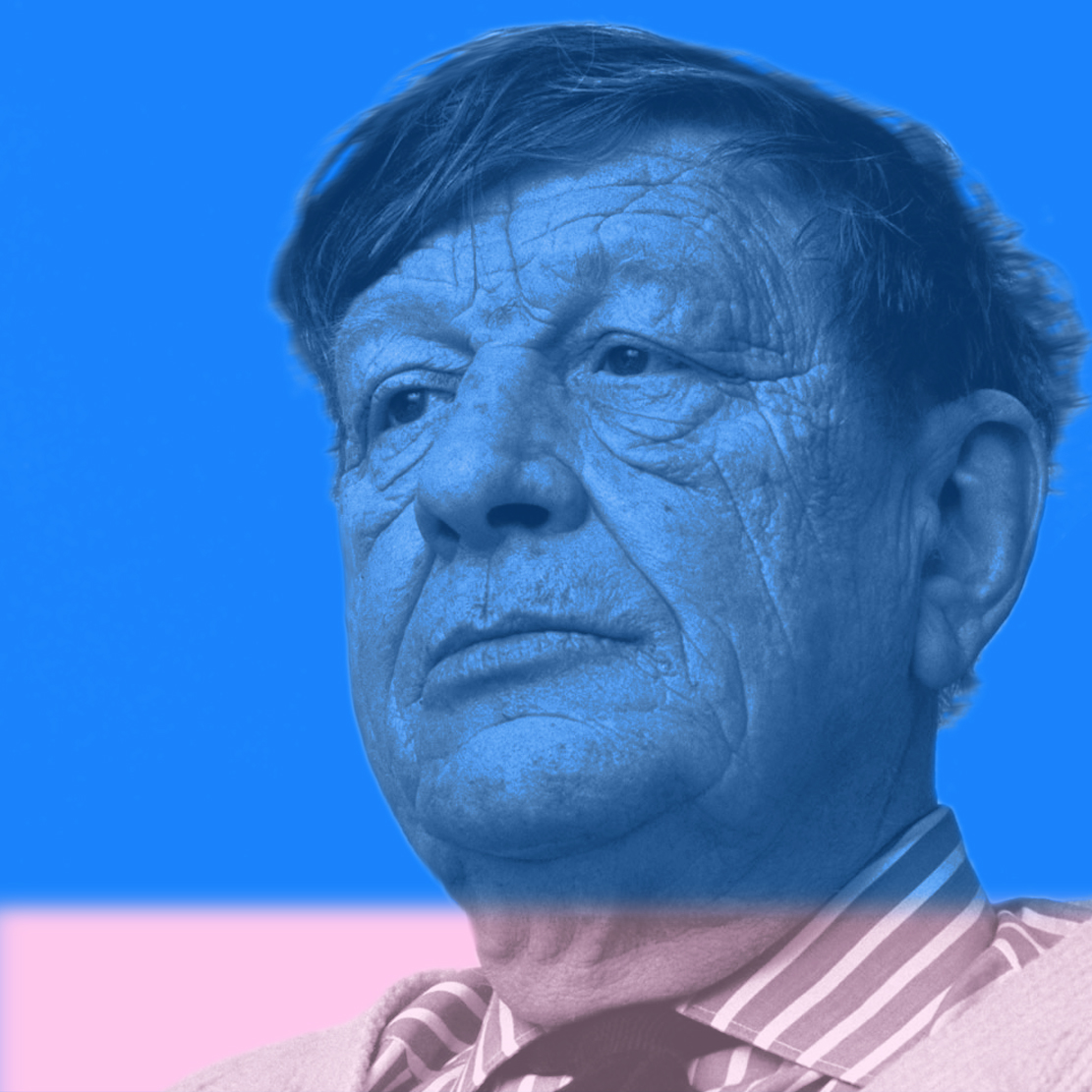



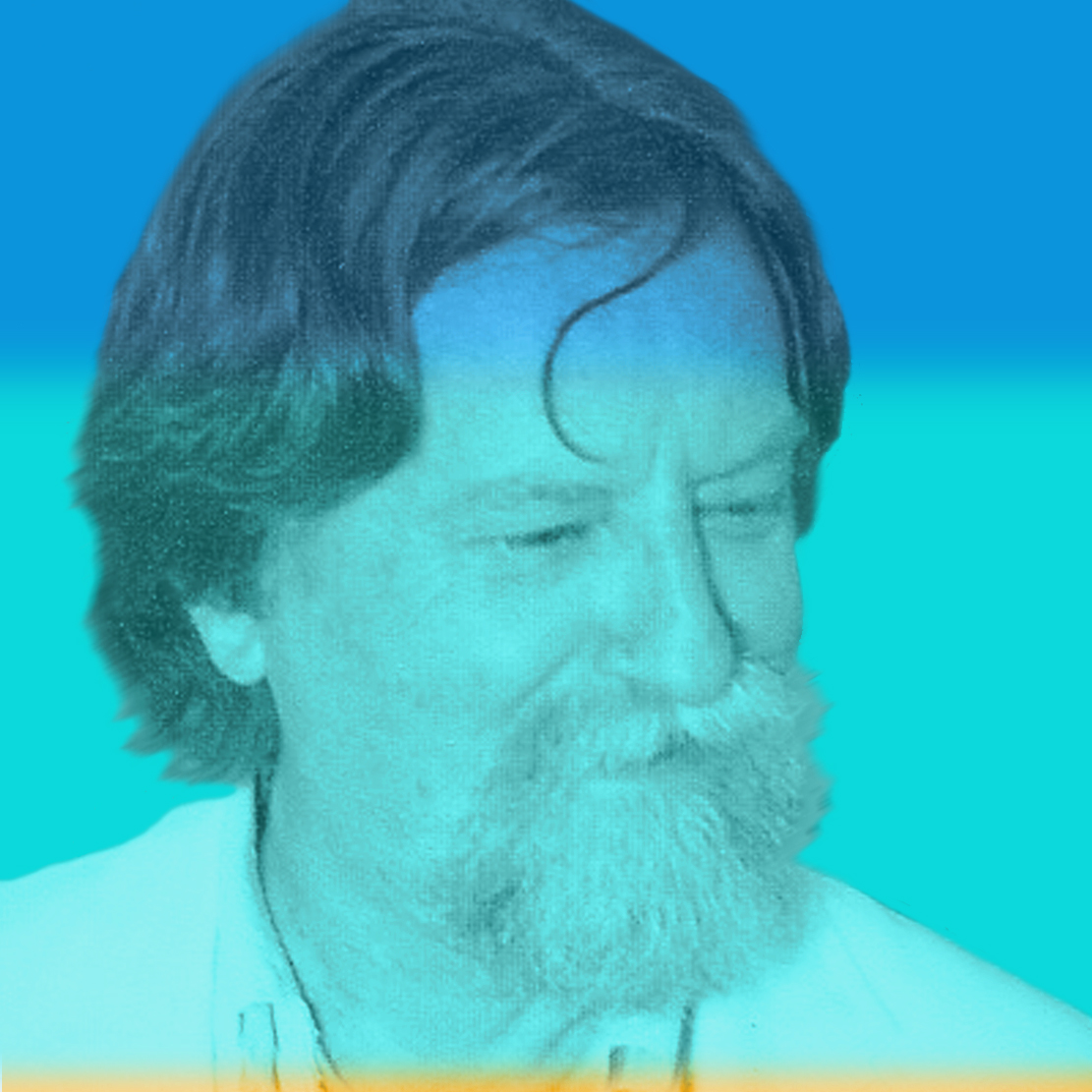
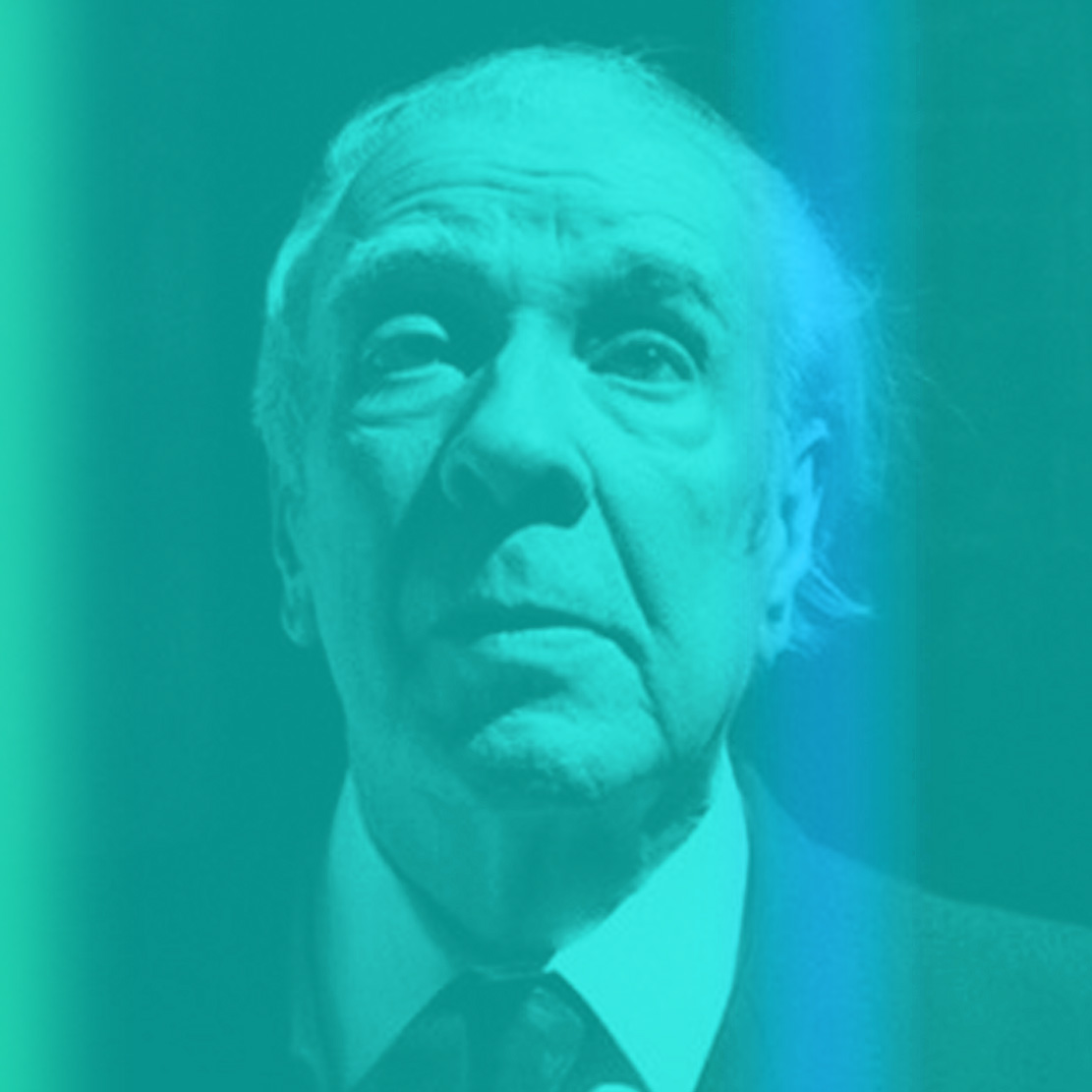




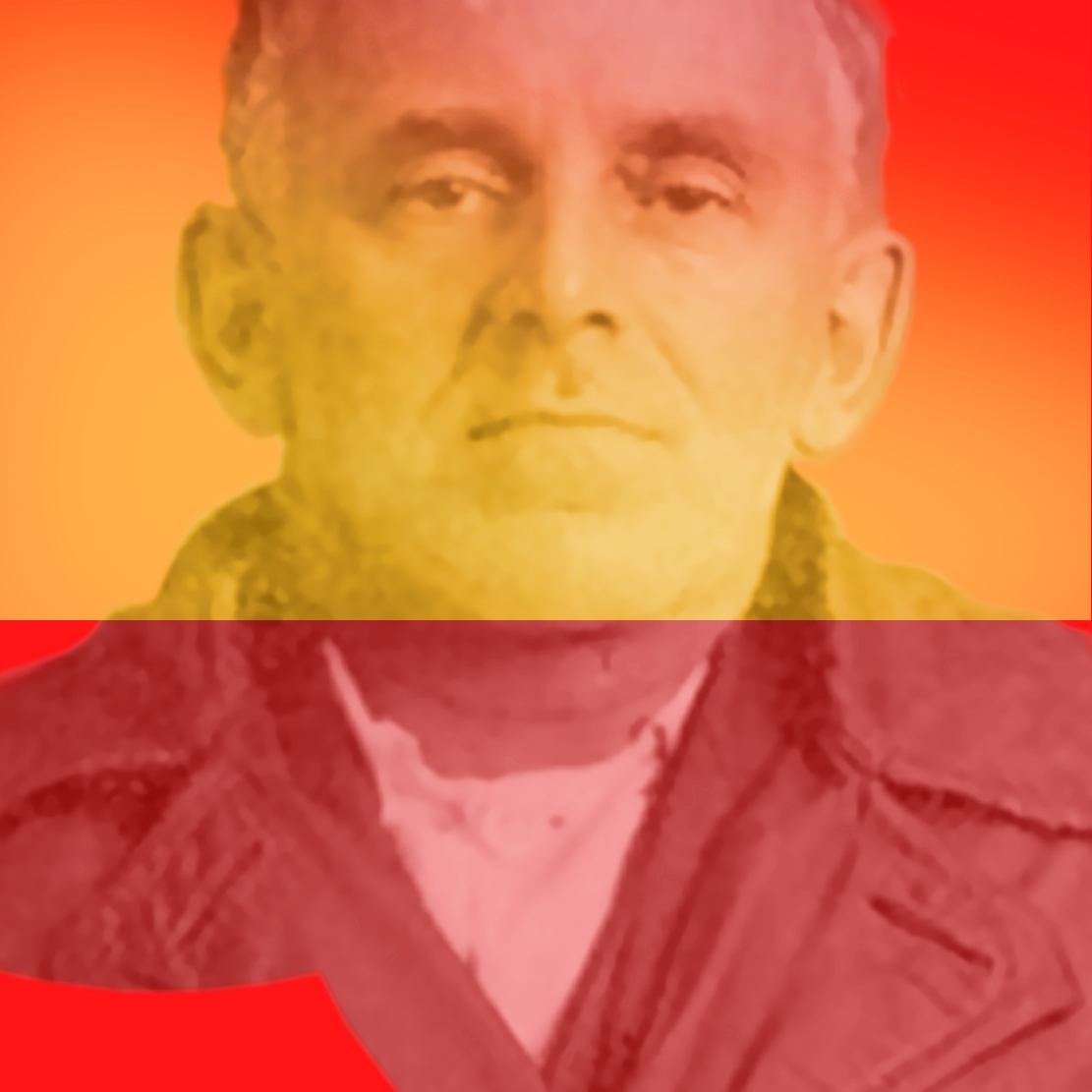






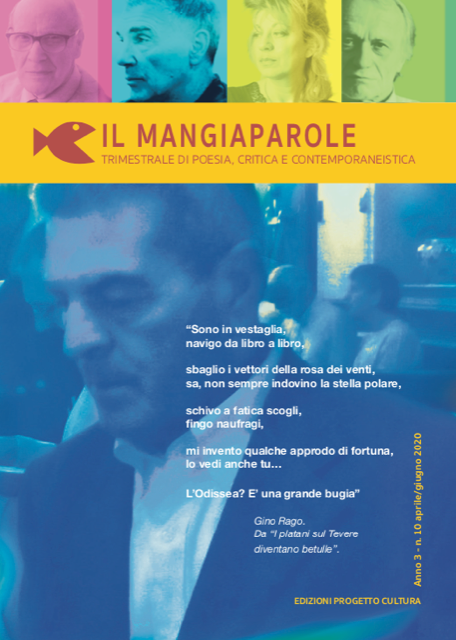




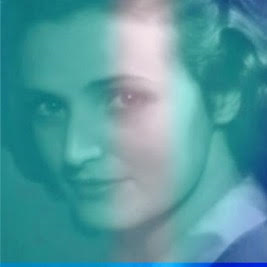
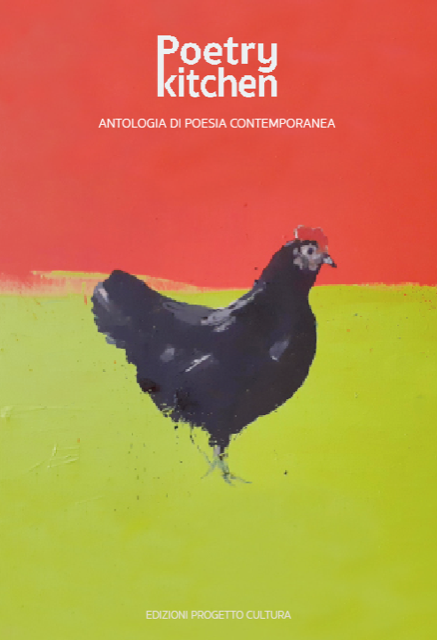



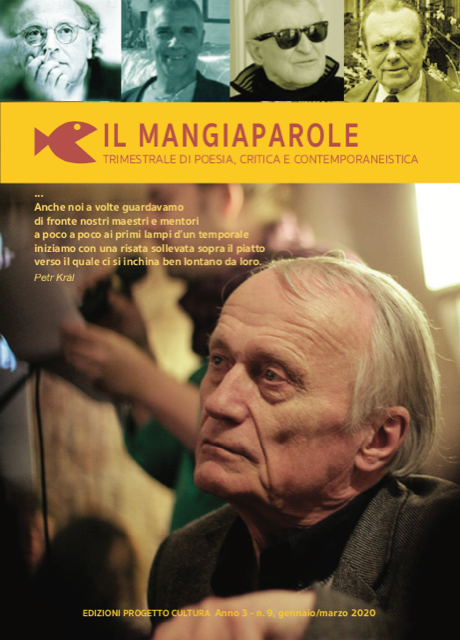











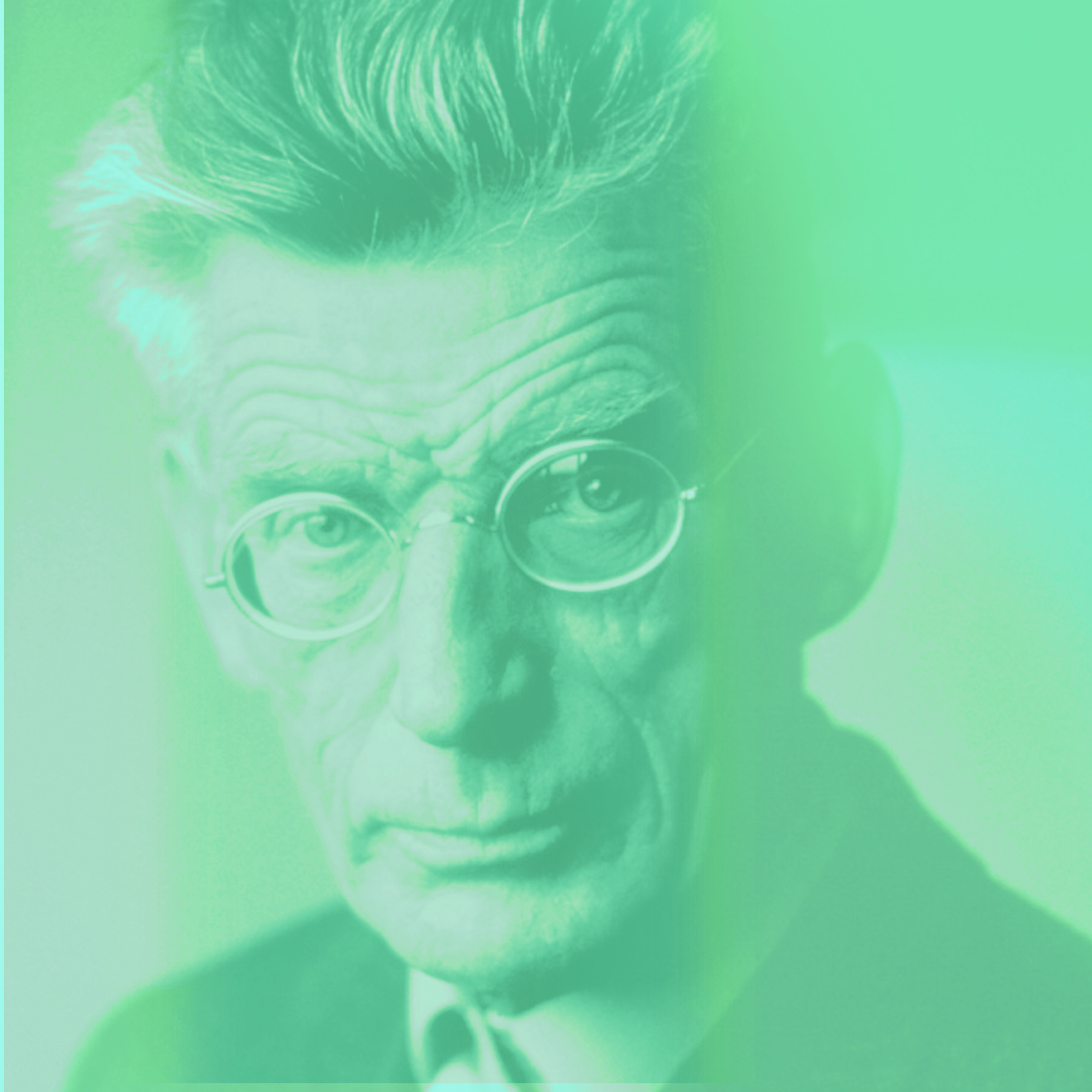
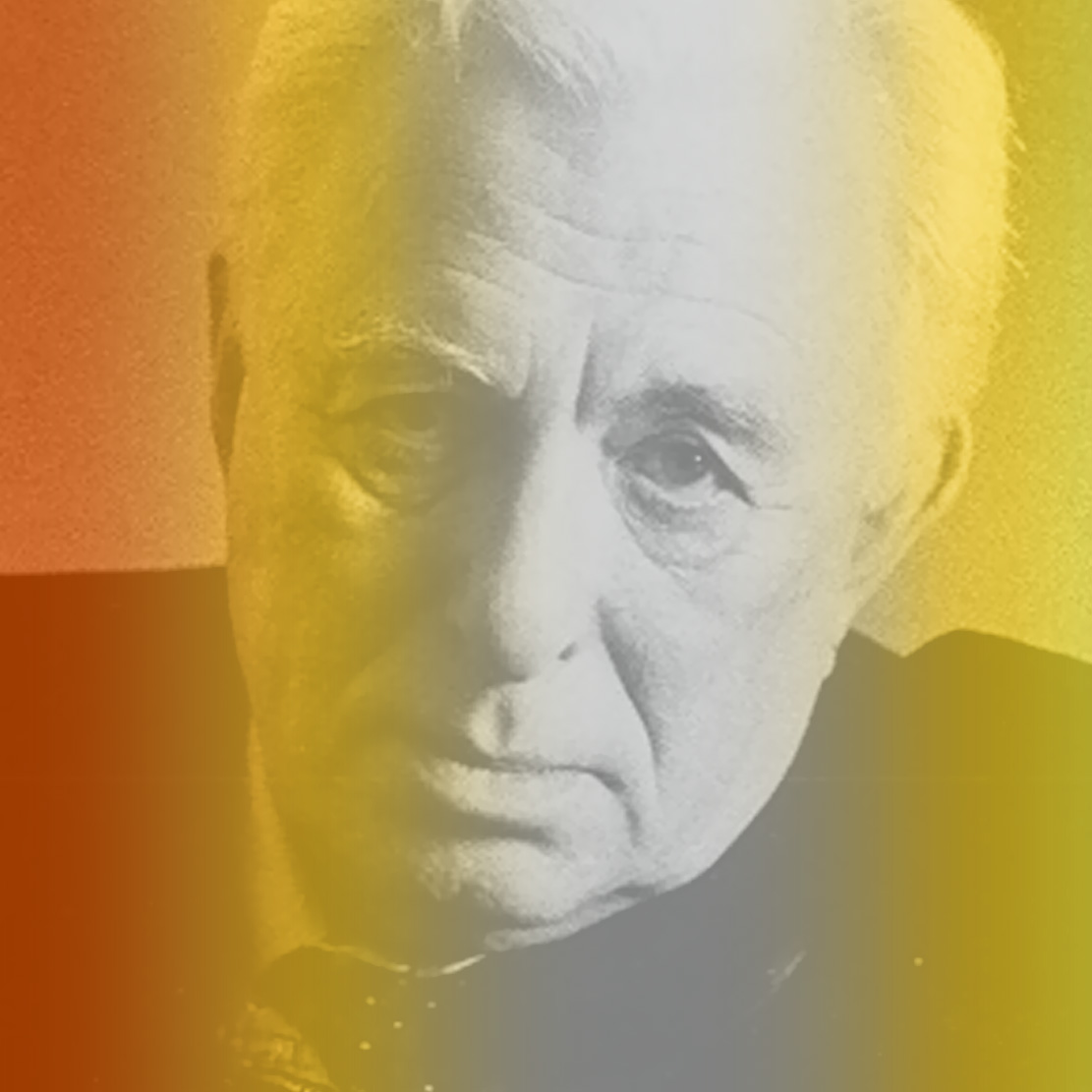









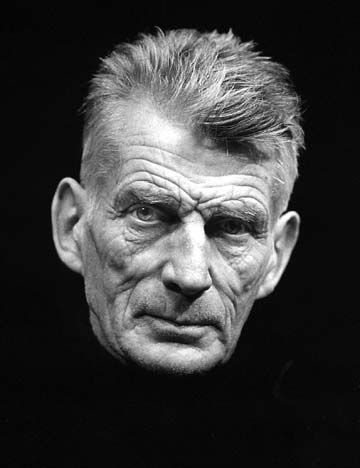


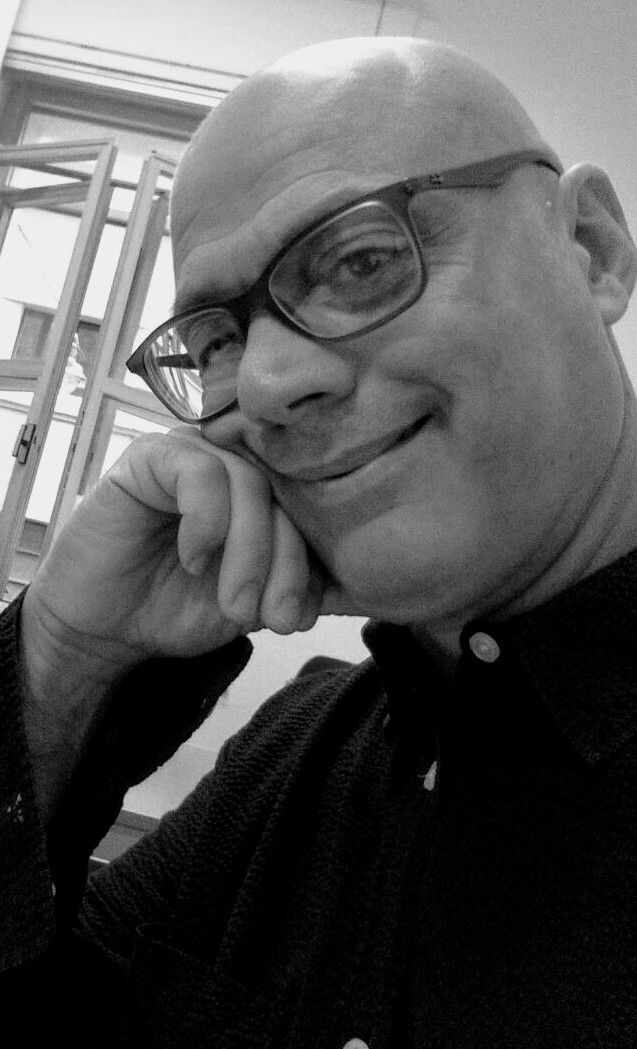
T.S. Eliot formula il concetto poetico di “correlativo oggettivo”nel saggio Hamlet and His Problems :
“[…] un insieme di oggetti, una situazione, una catena di eventi che rappresenta la formula di quella particolare emozione; così che, quando sono dati i fatti esterni che devono culminare in un’esperienza sensoriale, l’emozione è immediatamente evocata.”
La teoria del correlativo oggettivo, come usa il termine Eliot, ha le sue radici in Amleto e i suoi problemi, uno dei saggi più importanti e influenti di T. S. Eliot. Fu pubblicato per la prima volta nel 1919. In Amleto e i suoi problemi, Eliot afferma audacemente che l’opera teatrale di Shakespeare Amleto, lungi dall’essere un trionfo, è un fallimento artistico. Come mai? Eliot è provocatorio con una tale affermazione, ma fornisce alcune ragioni per questa posizione.
Eliot sostiene che l’opera di Shakespeare è un “fallimento”, ma l’opera è diventata così familiare e onnipresente come opera d’arte che non siamo più in grado di vederne i difetti. Questa audace affermazione revisionista è fondata su diversi punti, non ultimo il fatto che Shakespeare ereditò il testo teatrale originale di Amleto da un altro scrittore (probabilmente Thomas Kyd, che scrisse anche The Spanish Tragedy).
Questa prima commedia conteneva molti degli ingredienti che appaiono nella successiva riscrittura di Shakespeare della storia di Amleto, ma è un esempio più crudo della tragedia della vendetta. Shakespeare ha riscritto questo materiale originale piuttosto grezzo e pronto e lo ha aggiornato per un pubblico teatrale successivo e più raffinato. Ok, sono passati solo dieci anni, ma il dramma poetico inglese ha fatto molta strada dai tempi in cui Kyd dominava la scena teatrale londinese. Prima Christopher Marlowe con opere come Il dottor Faustus e L’ebreo di Malta, e poi Shakespeare con le sue numerose prime opere, avevano rapidamente trasformato il teatro elisabettiano in un luogo in cui il linguaggio poetico poteva fiorire e raggiungere nuove vette.
Secondo Eliot, c’è un grosso problema quando si tratta di Amleto. I doni di Shakespeare superano la trama di vendetta piuttosto cruda che costituisce la base della precedente commedia di Amleto. L’Amleto di Kyd (se assumiamo che Kyd abbia scritto l’originale) era probabilmente una figura primitiva e psicologicamente poco interessante. Diciamo “probabilmente” perché nessuno lo sa per certo: la commedia originale di Amleto non è sopravvissuta. Ma sappiamo dal confronto di alcune altre opere di quel periodo prima di Marlowe, comprese altre opere di Kyd (come The Spanish Tragedy), che l’Ur-Hamlet era probabilmente uno studio meno raffinato di psicologia, mascolinità e vendetta rispetto alla versione di Shakespeare.
Questo non significa che la versione di Shakespeare sia un successo artistico: non per Eliot, comunque. Eliot sostiene che la resa di Shakespeare del personaggio di Amleto è troppo “grande” per la trama dell’opera e il “materiale intrattabile” con cui Shakespeare è costretto a lavorare. È come se un maestro analista della mente umana, come Dostoevskij, cercasse di riscrivere la storia di Pinocchio come un dramma psicologicamente complesso.
Lungi dall’essere un capolavoro letterario, la rielaborazione di Shakespeare della storia dell’Amleto fallisce, secondo Eliot, perché Shakespeare ha tentato di fare troppo con il personaggio e, di conseguenza, le emozioni di Amleto nell’opera sembrano poco chiare. Ha perso il controllo del suo materiale originale e la sua ambizione e la sua portata hanno superato i confini piuttosto ristretti del complotto di vendetta. C’è un abisso tra l’emozione provata da un personaggio come Amleto della cronaca medievale e il modo in cui questa viene trasformata in dramma nell’opera di Shakespeare.
"Mi piace""Mi piace"
Se c’è qualcuno che ha voglia di seguire il dibattito sulla poesia, veda come un critico onesto e intelligente, Alfonso Berardinelli, dice delle cose che mettono il Re a nudo. Però dovete avere la pazienza di arrivare fino alla fine.
"Mi piace""Mi piace"
… in fin dei conti la scrittura poetica è sempre una riscrittura di un’altra scrittura che la precede, non c’è nulla di strano in ciò, nulla si inventa dal nulla, mi dispiace dirlo, di solito sono i poeti di seconda e terza fascia che pensano di scrivere dal nulla.
Eliot è il più grande poeta del ‘900, davanti alla sua poesia è bene sostare in riflessione. Con il correlativo oggettivo la poesia che seguirà è mutata di 360°, la nuova poesia ha qui un banco di prova difficilissimo: deve misurarsi con la poesia di Eliot e con il correlativo oggettivo per reinventarlo nelle nuove condizioni del mondo di oggi.
Ha ragione Vincenzo Petronelli a dire che Charles Simic è un poeta utilissimo, ha reinventato la poesia americana che languiva (e langue) in una miriade di bravi professori, meticolosamente intelligenti, professionisti della poesia, che sono poi i peggiori nemici della «poesia». Dunque: reinventare un nuovo modello di correlativo oggettivo. Tutto qui. Semplice.
In fin dei conti che cos’è la poesia? Risponde Simic:
Una poesia è come una rapina in banca. l’idea è di entrare – attirare l’attenzione – prendere i soldi e scappare …
Essere poeti significa essere dei rapinatori, entrare in banca a mano armata e fare una rapina. Siete (siamo) capaci? se sì, siete (siamo) dei poeti.
"Mi piace""Mi piace"
Ringrazio Marie Laure per avermi citato nel suo intervento, che ho appena ripescato in questo lavoro di recupero degli articoli dei giorni scorsi che sto conducendo in questi giorni (in fondo anche questo è un lavoro di compostaggio, vero Mauro?)
Aggiungo che condivido pienamente l’idea che il vero lavoro di creazione sia un lavoro di ri-creazione del proprio cosmo ed ovviamente l’artista, l’intellettuale vero, si presuppone abbia raccolto diversi stimoli, impulsi, dalla propria ricerca consapevole, mediante letture, visioni, confronti e quant’altro; è evidente perciò, che per un intelletto vivo, come dovrebbe essere il vero poeta, la riproduzione del proprio universo non possa limitarsi ad una riproduzione meramente “fisica”, ma debba necessariamente rifarsi ai vari riferimenti ai punti luminosi raccolti nel suo percorso, poiché se così non fosse si presupporebbe un retroterra intellettivo sostanzialmente vuoto, informe.
Ovviamente sarebbe impostulabile che la personalità di un poeta possa corrispondere a tale ritratto, ma in reatà è esattamente uno dei grandi equivoci che circondano la pletorica produzione poetica odierna; il che susciterebbe uno spontaneo moto di riso e nulla di più, non fosse per l’inquinamento che questa poesia effusiva e dell’ego, ha ormai prodotti del panorama della produzione editoriale.
Mi consola pensare che da qualche parte nel mondo e nel tempo, grazie anche agli spazi digitali, esisteranno sempre ricettacoli di alto livello come l’ “Ombra” e poeti veri, tracce che segnano il percorso umano nel tempo, come può essere lo stesso Simic, o Eliot, o Transtromer, o De Palchi e tutti i grandi che hanno davvero saputo rendere omaggio a questa arte e per suo tramite, all’umanità tutta.
"Mi piace""Mi piace"
caro Vincenzo,
leggo sempre con attenzione le tue riflessioni, convengo con te sulla pochezza della poesia italiana di oggi, in fin dei conti la nuova ontologia estetica è una reinterpretazione in chiave moderna del correlativo oggettivo.
"Mi piace""Mi piace"
Non si PUO’ non essere di accordo con Berardinelli su tutta la linea… peccato che in questa intervista non sia stato più radicale, più estremista nel senso di eliminare dal REGNO della POESIA COME DAL REGNO DI COMO tutti i nomi dei poeti italiani che ha menzionato durante l’intervista – non si tratta tanto di “sostanzialità” come Berardinelli stesso afferma anche con giustezza , quanto di TOTALE ASSENZA DI VISIONE IN QUEI POETI –
CHE FOSSERO STATI I O SONO OTTIMI TRADUTTORI DI POESIA NON SIGINIFICA NULLA, ANZI PEGGIORA IL LORO STATO DI CREDERSI POETI, E INVECE SONO PIU’ TRADUTTORI E PER NULLA POETI.
TRADURRE UNA VISIONE IMPLICA CHE IL TRADUTTORE E IL POETA CHE VIENE TRADOTTO SIANO LA STESSA PERSONA!
PERSONALMENTE NON SO CHE FARMENE DEI VERSI DEI POETI MENZIONATI: NON HANNO “SOSTANZIALITA’ “, MANCANDO TOTALMENTE DI “VISIONARIETA’ !!!
"Mi piace""Mi piace"
tutto molto interessante, Giorgio. E la conclusione di Berardinelli è stata, almeno per me, illuminante
"Mi piace""Mi piace"
Set 40
…
il tritacarne ingurgita
trita e ritrita tutto, poi
chiede a Poetry Kitchen
altra carne da tritare
la risposta latita
…
"Mi piace""Mi piace"
Un dubbio da ingenuo di provincia rispetto al video proposto.
Se quello che conta è la firma, com’è che una firma diventa una firma? Cos’era una firma prima di essere firma? Come ha fatto Armani a diventare Armani? Se man mano le firme muoiono, non resta più nessuna firma.
"Mi piace""Mi piace"
Non possiamo pensare oggi al correlativo oggettivo eliotiano senza tenere nella massima considerazione l’esistenza di una realtà pre/ontoologica con i suoi non-linguaggi. E questo elemento cambia tutto. Nel mondo odierno il soggetto è spaesato perché si trova a dover fronteggiare l’agguato della realtà preontologica, ci troviamo di fronte all’esistenza di una realtà preontologica e, dal momento che la nostra conoscenza rispecchia sempre in qualche modo la realtà ontologica, abbiamo anche a che fare con un protolinguaggio, cioè, con il mormorio, il rumore del Reale, che è sempre ben distinto dal logos pienamente costituito all’interno della struttura simbolica. Il linguaggio pulito e rotondo della poesia di un Sandro Penna oggi sarebbe palesemente kitsch, sarebbe un fuori luogo in quanto oggi i linguaggi sono contaminati e accerchiati dai protolinguaggi della realtà preontologica e dai rumori di fondo dei linguaggi ontologici del mediatico. Tutto ciò cambia radicalmente la posizione tradizionale del correlativo oggettivo.
"Mi piace""Mi piace"
Il soggetto occupa la posizione di «mediatore evanescente», è un vuoto sostanziale che, mediante il processo di soggettivazione, crea la rete Simbolica, nonché la realtà nella quale noi tutti abitiamo. Il soggetto si
costituisce come un ente in se stesso decentrato rispetto al suo àgalma, concetto platonico ripreso da Lacan e tradotto in objet petit a. L’identità primordiale dell’io, quella dello stadio dello specchio, può allora emergere mediante il fantasma dell’identità. L’emergere del fantasma precede l’emersione del Simbolico, entro la quale soltanto può prendere forma e consistenza il fantasma.
Il soggetto, dunque, è un soggetto fantasmatico, che per sopravvivere ha bisogno di produrre una processualità fantasmatica che lo tiene in vita ed assicura la certezza della sua identità.
L’àgalma è l’oggetto nel soggetto, quella parte di Reale che, in quanto indomabile e non soggettivabile rispetto alla rete Simbolica, non è altro che un vuoto, un nulla che rende il soggetto scisso rispetto alla rappresentazione Simbolica che egli se ne dà e rispetto alla maschera identitaria che il soggetto si crea per poter abitare la realtà. Ma tale vuoto conserva in sé la potenza che mette in moto la jouissance, il sentimento di desiderio, per un verso terribile mentre per l’altro attraente, che riporta il soggetto a contatto con quella parte di Reale presente in lui che ritorna come «spettro perturbante». Questo oggetto presente nel soggetto, che è più del soggetto stesso è la sua stessa verità, è quel residuo di Reale rimasto in lui che lo rende resto eccedente rispetto all’ordine Simbolico.
L’ordine Simbolico è nient’altro che la realtà nell’ambito del quale è costituita la vita sociale, è creato da un gesto vuoto di soggettivazione da parte del soggetto; si ha quindi un’iscrizione, parziale, del Reale all’interno del grande Altro. Questo processo è ciò che in Žižek viene identificato come operazione ideologica: è l’ideologia che permette al Simbolico di emergere ed assumere la dimensione onniavvolgente, è l’ideologia che crea un campo di significati e significanti entro i quali si muoverà tutta la realtà sociale. Il soggetto non può mai sortire fuori dall’ideologia, che lo incide profondamente e lo scinde in altro, in altro da sé. Questo processo di scissione perpetua non può essere arrestato da nulla che non sia la riproposizione del soggetto in un altro da sé. Questa processualità è la responsabile dei fenomeni acuti di paranoia e di psicastenia (debolezza psichica caratterizzata da stato ansioso, ipocondria, impulsi ossessivi, idee fisse) che investono le società de-politicizzate dell’Occidente.
Le forme artistiche del mondo di oggi assumono e riflettono al proprio interno le processualità paranoiche e psicasteniche dei linguaggi contemporanei. Dicendo ciò non diciamo nulla di nuovo che non si sappia da tempo.
"Mi piace""Mi piace"
Rumore? Quel che scrive Linguaglossa somiglia al “ruomre futurista” ed è ovvio a chi conosce la materia che è necessario tenere conto del tempo trascorso e son quasi 100 anni! Ma poco è cambiato.
–E a proposito di rumori consiglio la lettura de ” Il rumore del Tempo” di Mandel’stam.
Da due mie note sul futurismo russo: movimento in cui ogni rumore era permesso vedi più sotto.
Ripellino scrive nel Corso su Majakovskij del 1971-72:
“E il pianto e il riso spesso si equivalgono. Il rumorismo majakovskiano ingloba anche l’urlo, e talvolta il poeta dà interi concerti e il mondo è un podio fatto vacillare dal rogo dell’orchestra.”.
—
da mia nota n. 63, p. 37 su questo tema riferisco:
“Per Majakovskij il turbinio sfrenato, senza fine, dei mantelli, diviene simbolo dell’incessante vorticare delle manifestazioni delle moderne città, dove al moto senza requie s’accodano lampi di luci variopinte accompagnati da un rumorismo e da un frastuono esteriore, che poi sono riflessi dei tormenti interiori dell’uomo davanti alla nuova epoca meccanicistica, che tutto oggettivizza, divenendone infine vittima sacrificale”.
…in altra nota n. 67, p. 40 scirvo:
“Vi è di certo dell’umorismo, ma di più un r-umorismo, un baccanìo, un tale frastuono che tutto è trasformato in metallo sonoro: dalla luna immobile a tutti i mezzi in moto! La poesia successiva non è che il trionfo esaltante del rumore fine a se stesso; ma questo rumore universale serve solo a mascherare una solitudine cosmica, quella del poeta che a tutti i costi vuole un pubblico, un applauso, un riconoscimento: ed è quello che chiedeva Majakovskij al suo uditorio, altrimenti si adombrava gravemente e cadeva nell’umore più tetro, già così fin da giovane e molto di più in futuro”.
—
E quello umorismo era umbratile, il soggetto-poeta era “spaesato” a causa di un “nuovo” che gli presentava i conti con “rumori della Realtà” sempre cangianti e impossibilli a dominare.
E d’altra aprte R-UMORISMO E UMORISMO VANNO A BRACCETTO DAI TEMPI DEI POETI LATINI; RICORDO CHE VI ERA UN POETA (NON RICORDO ORA IL NOME) CHE PREFERIVA VIVERE IN CAMPAGNA LONTANO DAI RUMORI DELLA CITTà (ROMA, in questo caso).
"Mi piace""Mi piace"
Ritengo molto interessante il dialogo tra Berardinelli e gli altri e di forte stimolo per riflettere sul rapporto tra firma e opera.
I MILITARI SPARANO DAL KAZAKISTAN
Il virus sconvolge il mare, il governo pettina i capelli
La riga di oggi : un ghiacciaio di qua, l’Africa di là
Il filo di sedano galleggia nelle Sirti
Le bolle non si attengono alla pettinatura
La falla sull’equatore ci porterà a casa
Ma intanto l’ammiraglio ha un buco nella tempia
– Io, dice il capogabbiano – ho scioperato per il bucato andato a male
l’inverno portò neve marcia e cambiò la formula dell’acqua.
L’ordine del giorno?
Il re Kazako ordina di sparare a vista.
I cormorani accumulano sacchi
a difesa delle alici.
Una raffica d’acqua stermina i granchi
Un mucchio di scogli armati galleggia nell’etere.
Forse oggi o domani porteranno a spasso il pianeta
Senza chiedere permessi all’Universo.
(ringrazio Giorgio per gli utili suggerimenti di modifica alla poesia originale)
Francesco Paolo Intini
"Mi piace""Mi piace"
In questa nuova versione, con interventi di labor limae, con intervenenti per sottrazioni sulla precedente versione, la com-posizione di Francesco Paolo Intini brilla di una luce nuova, si irradia in tutta la sua intensità ogni direzione.
Lo stesso Eliot avrebbe avuto almeno 500 versi in più (non proprio necessari alla economia estetica e di stile del suo capolavoro modernista) se non avesse affidato La terra desolata alla revisione dell’homo faber Ezta Pound.
"Mi piace""Mi piace"
La poesia di T. S. Eliot segna il trionfo del discorso poetico su le forme misurate della poesia di tradizione occidentale. Il verso libero, che libera, diventa giornalistico, cronachistico; flusso di parole, interno esterno. Ma nel leggere poesie moderniste sento il ticchettio della macchina da scrivere. Quel rumore non esiste più. Oggi è silenzio digitale. Ciò non toglie che a tratti, il verso che dice o vorrebbe dire, anche inebriato, possa tornare utile alla poesia kitchen, che si fa con scrittura di rinuncia, non consequenziale, priva di tempo lineare; ma soprattutto non finge di avere significato, come invece fa Eliot in The lovesong of J. Alfred Prufrock.
"Mi piace""Mi piace"
Tutti gli elementi di lingua, di temi, di stile del modernismo inglese prebellico e postbellico si ritrovano in questo testo di T. S. Eliot, proposto, a ragion veduta, da Giorgio Linguaglossa, e magistralmente affidato alla Voce di Carmelo Bene.
Con l’onestà intellettuale e l’umiltà dei grandi, Dostoevskij affermò:
«Siamo tutti usciti dal cappotto di Gogol».
Che voleva dire se non che tutta la letteratura sovietica successiva prendeva le mosse dai lembi del cappotto rubato all’impiegatuccio Akakij Akakievič.
Così com’è da ammettere che buona parte della Nuova Ontologia Estetica, fino alle attuali esperienze di poiesis indicate come poetry kitchen, prende le mosse da certi aspetti del modernismo poetico anglosassone, compreso quello di T. S. Eliot.
Propongo, dal libro Storie di una pallottola e della gallina Nanin, (di prossima pubblicazione con le edizioni Progetto Cultura), la Storia di una pallottola
n.8
Gino Rago
n.8
Berlino. Via dei Ciliegi.
Un cappello indossa una giacca a quadretti.
Tre giacche color fumo di Londra si presentano al n. 21
della Circonvallazione Clodia.
Il vicequestore irrompe nell’atelier di Marie Laure Colasson.
Dice:
«Madame, la quarantena non è finita, Lei è senza autocertificazione.
Apra la Sua borsetta. La dichiaro in arresto».
«Voilà…
Perle, un bottone, una cartolina di Derrida, bracciali,
coriandoli,
una pipa di Magritte che non è una pipa,
una boccetta di Chanel n.5
e un revolver a tamburo con il manico di madreperla».
Com’è, come non è
parte una pallottola tracciante.
Esce dal set del film La piscina con Alain Delon e Romy Schneider
ed entra nel commissariato della Garbatella.
Ma poi ci ripensa
e torna indietro verso la sua legittima proprietaria,
rientra nella borsa Birkin di Madame Colasson.
Dei protagonisti presenti e assenti si perdono le tracce.
La variante delta-omicron del Covid-19 saltella
per la Berlinerstrasse.
Entra il commissario Ingravallo con l’impermeabile blu.
Esce Marie Laure Colasson con la collana di perle in tasca.
"Mi piace""Mi piace"
caro Gino,
ricordavo la poesia in una versione precedente, vedo che l’hai ritoccata. A mio avviso va molto meglio così, è più folle, più kitchen. Una nota: dovresti mettere “via delle ciliege” in tedesco perché si trova a Berlino, non credi?
Grazie per averrmi messo in questa poesia!
"Mi piace""Mi piace"
Gino Rago
n.8
Berlino. Kirschbäumestraße.*
Un cappello indossa una giacca a quadretti.
Tre giacche color fumo di Londra si presentano al n. 21
della Circonvallazione Clodia.
Il vicequestore irrompe nell’atelier di Marie Laure Colasson.
Dice:
«Madame, la quarantena non è finita, Lei è senza autocertificazione.
Apra la Sua borsetta. La dichiaro in arresto».
«Voilà…
Perle, un bottone, una cartolina di Derrida, bracciali,
coriandoli,
una pipa di Magritte che non è una pipa,
una boccetta di Chanel n.5
e un revolver a tamburo con il manico di madreperla».
Com’è, come non è
parte una pallottola tracciante.
Esce dal set del film La piscina con Alain Delon e Romy Schneider
ed entra nel commissariato della Garbatella.
Ma poi ci ripensa
e torna indietro verso la sua legittima proprietaria,
rientra nella borsa Birkin di Madame Colasson.
Dei protagonisti presenti e assenti si perdono le tracce.
La variante delta-omicron del Covid-19 saltella
per la Berlinerstraße.
Entra il commissario Ingravallo con l’impermeabile blu.
Esce Marie Laure Colasson con la collana di perle in tasca.
* via dei ciliegi
"Mi piace""Mi piace"
Posto un commento di Marie Laure Colasson che mi ha fatto pervenire via e-mail:
Leggo adesso le pop-poesie di Francesco Intini, Raffaele Ciccarone, Mimmo Pugliese e Gino Rago. Le trovo vive e imprevedibili, frizzanti come uno spumante Brut della cantina Radiguet di Asti. Palazzeschi e Derrida ne sarebbero rimasti incantati… so che in Italia questo genere di poesia non è molto apprezzata, ma va bene così… la nuova poesia sosta preferibilmente negli armadi polverosi, negli sgabuzzini, meglio se in presenza di scope, dischi rotti, libri dismessi, aspirapolveri guasti, cavallini a dondolo, scolapasta e pentolame vario. Soltanto così la poesia potrà sopravvivere, a lato di scatole di fagioli e confezioni di spaghetti scaduti. La pop-poesia si nutre di scatolami e di foto ricordo, di pantaloni dismessi e di camicie verdi e di giacche a quadretti.
(Marie Laure Colasson)
"Mi piace""Mi piace"
Su Youtube c’è (quasi) tutto, compreso Eliot che recita questa poesia
"Mi piace""Mi piace"
Il correlativo oggettivo. Che cos’è? di che cosa si tratta? Ecco, la risposta è semplice. Si tratta della più grande riforma del linguaggio poetico del novecento, un vero e proprio cambio di paradigma. Adesso, a distanza di un secolo dalla pubblicazione di The Waste Land (1922), possiamo ammetterlo con tutta tranquillità
In Italia il più grande interprete del correlativo oggettivo è stato il primo Montale, ma la sua interpretazione è racchiusa nello spazio ristretto della chiave simbolistica. Montale ha messo in naftalina il correlativo oggettivo di Eliot, lo ha messo in un cassetto dell’armadio del simbolismo e lo ha chiuso a chiave. E infatti in Italia non se ne è più parlato. Lo sperimentalismo, lo pseudo orfismo, la poetica degli oggetti, il minimalismo, il post-minimalismo etc. se ne sono disinteressati, lo hanno considerato un attrezzo d’antan, di un’epoca che fu, un francobollo per numismatici.
Per la «nuova poesia» invece lo considero un dispositivo indispensabile, il solo che può consentire l’uscita della poesia dai linguaggi stereotipati della poesia italiana ed europea delle ultime decadi. Un ripensamento del correlativo oggettivo e del surrealismo in funzione di un «nuovo dispositivo» è assolutamente indispensabile, ma tale ripensamento è già in atto nei poeti europei che abbiamo spesso pubblicato sull’Ombra. Dobbiamo fare ancora un passo in avanti, con decisione, procedere speditamente verso il traslato, in direzione di una poiesis che si sia liberata della cellula monastica dell’io panopticon. Come questo obiettivo possa essere raggiunto, nessuno lo sa, nessuno ha la bacchetta magica, ma già prenderne consapevolezza sarebbe un gesto utile.
"Mi piace""Mi piace"
«Serendipico» oltre ad essere un aggettivo si configura come una vera e propria figura retorica.
Ecco cosa dice il dizionario :
1 (neologismo) caratteristica di una cosa, una persona o un evento che venga inaspettatamente trovato mentre se ne cerca un altro di natura diversa o distante;
2 (neologismo) (filosofia) nell’epistemologia: relativo alla serendipità, proprio della serendipità.
"Mi piace""Mi piace"
Parla Massimo Cacciari:
“Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo ci vada lo stesso, perché queste sono le leggi e finchè non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle”. Lo dice Massimo Cacciari parlando al Gazzettino. Il filosofo veneziano, che non ha mai nascosto le sue polemiche sulla politica del Governo sulla pandemia, ieri si è sottoposto alla terza dose di vaccino.
“Non vedo alcun caso! – commenta – ho fatto il vaccino. Sei costretto a farlo, alle leggi si obbedisce. I filosofi obbediscono alle leggi, anche quando le ritengono totalmente folli. Socrate insegna”.
"Mi piace""Mi piace"
Modo elegante per tirarsi fuori. L’istituzione filosofica è salva.
Ora mi aspetto libri scritti con furore.
Comunque sono questi i traghettatori del pensiero filosofico, li riconosci dalla capacità di esporre un pensiero complesso nei 3 minuti concessi dai Tg. Cacciari non c’è riuscito (qui il disappunto?) ma ci riproverà.
Serve Instant philosophy.
"Mi piace""Mi piace"
Cade a proposito la frase, posta in calce a una lettera, e attribuita a quasi tutti: Voltaire, Pascal, Mark Twain, Virginia Wolf.
“Ti ho scritto una lettera lunga perchè non ho avuto tempo di scriverne una corta”
"Mi piace""Mi piace"
Qui ci stanno 2 instant:
Cosa dicono i bicchieri sbattendo nel lavabo, cosa strillano?
La carta del formaggio sta rompendo il cazzo.
*
Sul pianerottolo. Magico settembre.
Scultura.
LMT
"Mi piace""Mi piace"
caro Lucio,
non trascurare il “montaggio” che nella poesia kitchen è essenziale, tu fai forse troppo affidamento all’epifania di un istante, e così ricadi o rischi di ricadere in una poesia dell’impressione retinica.
Io la tua poesia la vedrei così:
Cosa dicono i bicchieri che sbattono nel lavabo, cosa strillano?
La carta del formaggio
Sul pianerottolo. Magico settembre.
Scultura.
"Mi piace""Mi piace"
L’espressione “rompendo il cazzo” andrebbe tenuta fuori dal recinto? A me sembra un’espressione adeguata a “carta del formaggio”… Sono due momenti separati da (vuoto) ma consecutivi. Stesso personaggio. e i due instant sono indipendenti, non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro.
"Mi piace""Mi piace"
"Mi piace""Mi piace"
Grazie, ma preferisco la mia versione. Non adesso almeno.
"Mi piace""Mi piace"
TRAUMI INFANTILI
Di Eliot mi parlava l’enciclopedia Capire (se ricordo bene) prestata da un amico. Versi strani, tutt’altra cosa rispetto al Pascoli della Cavallina storna che portavi colui che non ritorna. Un volume di quella enciclopedia sovrastava la sedia accanto al mio letto, fonte inesauribile su cui posava la curiosità di ragazzino. Mi chiedevo perché ci facessero imparare quelle poesie a memoria e nessuno che nominasse un poeta del genere. Un altro che mi suonava strano era Lorca, che faceva bella mostra tra i libri di mio fratello. Di lui m’incuriosiva il linguaggio surreale e del tutto incomprensibile di Poeta in Nuova York e quello che succedeva all’ombra di Wall Street. C’erano poeti davvero strani in giro per il mondo mentre tra i banchi di scuola ci dovevamo alzare a turno per recitare un verso dell’Aquilone o della Quercia caduta. Una fatica immensa per chi aveva pessima memoria. Penso che da allora sia nata una specie di rifiuto organico nei confronti di questo tipo di poesia, una specie di trauma che non mi ha più lasciato e che mi fa venire l’orticaria o peggio, se qualcuno me ne parla.
Ciao Ombra
"Mi piace""Mi piace"
Caro Intini,
più o meno è successo la stessa cosa a me.
Soltanto che non ho aspettato tanto, e sono stato fortunato, perché amante delle novità fin dall’adolescenza, quando uscivo da scuola, a Lecce, mi fiondavo verso le bancarelle di libri e cercavo in opposizione alla scuola (come sempre del resto fino a l’università e dopo verso qualcosa di simile)… e rovistando libri tra le bancarelle ho scoperto decine e decine di poeti stranieri… p.e. a 17 anni (1963) mi capitò tra le mani “Nuovi poeti sovietici” tradotti da Ripellino, che solo 6 anni più tardi ne divenni suo allievo a Roma.
Ma prima di questa scoperta verso i 14 anni conobbi, in traduzione ovviamente, Rimbaud e il resto e pur non comprendoli bene, restai affascinato… e poi via… e allora via i Carducci, Pascoli e altri similari ma insieme agli stranieri vennero Campana, Villa Ceronetti Zanzotto, ma ancora ebbi da lavorare per buttare via Quasimodo Montale Ungaretti ecc.
ma basta per ora
"Mi piace""Mi piace"
Pingback: Stefanie Golisch – Alessandria today @ Web Media. Pier Carlo Lava