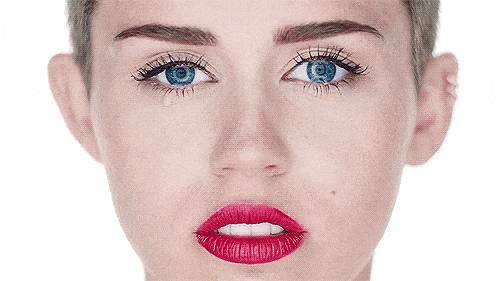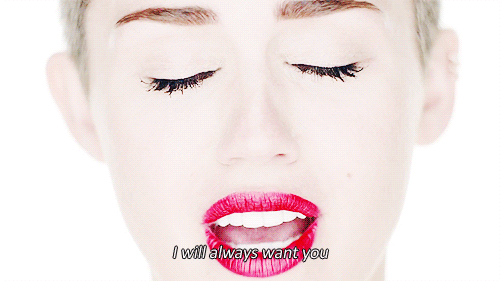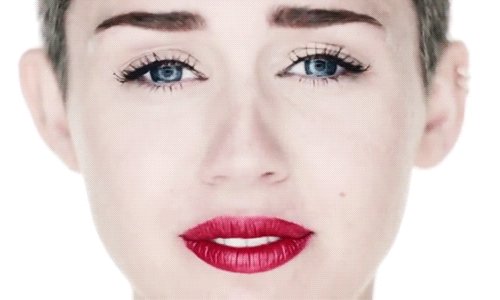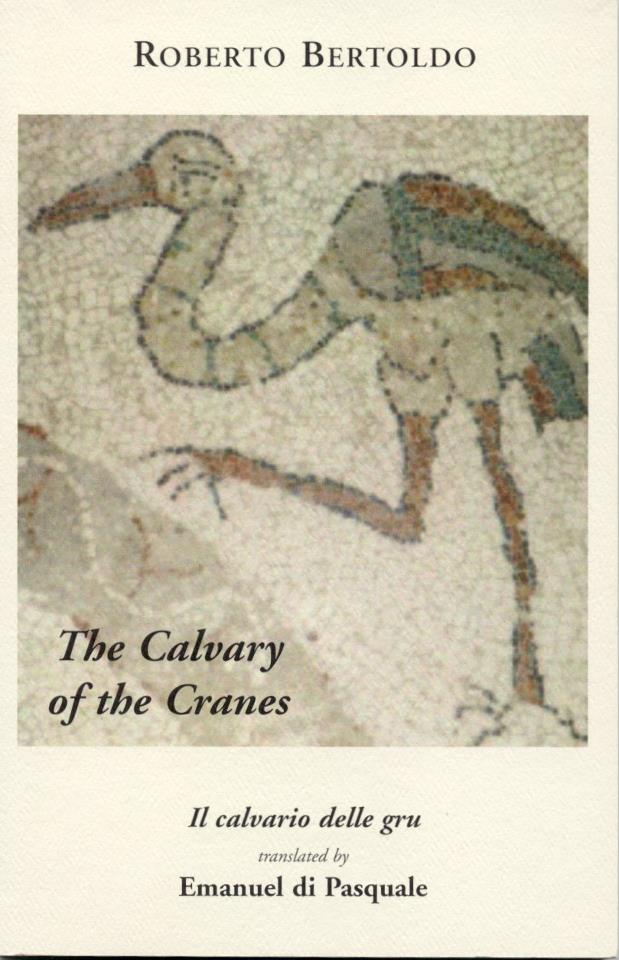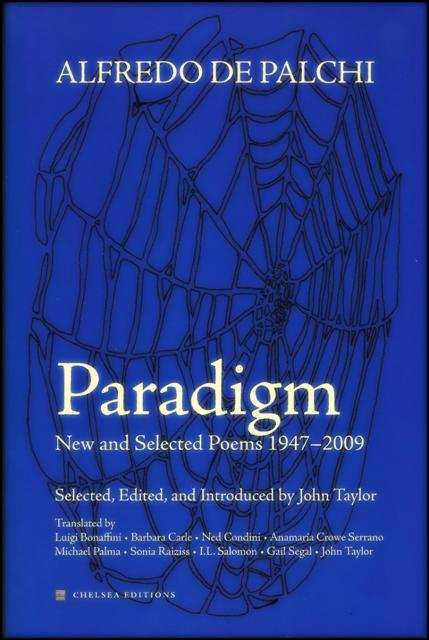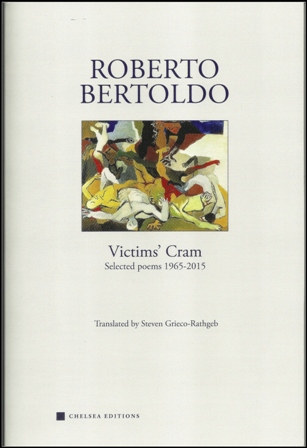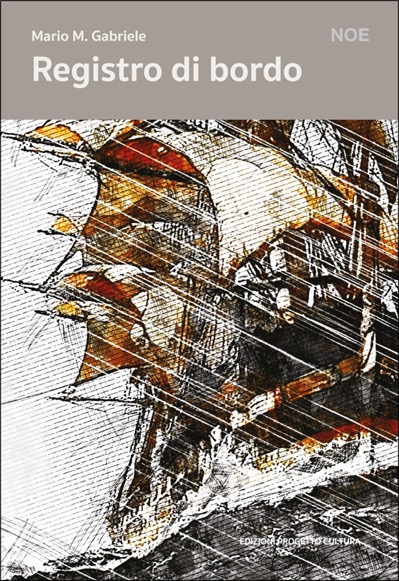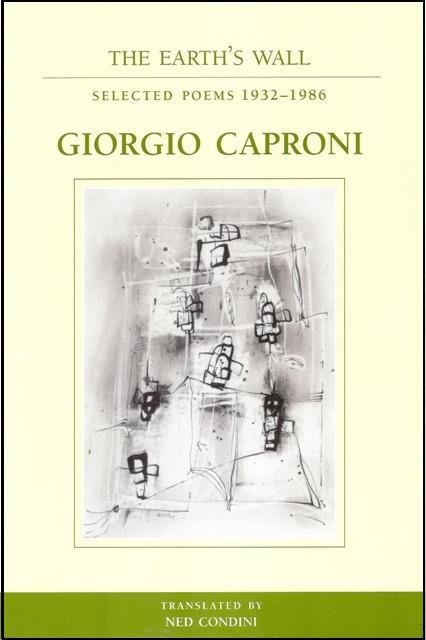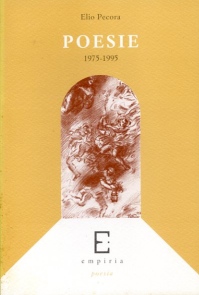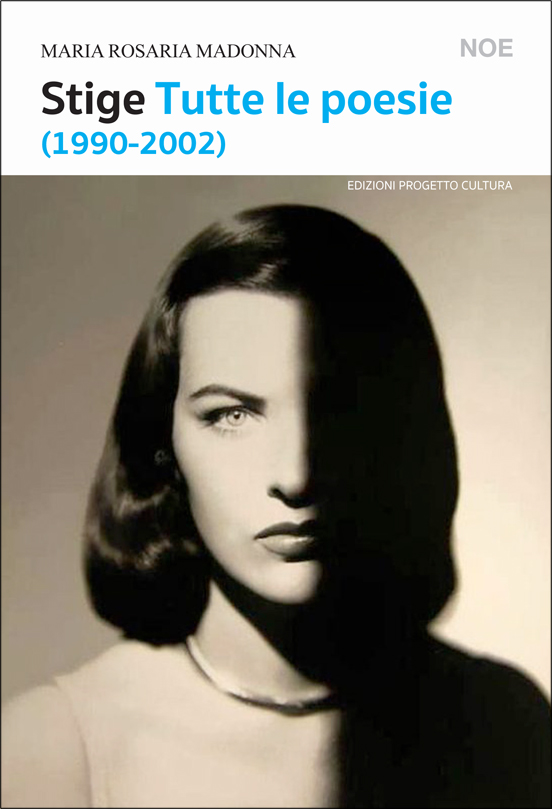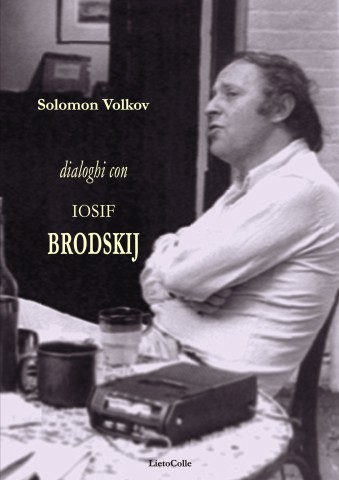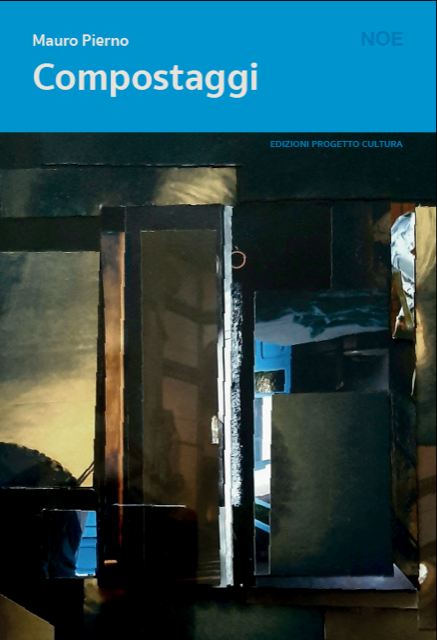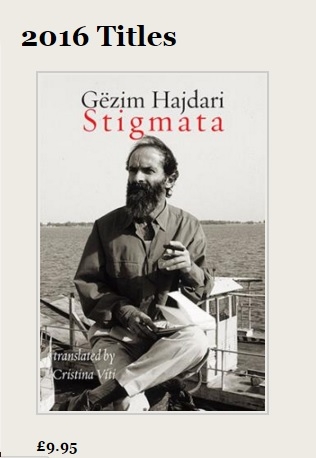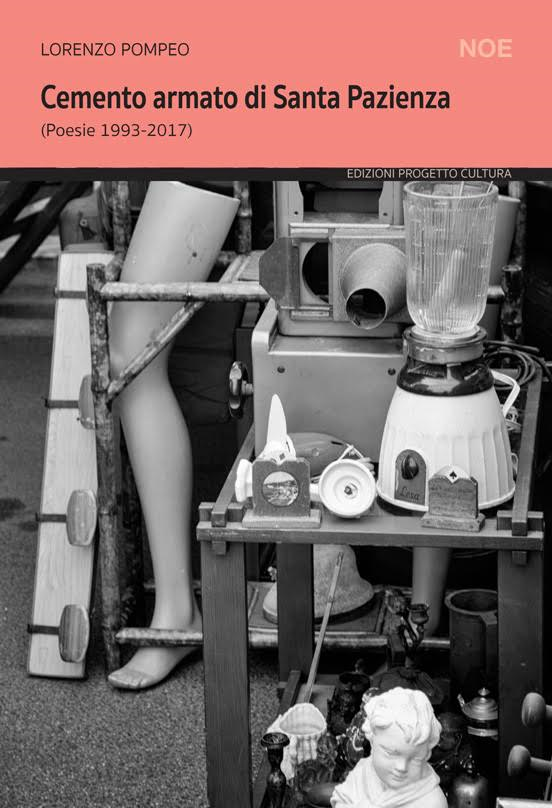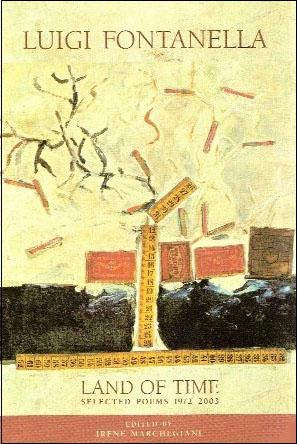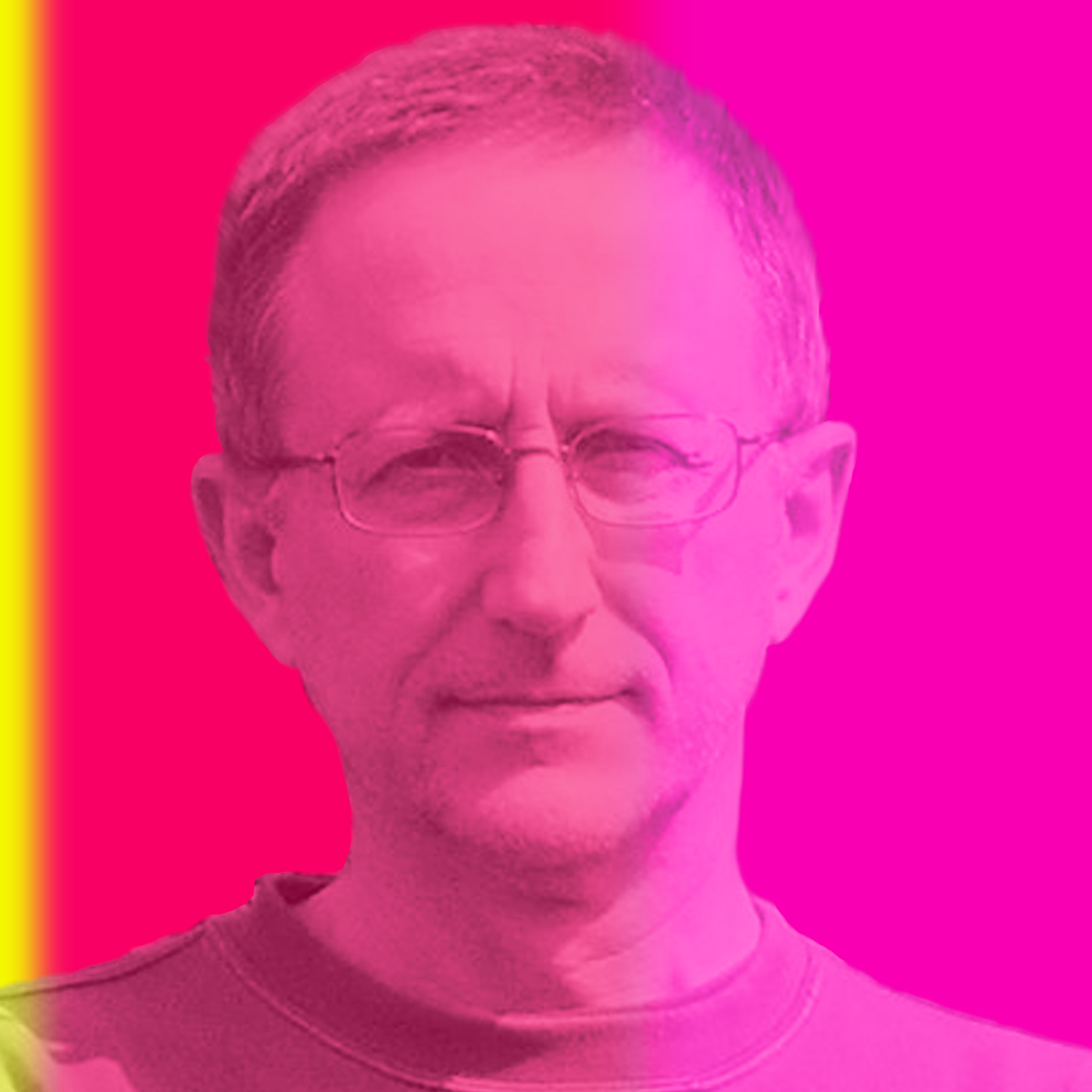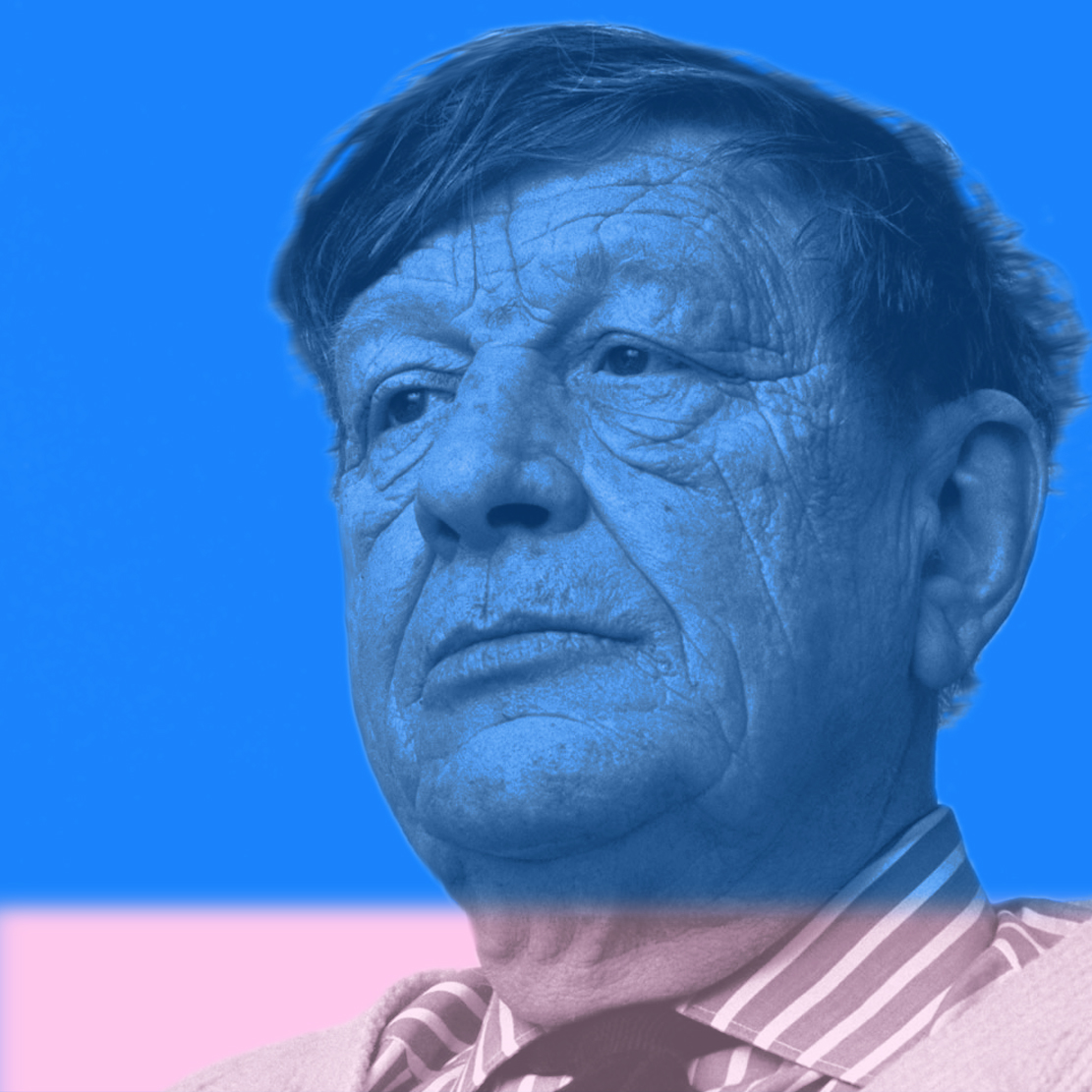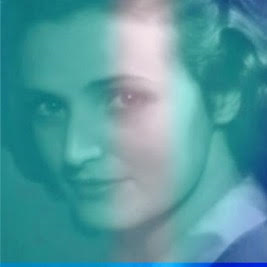Ecco due waka giapponesi:
Oritsureba
sode koso nioe
ume no hana
ari to ya koko ni
uguisu no naku
Ho appena colto un ramo;
così le mie maniche profumano
del fiore di susino
ma ecco che, forse da questa fragranza
ingannato, canta l’usignolo.
[Anonimo, Kokinshū I-32. Susino giapponese (ume)]
*
Hototogisu
haku o no ue no
unohana no
uki koto are ya
kimi ga kimasanu
Canta un cuculo
sulla vetta di una montagna,
ove sboccia mesto il fiore di deutzia.
Provi, forse, rancore verso di me,
amor mio che non ti degni di visitarmi?
[Owarida no ason hiromimi, Man’yōshū VIII-1501. Deutsia scabra (unohana)]
Il testamento spirituale e stilistico che la poesia giapponese waka e choka ci lascia è di grande importanza anche per la poesia che si fa oggi; innanzitutto, direi, riabilitare l’immagine, ripristinare le figure di uccelli, di alberi, nominare le montagne, i fiori… lasciare da parte il consunto e corrivo “io” che tanto abbonda nella poesia del minimalismo. L’«io», rapportato alla vastità dell’universo, non ha alcuna importanza, e inoltre è muto, non può parlare di altro che dei suol mal di schiena e del suo mal di denti (che mi affliggono da un po’). Ma tutto ciò è realmente importante in poesia? È veramente indispensabile?
VERSO UNA NUOVA ONTOLOGIA ESTETICA
Vorrei riprendere da quanto dice Carlo Sini in una recente intervista sul problema dei segni e delle immagini:
“Si può ipotizzare che diecimila anni fa sulla terra esistesse una sorta di «linguaggio universale», che i nostri antenati utilizzassero «un sistema di espressione comune, fatto della convergenza di gesto, suono, visione, esercitati e vissuti come un atto globale». La differenziazione culturale, la torre di Babele nella quale viviamo sarebbe un’acquisizione successiva.
Analogamente, la sintassi dell’arte preistorica potrebbe aver generato la nostra attuale forma di scrittura. «La configurazione delle nostre lettere alfabetiche non è affatto arbitraria o convenzionale. Ogni lettera è invece un disegno decaduto o stilizzato la cui origine va rintracciata proprio nelle figure e nei segni del paleolitico e del neolitico».
Rispetto al passato, dunque, c’è qualcosa che abbiamo perduto. L’unità di scrittura, figura e azione. Le parole si sono separate dalla loro figura, si sono «s-figurate», diventando astratte e autonome. La figura si è svuotata della presenza originaria che l’abitava, il mondo della vita. Come Euridice, essa può essere richiamata in essere, ma il canto capace di risvegliarla è lo stesso che la uccide: quando la figura si consegna al sapere, resta inchiodata a un apparire determinato e oggettivo e, in un certo senso, smette di vivere, di transitare. Il gioco dei segni si mantiene solo nel rimando continuo, molteplice e indefinito, di qualcosa a qualcos’altro.
Le dinamiche percettive sono complesse e intrecciate; per scoprire cosa significa davvero «sentire», dovremmo considerare la possibilità di «ascoltare con gli occhi e vedere con le orecchie». L’esperienza non è mai univoca. Anche del lattante di poche settimane o di pochi mesi, non si può dire che sia una «tabula rasa», un «foglio bianco» unidimensionale, puramente ricettivo: egli «è già un mondo complesso di emozioni, di immaginazioni e di pensieri, ancorché non verbali». Secondo gli studi di Daniel Stern sulla prima infanzia e sullo sviluppo psichico infantile, la formazione del Sé emerge molto prima dell’avvento del linguaggio. Da sempre siamo circondati dai segni e, grazie ai segni, impariamo a comunicare”.
Negli haiku come nei waka c’è ancora il ricordo di quella antica «unità di scrittura, figura e azione» che è andata smarrita. Ora, io ritengo che sia difficile assai per un occidentale del XXI secolo ripristinare artificialmente una scrittura che ripristini quella antichissima unità, ma ritengo invece assai possibile scrivere poesia moderna tenendo presente che la poesia non può essere disgiunta da quella complessa unità di «figura e azione», cioè di immagine e di personaggi “in azione”, perché l’azione è assolutamente necessaria non soltanto nel romanzo (come abbiamo visto nel post odierno dedicato a Milan Kundera), ma anche in poesia (ovviamente in forma diversa). Una «figura» è sempre «azione» (attiva o passiva), e una «azione» è sempre anche «figura». Questa dinamicità è interna sia alla «figura» che alla «azione».
Ho l’impressione (anzi la convinzione) che la poesia italiana si sia allontanata o abbia dimenticato questo assioma e che oggi si scriva poesia copiando la linearità (temporale) della prosa senza tenere conto del problema del dinamismo spazio-temporale di ogni «figura» in movimento.
-
 Steven Grieco Rathgeb
Steven Grieco Rathgeb
11 novembre 2014 alle 14:21 Modifica
Wow! Bellissimo intervento, dettato da una profonda ispirazione a livello critico. “L’unità di scrittura, figura, azione”. Fa bene al cuore sentire cose così. È anche la gioia di capire che molte nostre strade procedono in parallelo.
La fluidità della scrittura, la consapevolezza che non possiamo fermarne il flusso, soltanto afferrarne l’attimo… È quello che si chiama satya in Sanscrito: ciò che è vero, folgorante, in questo preciso attimo, forse non lo sarà ‘attimo dopo. Le foglie sull’albero, quanti milioni di riflessi di luce esprimono in un istante di tempo?
“La figura si è svuotata della presenza originaria che l’abitava, il mondo della vita. Come Euridice, essa può essere richiamata in essere, ma il canto capace di risvegliarla è lo stesso che la uccide: quando la figura si consegna al sapere, resta inchiodata a un apparire determinato e oggettivo e, in un certo senso, smette di vivere, di transitare. Il gioco dei segni si mantiene solo nel rimando continuo, molteplice e indefinito, di qualcosa a qualcos’altro.”
Queste sono parole di alta ispirazione. Sì, dobbiamo capire dove è quel fulcro di significato che abbiamo perso.
Consiglio a tutti di leggere questo commento, e di meditarlo profondamente, perché a me sembra contenere tutte le indicazioni, tutti i suggerimenti essenziali, necessari per riscoprire il vero valore della poesia, e del significato essa può avere nella nostra vita.
Andiamo avanti, anche insieme, per questa strada che ci rivelerà le cose che già si sapevano nel Paleolitico! (basta vedere le pitture rupestri per capire questa semplice verità). E troviamo il modo in cui tutto ciò è vero oggi, nella nostra complessa realtà post-moderna.
Grazie, Giorgio
- Opere di Lucio Mayoor Tosi
- Lucio Mayoor Tosi
11 novembre 2014 alle 11:39 Modifica
Si potrebbe dire che maggiore è il numero delle sillabe e minore si fa la distanza tra poesia giapponese e poesia occidentale. È una domanda.
Ad esempio, e traggo a caso da Montale, da la poesia «I limoni»:
le viuzze che seguono i ciglioni,
discendono tra i ciuffi delle canne
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.
Invece, per quanto attiene agli Haiku, il discorso secondo me è diverso; e fa bene Linguaglossa a dire dell’azione, perché si tratta di un principio basilare della cultura Zen. Possiamo aver letto anche mille haiku, e magari, se non siamo degli specialisti come Steven Grieco Rathgeb, anche quel che ha scritto Alan Watts sullo Zen, ma se non abbiamo esperienza di Koan (o di arti marziali, o dell’arte Ikebana) difficilmente riusciremo ad andare oltre il solo piacere estetico di scriverne. Zen è una sofisticata arte della trasformazione mentale, richiede molta pratica… e poche parole.
-
- Steven Grieco Rathgeb
11 novembre 2014 alle 16:47 Modifica
Sì, ha ragione Lucio Mayoor Tosi. La giovane giapponese in kimono rosa, che compose un ikebana in una stanza del museo orientale Rietberg di Zurigo anni fa, nel 1986, mi fece capire come avrei voluto da allora in poi scrivere una poesia: lasciando che l’energia si sprigionasse dall’interno della poesia, non conferendogliela dall’esterno. È diventato il lavoro di una vita!!
Fra le sue fragilissime mani sembrava che i tre ramoscelli fioriti non dovessero mai entrare in dialogo, continuamente ricadevano giù. Poi d’un tratto il miracolo era compiuto, già si allontanava da noi indietreggiando nel tempo: ma adesso i ramoscelli stavano lì, in piedi, labili e un po’ storti: in un gruppo di tre, ma anche ciascuno per sé: come se fossero arrivati per caso, come se fossero tre anatre iridescenti che un colpo di vento costringe ad atterrare su un fiume, e tu passando di lì, a un tratto – le scorgi sull’acqua.
VERSO UNA NUOVA ONTOLOGIA ESTETICA
Caro Steven Grieco mi rendo conto che parlare di queste cose in Italia sia una aberrazione, come parlare in inglese a dei bororo, ma certe cose dobbiamo dirle. Cito ancora da Carlo Sini:
“Nelle lingue occidentali si è invece imposta la mentalità classificatoria della grammatica (modellata sul nostro alfabeto e sulla nostra conseguente logica e metafisica), con la tendenza a sostanzializzare l’azione e le figure del soggetto e predicato. Vige qui la prevalenza assoluta della frase assertoria o apofantica costruita con la copula “è”, forma peraltro ancora molto rara in Omero. Nella primitiva frase cinese l’agente e l’oggetto sono nomi solo in quanto limitano un’unità d’azione, Nell’ideogramma “contadino pesta riso”, contadino e riso sono i termini che definiscono l’azione del pestare (che a sua volta può significare “uomo”); fuori da questa funzione, contadino e riso sono verbi a loro volta. “Contadino” appare allora come “Colui che coltiva il riso”. “Riso” uguale a un determinato crescere della pianta nell’acqua. Altro esempio: “La tazza brilla” (traduciamo noi). Qui il brillare è reso da un ideogramma che unisce il segno del sole con quello della luna. La scrittura effettiva è da intendersi letteralmente così: “tazza sole-luna”. La potremmo tradurre “il luccichio della tazza”, oppure “la tazza brilla” o ancora “la tazza è lucente”. Come si vede, l’ideogramma “sole-luna” (ming o mei) svolge contemporaneamente e indifferentemente la funzione di un aggettivo (lucente), di un verbo (brilla), di un sostantivo (il luccichio)”.
Vorrei riepilogare così il pensiero di Sini: “dimmi come metti l’aggettivo e ti dirò chi sei”. Voglio dire che dal modo in cui uso quel “brilla”, ne deriva una certa idea di poesia. Fatto sta che c’è stato un tempo in cui quell’aggettivo era una «forma verbale», cioè indicava una «azione» (la rifrazione della luce su di un corpo e il riflesso di quella luce su di un altro corpo).
Ora, in prosa non è più possibile scrivere dando ascolto a questo complesso problematico, ma in poesia sì, è assolutamente necessario fare apparire al di sotto dell’aggettivo la sua vera sostanza verbale. Che cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente che la poesia diventa viva e significativa se noi teniamo presente il valore verbale di azione insito in ogni parola, e che nella costruzione sintattica e semantica poniamo attenzione alla «azione» che costituisce il comune denominatore verbale sia dell’aggettivo che del sostantivo. La costruzione sintattica è analoga allo spazio che viene ad essere deformato dalla presenza della gravità della materia. La costruzione sintattica e semantica non è un in sé dato per definitivo, ma è una forma del pensiero che si adatta alla «gravità della materia verbale».
-
- Giuseppe Talia
- Giuseppe Talia
Gran bel discorso, caro Linguaglossa, condivisibile. Il male di noi poeti occidentali è che “copuliamo” troppo, e copuliamo con noi stessi, ci facciamo tante pippe mentali. E allora Linguaglossa, rileggi Thalìa e trova quante copule vi siano, 3, 4 (funzionali ma non necessarie) su 80 pagine? E nei Fiori di U? 2 copule superflue su circa 200 versi (ho controllato).
Allora, il mio miglior haiku zen? Questo:
Rotola l’estate
si stacca dalla pianta
il fico d’india.
Quello più intrigante? Quest’altro:
Il gatto all’alba
ascolta il concerto
sognando le ugole.
Giuseppe Talia
Lack of memory. Il grande male del nostro nuovo secolo.
Mnemosine, figlia del cielo (Urano ) e della terra (Gea), nella velocità dell’oggi, a chi può essere paragonata? Se dicessi a suo fratello Crono farei una pubblicità occulta a una nota marca di orologi.
E allora, il passato cerchiamo di farlo rivivere nell’immediato. Proviamo a fermarlo, andiamo contro-tempo.
Nei film Hollywoodiani assistiamo a incontri interminabili di scherma e karate, in realtà, come avviene anche da noi in queste discipline sportive, la stoccata e l’atterramento durano pochi secondi. La stessa cosa accade nelle brevissime poesie giapponesi, che sembrano scritte in gara con l’attimo vitale e l’azione che l’accompagna. Bisogna tenete presente che il pensiero si svolge nel tempo, tra passato e futuro, ma non può vivere nell’istante. Di fatto tutti i pensieri sono sogni ( maya, illusione), non così la scrittura mentre accade. Si crea per tanto uno stretto rapporto tra scrittura e accadimento, in modo che possa accadere il Satori (risveglio). Chiunque può farne l’esperienza, anche chi scrive graziosi haiku contando le sillabe.

Giorgio Linguaglossa
“Lo studio delle lingue – ha notato Thom in una relazione tenuta a un importante convegno internazionale su ‘le frontiere del tempo’ organizzato nell’aprile 1980 da Ruggiero Romano – mostra che in quasi ogni lingua – se non in tutte – esiste una classe di parole indispensabili alla costituzione di una frase semanticamente autonoma, quella che nelle nostre lingue indoeuropee si designa con il VERBO. Il verbo ha con la localizzazione temporale una affinità evidente, che spesso si manifesta attraverso una morfologia esplicita (i tempi del verbo); non si può dire altrettanto dello spazio, che sembra avere il solo ruolo – molto implicito – di differenziare gli attanti che intervengono nella sintassi di una frase”. Per questa via Thom ritiene di poter venire alla conclusione che “il tempo abbia una profondità ontologica superiore a quella dello spazio”.
Un opposto scenario ci viene prospettato da quei glottologi che si sono soffermati sugli aspetti linguistici della modellizzazione del tempo. Essi non si limitano a constatare che il principale ostacolo nel cogliere l’enigma della dimensione temporale sta nel fatto che i “percetti” che la compongono “possono essere confrontati fra loro solo memorialmente”: e che pertanto a essere comparate sono “le esperienze portate dal tempo, non la dimensione che lo porta”. Ma ritengono addirittura di poterne concludere che il solo modello “percepibile nella sua interezza”, a cui ricondurre l’ “insieme dei riferimenti temporali”, sarebbe, per l’appunto, “lo spazio” (Giorgio R. Cardona)».2]
2] Marramao Giacomo, Minima temporalia luca sossella editore, 2005 p. 15