 Guido Galdini (Rovato, Brescia, 1953) dopo studi di ingegneria ha lavorato nel campo dell’informatica. Ha pubblicato le raccolte Il disordine delle stanze (PuntoaCapo, 2012) e Gli altri (LietoColle, 2017). Alcuni suoi componimenti sono apparsi in opere collettive degli editori CFR e LietoColle.
Guido Galdini (Rovato, Brescia, 1953) dopo studi di ingegneria ha lavorato nel campo dell’informatica. Ha pubblicato le raccolte Il disordine delle stanze (PuntoaCapo, 2012) e Gli altri (LietoColle, 2017). Alcuni suoi componimenti sono apparsi in opere collettive degli editori CFR e LietoColle.
Commento impolitico di Giorgio Linguaglossa
Il nichilismo non corrisponde al nulla ma all’invariabilità. Non è quindi attestabile.
Il mondo non è una prigione, lo diventa se gli si inventano finestre dietro alle quali si mette il paradiso terrestre. Senza false finestre il mondo non ha limiti.
Il guardare verso e attraverso finestre che non c’erano
ha reso il mondo un locale impolverato di egoismi, colmo di scope fasulle
con proprietà terapeutiche improbabili.
L’uomo deve quindi badare da sé una volta per tutte al proprio mondo.
[…]
Il nullista è un nichilista per il quale solo ciò che è immutabile, ovvero la sostanza della materia, è eterno e che comunque tratta da eterno ciò che sa mutabile, ossia le forme della materia. Il nichilista tout court è privo di questo prometeismo.
(Roberto Bertoldo Nullismo e letteratura, 2011)
Mi scrive Guido Galdini:
«I temi di questa raccolta sono molto lontani da quelli dagli Appunti Precolombiani: nel suo piccolo è il tentativo di dare un’idea dello sgretolamento del mondo contemporaneo a partire da modesti fatti quotidiani. Ho cercato, come autore, di acquisire la massima invisibilità e, nel contempo, di operare con la massima precisione. Non posso permettermi sbavature. Mi sembra di camminare in equilibrio sul filo per non cadere nell’abisso del minimalismo (o forse ci sono dentro da sempre senza rendermene conto e senza riuscire a risollevarmi). Il punto di partenza deve comunque essere concreto: vi sono parecchi riferimenti specifici al paese dove abito, con nomi di luoghi e riscontri immediatamente verificabili.
Lei aveva, molto acutamente, nel commentare gli estratti degli Appunti Precolombiani, fatto riferimento ad una pittura realistica (Delvaux) però prosciugata dallo spaesamento surrealista. Io mi sento affascinato in modo totale dall’informale e dall’astrazione (Afro, Santomaso, Morlotti, Veronesi, Licini), ma il mio pennello ha le setole di Antonio Donghi».
*
In apertura del libro di Guido Galdini c’è una citazione di René Daumal: «La porta dell’invisibile deve essere visibile» e, conseguentemente con questo assunto, l’attenzione dell’autore è incentrata sul «visibile», sugli oggetti del quotidiano, sui personaggi di tutti i giorni; una vita grigia, sbiadita, piccole cose neanche di cattivo gusto: l’ordinario, il routinario, il normale: «i venditori di ombrelli sui marciapiedi», la fornaia, le persone, i piccioni alle finestre, i colombi sul tetto, le vetrine dei negozi, la corriera, il lavandino, i marciapiedi, le automobili, una lucertola cui «si è staccata la coda», il «ponte dell’autostrada», «la cassetta per le lettere», «i portici verso piazza della Repubblica», la «cassiera»; e poi ci sono gli oggetti consueti: l’ombrello, il cellulare, la bicicletta, il televisore, le ciabatte, «le bandierine di plastica… sopra le vie di San Rocco», «i tacchi a spillo», «il gregge di pecore / che stamattina ci ha bloccato sulla circonvallazione», «il furgoncino della raccolta della carta», la «cabina telefonica», il «parcheggio del supermercato», «olio, patate, insaccati e birra… pasta e passato di pomodoro», «due panini, un cartone di latte, qualche pesca, una scatoletta di cibo per gatti», «l’edicola di fronte al castello Quistini», «le tecniche di attraversamento di una rotonda europea / sono una prova che la vita ci impone», «c’è sempre un incidente, sulla strada o al lavoro», «i libri usati», «un segnalibro», «le poesie di Raboni, / farcite di biglietti di cinema, di mostre e di filovie», «scrivono con lo spray / le banali frasi d’amore copiate da qualche foglio», «una zanzara si posa sulle pagine», «il cane che si era perso», «un tailleur grigio con il colletto di velluto», «la felicità dello schermo», «il gratta e vinci», «un batuffolo di cotone», «i riccioli biondo rosa ben curati», «bambini ammucchiati in stazione», «un mappamondo che s’illumina con la spina», «i pendolari di luglio».
salve è il saluto
che salva dall’imbarazzo di scegliere
tra il tu ed il lei, tra la
complicità e la distanza,
rimanendo sospesi
nella stessa indecenza del grigio
Come ho scritto in altre occasioni, il processo di narrativizzazione che ha investito in queste ultime decadi la poesia italiana trova qui una perfetta esemplificazione: fare una poesia della «indecenza del grigio», dei «modesti fatti quotidiani» in cui si sveli lo «sgretolamento del mondo contemporaneo», come scrive l’autore, «sul filo per non cadere nell’abisso del minimalismo» è un progetto che è stato già perseguito nel secondo novecento dalla poesia di adozione milanese e lombarda, Guido Galdini è tra i più bravi in assoluto in questo tipo di poesia, ma mi chiedo se ci sia ancora spazio per uno sviluppo ulteriore in questa direzione; quella narrativizzazione, quel pedale basso, quel lessico «grigio» una volta pigiato a tutto tondo non può essere schiacciato oltre, e i nodi estetici vengono al pettine. Questo stare ossessivamente qui e ora che la poesia dei lombardi si ostina a percorrere, rischia di rivelarsi un vicolo cieco.
Quella narrativizzazione della poesia contemporanea, quella che è stata chiamata da un autorevole critico «la poesia verso la prosa», altro non è che un riflesso della crisi del logos che si vedrà costretto ad accentuare il carattere assertorio, suasorio e minimal del demanio «poetico» con la conseguenza di una sovra determinazione della «comunicazione» del discorso poetico ad inseguire il narrativo.

grafica di Lucio Mayoor Tosi
E allora occorrerà fare un passo indietro: la riflessione di Heidegger (Sein und Zeit è del 1927) sorge in un’epoca, quella tra le due guerre mondiali, che ha vissuto una problematizzazione intensa intorno alla defondamentalizzazione del soggetto. Oggi, in un’epoca di crisi economica e spirituale, mi sembra che i tempi siano maturi affinché vi sia una ripresa della riflessione intorno alle successive tappe della defondamentalizzazione del soggetto (e dell’oggetto). L’esserci del soggetto è il nullo fondamento di un nullificante, avrei qualche dubbio sulla scelta di porre una poesia intorno al «soggetto» perché dovremmo chiederci: quale «soggetto»?, quello che non esiste più da tempo?
Ritengo che la poesia non possa essere esentata dalla investigazione della crisi del «soggetto», che una «nuova ontologia estetica» non può non prendere a parametro del proprio comportamento questa problematica.
Però, però c’è anche un’altra forma di pensiero: il pensiero mitico.
In questa forma di pensiero noi possiamo stare, contemporaneamente, qui e là, nel tempo e fuori del tempo, nello spazio e fuori dello spazio. Il nocciolo della «nuova ontologia estetica» è questo, credo, in consonanza con il pensiero espresso dalla filosofia recente, da Vincenzo Vitiello nelle due domande postate qualche giorno fa e in accordo con il pensiero di Massimo Donà secondo il quale la «libertà» mette a soqquadro il Logos, la «libertà» infrange la «necessità» (Ananke).
Allora, sarà chiaro quanto andiamo dicendo e facendo: che la poesia deve ritornare ad essere MITO; si badi non racconto mitopoietico o applicazione e uso strumentale della mitologia, ma «mito». Innalzare a «mito» il racconto del «reale», un po’ quello che ha fatto Kafka nei suoi romanzi e racconti, quello che ha fatto Mandel’stam nelle sue poesie della maturità, quello che fa la poesia svedese di oggi, ad esempio, tre nomi per tutti: Werner Aspenström, Tomas Traströmer, Kjell Espmark.
È finito un concetto di «reale» – Inizia un nuovo realismo
Il limite della poesia italiana di questi ultimi cinquanta anni è che è restata ingabbiata all’interno di un concetto di «reale linguistico» asfittico, chiuso (vedi l’egemonia di un certo lombardismo stilistico molto affine alla prosa), un concetto di reale che seguiva pedantemente la struttura della sintassi in uso nella narrativa media italiana, un positivismo sintattico che alla fine si è dimostrato una ghigliottina per la poesia italiana, un collo di bottiglia sempre più stretto… Ad un certo punto, i poeti italiani più avvertiti e sensibili si sono accorti che in quella direzione non c’era alcuna via di uscita, e hanno cercato di cambiare strada… La «nuova ontologia estetica» altro non è che la presa di consapevolezza che una direzione e una tradizione di pensiero poetico si erano definitivamente chiuse e non restava altro da fare che cercare qualcosa di diverso…

grafica di Lucio Mayoor Tosi
GLI ALTRI (persone, animali, cose)
quando gli altri siamo invece noi stessi,
e ci accorgiamo di avere indosso la stessa maschera
dal talloncino che penzola sulle spalle,
e dallo stesso finto sorriso
che spunta immobile su tutte le labbra
sotto, resta sempre qualcosa
che non si fida ad essere un volto.
*
attende, con una messa in piega da vedova,
che qualcuno la incontri, ne raccolga il fruscio,
il soprabito è troppo giallo, troppo vuoto il sorriso,
troppo spente le insenature degli occhi
quante volte ha confuso
una coincidenza con un’occasione,
un’occasione con un equivoco,
quante volte ha aspettato che finisse di piovere
per ricominciare a nascondersi tra le pozzanghere.
*
scendi leggero questi sentieri,
e arrivi in tutti i luoghi che si rifugiano
raggiungi anche un orto nascosto tra i rovi
dove sta per pranzare una coppia di anziani,
lui le versa dell’acqua,
lei gli ha appena condito
la più fresca insalata del mondo:
c’è qualcun altro
a cui chiedere l’indirizzo del paradiso?
*
la tristezza delle commesse al lavoro
nel pomeriggio di festa
scivola indifferente dentro gli occhi:
dal loro vuoto
fissano il vuoto della corsia centrale,
lo sguardo dondola sulle vetrine
zeppe dell’allegria che oggi
nessuno vuol regalare
la penombra le assale,
la gioventù le fraintende,
e un altro primo passo hanno compiuto
verso la grandine della rinuncia.
(Guido Galdini)
*
sotto il bersò il pensionato sonnecchia
mentre si perde tra le parole crociate,
i gelsomini gli offrono un’occasione
per scomparire in un angolo di splendore
una vecchia, più in là, scopa l’ingresso dai petali
che l’ingombravano dopo la notte di vento
la mattina di giugno incontri tutti i confini,
il mondo si raggiunge camminando.
*
e alla fine, a settant’anni, ha incominciato
a prendere lezioni di greco antico
insieme con altri anziani, clandestini
in una terra di briciole e paludi
hanno in sé la certezza che sia un modo adeguato
per prepararsi al discorso che dovremo tutti tenere
da entrambe le pareti dello specchio.
*
l’altra notte che era umida e inquieta
mia cugina mi ha telefonato in un sogno,
non ci sarebbe quasi niente di strano,
se non fosse che lei
sono due anni che è morta,
ma mi è mancato, nel sogno, il coraggio di dirglielo.
*
in treno osserva allarmato
i passi del controllore, appena gli si avvicina
si rifugia in un altro scompartimento,
approfitta della carrozza a due piani
per un’inattesa e protetta via di fuga
questa è la vita di chi viaggia senza biglietto,
senza un minuto per guardar fuori il paesaggio,
o passeggiare un poco dentro di sé
appollaiati sul nostro sedile,
lo sbirciamo con disattenzione e fastidio,
diversa la nostra sorte, che abbiamo nel portafoglio
tutti i previsti permessi di viaggio,
compreso quello, gratuito, del disprezzo.
*
li incontri tutti la mattina presto,
arrancano in bicicletta sul ponte dell’autostrada,
pedalano a fatica verso la fatica del giorno
nella salita che soffoca la gola
per loro l’alba verrà così tardi
che non se ne faranno più niente della luce.
*
l’ombrello che è rimasto infilzato
dentro il cestino della spazzatura:
forse non era di protezione adeguata,
forse ha deciso, chi l’ha abbandonato,
che miglior scelta era rinunciare a proteggersi
il televisore, lasciato da solo,
quieto a disfarsi sopra il marciapiede,
dove ora andrà in onda,
senz’altra replica, la sua ultima trasmissione
la bicicletta l’hanno legata ad un palo,
senza ruote né sella, arrugginita e intoccabile,
pronta all’uso di allontanarsi e svanire
il sonno delle cose tralasciate,
immenso e lieve come la polvere sull’autunno.
(Guido Galdini)
*
i pensionati invecchiano, seduti nella noia
sotto i tigli di piazza della verdura
è domenica e aspettano un’altra domenica,
ma finiscono sempre
col farsi intrappolare dai lunedì.
*
a piccoli passi, anziana e cauta,
cammina per i marciapiedi di luglio,
magri i polpacci, abbronzati
da un mare economico di bassa stagione
luglio è il calore della città, la mattina
presto dall’ortolano,
poi tutto il giorno nella penombra della cucina,
con in mano una mela che non ha voglia di sbucciare.
*
sono rimaste le bandierine di plastica,
appese a un filo, sopra le vie di San Rocco;
la festa è finita, ma nessuno
le ha finora avvisate, così loro
continuano a tremare al piccolo vento,
per la piccola felicità
di chi prova a tenere gli occhi alzati da terra.
*
quando chiude un’attività, svuotano la vetrina
e capovolgono, in alto, l’insegna,
che a malapena si può ancora leggere,
come se fosse avvolta da una nuvola di foschia
e il commercio avesse cambiato
il genere di prodotti e di clientela
ad esempio, la Gastronomia Eugenio e Rosy,
all’inizio della salita dell’oratorio,
dopo aver sgomberato la mobilia
e sparsa tutta la segatura sul pavimento,
adesso vende il fantasma dei suoi antipasti
a quegli spettri che non hanno tempo per cucinare.
*
quando, in colonna, all’incrocio per l’autostrada,
una Punto decrepita ha tentato
all’improvviso un taglio di corsia,
e tu le ha fatto spazio, rallentando la fretta,
un braccio nero si è sporto dal finestrino,
e una mano, stringendo l’aria, ti ha ringraziato
hai risposto con un cenno, e per un istante
il traffico ha interrotto la sua ingordigia:
i ponti più coraggiosi non hanno bisogno di parapetti.
*
il furgoncino della raccolta della carta
scodinzola lungo le curve verso Iseo,
perde un foglio di giornale, un petalo rosa
vola via sull’asfalto, stritolato
dalla ferocia delle automobili in coda
gli attuali eroi hanno un breve destino, le loro imprese
sono cantate per l’ebbrezza di un giorno,
restano solo nei cuori spezzati
di chi non si arrende alla disgregazione dell’epica.
*
per la loro festa hanno radunato i disabili
nel parcheggio del supermercato,
i volontari li accompagnano a ricevere un palloncino;
alcuni lo stringono in mano con attenzione,
altri, delusi, se lo sono lasciato scappare
ci sono varie metafore a disposizione di noi autori,
e forse questa non è nemmeno delle più ardite.
*
chiara innocente e ingenua la benzina
disseta il serbatoio della cippatrice,
e ti domandi, mentre la vedi scorrere,
da che abissi d’Arabia, da che gorghi
è risalita fino a questa luce,
e da quali foreste del pliocene
ha ereditato il carbonio,
per scomparire nella tranquillità dell’estate
sbriciolando le ramaglie della siepe.
*
sfida la figlia che sta sbocciando:
più attillati i calzoni, più spietate le ciglia,
più indiscreta l’abbronzatura del volto
ma lo sguardo si approssima troppo in fretta,
malgrado l’indulgenza dei cosmetici,
a una foglia che novembre ha deciso
di non dare il permesso agli altri mesi di cogliere.
hanno trovato il cane che si era perso
nella campagna dalle parti del cimitero,
lo tengono legato
a un guinzaglio di corde di tapparella;
ora aspettano l’arrivo del padrone,
e intanto provano a farselo un po’ amico
è soltanto da azioni come questa,
contate a minuzie, a miriadi, a infinità,
che alla fine di tutte le rincorse
forse anche il mondo potrà essere salvato.
*
strofina con pazienza il gratta e vinci
che le regala una nuova attesa da sorseggiare,
poi lo sminuzza, sollevata
d’aver sepolto questa minima delusione
la speranza non si lascia sconfiggere
senza una cerimonia che ne lusinghi la cecità.
*
con l’altra mano tengono premuto
contro il braccio un batuffolo di cotone,
escono dal cancello di via Màcina
con lo sguardo circospetto e impaurito
hanno appena confessato ad un ago
le più estreme verità su se stessi.
*
le strade del mio paese hanno l’abitudine
di riservare varie accoglienze a chi le percorre;
lungo la polvere dei marciapiedi
spesso incontro due tranquilli alienati,
il primo con lo sguardo vuoto davanti a sé
e un’eterna sigaretta che penzola dalle labbra,
l’altro altissimo, scheletrico e curvo,
che pare sempre stia quasi per correre
e mentre i giorni provano a farsi tenebra
loro proseguono ad evitare ogni direzione:
non hanno alcuna fretta di arrivare,
la loro meta è il cammino,
solo per loro la strada
rinuncia a mettere ostacoli, false occasioni, voragini.
*
bianca come il grembiule, sfiorita e spenta,
la fornaia, di spalle alla vetrina,
guarda i cassetti vuoti, gli ultimi filoncini
persi in mezzo alle briciole, le frittelle rimaste
pronte per l’allegria di qualche ritardatario
fuori è già quasi sera, ha appena smesso di nevicare,
le strade sono dovute venire a patti con il fango,
e i pochi lampioni accesi non hanno niente da illuminare.
*
la zucchina, sul tavolo, sta aspettando
d’essere sminuzzata a cubetti
per invadere la pentola del soffritto;
provi ad usare il marchingegno miracoloso
che hai comprato a una fiera, anni fa,
ma smette subito di funzionare,
forse non ha mai funzionato
dopo le capriole dell’imbonitore
cerchi di mascherare la delusione
ma non si lascia restringere tanto in fretta:
ampia è l’abilità degli oggetti
di riempire i cassetti lascandoli vuoti.
*
la sigaretta, in equilibrio sull’orlo
del tavolino appena fuori dal bar,
l’hanno lasciata dopo due boccate
per noia, disattenzione, o per un colpo di tosse
più tenebroso del consentito,
o forse per una telefonata improvvisa,
insulsa allegra o fatale,
o forse ancora per inseguire all’istante
l’amore atteso lungo tutta la vita
cosa mai ci confessa, quella sigaretta ormai spenta,
che non possiamo esimerci dall’ascoltare,
non dà tregua il suo grido
né percorsi di fuga, da ogni lato
ci avvolge, si fa cenere in gola,
e soltanto i nostri sensi assopiti
ci permettono di allentare la presa
della realtà che ci abbraccia e ci stritola.
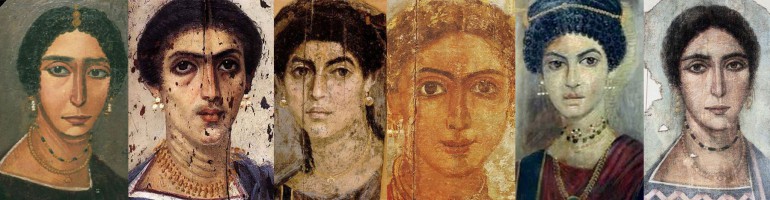






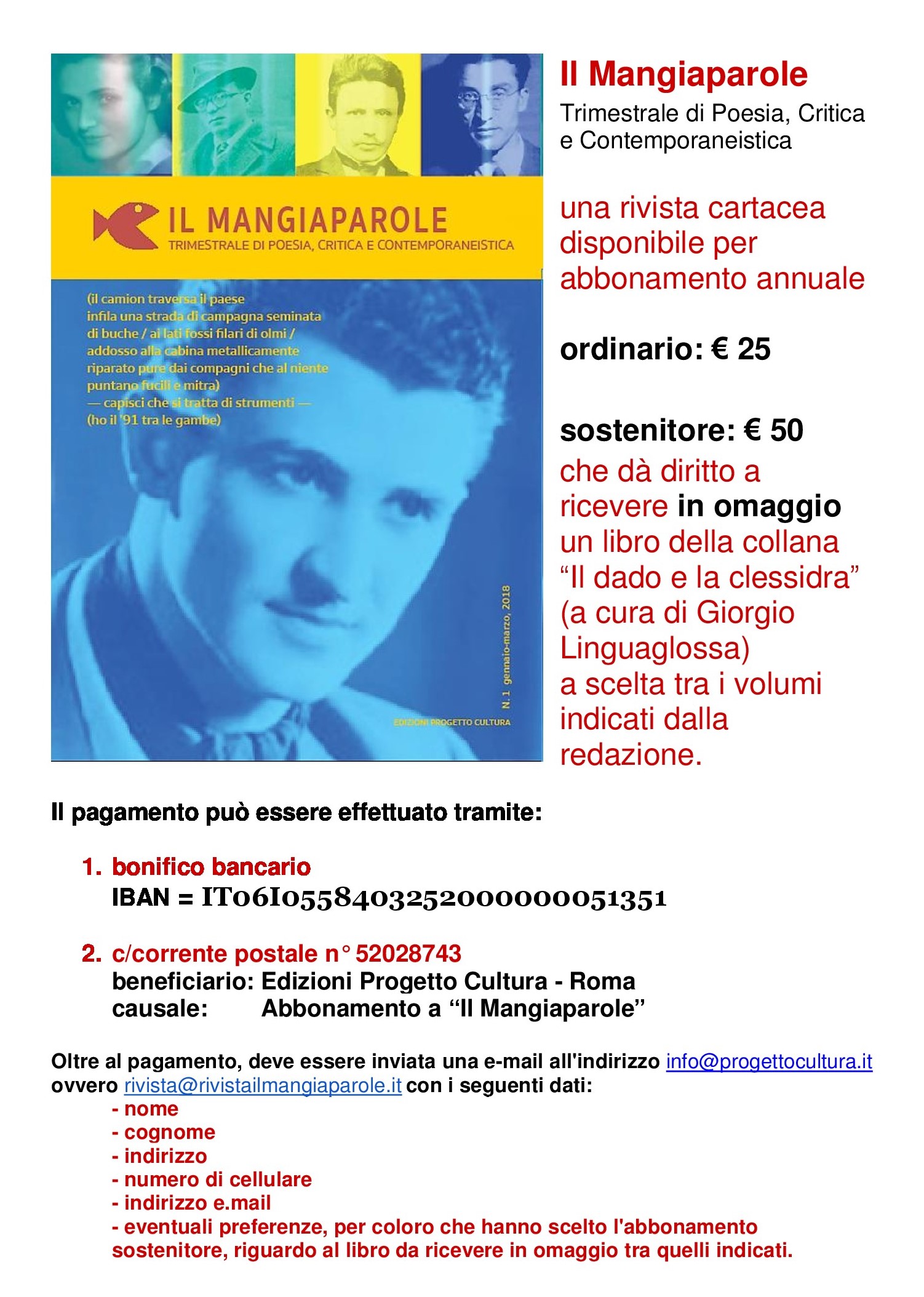
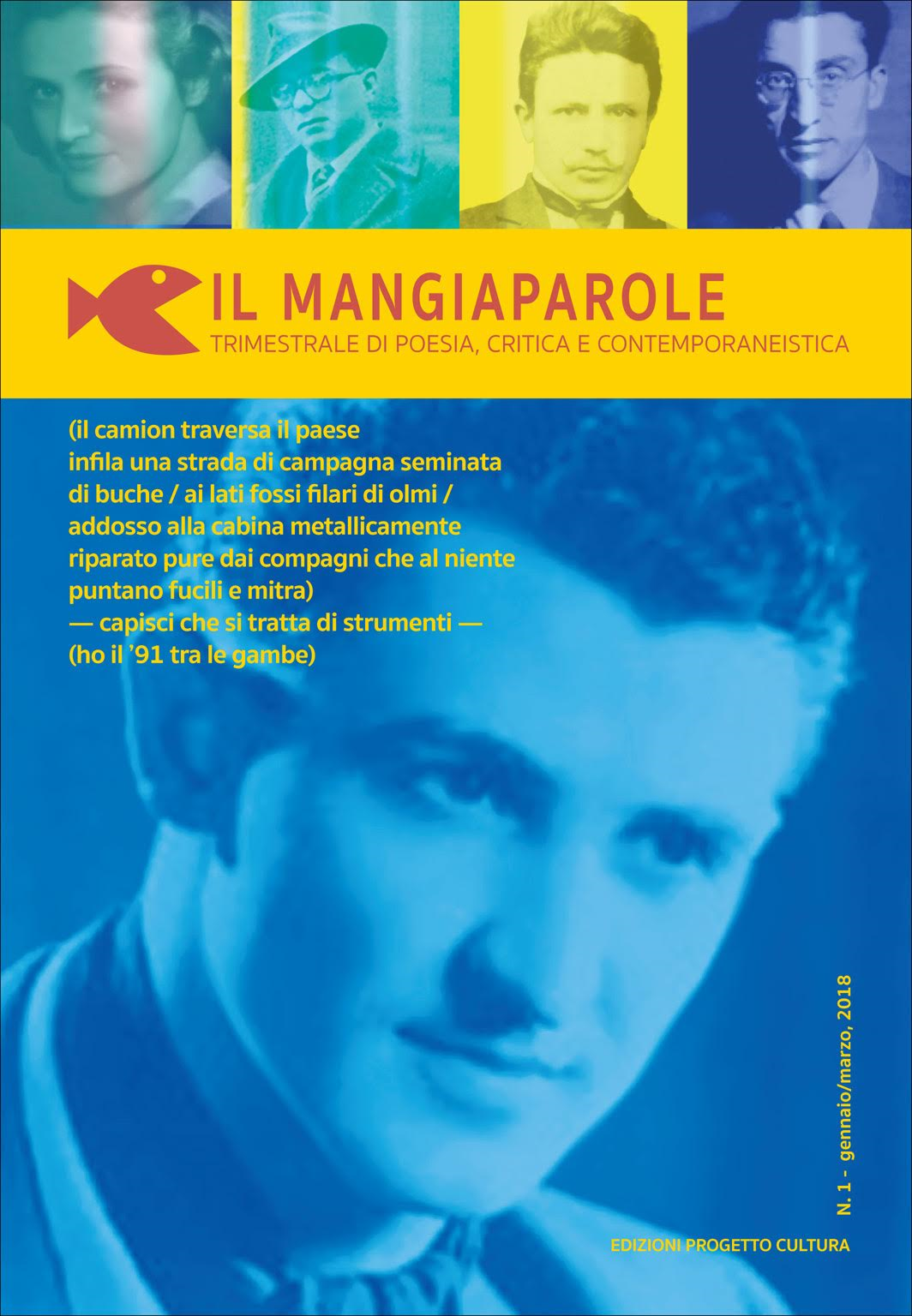

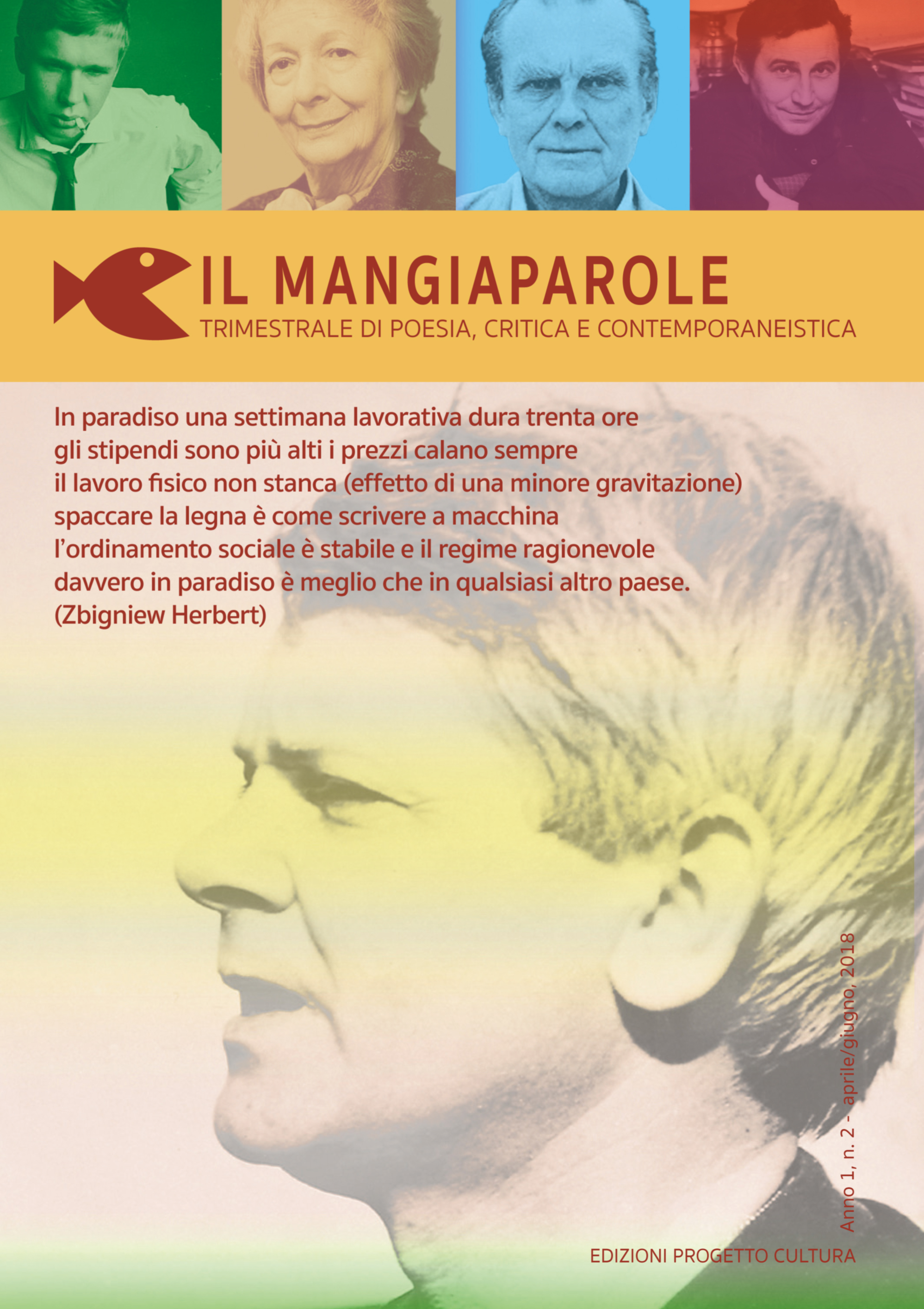



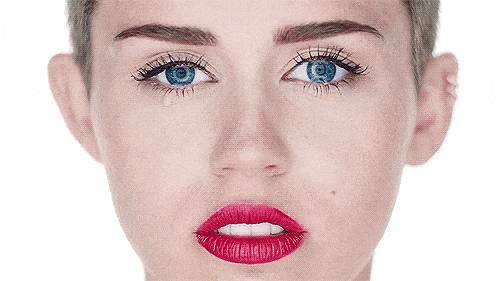
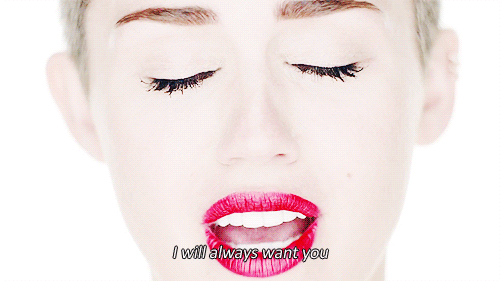
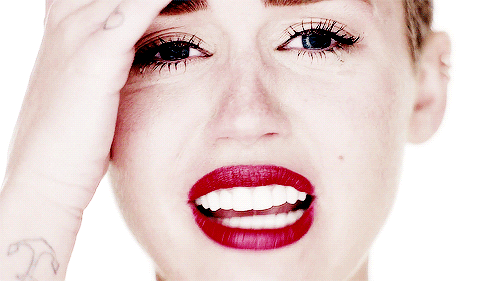
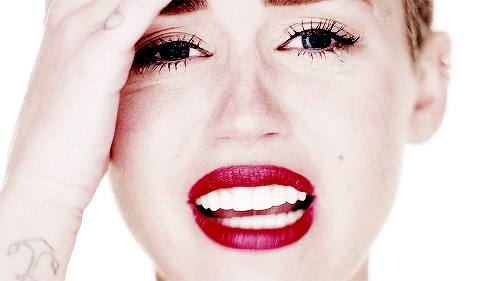
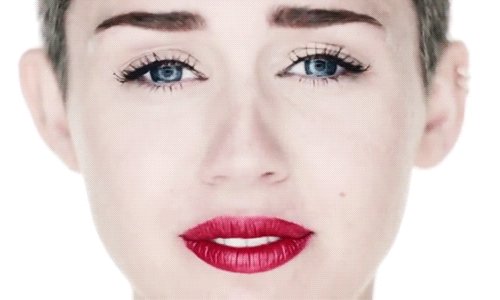



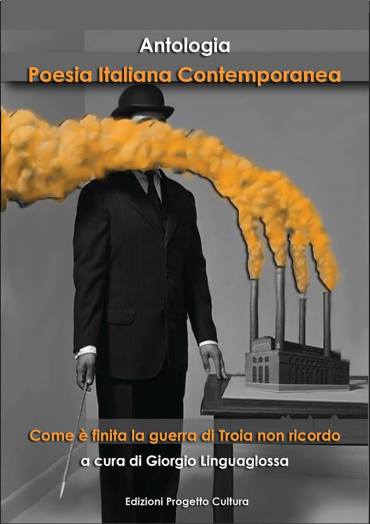




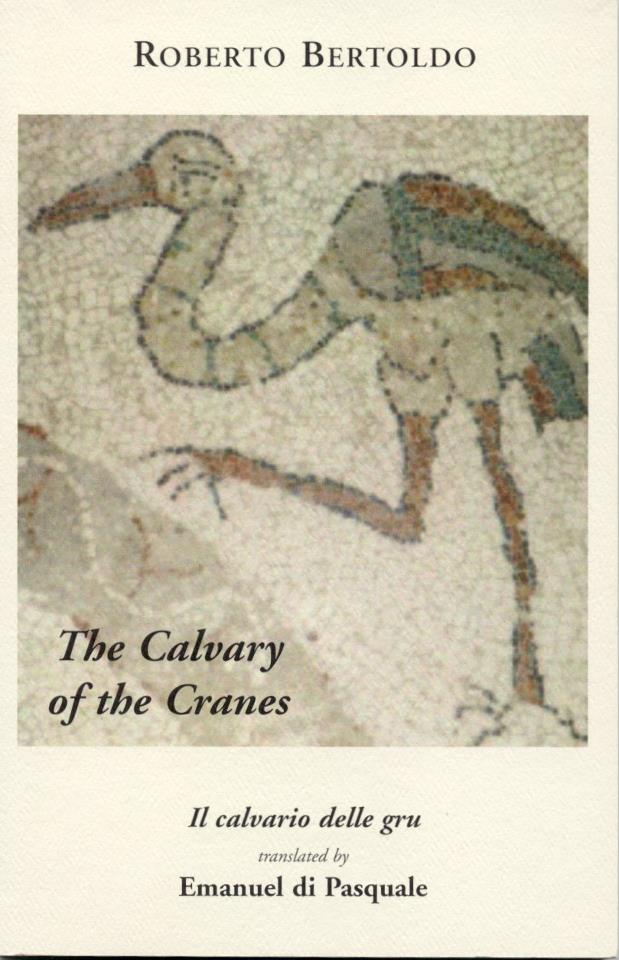
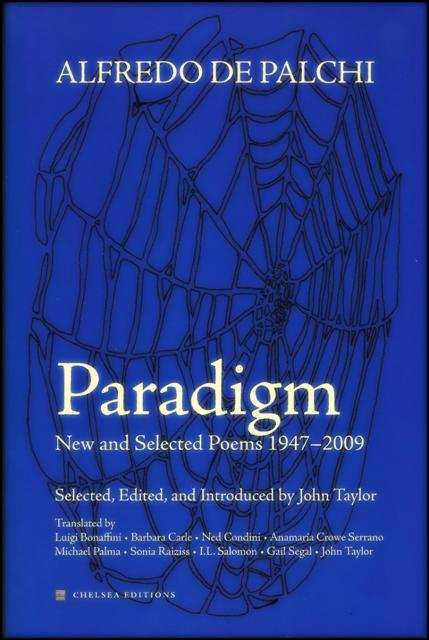


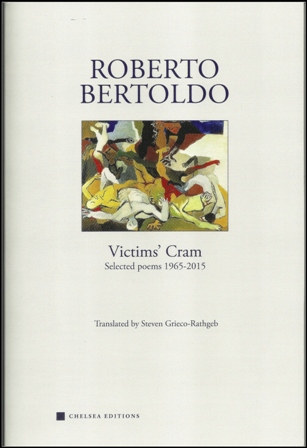





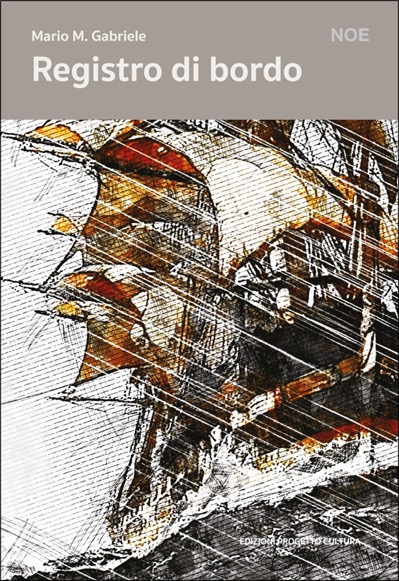

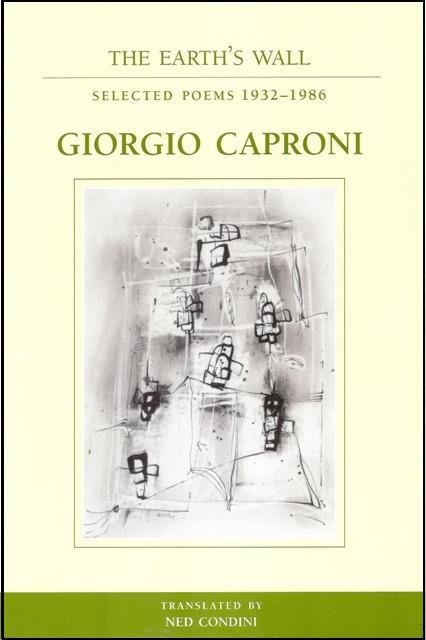
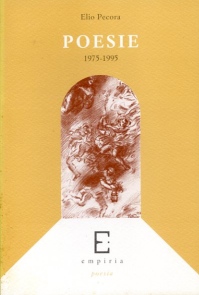

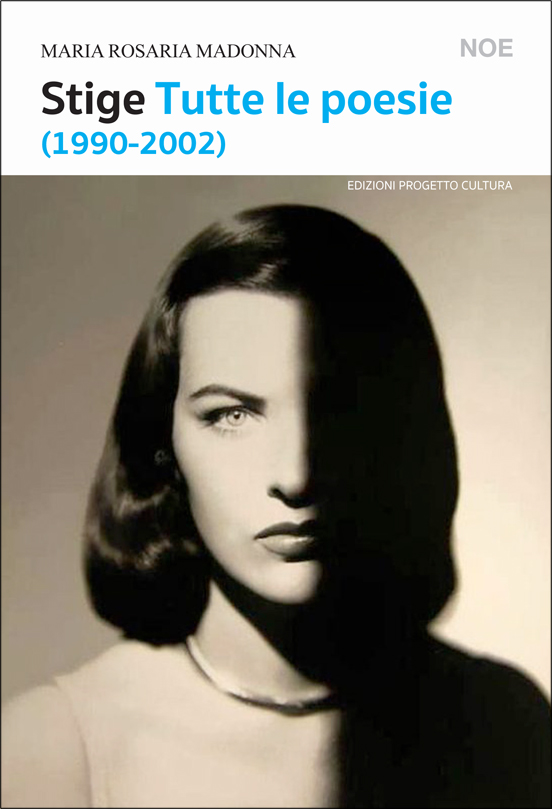

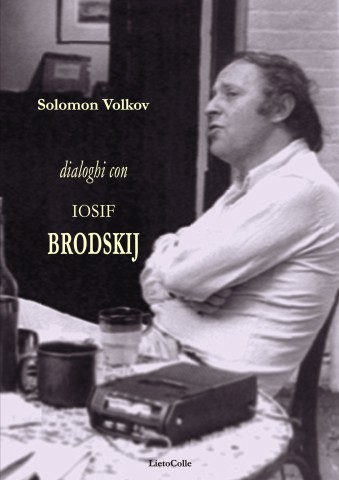




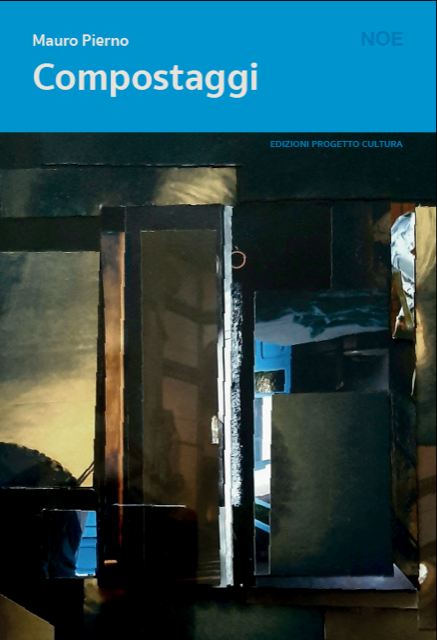
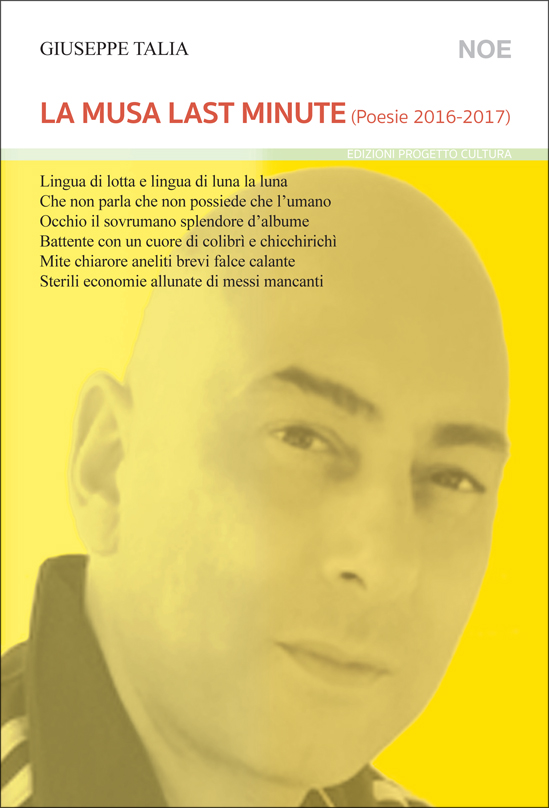


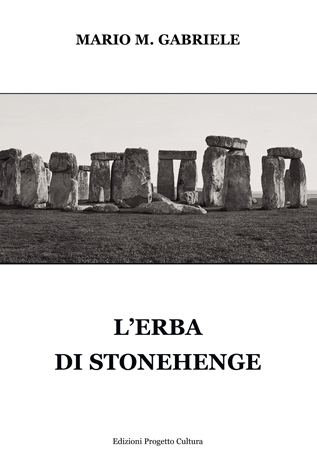
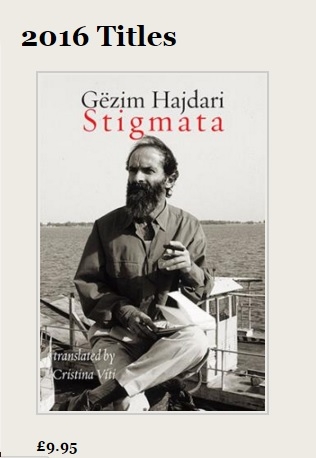
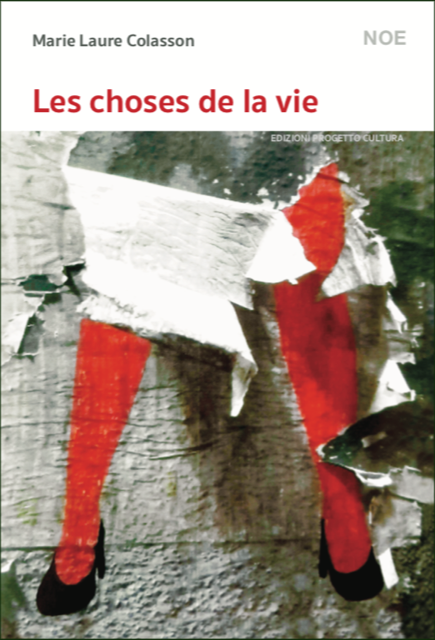




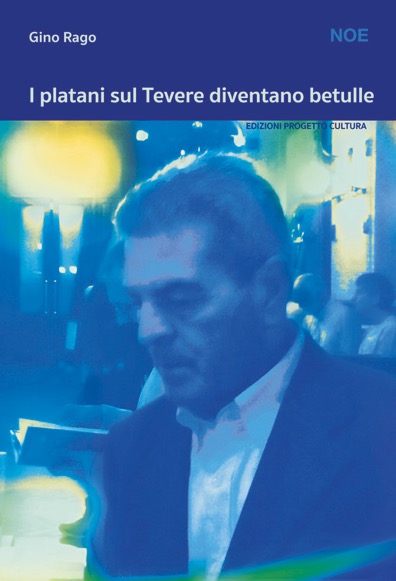
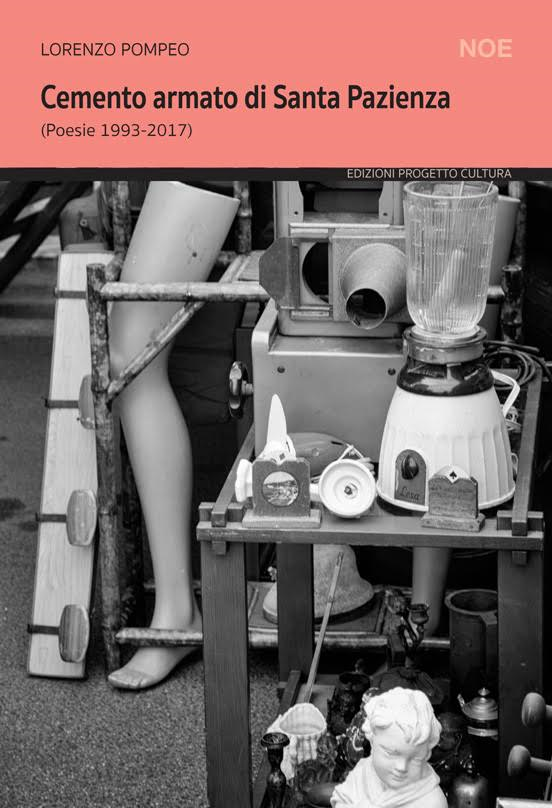
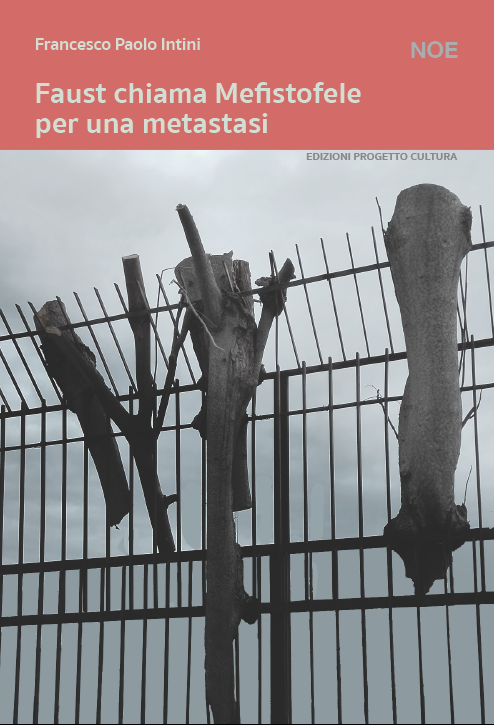

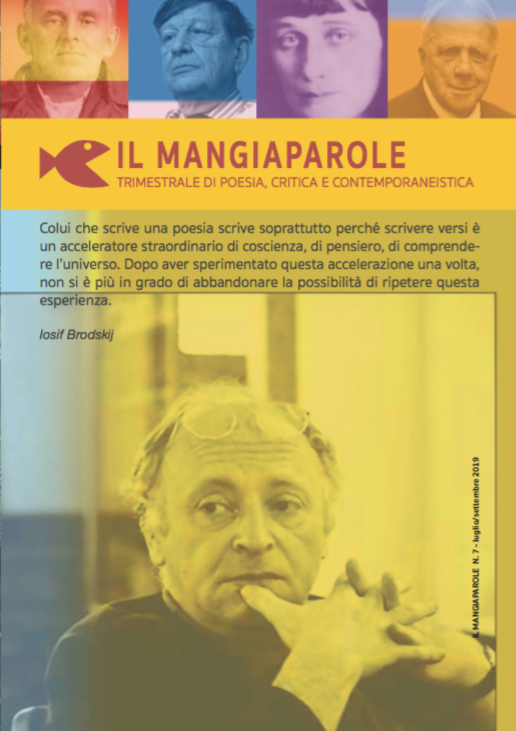




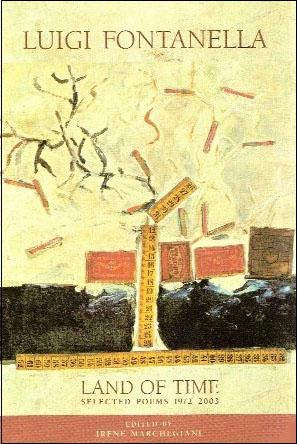








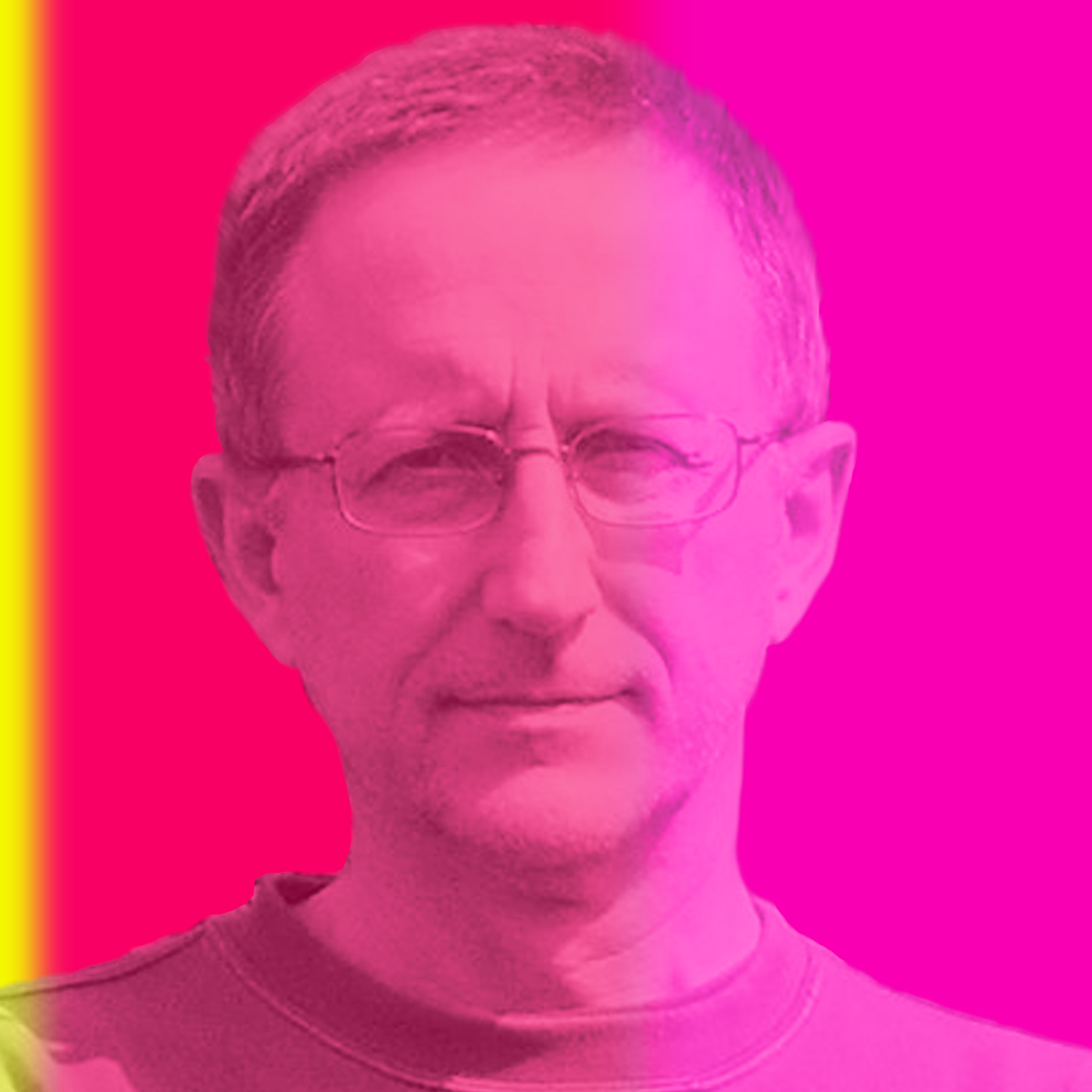







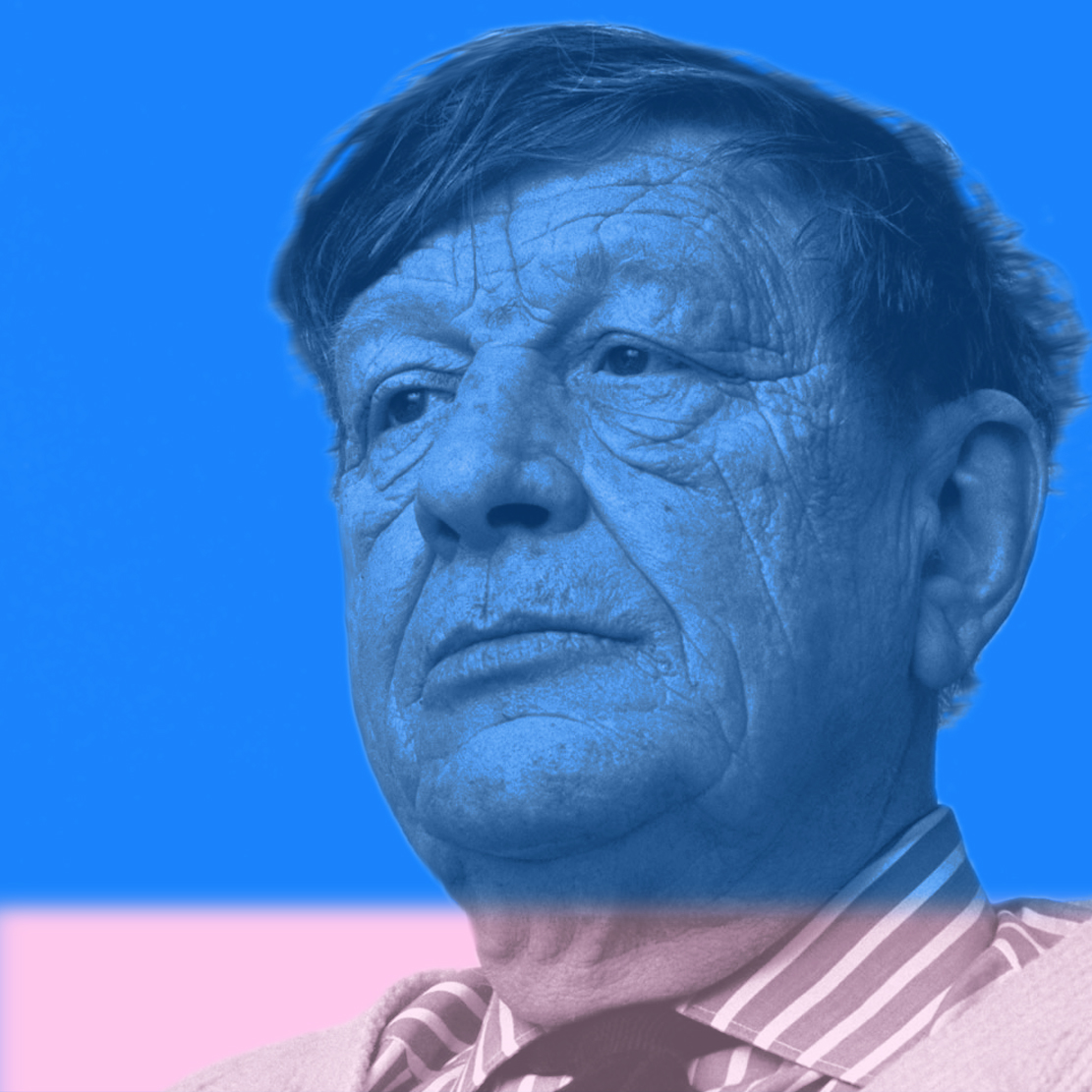



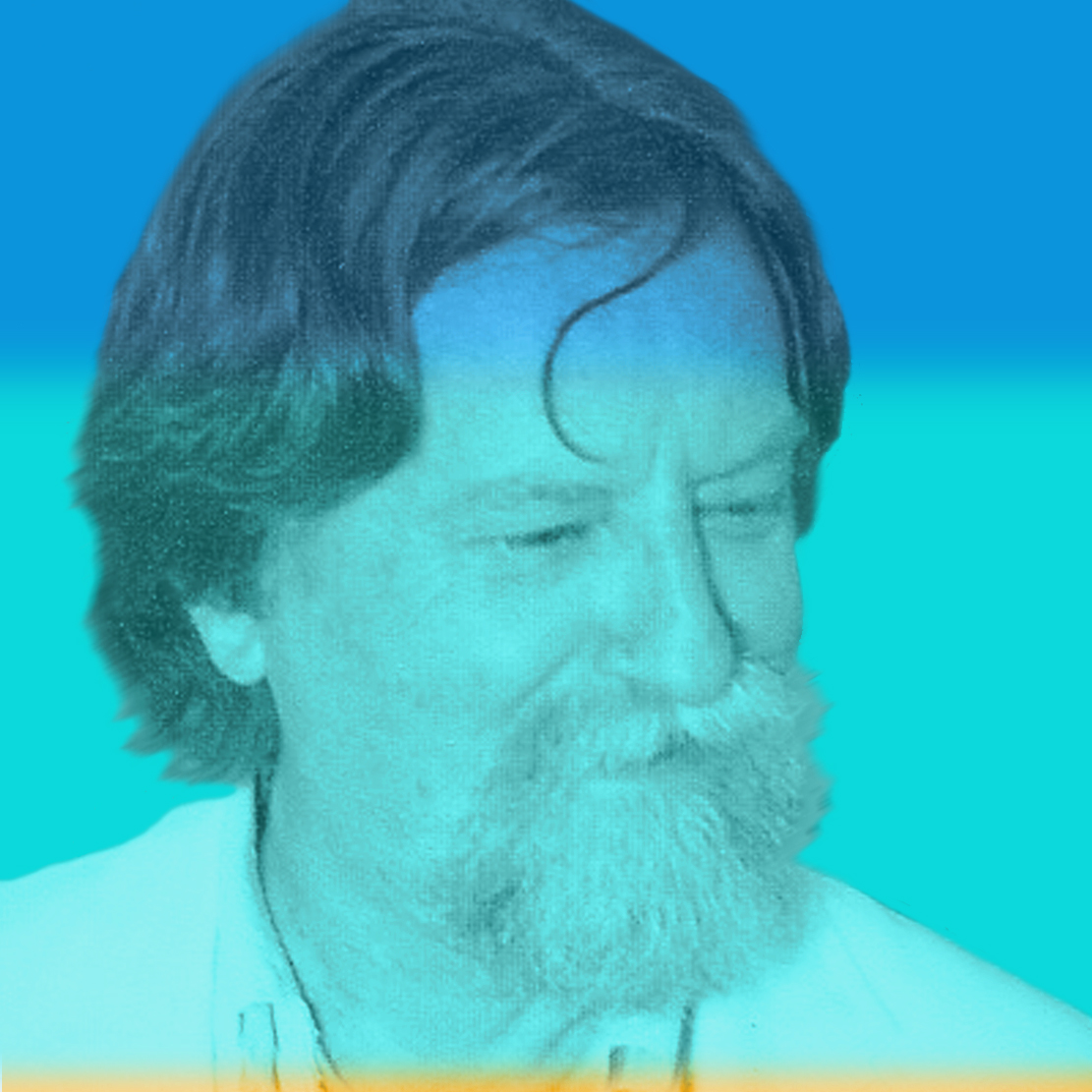
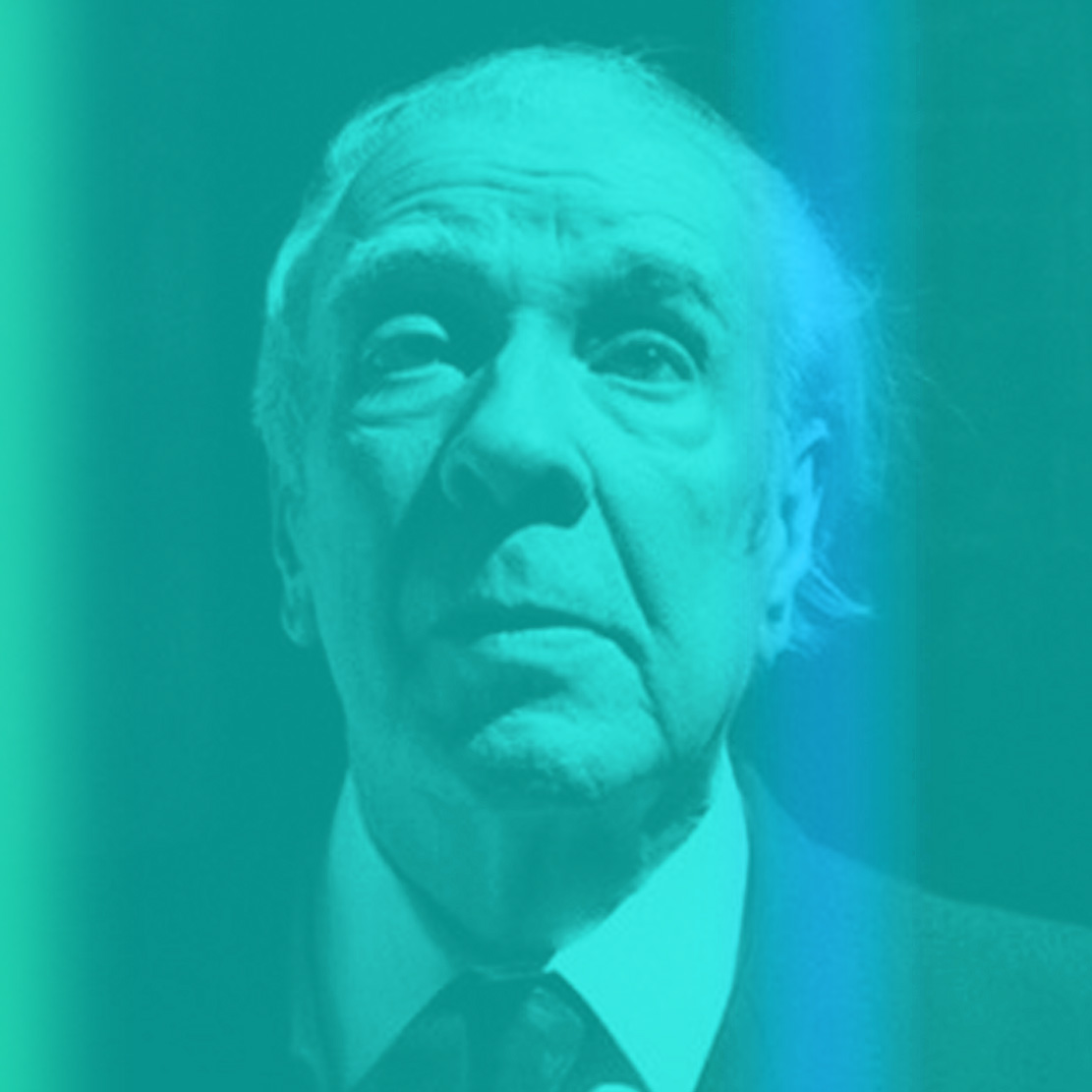




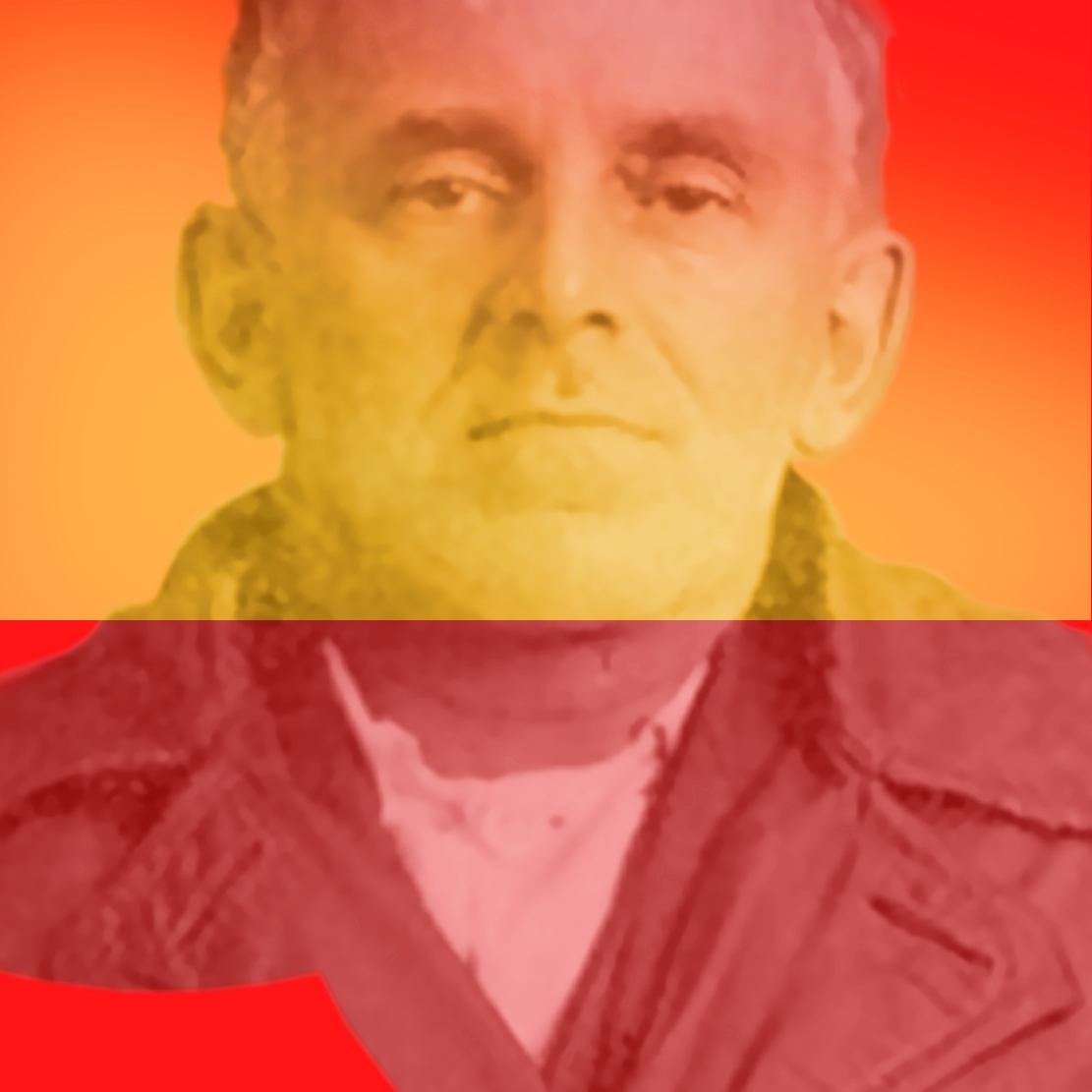






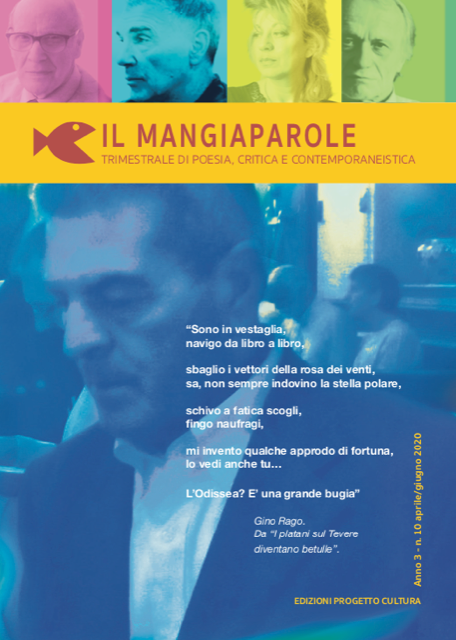




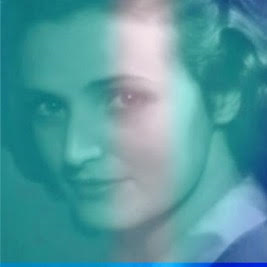
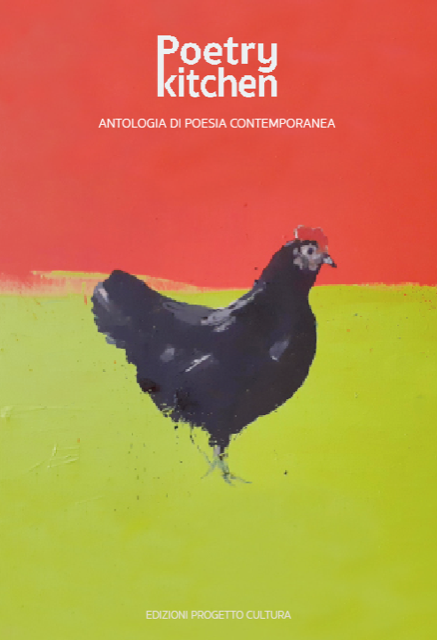



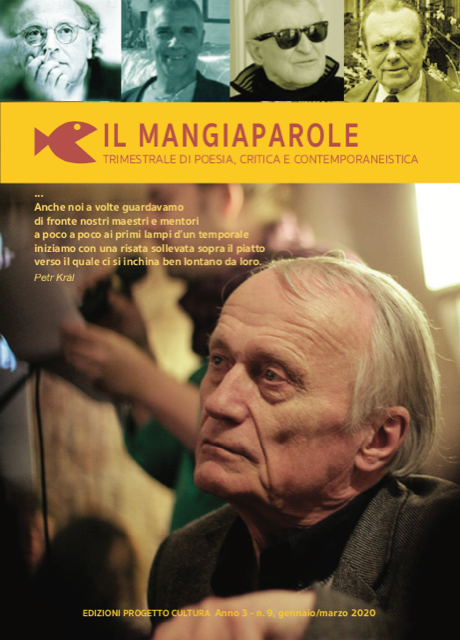











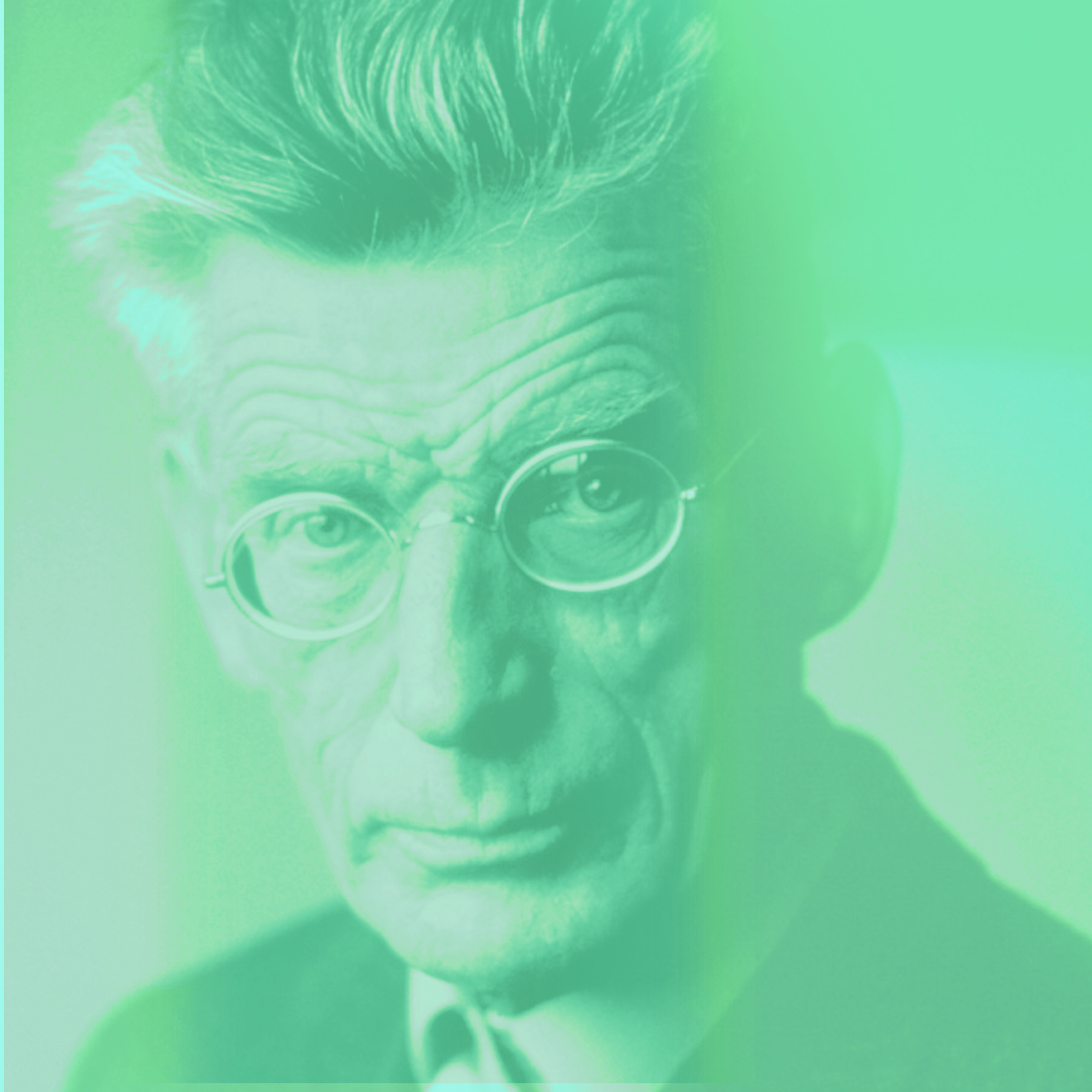
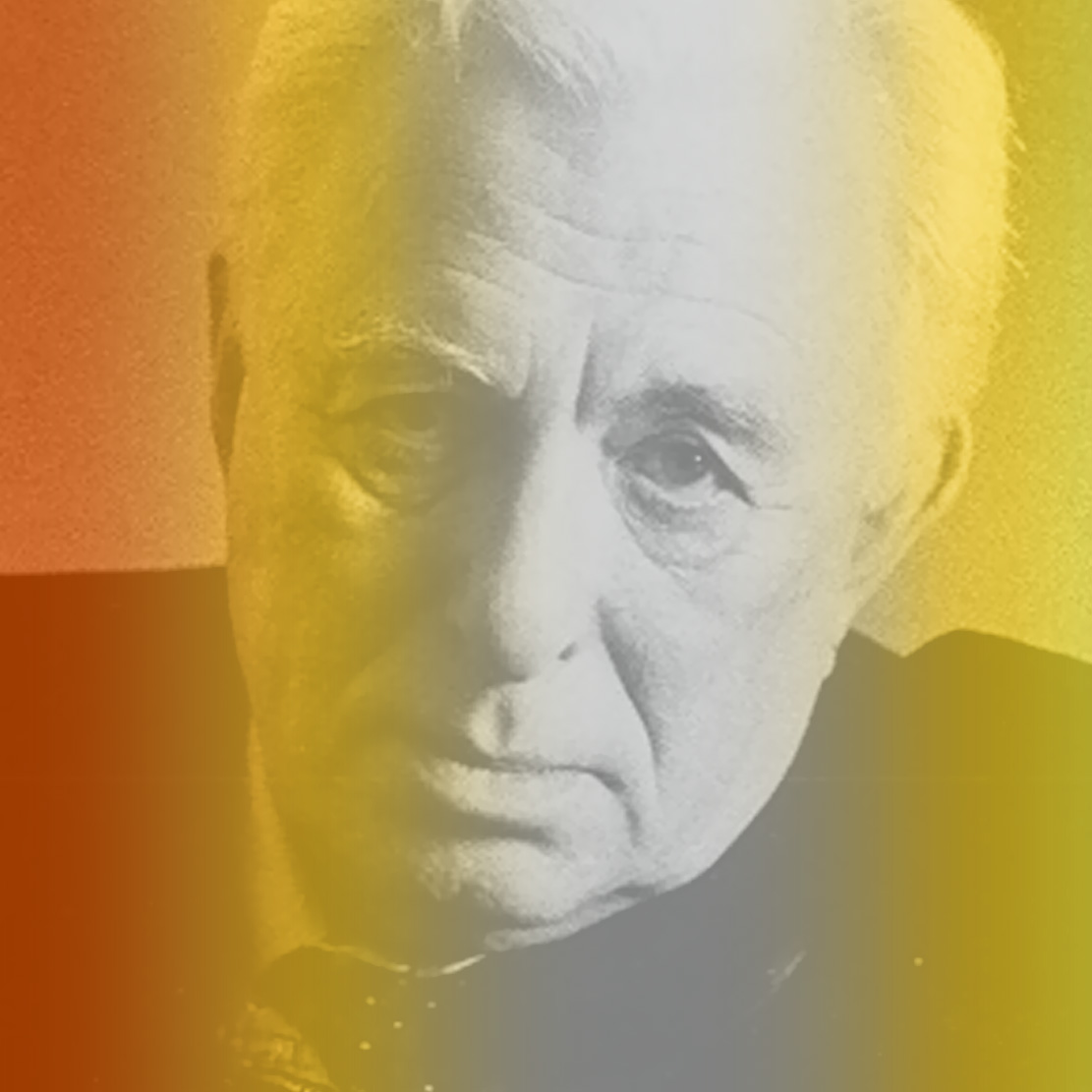









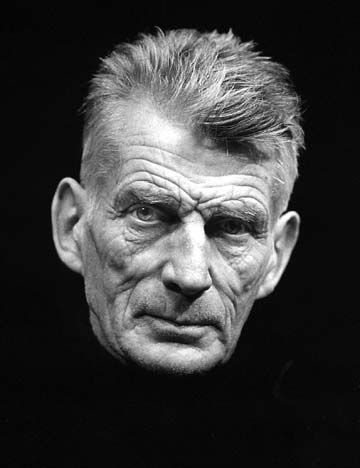


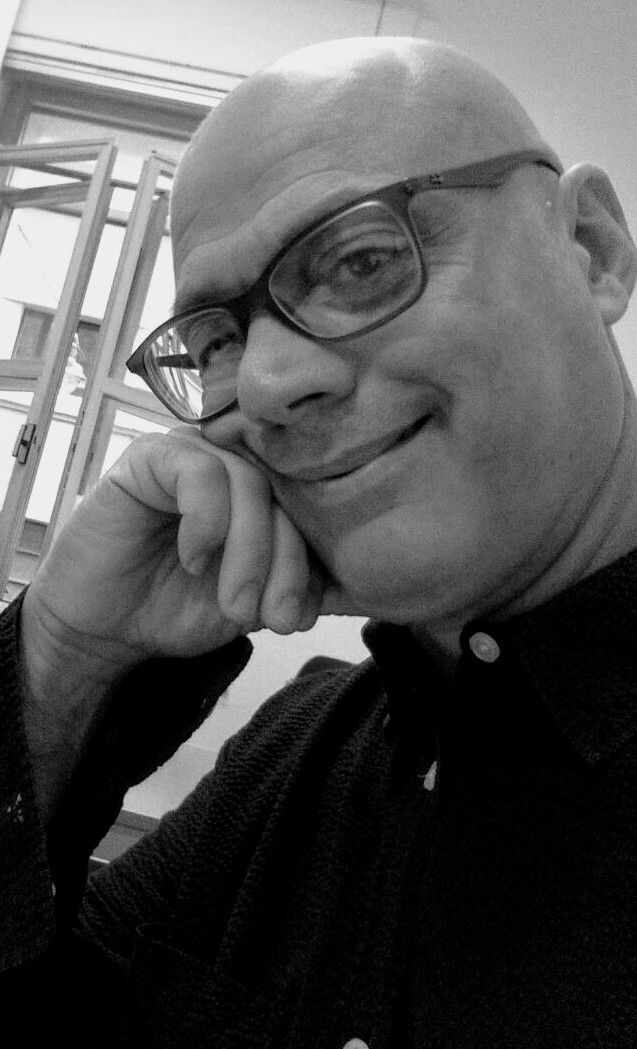
Poiché c’è molta confusione e prevenzione intorno alla NOE, riassumo qui, come si fa con il catechismo, le regole principali della «nuova ontologia estetica».
Ecco le regole base per capire come funziona la «nuova ontologia estetica»:
1) La struttura lineare di un verso non è fatta dalla struttura lineare di istanti che si susseguono l’uno agli altri.
2) La poesia tradizionale identificava l’istante alla parola, cioè più parole messe insieme formavano un polinomio frastico tenuto insieme dalla legge del tempo lineare (Passato, Presente, Futuro).
3) La NOE ha dimostrato l’erroneità (e la convenzionalità) di questa struttura lineare. La scienza e la filosofia del novecento hanno dimostrato che Passato, Presente e Futuro sono tutti contemporanei e che non esiste una cronologia, non esiste una priorità ontologica dell’uno sugli altri. Passato Presente e Futuro sono tutti contemporanei, quindi è errato tradurre la contemporaneità in un continuum temporale qual è la frase sintatticamente regolata dallo scorrere unilineare del tempo.
4) la NOE assume dunque la contemporaneità di Passato, Presente e Futuro nell’ambito di una organizzazione frastica che li contempla tutti insieme contemporaneamente.
5) Questo modo di intendere l’organizzazione frastica fa saltare, come sulla dinamite, la concezione unilineare del tempo, sostituendola con la concezione multilineare e multiprospettica del tempo.
6) La NOE decreta la fine della poesia intesa come «descrizione» o «commento» di un Io posto al di fuori di una rappresentazione. La poesia italiana del novecento, da Pascoli a Bacchini, si è uniformata ad una concezione del tempo prescientifica e ingenua, cioè legata alla evidenza del senso comune per il quale il tempo è una successione di Passato-Presente-Futuro.
7) la NOE assume il concetto di poesia come accadimento di un evento (Ereignis).
"Mi piace""Mi piace"
Carlo Rovelli:
La grammatica di molte lingue moderne declina i verbi in «presente, «passato» e «futuro». Non è adatta per parlare della struttura temporale reale del mondo, che è più complessa. La grammatica si è formata dalla nostra esperienza limitata, prima che ci accorgessimo della sua imprecisione nel cogliere la ricca struttura del mondo.
Quello che ci confonde, quando cerchiamo di mettere ordine nella scoperta che non esiste un presente oggettivo universale, è solo il fatto che la nostra grammatica è organizzata intorno a una distinzione assoluta «passato-presente-futuro», che invece è adatta soltanto parzialmente, qui vicino a noi. La struttura della realtà non è quella che questa grammatica presuppone. Diciamo che un evento «è», oppure «è stato», oppure «sarà». Non abbiamo una grammatica adatta per dire che un evento «è stato» rispetto a me, ma «è» rispetto a te.
Non dobbiamo lasciarci confondere da una grammatica inadeguata.
1] 1 Carlo Rovelli L’ordine del tempo Adelphi, 2017 pp. 98.99
"Mi piace""Mi piace"
Per comprendere un testo della NOE non serve più un critico tradizionale, un critico cioè in possesso della «vecchia» grammatica fondata sullo schema: passato-presente-futuro. Il fatto è che nella «nuova ontologia estetica» si parla mediante una nuova grammatica, dove non c’è alcuna via prestabilita che dal passato porta al presente e che sfocia nel futuro; e qui l’ermeneuta è simile ad un acchiappa farfalle, acchiappa farfalle con lo strumento consono, con una retina a cono.
In una poesia di Mario Gabriele, di Lucio Mayoor Tosi, Mariella Colonna o Steven Grieco Rathgeb o Costantina Donatella Giancaspero ci sono tante temporalità che convivono asieme e litigano per assicurarsi una primazia, una primazia che, ovviamente, non esiste a livello ontologico e né a livello grammaticale.
Non si dà alcuna priorità ontologica nella cristallografia, perché tutti i cristalli rientrano a buon diritto nella cristallografia…
"Mi piace""Mi piace"
Temo ci sia un malinteso circa l’interpretazione del testo di Rovelli, il cui intento è far capire che, nel contesto della teoria della relatività, non esiste un passato-presente-futuro assoluto, essendo il tempo relativistico legato al sistema di riferimento, quindi all’osservatore. Una discrepanza si manifesta, in effetti, o a velocità prossime a c o in presenza di forti campi gravitazionali, ad esempio in prossimità di buchi neri. Poiché queste condizioni non sono quasi mai verificate, tutti noi, poeti NOE o meno, condividiamo la stessa rappresentazione del tempo che Linguaglossa considera ingenua e prescientifica, quella che ha alimentato insomma la letteratura da sempre e da cui qui si vorrebbe prendere le distanze. Il problema a cui allude Rovelli è piuttosto come sia possibile l’emersione del tempo da una realtà fondamentale, quella dei campi quantistici covarianti (teoria della gravità quantistica), in cui la descrizione dei fenomeni non richiede lo spaziotempo. Il quid problematico non è tanto la non linearità o poliedricità del tempo a cui si vorrebbe dare espressione fantastica, in presunta sintonia col progresso del pensiero scientifico, ma cosa significa “realtà fisica fondamentale”, che secondo Rovelli “non è quella che ci appare”, cioè quella che esperiamo sensibilmente. Rovelli in effetti ci invita platonicamente a credere che la realtà fondamentale si coglie con l’intelletto, in forma teoretica. Il problema è invece, a mio avviso, proprio l’emersione del mondo come lo percepiscono i sensi, quindi lo spazio e il tempo dell’esperienza. Per quale ragione non possiamo ritenere ingenuo il riduzionismo teoretico-intellettualistico della fisica piuttosto che la rappresentazione, che qui si vuole ingenua, di chi vive il tempo nella sua forma esperienziale più immediata? A ben vedere la fisica più recente è proprio imbrigliata nel tentativo di spiegare come emerge il tempo quotidiano della coscienza da una realtà senza tempo (vedi la teoria del tempo termico). Lo stesso Rovelli, con grande umiltà, professa l’inadeguatezza della scienza a spiegare. Lo stesso atteggiamento aveva Einstein. La dinamica interiore del tempo, la memoria, la percezione del presente come luce in fuga e del futuro come timore d’aspettazione, non saranno mai terra di conquista della scienza. Lasciamo alla poesia l’enormità dell’ignoto in cui deve navigare sola, oltre l’orizzonte speculativo in cui ogni teoria razionale necessariamente deve fermarsi.
"Mi piace""Mi piace"
ESSERE (è) TEMPO
Ad integrazione di queste preziose osservazioni di Claudio, credo sia utile ricordare che nella tradizione filosofica tardo-antica e medievale – forse un po’ troppo frettolosamente liquidata spesso dalla modernità come pensiero atavico, dogmatico, orientato ad una visione sostanzialistica e ‘statica’ della realtà – troviamo un grande e appassionato dibattito (ben poco conosciuto) sulla natura del tempo.
In particolare in un manoscritto anonimo di età neoplatonica (I-II° sec. d.C.), a noi giunto nella traduzione e interpretazione di Tommaso D’Aquino – il “Liber de Causis” – abbiamo una serie di proposizioni di argomento cosmologico-metafisico. Tra esse una recita come segue:
«L’essere primo è creato nel Principio ed è al di sopra del tempo.
L’essere secondo, o intelletto, è creato con il tempo nell’attimo eterno.
L’anima è creata dopo il tempo e partecipa, nel tempo, all’intelligenza dell’essere»
(LIBER DE CAUSIS, p. 333, ediz. it. a cura di Cristina D’Ancona Costa, 2002)
Al di là dell’evidente contesto spirituale e creazionista (ma ciò non inficia in alcun modo la pregnanza teoretica del testo!), quasi 2000 anni prima della fisica einsteiniana e della gravità quantistica, assistiamo qui ad una riflessione in cui la temporalità appare “co-essenziale” alla mente che la intende: da un lato, ciò che possiamo conoscere, ciò che possiamo
“com-prendere” è sempre connaturato ad una qualche esperienza del tempo (impossibile per noi oltrepassare “l’orizzonte degli eventi” dell’esistenza fenomenica); dall’altro lato, a partire dal tempo che noi stessi “siamo”, possiamo “partecipare” alla profonda interiorità dell’essere, attingendo alla “unità” infinita dell’Origine.
Questa dimensione fontale – in cui il sapere razionale necessariamente si trasfigura in «sapienza poetica» (Vico) – non consiste tuttavia in un irrazionale ‘annullamento’ del tempo, non si riduce ad una malintesa ‘trasgressione’ delle leggi della natura (come vorrebbe la N.O.E.), bensì potremmo dire in essa prende forma un’ ‘intensificazione’ della sua razionalità: lo essere “nel tempo” – con buona pace di Heidegger e degli heideggerismi redivivi – è la più alta (non la più bassa) espressione ontologica del nostro costitutivo Esser-ci.
E non mi sembra un caso, anzi credo sia di notevole fascino, che l’ultimo saggio di divulgazione epistemologica di Rovelli – «L’ordine del tempo» – vada proprio in questa medesima direzione teoretica: parafrasando Pascoli, ora è la stessa scienza della natura a farsi “coscienza” del suo intrinseco Limite, della propria incommensurabile Natura temporale.
"Mi piace""Mi piace"
La poesia deve tornare ad essere mito. Perfetto. Porto ancora una volta (perché più chiaro esempio in Europa davvero non c’è) l’esempio di Elytis, il quale ha piegato la propria lingua greca (e in questo modo l’ha fatto per tutti, ha “smagliato” le trame del greco moderno) riuscendo ad aprire un varco affinché la poesia diventasse mito. E’ stata un’impresa titanica, pensando alla storia plurimillenaria del greco. Dunque anche la nostra lingua italiana si trova un po’ incondizioni simili.
Il coraggio di piegarla, la lingua, di maltrattarla anche finché essa stessa non sarà duttile a questo movimento… può sembrare forse doloroso – ma è fondamentale. Difficile, ma realisticamente è l’unico modo per approdare ad una riformulazione della poesia, che torni insomma ad essere cosa viva.
"Mi piace""Mi piace"
Sulla questione della declinazione dei tempi verbali, ad esempio (mi rifaccio a quanto scrive Giorgio Linguaglossa nel commento più sopra), è interessante notare come alcune lingue (appunto anche il greco) più che alla suddivisione temporale diano peso all’aspetto dell’azione. Così i presenti congiuntivi li ritrovi dentro un’azione avvenuta nel passato, il futuro viene usato per il presente, e di nuovo il presente congiuntivo per esprimere in qualsiasi tempo (passato presente futuro) la permanenza di alcune situazioni. Ciò permette di muoversi attraverso stratificazioni e piegamenti, senza doversi spingere su rotaie, linearmente.
La NOE ha compreso perfettamente l’aspetto essenziale di ciò che una riformulazione del linguaggio poetico necessita oggi.
"Mi piace""Mi piace"
Nel mio caso accetto la NOE non come una novità ma come una diversità, e benissimo che chi ne sta dentro utilizzi la parola “nuova” poesia. A mio parere la linearità può essere annullata o frammentata o addirittura interpolata come potenzialità razionale, scientifica o filosofica, e a mio avviso è un congelare a mezza corsa quella linearità. Compimento di quella linearità, su cui a mio avviso la NOE non ha nessun potere e non lo vuole avere, sono la propria nascita di un individuo e il proprio discendere e il proprio divenire. Insomma banalmente prima nasco e dopo muoio. Non c’è possibilità di controvertire questa realtà se non nelle dimensioni della mente, della riflessione. Prima vivo con chi è vivo e dopo non vivo più con chi è morto. Può esistere un ideale che concilia le due parti: una linearità compiuta che abbia in sé la non linearità, ossia la stabilità del mondo pratico abitato dall’instabilità della mente. La scoperta della NOE resta stupefacente.
"Mi piace""Mi piace"
Ringrazio Mariella Colonna per le sue parole intense e sincere. Anch’io ho imparato molte cose della frequentazione dell’Ombra, una vera officina, anzi, una bottega come era nel Rinascimento, di un nuovo modo di intendere la funzione del linguaggio poetico. Credo che molti autori che scrivono versi dovrebbero pensare seriamente, prima di mettere la penna sulla carta, a quale ontologia estetica pensano di corrispondere, ogni scrittura si rifà ad una ontologia estetica (consapevole o meno).
Questa della NOE è una autentica rivoluzione del linguaggio poetico, ma non solo, è una rivoluzione del modo di intendere il tempo e lo spazio in una poesia. Il poeta Guido Galdini in queste poesie rivela doti espressive non comuni ma, chiediamoci, che idea ha l’autore della propria ontologia estetica? Acutamente Giorgio Linguaglossa ha messo il dito nella piaga, ha indicato il vicolo cieco di un certo “lombardismo stilistico” che produce una poesia già ampiamente esperita nel secondo e tardo novecento e quindi epigonica… per questa strada non si potrà produrre che poesia di derivazione lombarda, affetta da lombardismo stilistico…
Però ritengo che un poeta di valore, attento, sensibile e colto come Guido Galdini saprà fare tesoro delle nostre osservazioni.
"Mi piace""Mi piace"
per quanto mi riguarda io imparo da tutti voi.
"Mi piace""Mi piace"
posto qui una poesia di Adeodato Piazza Nicolai giunta alla mia email in quanto scritta à la maniére di Ajvaz:
Adeodato Piazza Nicolai
dall’ontologia estetica di Ajvaz
In piena umiltà inseguiamo il paradosso
della classica meta-poesia un po’ dimenticata
o messa in cantina poiché (la crediamo)
sia rimasta senza benzina. Forse meglio tuffarsi
nei labirinti borgesiani o perdersi nella sua
biblioteca infinita. Anche Jung e Jodorowski
ci conducono in fiumi sotterranei che a volte
spuntano sulla supeficie, ma solo come frammenti
e lamenti delle viscere poetiche sotterrate
da troppe teorie sparpagliate a vanvera un po’
dappertutto … E il teorema di Zeno ha ancora qualche
valore? Un disonore studiarlo tuttora? Da tempo
tento di varcare certi confini immaginari, muraglie
illusionarie. Non voglio ritornare né all’alfa né all’omega.
Lasciatemi remare e poi ascoltare il fruscio delle vele
sulla barca mai costruita dalle mie mani,
chissà se ci sono altri porti sepolti da esplorare…
© 2017 Adeodato Piazza Nicolai
Vigo di Cadore, 27 giugno, ore 18:30
"Mi piace""Mi piace"
Ho provato più volte a commentare queste poesie di Guido Galdini, ma ho dovuto desistere. E mi dispiace perché mi sembra di capire lo splendido autore di Appunti precolombiani: qui alle prese con un reportage, imbrigliato nel silenzio della fotografia. Lui, un cacciatore di senso, alle prese con il vuoto urbano: perché ancora incredulo, finisce col fare il verso al peggior Raboni (mio modo di vedere) il quale già si era fumato i propri talenti per rincorrere chissà quali traguardi mentre era in vita. E magari Galdini neanche ci pensava mentre scriveva: per lui forse sono reperti su cui basta un soffio per rimetterli in vita. Ma il soffio di chi? Un vistoso errore di critica, o una esecuzione fatta con strumenti inadeguati. E’ un po’ tutto troppo ragionato. Non si contano le verità che si possono dire. Oggi nemmeno quelli della famiglia Crespi si commuoverebbero davanti a una foto della vecchia (di ieri) Milano. Turnisti compresi. Quindi è una scelta sbagliata anche dal punto di vista comunicazionale. Vero è che nessuno sa più quale sia il senso delle cose; anche a saperlo, magari perché si è letto Essere e tempo, comunque non si saprebbe che farne. Ma non c’è nessuna ragione al mondo che possa dar credito alle parole di un singolo poeta posto di fronte all’accadimento di tanta devastazione. Specie se porge melanconie. In Portogallo, forse. Me no, lì a fermarli è l’oceano. Non so come spiegare, una mancanza di ossigeno, quell’io che parla sulle cose ma che sa nascondersi…
"Mi piace""Mi piace"
La ringrazio del commento che, pur essendo totalmente negativo, non posso che accettare senza (troppo) controbattere.
Solo una curoisità: non mi è del tutto chiaro l’accenno alla famiglia Crespi e alla Milano di ieri. Purtroppo è tutto di oggi.
Cordialità
GG
"Mi piace""Mi piace"
Mi scusi lei, caro Guido ( in confidenza, sono anch’io nativo di Brescia, solo un anno dopo di lei) per le mie dis-connessioni ( Raboni, Milano, ecc). Certo che è tutto così anche oggi ma dal linguaggio, o per certi schemi, sembra ieri – per quanto fanno testo coloro che ne sanno qualcosa dei lombardi in letteratura, quindi non sarebbe poi la fine del mondo – .
A me interessava condividere con lei, in positivo, il feet back che ho avuto osservando la sequenza-reportage, chiaramente fotografica, con tutti i limiti che questo comporta nella relazione tra soggetto e oggetto. Ma, ripeto, questo potrebbe essere dovuto al linguaggio che rimanda, come è stato detto, a un dato modo di concepire la poesia. Non si tratta quindi nemmeno di linguaggio – lei è bravissimo – ma di qualcosa che riguarda l’osservazione, tant’è che ci si trova ancora costretti a scrivere versi per chiudere, quasi l’aver osservato non bastasse a far capire. Nella poesia-evento il lettore è costretto ad attivare le proprie meningi se vuol partecipare. Ma a questo proposito la discussione è ancora aperta.
"Mi piace""Mi piace"
caro Borghi,
la nuova ontologia estetica è la violazione consapevole di tutte le certezze su cui si è scritto fino ad oggi la poesia italiana. Intendo qui le certezze spazio temporali, le certezze intorno al soggetto e all’oggetto, la certezza dello scorrere unidirezionale della sintassi e della grammatica, la certezza della presenza, la certezza della assenza… Dalla mia poesia matura ho bandito tutte queste certezze e le ho rimpiazate con l’incertezza e l’indeterminazione. Ho fatto male? Ho fatto bene? Non lo so, forse scrivo una pessima poesia ma, del resto scrivere come tutti gli altri allievi del minimalismo e del lombardismo stilistico mi faceva ridere. E poi ho trovato dei compagni di viaggio di assoluto valore, da Anna Ventura, la nostra Szymborska a tutti gli altri, e questo mi basta.
Posto qui la seconda parte di una poesia già pubblicata ma sulla quale sono tornato con delle variazioni. Come vedi qui è saltato tutto. Tutto quello su cui i “credenti” credevano fosse poesia:
[…]
Siamo nel secolo XXI.
Uno studio fotografico. Una donna nuda.
In bianco e nero. [Una modella di Vogue?]
cammina con i tacchi a spillo su un pavimento
di linoleum bianco su sfondo grigio chiaro.
Un fotografo
scatta delle fotografie, da tutte le posizioni.
“Non ho mai visto una donna così bella”,
pensai “se non a Venezia nell’acqua alta.
Una dama in maschera solleva il vestito sopra il ginocchio…”,
ma dimenticai quel pensiero.
Poi qualcuno cambiò fotogramma
e pensai ad altro.
Prese un altro film dalla cineteca.
E riavvolse il nastro.
[…]
La dama veneziana si cambia d’abito.
Noi, al di qua dello spazio e al di là del tempo,
ammiriamo i suoi merletti di trine,
i capelli color rame a torre sul suo volto in maschera.
Intanto, dietro il muro bianco c’è mio padre
che gioca con i serpenti.
[…]
Hotel Astoria.
Nel sogno ci sono quindici possibilità.
Quindici stanze.
Mio padre imbraccia il violino.
Un corridoio. Ci sono quindici porte chiuse,
ma io ho una sola chiave.
[…]
Mi affaccio ad una finestra.
Un centauro galoppa su un prato verde di cartolina.
La ruota del luna park ci porta in alto.
Un pittore dipinge sulla tela un sole spento.
Una dama veneziana passeggia sul Ponte di Rialto.
È mia madre.
Tocco nella tasca interna della giacca
la foto di Enceladon.
È sempre lì, dove l’avevo dimenticata.
[…]
Un altro passo all’indietro.
Il libro della felicità lo sta scrivendo il pittore.
Un cavalletto e una tela bianca.
Dalla parete di destra una debole luce filtra dalla finestra.
Il pittore dipinge il volto della sua amante.
Una prostituta di Trastevere. Le chiede di stare in posa.
E scivola anche lui nel sonno.
"Mi piace""Mi piace"
Ogni viaggio interiore, ogni passione se autentica suscita in me interesse, caro Giorgio, non giudico di certo, ho solo cercato, come sempre, di fare chiarezza. Non accetto che si dicano cose approssimative, specie quando si parla di fisica, o che ci si senta portatori di chissà quale novità laddove questa nasce da un probabile malinteso. Solo il dialogo porta avanti: questo insegna la scienza, quando produce pensiero fertile. Questo dovrebbe fare la poesia, quando riesce a farsi portatrice di forza e mistero.
"Mi piace""Mi piace"
Ubaldo De Robertis mi sta suggerendo di ricordarti per tutti quegli indeterminativi, all’inizio della prima strofa 🙂
Questa poesia a me fa pensare al viaggio coraggioso di un astronauta fuori dalla navicella spaziale: è un momento di assoluta bellezza e concentrazione. Io eviterei quei versi che rimandano esplicitamente al sogno. Ok, siamo bene affrancati alla navicella? Allora si perte! O, se si preferisce il parapendio…
"Mi piace""Mi piace"
Lo so, sono un disastro, sbaglio sempre gli articoli indeterminativi e i determinativi. Chiedo aiuto a tutti voi, quali devo correggere?
"Mi piace""Mi piace"
Non so, così ad esempio:
Secolo XXI.
Studio fotografico. Una donna nuda.
In bianco e nero [modella di Vogue?]
cammina con i tacchi a spillo su un pavimento
di linoleum bianco su sfondo grigio chiaro.
Il fotografo
scatta fotografie, da tutte le posizioni.
“Non ho mai visto una donna così bella”
"Mi piace""Mi piace"
… notare che insieme a un e una è sparito anche “delle” 🙂
"Mi piace""Mi piace"
.. pure quel “UN pavimento”: meglio SUL p. Così tutta la scena secondo me diventerebbe più verosimile, si perderebbe quell’alone da lettino dello psicanalista che talvolta hanno alcune tue poesie ( solo alcune, eh), che inquieta.
"Mi piace""Mi piace"
sono d’accordo con Lucio sulle varianti grammaticali…ma non capisco “l’alone da lettino dello psicanalista”! Semmai, in molte poesie di Giorgio, c’è il ricorrere del pensiero della morte, un amore(-odio?) per il nulla, ci sono note ossianesche…manca la gioia, questo sì…
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Lucio,
ho accettato tutti i tuoi consigli…
"Mi piace""Mi piace"
Ah, te ne devo io in gran quantità 🙂
"Mi piace""Mi piace"
Ubaldo De Robertis mi sta suggerendo di ricordarti per tutti quegli indeterminativi, all’inizio della prima strofa 🙂
Questa poesia a me fa pensare al viaggio coraggioso di un astronauta fuori
dalla navicella spaziale: è un momento di assoluta bellezza e concentrazione. Io eviterei quei versi che rimandano esplicitamente al sogno, queste poesie hanno già la fattura del sogno, dell’inconscio durante l’ipnosi. Ok, siamo bene affrancati alla navicella? Allora godiamoci ogni passo. O, se si preferisce il parapendio…
"Mi piace""Mi piace"
Caro Claudio,
poiché non sono uno scienziato, mi sono limitato a citare testualmente le frasi di Carlo Rovelli dall’ultimo libro L’ordine del tempo Adelphi, 2017.
Non mi sognerei mai di rubare il mestiere a Rovelli o a qualche altro fisico teorico, io faccio poesia e mi costruisco una poetica. Una poetica che tiene conto dello sviluppo del pensiero di tanti filosofi, ma non una poetica incontraddittoria, come ama ripetere il filosofo DAVIDE INCHIERCHIA. UNA POETICA NON è UNA EQUAZIONE DI MATEMATICA O UNA TEORIA FILOSOFICA, è un’altra cosa. Sarebbe buffo andare a cercare le contraddizioni nelle poetiche del novecento o nella poetica del surrealismo, per il semplice fatto che non è lo scopo di una poetica quello di essere incontraddittoria. Una nuova poetica serve a fare nuova arte (più bella o più brutta, non so ma diversa sì)
"Mi piace""Mi piace"
Caro Claudio,
Come per Andrea Emo, anche per Luigi Pareyson il linguaggio mitico è «l’unico adatto» a rappresentare la Trascendenza divina, «in quanto idoneo a dire cose che non si possono dire se non in quella maniera» (cfr. L. Pareyson, Ontologia della libertà, cit., p. 103).
Io penso invece che il linguaggio mitico sia l’unico adatto alla forma-poesia, ciò soprattutto perché esso si esprime, non solo attraverso la metafora ma anche mediante la metonimia e il simbolico. Questo linguaggio mitico «col salto di tutti i passaggi intermedi e proposizionali produce una concentrazione così densa, che mantiene in perfetta simultaneità e coincidenza l’identità e la differenza, l’unità e l’alterità, l’assimilazione e la dissomiglianza».
"Mi piace""Mi piace"
Sono perfettamente d’accordo: il linguaggio mitico è il linguaggio della vera poesia da sempre: nasce come “sogno dei popoli”, immediato, primordiale e rimane sepolto nella profondità dell’inconscio fino a quando una rivoluzione espressiva lo fa riemergere e lo riporta in vita nelle forme e con un linguaggio nuovo, come sta accadendo nella NOE e in altri poeti o gruppi di poeti… viva la diversità!
"Mi piace""Mi piace"
Il neoplatonico Damascio, nell’opera Dubitationes et solutiones de primis principiis, Paris 1899, sostiene che il Principio Ineffabile (tò apòrretos) del tutto non coincide con l’Uno e si trova epékeina tou henòs, al di là dell’Uno (quest’ultimo denominato da lui, talvolta, «indicibile», arrètos, ma mai «ineffabile»). Il Meta-Principio, insomma, non è identificabile con niente, e non è definibile in nessun modo, neanche come indefinibile: «Infatti, noi non lo [l’Ineffabile] diciamo neppure ‘totalmente inconoscibile’, in modo che esso, essendo qualcos’altra cosa, possieda per natura l’inconoscibilità; ma non lo diciamo né ‘ente’, né ‘uno’, né ‘tutto’, né ‘principio del tutto’, né ‘al di là del tutto’; noi riteniamo di non predicare di esso assolutamente nulla. Dunque, neppure questi predicati costituiscono la natura di esso e neppure ‘il nulla’» (cfr. Damascio, De Princ. I, p. 13.17-21). In tal modo, il paradosso auto-referenziale è lo sbocco aporetico necessario di qualsiasi discorso sull’Assoluto, del quale si può parlare soltanto attraverso continui «capovolgimenti» o «inversioni» del logos; infatti, afferma Damascio, «se invece è necessario dare qualche indicazione [del Principio], bisogna allora servirsi delle negazioni di questi predicati; dire che non è né uno né molti, né generatore né non generatore, né causa né non causa. Bisogna per l’appunto servirsi di queste negazioni che, non so come, si capovolgono [peritrépesthai] totalmente all’infinito» (cfr. Damascio, De Princ. I 22, 15-19 e I 26, 3-5, corsivo mio).
"Mi piace""Mi piace"
La dialettica paradossale e aporetica della «nuova ontologia estetica» ha non solo la funzione di mostrare la fallacia di cogliere il «reale» mediante le categorie logico-ontologiche non-contraddittorie, ma anche quella di «chiave» che permette l’accesso ad un pensiero metafisico «Altro», in grado di cogliere un’altra realtà, quella che non si dà con un linguaggio poetico, diciamo, novecentesco. L’Altra realtà la si attinge mediante il paradosso, il capovolgimento, la peritropè. L’Altro reale non è maneggiabile con le categorie della descrizione realistica, ma lo si attinge secondo una dialettica del paradosso e della peritropè che può avere un antecedente significativo nella peritropè («capovolgimento» o «inversione») damasciana.
La poesia della «nuova ontologia estetica» si dà come atto magico (incontraddittorio perché in sé contiene tutte le contraddizioni), nel senso che l’atto della poiesis pone il reale di per sé, senza il bisogno di aderire ad un modello riconoscibile ed accettabile di narrazione o meta narrazione (come avviene ad esempio nella poesia di Guido Galdini). Nell’atto del porre la poiesis, tutto è identico, ma proprio per questo tutto è Nulla, tutto è Altro nel senso che sono non soltanto simultaneamente uno, ma anche simultaneamente non-uno; l’identico è simultaneamente anche il non-identico, il simile è simultaneamente anche il dis-simile; gli opposti si toccano e si identificano e si annullano. Tuttavia, in questo stesso atto della poiesis al contempo gli elementi si oppongono radicalmente a se stessi. Il reale è terribilmente contraddittorio e problematico, e la poiesis non può adoperare le categorie della verosimiglianza e del verosimile, pena l’impoverimento della rappresentazione del reale.
"Mi piace""Mi piace"
ESSERE (è) TEMPO
Ad integrazione di queste preziose osservazioni di Claudio, credo sia utile ricordare che nella tradizione filosofica tardo-antica e medievale – forse un po’ troppo frettolosamente liquidata spesso dalla modernità come pensiero atavico, dogmatico, orientato ad una visione sostanzialistica e ‘statica’ della realtà – troviamo un grande e appassionato dibattito (ben poco conosciuto) sulla natura del tempo.
In particolare in un manoscritto anonimo di età neoplatonica (I-II° sec. d.C.), a noi giunto nella traduzione e interpretazione di Tommaso D’Aquino – il “Liber de Causis” – abbiamo una serie di proposizioni di argomento cosmologico-metafisico. Tra esse una recita come segue:
«L’essere primo è creato nel Principio ed è al di sopra del tempo.
L’essere secondo, o intelletto, è creato con il tempo nell’attimo eterno.
L’anima è creata dopo il tempo e partecipa, nel tempo, all’intelligenza dell’essere»
(LIBER DE CAUSIS, p. 333, ediz. it. a cura di Cristina D’Ancona Costa, 2002)
Al di là dell’evidente contesto spirituale e creazionista (ma ciò non inficia in alcun modo la pregnanza teoretica del testo!), quasi 2000 anni prima della fisica einsteiniana e della gravità quantistica, assistiamo qui ad una riflessione in cui la temporalità appare “co-essenziale” alla mente che la intende: da un lato, ciò che possiamo conoscere, ciò che possiamo
“com-prendere” è sempre connaturato ad una qualche esperienza del tempo (impossibile per noi oltrepassare “l’orizzonte degli eventi” dell’esistenza fenomenica); dall’altro lato, a partire dal tempo che noi stessi “siamo”, possiamo “partecipare” alla profonda interiorità dell’essere, attingendo alla “unità” infinita dell’Origine.
Questa dimensione fontale – in cui il sapere razionale necessariamente si trasfigura in «sapienza poetica» (Vico) – non consiste tuttavia in un irrazionale ‘annullamento’ del tempo, non si riduce ad una malintesa ‘trasgressione’ delle leggi della natura (come vorrebbe la N.O.E.), bensì potremmo dire in essa prende forma un’ ‘intensificazione’ della sua razionalità: lo essere “nel tempo” – con buona pace di Heidegger e degli heideggerismi redivivi – è la più alta (non la più bassa) espressione ontologica del nostro costitutivo Esser-ci.
E non mi sembra un caso, anzi credo sia di notevole fascino, che l’ultimo saggio di divulgazione epistemologica di Rovelli – «L’ordine del tempo» – vada proprio in questa medesima direzione teoretica: parafrasando Pascoli, ora è la stessa scienza della natura a farsi “coscienza” del suo intrinseco Limite, della propria incommensurabile Natura temporale.
"Mi piace""Mi piace"
P.S. Egregio Giorgio Linguaglossa,
affinché il discorso non rimanga confinato ad un dialogo chiuso tra me e Claudio, ripropongo in calce le mie considerazioni di ieri augurandomi che lei, ma anche soprattutto qualcuno degli altri interlocutori qui presenti – che restano al solito opportunamente e sornionamente silenziosi: salvo magari uscirsene ogni tanto con qualche improvvisa e improvvisata “morte di dio”… – possiate entrare nel merito specifico della riflessione metafisico-cosmologica da me qui evocata attraverso lo spunto offerto da un testo antico.
Il tema è la natura ontologica del tempo in rapporto alla coscienza poetica: ora si tratta di argomentare razionalmente, anziché cercare rifugio in asserti psicologistici e rapsodici.
Solo una precisazione, en passant: quando una Poiesis persiste nell’illusione di credersi esperienza situata “fuori” dal Logos – Logos: essere come identità concreta dell’intellegibile, pensiero che si sa non-altro da sé – tale esperienza resta unicamente (per definizione) astratta parola senza concetto: puro sofisma, vuota retorica…
Grazie
"Mi piace""Mi piace"
Scusi.
Signor Davide Inchierchia, desidero porle una domanda, senza che qui si apra un nuovo capitolo tra Fede e Ragione,di cui la nostra civiltà ne è piena, in quanto incapace di dare una risposta alla problematica esistenziale, tra riflessione metafisico-cosmologica e soggettivismo razionale, considerando la filosofia come indagine e la scienza come verifica dei dati a disposizione, che hanno creato un fenomeno inflattivo nella scienza e nel percorso culturale dalla antropologia di Lèvi Strauss, alle teorie dei filosofi marxisti (L.Altusser), alla linguistica di Jakobson e A Greimas, alla fonologia delle scuole strutturalistiche del Circolo di Praga (N,S.Trubeckoj), quello di Copenaghen (L.Hjelmslev) e allo strutturalismo americano (L.Bloomfield). Ma lei la poesia come la vede? e soprattutto, Dio come lo vede fisicamente? E lo spazio Infinito? e la sua fine se mai dovesse esistere? La tradizione religiosa ci dice che Dio creò il Mondo dal Nulla. Allora il Nulla esiste e tornerà ad esistere. Può darsi che sia stato così per qualche amanuense che scrisse le pagine della Bibbia. La nascita, la morte, il dolore, il suicidio, la malattia, le malformazioni del DNA, come quella del piccolo Charlie e di tanti altri bambini che non conosciamo, fanno parte di un questionario di difficile interpretazione. Chi ha voluto, Signor Inchierchia questo castigo o fallimento della Creazione, Dio o la natura, assoggettata a Dio? E’ tutto dentro un “quantum” sigillato dal Mistero e da un Codice Segreto da scoprire e decodificare come la Stele di Rosetta.E tutti quei morti che ci lasciamo dietro. La scienza espone le sue tesi, le organizza in sistemi per esplorare e rivelare i dati scientifici, presi come parametri oggettivi. Il filosofo elabora un progetto teoretico ed estetico attraverso la socializzazione della parola nata dal pensiero, che si espone ad un dibattito pluralistico. Conoscere la realtà delle cose appartiene alla scienza e alla filosofia, ed è parte fondante della loro stessa funzione storica di fronte ai moltissimi “Quid” di cui la natura si circonda, proiettandoli sul destino dell’uomo. Qui non vorrei citare Heidegger, né altri Vescovi del Vaticano, ma mi soffermerei a considerare la struttura fisica di Dio, già accennata sopra, sebbene su questo tema esistano pareri diversi tra Fede e Ragione, A meno che non si consideri Dio come lo scienziato Hawking quale unica forza di gravità che ha dato inizio all’Universo..
"Mi piace""Mi piace"
Nel suo rapporto giuridico con le scienze e la letteratura, il signor Inchierchia ribadisce che “è la stessa scienza della natura a farsi “coscienza” del suo intrinseco Limite, della propria incommensurabile Natura temporale”.
Spicca la parola “Limite”, maiuscolo – Ehi voi, dove andate! Non si può non si può non si può! – Non si può oltrepassare la soglia (impossibile per noi oltrepassare “l’orizzonte degli eventi” dell’esistenza fenomenica)… Si unisce a Borghi nel dire che possiamo solo attingere “alla “unità” infinita dell’Origine”. Sembra che il signor Inchierchia ci tenga a sottolineare l’umano limite, la nostra, di tutti, transitorietà. Le sue a me sembrano le riflessioni di una persona s-caduta nel tempo.
” L’essenza dello spirito è il concetto. Con questa parola Hegel non intende il generale intuito di un genere in quanto forma di un pensato, bensì la forma del pensiero stesso che si pensa: il concepirs-si – in quanto coglimento del non-io” (Heidegger)
“Il tempo è il concetto stesso, che ci è e si rappresenta alla coscienza come intuizione vuota” (Hegel)
In questi labirinti io non ci vorrei entrare, né potrei, ma una cosa la so: finche il signor Inchierchia non sarà in grado di osservare il proprio pensare, inevitabilmente si ritroverà costretto a stare costretto nel Limite (giuridico) delle Sue possibilità; che poi sono quelle dell’io: se ho ben capito le stesse da cui vorrebbe disperatamente elevarsi Claudio Borghi.
"Mi piace""Mi piace"
Essendo coinvolto, mi permetto di dire che non ho capito, ma sono interessato a sapere da cosa vorrei disperatamente elevarmi, nè in cosa consista questo limite “giuridico” delle possibilità dell’io. Probabilmente sono io che non riesco a cogliere, ma mi sfugge anche il senso dell’essere “s-caduto nel tempo” (cos’è, una sottile velenosa ironia che rimanda in senso denigratorio alla caduta nel tempo di cui parla Cioran?) e di “essere in grado di osservare il proprio pensare”. Sono tutti effetti dell’oltrepassamentiamento della soglia? O nuove tecniche di meditazione?
"Mi piace""Mi piace"
Solo il “giuridico” vorrebbe essere ironico, e non è indirizzato a te a ma Davide Inchierchia il quale si scandalizza per le presunte verità scientifiche, filosofiche ed esistenziali proposte dalla NOE. A mio parere vi accomuna la tragica consapevolezza del limite individuo-mistero che per Inchierchia sembra sconfinare in questioni bibliche. Quasi una condanna (che però gran parte dell’umanità ha accolto senza battere ciglio: nascere nel senso di colpa, indegni di poter aspirare al divino, fosse anche l’essere assoluto).
Cadere nel tempo è accettare questi limiti. Anche se nella tua orgogliosa ricerca c’è ben altro che una semplice, stizzita obiezione filosofica, si contesta la procedura lirica, perché ritenuta ormai insufficiente, dove soggetto e oggetto agiscono concatenati, seppure nel volo dell’ispirazione verso quel che viene ritenuto mistero sovrastante. A conti fatti sembra riemergere il limite biblico di cui sopra.
Poter osservare il proprio pensare è una delle possibili conseguenze della perdita dell’io. Ma ve ne sono altre, non ultima un diverso approccio all’autenticità. Sul linguaggio si sta lavorando senza posa, ma questo è un altro aspetto.
"Mi piace""Mi piace"
Egregio Davide Inchierchia,
lei ha portato l’esempio di un filosofo medioevale di indubbio interesse, ma qui cerchiamo di approfondire la natura del tempo in ordine ad una ontologia estetica, non abbiamo velleità di statuire una ontologia della temporalità, ma sì una ontologia estetica della temporalità. In merito a ciò, i suoi contributi possono essere di indubbio interesse. Certo, il luogo della temporalità come noi la intendiamo è sempre da rinvenire nella natura del Logos, non certo al di fuori, non siamo dei mistici o dei sognatori.
Cordiali saluti.
"Mi piace""Mi piace"
egregio Davide Inchierchia,
lei scrive: “Il tema è la natura ontologica del tempo in rapporto alla coscienza poetica”; ecco, sarei interessata a conoscere le sue idee in ordine alla problematica indicata.
"Mi piace""Mi piace"
(META)FISICA
Grazie Giorgio Linguaglossa,
apprezzo il suo tentativo di apertura verso la linea teoretica che sto cercando di sostenere qui, nonostante la mia posizione palesemente critica in merito all’impostazione generale della NOE.
Ringrazio anche Donatella Costantina Giancaspero, per la delicatezza del suo intervento: cercherò di risponderle tramite le considerazioni che seguono.
Per quanto riguarda le osservazioni di Lucio Mayoor Tosi (al di là del velato sarcasmo), vorrei chiedere che mi sia chiarito il senso logico della seguente affermazione:
«poter osservare il proprio pensare è una delle possibili conseguenze della perdita dell’io»
Osservare il proprio “pensare”? Il pensiero non è un oggetto tra gli oggetti. Ancora più importante, il pensiero – se è tale – non può scindersi, non può separarsi da sé, pena contraddizione: ciò infatti significherebbe avere da un lato un pensiero che “è” l’atto stesso di tale scissione (identità) e, dall’altro lato e necessariamente, un pensiero che – essendo da sé distinto – “non è” tale atto di separazione (differenza).
Allora, mi dica: tale pensiero è o non è?
Inoltre, nella fattispecie: lei, tale pensiero, lo sta “pensando” o no?
E dunque, «perdita dell’io» non si rivela comunque un concetto dell’ “io”?
Insomma, caro Tosi, temo sia lei il portatore di uno «s-cadimento» del pensare: ovvero, temo sia lei a con-fondere il pensiero in quanto CONTENUTO PENSATO (ente astratto) e il pensiero in quanto FORMA PENSANTE (essere concreto): ma “sapere” l’astrattezza dell’astratto è precisamente tutto ciò in cui consiste l’autentica dialettica filosofica, così come “mostrare” in immagine la medesima concretezza è la finalità ultima di ogni autentica esperienza poetica.
Mi rivolgo infine all’egregio Mario Gabriele.
Devo dire che mi ha molto divertito la sua richiesta anacronisticamente positivista sulla «struttura fisica» di Dio: neanche Charles Darwin avrebbe osato tanto…
Tornando seri, mi stupisce molto che una personalità come lei, con la sua levatura intellettuale, non riesca a cogliere la finezza speculativa del passo da me proposto di Tommaso D’Aquino. Se lei (qui come altrove) leggesse bene e ponderasse ciò che legge, si accorgerebbe della profonda “attualità” di tanta tradizione spirituale e teologica, lontanissima da quel dogmatismo e da quel fideismo che lei – quasi con infantile disprezzo – senza criterio le attribuisce.
In particolare, le suggerisco di soffermarsi sulla seconda ipostasi della citazione, che ripropongo alla sua attenzione:
«L’essere secondo, o intelletto, è creato con il tempo nell’attimo eterno»
A mio avviso – in sintonia con le riflessioni di Claudio Borghi sullo stesso tema, da lui più volte dibattute in questa e in altre sedi – qui troviamo espresso in eccezionale sintesi, con la forza dell’immediatezza allegorica, l’intero “Uni-verso” del Neoplatonismo.
Una “cosmo-logia” che, non solo ha rappresentato il referente più o meno taciuto di tanta filosofia otto e novecentesca (in primis Hegel e Heidegger, la cui intera opera risulterebbe altrimenti incomprensibile); ma soprattutto, che oggi, per vie traverse e non certo ovvie, sta alimentando indirettamente buona parte dell’indagine scientifica contemporanea (compresa la gravitazione quantistica del già citato Carlo Rovelli: ma si pensi ancor prima alle ricerche sul cosmo a “guscio di noce” di Stephen Hawking).
Perché, se l’intelletto e il tempo – considerati ontologicamente – sono “uno”, non ha alcun senso continuare a crogiolarsi con la vecchissima, trita e ritrita questione del conflitto tra razionalità e spiritualità.
Analogamente, perde di consistenza qualunque appello alla (presunta) irrazionalità della “nuova poetica” post-novecentesca – di cui la NOE sarebbe pioniera – che si troverebbe illuminata dalla oscura luce del (presunto) Nulla: al contrario, nell’ “attimo” della intuizione eidetica tutto l’essere si co-implica, tutto l’essere è tratto “in unitatem” verso «l’alta Luce che da sé è vera» (Dante).
E la nostra piccola anima “gettata” nella storia – terza ipostasi: «creata dopo il tempo» – non può certo illudersi di conoscere “tutto” l’essere (come potrebbe, se è l’essere il suo Principio, “com-prendere” ciò in cui è “com-presa”?).
Eppure, quando conosce qualcosa (attraverso la scienza, la filosofia, la poesia…) la nostra piccola anima lo fa con “tutta se stessa” (Agostino): qui il pensiero si “manifesta” in se stesso a sé ed entra, in misura infinitesima, nella infinita interiorità del Non-Altro (Cusano).
Ma in tale presenza a sé dell’intelligenza il pensiero già hic et nunc si sa eternamente “presente”. Eternamente Uno.
"Mi piace""Mi piace"
Santa pazienza, gentile Inchierchia, se Lei ha voglia di giocare a tennis e far perdere tempo, come si dice, alla gente che lavora, sia più esplicito. Ricompongo la mia affermazione: la perdita dell’io ( cosa impossibile in quanto l’io appartiene alla struttura del corpo-mente, quindi: mettersi l’animo in pace finché si è vivi!) ha tra le conseguenze quella di poter osservare il proprio pensare. Solo se la persona non si identifica con il proprio pensare ( ma qui saremmo avanti mille miglia rispetto al pensiero occidentale, perché questo è zen: lo dico perché lei possa incasellare in qualche maniera qualcosa di vago) l’atto stesso del pensare assume altra identità: si oggettivizza, cosa impensabile per un occidentale. L’essere è altra cosa, e per quel che ho compreso io è pura osservazione, non speculazione intellettuale.
Il pensiero è come ogni altra cosa.
"Mi piace""Mi piace"
… e non si precipiti ad attribuire alla NOE questa sentenza perché è pensiero mio. Non esiste gruppo, ma nemmeno religione, al più sussiste qualche partito. Esiste l’unità degli intenti, l’amicizia, che poi ha significato: fare le cose insieme. Se piace.
"Mi piace""Mi piace"
Gentile Tosi,
le chiedevo di “argomentare” le sue affermazioni, ma lei preferisce “osservare”: come vuole…ma allora almeno abbia la correttezza di non usare il termine “pensiero”, come se esso dipendesse dall’emozione o dall’umore del momento.
Lei ha appena fornito una “immagine” del pensiero: peccato che pensare sia il “toglimento” (infinito) di ogni immagine (finita): Hegel, da lei stesso citato.
"Mi piace""Mi piace"
Lei devia dai miei quesiti che sono diversi. Non risponde, e argomenta su procedure pedagogiche. Trova divertente e anacronistico averle chiesto quale è la struttura fisica di Dio. Non mi risponde,è così ironico da dire che neanche Darwin avrebbe osato tanto, perché lei, illustre filosofo del sapere, non lo sa, né si può avvicinare al pensiero di un Dio così grande da superare la stessa circonferenza dei pianeti e dell’Infinito. Allora se è in possesso di documentazione scientifica di un dio extrafisico me lo faccia sapere e non usi le risposte di tipo onirico o da anfetamine. Leggerò con attenzione tutte le sue argomentazioni.Lei non mi risponde sui delitti della Natura, sull’imperfezione dell’essere umano. Che ci vuole Veronesi a rispondere? Di chi è la causa?. Attendevo un lume di risposta. Si è perso come un naufrago in mezzo al mare. Non mi prenda per i fondelli. Mi sembra Tommaso d’Aquino con la sua Summa Contra Gentiles: ma Tommaso aveva qualcosa in più di lei, in quanto egli realizza il superamento delle consolidate filosofie positiviste, avvicinando il “Lume della fede” al “Lume naturale della ragione”, anche se poi si perde strada facendo ritenendo la ragione “ancella” della Teologia. Ma cosa ancora più destabilizzante è quando Lei afferma con una municipalità arrogante che “non ha alcun senso continuare a crogiolarsi con la vecchissima trita e ritrita questione del conflitto tra razionalità e spiritualità”, confermando ancora una volta, la sua caratterialità stile Mein Kampf. Sia più umile e avrà più rispetto. Per questo motivo studi ancora la sua filosofia, vedrà che alla fine troverà un posto per il paradiso quando sarà un Nihil. Lei ha superato veramente Schodinger ed Heisenberg. Si tenga per sé l’ UNO-Dio e l’UNO-Tutto. Non mi interessano le dissertazioni parauniversitarie. Andrò all’inferno e lei intanto viva pure di illusioni da spiritualista, fregandosi del pensiero altrui o ridicolarizzandolo perché contrario al suo. L’Anima, il Principio, L’Essenza, la Luce, la Verità, l’Incommensurabilità, ma di che cosa sta parlando? Di che cosa si sta nutrendo? Si rende conto che sta facendo propaganda vaticana? Un solo esempio: la sua posizione semplicisticamente avversativa al contestualismo rispetto all’universalismo, è pari al lavoro di un PROMOTER. La Verità, diceva Voltaire, citando P. Bayle, deve essere accolta dalla libertà e perciò deve essere offerta non imposta come fa lei con le sue paraplegie concettuali.
Non si disturbi con la replica. Con questo caldo: HELP, HELP! non so come potrò reagire. Se non le rispondo ad una sua probabile controreplica, vuol dire che non ne vale la pena. Non sono amico dei benedettini e dei fuori corso.
"Mi piace""Mi piace"
Attenzione. La mia replica è rivolta all’esimio Filosofo Davide Inchierchia.
"Mi piace""Mi piace"
Lei, poeta Mario Gabriele, non è capace di mantenere la discussione ad un livello teoretico: sputa sentenze, giudica arbitrariamente, fa riferimenti fuori contesto e allusioni offensive (“Mein Kampf”???).
Ma è capace almeno di “leggere” ciò che uno scrive?
Una volta già le dissi che non si deve preoccupare dei miei studi filosofici. Piuttosto, si vada a rispolverare lei qualche autore. Noto infatti, dalle sue considerazioni, che non ha ancora ben chiara la differenza tra spiritualità e devozionismo (“propaganda vaticana”???)…
"Mi piace""Mi piace"
Egregio filosofo Inchierchia, leggo il suo riscontro delle ore 2,19 di mattina. Un orario un po’ fuori mano nel rispondere o controbattere. Per caso non ha dormito? O è appena tornato da qualche Movida? Gira e rigira, lei fa di tutto per non rispondere. Esca allo scoperto. Non faccia come il professore di fronte allo studente che lo interroga come nella famosa lettera di Einstein. Affronti il problema alla radice. Mi risponda per favore, a tutte le domande che le ho fatto. Lei mi deve dire come vede Dio? e perché ci sono la morte e il dolore.Non trovi soluzioni da frate Ermengaldo. In questo modo non fa altro che schivare la scheggia, spampaneggiando di qua e di là.Pensare è Essere senza teorizzazioni trascendentali.I Pensatori essenziali dicono sempre la stessa cosa o rifuggono dalla verità alla quale io la chiamo a deporre davanti a un pubblico che chiede come stanno le cose. A lei l’ingrato compito. So che le chiedo molto. Ma queste cose ad un filosofo come lei fornito di tanti Beni, non sono una violazione al sapere, a meno che, non abbia dei limiti come tutti noi poveri mortali.
"Mi piace""Mi piace"
gentile Davide Inchierchia,
lei scrive, citando Tommaso D’Aquino:
«L’essere secondo, o intelletto, è creato con il tempo nell’attimo eterno».
Allora, secondo lei esistono due «essere», il primo e il secondo? – Bene, ma da filosofo qual è, dovrebbe spiegare perché esistono due «essere» e non uno, come sembrerebbe più logico anche ad una mente non filosofica come la mia. Poi lei parla di «attimo eterno»; bene, considero questa terminologia un lapsus o un vero e proprio auto goal; poi lei cerca di chiamare dalla sua parte sia Stephen Hawking che Carlo Rovelli affiliandoli al partito della sua Fede, cosa che mi fa sorridere alquanto.
Ho appena postato un filmato che si trova su youtube dove lo scienziato Stephen Hawking dimostra l’inesistenza del suo «Dio» e spiega la nascita del «tempo» con il Big Bang, in quanto non c’è un «prima» del Big Bang dove «dio» può prendere alloggio. Quindi, una preghiera, cerchi di non affiliare alle sue posizioni neotomistiche scienziati del calibro di Hawking e Carlo Rovelli.
Noto, caro Davide Inchierchia, che lei è rimasto fermo alla filosofia di Tommaso D’Aquino e cerca disperatamente di cancellare la filosofia e la scienza che sono venute in questi secoli di storia occidentale dopo il «santo».
Poi lei accenna a presunte «contraddizioni» all’interno della NOE. Le comunico quindi che la NOE non è una filosofia tomistica ma una poetica, una petizione di poetica che contempla in sé molte idee che non hanno la pretesa di essere incontraddittorie e assolute. L’incontraddittorietà e l’assolutezza sono professioni di fede non appartengono al demanio del pensiero filosofico critico.
Infine, noto che lei si è ben guardato dal rispondere alla domanda posta da Donatella Costantina Giancaspero.
Buongiorno.
"Mi piace""Mi piace"
Gentile Giorgio Linguaglossa,
se leggesse bene si accorgerebbe che tutta la seconda parte del mio ultimo intervento è una ipotetica risposta proprio sul rapporto tra una possibile ontologia del tempo e la coscienza (poetica e filosofica), di cui mi chiedeva Donatella Costantina Giancaspero: in ogni caso lasciamo a Donatella una eventuale replica, se lo riterrà opportuno, non credo abbia bisogno di numi tutelari…
Quanto alle sue obiezioni sulla filosofia medievale, mi pare siano alquanto semplicistiche e gravate da grossolani stereotipi.
Anzitutto, come ho specificato chiaramente, il brano che ho scelto proviene da un testo neoplatonico, non tomista: Tommaso qui ne è solo il traduttore e interprete. Poi certamente si può discutere sul debito del tomismo nei confronti delle tradizioni precedenti, e su quanto travagliata e non sempre rigorosa sia stata l’introduzione del pensiero greco in ambiente cristiano: ma non mi pare sia questa la sede adeguata.
Limitandoci dunque al neoplatonismo, dovrebbe sapere che in Plotino le ipostasi della triade cosmogonica non vanno considerate in senso gerarchico o meramente consequenziale. Non ci sono affatto “due essere”: le apposizioni primo e secondo designano, all’esatto opposto, il grado di intensificazione “qualitativa” (non quantitativa) dell’essere in riferimento alla “emanazione” dell’Uno-Unico.
Se l’essere è la forza che proviene dal Principio, l’essere sarà ciò che “unifica” l’intelletto; l’intelletto, a sua volta, è ciò che conferisce “unità” all’anima: il senso della progressione è dunque ontologico, non cronologico.
Mi stupisce pertanto, Linguaglossa, che lei consideri l’idea dell’ «attimo eterno» – comunque non “mia” ma del testo originale (legga bene!) – un “lapsus”: da poeta, quale lei si definisce, non si accorge che questo è un esempio di linguaggio allegorico? E’ ben evidente, infatti, nella visione neoplatonica (e nel passo citato) che l’intelligenza dell’essere – ovvero l’essere intellegibile dell’Uno – “precede” il tempo: è il tema teologico ed escatologico (ripreso poi da Meister Eckhart e che giunge in età moderna fino a Pascal) del Kairos, l’eterno “ora”, in cui il Chronos – il tempo storico – si trova già co-implicato per essenza in quel Vertice che «non circumscritto tutto circumscrive» (Dante).
Le suggerisco infine, Linguaglossa, di non lasciarsi ingannare così ingenuamente dal (presunto) carattere a-teistico e laicistico della scienza moderna, e si domandi di quale “Dio” Stephen Hawking decreta la non esistenza: non può trattarsi certamente della Singolarità, in accezione platonica, la cui trascendenza è tutta “immanente” a ciascun essente inteso quale vivente “specchio” dell’originario «Fiat Lux».
Per quanto riguarda le provocazioni di Mario Gabriele, non capisco francamente quale sia il nesso con il mio discorso sulla cosmologia metafisica. La domanda “unde malum?”, come noto, appartiene alla cosiddetta teodicea: dove e come io avrei sollevato una tale questione e di tale portata? Forse, egregio Gabriele, lei è convinto che – laddove la filosofia ponga la domanda sulla “cosa ultima” (Cacciari) – in automatico il pensiero contemplativo si trasformi in qualche idolatrica forma di venerazione? Crede cioè che la filosofia, quando riconosce la propria essenza spirituale, si illuda che nel mondo tutto è “bene”?
Naturalmente ho una mia opinione sul significato del male, ma non trovo necessario doverla qui raccontare a lei: lei ha già le sue tribolazioni personali a dover sopportare tutto quel Nulla che si porta dentro…perché dovrei aggiungervi le mie?
"Mi piace""Mi piace"
caro Inchierchia,
io non mi sono mai definito “poeta” bensì “calzolaio della poesia”, lascio volentieri ad altri questi allori…
Cmq qui il tema in discussione non era l’«essere secondo» plotiniano ma l’ontologia estetica della NOE, della quale, ribadisco, non abbiamo ancora stilato un decalogo filosofico incontraddittorio ma è una poetica che si sviluppa in fieri, giorno per giorno.
"Mi piace""Mi piace"
Credo che ci sia un errore di fondo che ha fatto precipitare nella reciproca incomprensione il dibattito, comunque di grande interesse perché, se non risolve, almeno apre drammatici interrogativi che l’umanità si è posta da quando è cominciata la storia del pensiero. Dobbiamo tenere ben distinta la dimensione poetica e il pensiero filosofico scientifico, benché sia importante che i due campi della cultura umana interferiscano SENZA VOLER ARRIVARE A CONCLUSIONI perché sia ai percorsi della Poesia che a quelli della Filosofia non potremo mai mettere la parola FINE. (Perdonate il pressappochismo, ma se approfondisco non arrivo a dire quello che mi sembra più importante).
Giorgio Linguaglossa è un vero e vigoroso poeta che, per passione intellettuale ha sconfinato nella Filosofia lasciandosi trascinare nell’oceano delle tesi e ipotesi seguite da antitesi e ipotesi alternative e relative sintesi…anche a me è accaduto di vivere la passione per la filosofia, soprattutto quella teoretica…ma poi mi sono fermata perché sentivo che, per procedere degnamente, avrei dovuto abbandonare tutto il resto e mettere la scrittura e la poesia in secondo piano. Quindi, per noi poeti, il confronto sul piano del pensiero filosofico scientifico non può avvenire nelle forme introdotte da Davide Inchierchia. La sua mente limpida e rigorosa ci fornisce preziose informazioni di cui terremo conto se riusciremo a comprenderne il significato in modo completo e corretto: cosa difficile (per me), per la mancanza di approfondimento, da parte mia, dei temi trattati. Ma qui Mario Gabriele, il combattente NOE che generosamente si lascia prendere dai furori della battaglia, ha, con gesto coraggioso ma temerario, messo in campo argomenti che possono interessare tutti, anche i poeti meno intrigati dalla filosofia di Giorgio Linguaglossa, come “i delitti della natura” o “le imperfezioni dell’essere umano”, aggiungo io: la sofferenza dei bambini. Io non capisco perché si debba, da tutte e due le parti, passare da un livello di discorsività coinvolta al livello delle offese reciproche più o meno esplicite. A Giorgio Gabriele dico, io che sono credente (in modo drammatico, non tipo sacrestia): hai toccato i misteri più sconvolgenti anche per un credente, anche se lo stesso Dio nelle S. Scritture dice, con icastica semplicità: “I miei pensieri non sono i vostri pensieri.”
Auguro a tutti un ferragosto con Trump e Pyongyang “riconciliati”!!!!
"Mi piace""Mi piace"
Dimenticavo: Mariella Colonna (perdonate la mia franchezza)
"Mi piace""Mi piace"
sorry…Gabriele! Ti ho cambiato nome! Comunque la frase andava bene anche per Giorgio…
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Mariella Colonna.
Fa piacere che qualcuno abbia apprezzato lo sforzo speculativo del mio intervento sulla Metafisica: e, nonostante la diversa formazione culturale, senza pregiudiziali ideologiche ne abbia compreso le intenzioni.
Vorrei solo precisare che, oggi come oggi, la distinzione fra “credenti” e “non credenti” – in generale fra spiritualismo e razionalismo – ha ormai ben poco senso. E si badi: dico questo, non per ragioni teologiche, ma anzitutto per ragioni scientifiche. Proprio la scienza più recente – in primis la fisica teorica post-einsteiniana, ma non solo – si fonda cioè su premesse indeterministiche (indimostrabili) che sono totalmente ideali e filosofiche, all’estremo opposto da ogni riduzionismo di tipo materialistico: basti pensare al concetto quantistico di “anti-materia” o a quello di “multiverso”, per tacere della biologia del DNA.
Nonostante le tecniche matematiche e le procedure di calcolo alquanto sofisticate, dal punto di vista teorico generale la scienza di oggi è un sapere rigorosamente “qualitativo” e, oserei dire, inequivocabilmente “teleologico”: più si approfondisce la struttura della realtà materiale e più tale struttura fa segno ad una forma (o energia) spirituale, ovvero ad un “fine” intelligente.
Chi dunque crede nella non-esistenza dello spirito – leggasi: chi crede nel Nulla – ciò appunto lo può solo “opinare”, non “pensare”: poiché dal momento che si pensa, si pensa già l’Essere, ovvero ci si apre alla intelligenza di ciò che È. Spiritualità autentica può sussistere insomma unicamente proprio laddove vi è la massima razionalità: lo spirito altro non è infatti che il “manifestarsi” multiforme dell’essere nello specchio della coscienza.
E nello spazio e nel tempo di questa inesauribile “riflessività” simbolica – in cui la Natura, ogni natura, si fa Idea – vive l’anima dell’uomo.
"Mi piace""Mi piace"
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Mariella Colonna.
Fa piacere che qualcuno abbia apprezzato lo sforzo speculativo del mio intervento sulla Metafisica: e, nonostante la diversa formazione culturale, senza pregiudiziali ideologiche ne abbia compreso le intenzioni.
Vorrei solo precisare che, oggi come oggi, la distinzione fra “credenti” e “non credenti” – in generale fra spiritualismo e razionalismo – ha ormai ben poco senso. E si badi: dico questo, non per ragioni teologiche, ma anzitutto per ragioni scientifiche. Proprio la scienza più recente – in primis la fisica teorica post-einsteiniana, ma non solo – si fonda cioè su premesse indeterministiche (indimostrabili) che sono totalmente ideali e filosofiche, all’estremo opposto da ogni riduzionismo di tipo materialistico: basti pensare al concetto quantistico di “anti-materia” o a quello di “multiverso”, per tacere della biologia del DNA.
Nonostante le tecniche matematiche e le procedure di calcolo alquanto sofisticate, dal punto di vista teorico generale la scienza di oggi è un sapere rigorosamente “qualitativo” e, oserei dire, inequivocabilmente “teleologico”: più si approfondisce la struttura della realtà materiale e più tale struttura fa segno ad una forma (o energia) spirituale, ovvero ad un “fine” intelligente.
Chi dunque crede nella non-esistenza dello spirito – leggasi: chi crede nel Nulla – ciò appunto lo può solo “opinare”, non “pensare”: poiché dal momento che si pensa, si pensa già l’Essere, ovvero ci si apre alla intelligenza di ciò che È. Spiritualità autentica può sussistere insomma unicamente proprio laddove vi è la massima razionalità: lo spirito altro non è infatti che il “manifestarsi” multiforme dell’essere nello specchio della coscienza.
E nello spazio e nel tempo di questa inesauribile “riflessività” simbolica – in cui la Natura, ogni natura, si fa Idea – vive l’anima dell’uomo.
"Mi piace""Mi piace"
Caro Inchierchia, concordo con questa tua impostazione. attualmente sono qui ad Accettura (Matera), oggi pomeriggio si discuterà nella sala consiliare del comune con Luciano Nota e Donatella Costantina Giancaspero sulla poesia, ovvero, su cosa sia la poesia, e siccome mi rendo conto che ne sappiamo così poco su questa questione, sarei interessato ad avere dei suggerimenti su come iniziare il discorso,,,
"Mi piace""Mi piace"
Gentile Linguaglossa,
la ringrazio per questa richiesta, ma è difficile per chi, come me, non scrive poesie, riuscire a fornire una qualche definizione generale.
Da un punto di vista filosofico suggerirei ancora una volta, come buon inizio per impostare dialetticamente il problema, lo Heidegger del classico «L’origine dell’opera d’arte»: dove egli afferma che, domandare “cosa è” la poesia, significa già perderne di vista l’essenziale, ovvero significa ridurre l’arte poetica onticamente ad oggetto fra gli oggetti (facendola decadere a ciò che Heidegger chiama “utilizzabile”).
L’autentica poesia, al contrario, comporta la “sospensione” (Epoché) del giudizio determinante-obiettivante, poiché l’ “evento” poetico è uno dei modi in cui l’ «essere-dell’-ente» si manifesta all’«Esser-ci»: con l’arte poetica – anziché della totalità “generale” del concetto – ne va della “singolarità” esistenziale di ogni «forma di vita» (in senso anche wittgensteiniano).
D’altra parte l’esperienza della poesia non si riduce all’attività soggettiva (al ‘genio’) dell’individuo-poeta: essa non nasce da un impulso irrazionale, bensì riflette l’ “oggettità” ontologica della Natura (Physis) che precede – in quanto abissale “presenza” sovra-razionale – l’universo simbolico della rap-presentazione semantica (discorsiva, linguistica, culturale…): evidente qui il debito heideggeriano, mai adeguatamente riconosciuto dal filosofo, con la tradizione mistico-speculativa tedesca, da Eckhart a Silesius (nonostante la sua quasi totale ignoranza della tradizione rinascimentale e dell’umanesimo “tragico” italiano).
"Mi piace""Mi piace"
caro Inchierchia,
ho colto il suggerimento, infatti ho citata la sua citazione da Heidegger su che cosa è l’origine dell’opera d’arte, e che già porre la domanda implica il perdere di vista la sua abissale profondità… il fatto è che quando si parla ad un pubblico di persone ‘normali’, cioè non a letterati, riesce difficile parlare in modo non generico di certe cose… e allora ho citato degli aneddoti, come quello del poeta giapponese Kikuo Takano il quale a chi gli chiedeva come mai non avesse scritto poesie lungo un intervallo di circa trenta anni, lui rispose che le parole non gli erano venute a visitarlo perché in quei decenni l’imperversare dello sperimentalismo linguistico in Europa gli aveva reso impossibile scrivere poesie. E le poesie erano venute a visitarlo allorché la cultura dello sperimentalismo volgeva al suo esaurimento.
Poi Luciano Nota ha letto una poesia di Donatella Costantina Giancaspero e una mia su Pasolini. Ho detto che le parole abitano una loro patria metafisica e che rifuggono da una loro utilizzabilità, rifuggono ad una pratica discorsiva utilitaristica, le parole della poesia non sono degli utilizzabili, nn possono essere utilizzate al pari degli oggetti, come meri strumenti… le parole della poesia non sono degli strumenti che possono essere utilizzati per comunicare alcunché, in quanto scopo della poesia non è la comunicazione di contenuti ma comunicazione spirituale, e questo, ho ricordato, lo diceva un filosofo marxista, anche se non ortodosso, come Benjamin.
Ho potuto notare con soddisfazione che il pubblico, in larga parte femminile, è stato attento e partecipe.
Alla domanda di Luciano Nota di dire qualcosa sui poeti italiani di oggi conosciuti dal largo pubblico, ho preferito non citare nessun nome per non personalizzare eccessivamente questioni che attengono a problematiche di una intera epoca storica. E mi sono soffermato sul problema della intervenuta fine di un’epoca, quella della critica, sostituita dalla attività delle schedine editoriali promosse dagli uffici stampa degli editori. Fenomeno esiziale ed inquietante, nondimeno, però che ha dei risvolti, paradossalmente, anche positivi: la liberazione della forma-poesia dai canoni e mini canoni; la fine del novecento con il suo portato di etichette commerciali e pubblicitarie, la poesia come marchio, target, affine alla attività pubblicitaria, la poesia come intrattenimento ludico facoltativo, lo slam poetry, la poesia cosiddetta performativa, la poesia da intrattenimento nei caffè letterari, la poesia medicamentosa etc.
"Mi piace""Mi piace"