
Che cosa sono le cose? Si chiese Talete di Mileto (Letizia Leone)
Letizia Leone
Due miei inediti da un libro in costruzione:
Che cosa sono le cose? Si chiese Talete di Mileto
e inaugurò il pensiero. Sotto un platano.
Ma la natura non era ancora natura, era Erba.
Verde accecante.
La magnificenza di una rosa nella mano sinistra,
quanta inguaribile superiorità dell’umano.
In cucina è stata crocefissa una gallina.
*
Talete. Già questo fatto del domandare
Là sotto il platano altissimo lo riportò indietro.
Di nuovo povero e scalzo.
Stamattina a tre euro hai comprato una rosa.
Una rosa filosofica.
Per ciò che riguarda la metafora (“una picciola favoletta”) sarebbe utile anche ricordare il pensatore della “Scienza nuova” che sta all’origine dell’estetica moderna, Giambattista Vico, il quale delega alla metafora una funzione generativa del linguaggio ( !) oltre che conoscitiva: “Poiché i primi motivi che fecero parlare l’uomo furono passioni, le sue prime espressioni furono tropi. Il linguaggio figurato fu il primo a nascere, il senso proprio fu trovato per ultimo”.
Tanto che Cassirer considerò il Vico il fondatore della moderna filosofia del linguaggio.
L’uomo primitivo “poeticamente abita” il mondo, lo stare tra le cose del mondo si configura come atto poetico originario, prodotto dalla percezione e dall’immaginazione, da “vivido senso” e “corpolentissima fantasia” per dirla con Vico. Questo atteggiamento mitopoietico, spiegherà la logica poetica del pensiero, la poesia come modo fondamentale del conoscere, una modalità della coscienza…
Qui solo qualche accenno da approfondire data la vastità della questione

Marie Laure Colasson, Abstract, monocolore, La struttura dissipativa
Giorgio Linguaglossa
Penso che la struttura dissipativa e il polittico siano i corrispondenti speculari della nostra odierna forma-di-vita. Leggiamo una pagina di Giorgio Agamben.
Giorgio Agamben
Ho tra le mani il foglio di un giornale francese che pubblica annunci di persone che cercano di incontrare un compagno di vita. La rubrica si chiama, curiosamente, «modi di vita» e contiene, accanto a una fotografia, un breve messaggio che cerca di descrivere attraverso pochi, laconici tratti qualcosa come la forma o, appunto, il modo di vita dell’autore dell’inserzione (e, a volte, anche del suo destinatario ideale).
Sotto la fotografia di una donna seduta al tavolo di un caffè, col volto serio – anzi decisamente malinconico – poggiato sulla mano sinistra, si può leggere: «Parigina, alta, magra, bionda e distinta, sulla cinquantina, vivace, di buona famiglia, sportiva: caccia, pesca, golf, equitazione, sci, amerebbe incontrare uomo serio, spiritoso, sessantina, dello stesso profilo, per vivere insieme giorni felici, Parigi o provincia».
Il ritratto di una giovane bruna che fissa una palla sospesa in aria è accompagnato da questa didascalia:
«Giovane giocoliera, carina, femminile, spirituale, cerca giovane donna 20/30 anni, profilo simile, per fondersi nel punto G!!!». A volte la fotografia vuole dar conto anche dell’occupazione di chi scrive, come quella che mostra una donna che strizza in un secchio uno straccio per pulire i pavimenti: «50 anni, bionda, occhi verdi, 1m60, portiera, divorziata (3 figli, 23, 25 e 29 anni, indipendenti). Fisicamente e moralmente giovane, fascino, voglia di condividere le semplici gioie della vita con compagno amabile 45/55 anni». Altre volte l’elemento decisivo per caratterizzare la forma di vita è la presenza di un animale, che appare in primo piano nella fotografia accanto alla sua padrona:
«Labrador gentile cerca la sua padroncina (36 anni) un padrone dolce appassionato di natura e di animali, per nuotare nella felicità in campagna». Infine il primo piano di un volto su cui una lacrima lascia una traccia di rimmel recita: «Giovane donna, 25 anni, di una sensibilità a fior di pelle, cerca un giovane uomo tenero e spirituale, con cui vivere un romanzo-fiume».
L’elenco potrebbe continuare, ma ciò che ogni volta insieme irrita e commuove è il tentativo – perfettamente riuscito e, nello stesso tempo, irreparabilmente fallito – di comunicare una forma di vita. In che modo, infatti, quel certo volto, quella certa vita potranno coincidere con quel corsivo elenco di hobbies e tratti caratteriali? È come se qualcosa di decisivo – e, per così dire, inequivocabilmente pubblico e politico – fosse sprofondato a tal punto nell’idiozia del privato (corsivo mio), da risultarne per sempre irriconoscibile.
Nel tentativo di definirsi attraverso i propri hobbies emerge alla luce in tutta la sua problematicità la relazione fra la singolarità, i suoi gusti e le sue inclinazioni. L’aspetto più idiosincratico di ciascuno, i suoi gusti, il fatto che gli piaccia così tanto la granita di caffè, il mare d’estate, quella certa forma delle labbra, quel certo odore, ma anche la pittura di Tiziano vecchio – tutto ciò sembra custodire il suo segreto nel modo più impenetrabile e irrisorio.
Occorre sottrarre decisamente i gusti alla dimensione estetica e riscoprire il loro carattere ontologico (corsivo mio), per ritrovare in essi qualcosa come una nuova terra etica. Non si tratta di attributi o proprietà di un soggetto che giudica, ma del modo in cui ciascuno, perdendosi come soggetto, si costituisce come forma-di-vita. Il segreto del gusto è ciò che la forma-di-vita deve sciogliere, ha sempre già sciolto e esibito – come i gesti tradiscono e, insieme, assolvono il carattere.1]
1] G. Agamben, L’uso dei corpi, Neri Pozza, Vicenza, 2014, pp. 293-294
[Lucio Mayoor Tosi, Compositions]
Chiedo ai lettori: c’è un nesso e qual è se c’è, che lega la nostra odierna forma-di-vita alla struttura dissipativa e al polittico tipici della nuova ontologia estetica?
È la metafora che fonda il linguaggio. È la Figura che fonda la poesia. È il nome che «chiude» il linguaggio, che lo arresta, perché non si può andare oltre il nome. Il nome è la barriera contro cui si infrange la significazione.
Non ci sono vie di mezzo, non si può essere diplomatici su queste questioni, altrimenti si fa poesia mimetico-neorealistica, poesia memoriale-realistica o sperimentalismo post-moderno.
Marina Petrillo
Irraggiungibile approdo tra diafanie prossime alla perfezione.
Digrada il mare all’estuario del sensibile
tra risacche e arse memorie.
Si muove in orizzonte il trasverso cielo.
Fosse acqua il delirio umano perso ad infranto scoglio…
Sconfinato spazio l’Opera in Sé rivelata.
Conosce traccia del giorno ogni creatura orante
ma antepone al visibilio il profondo alito se, ingoiato ogni silenzio,
ritrae a sdegno di infinito, il brusio della spenta agone.
E’ nuovo inizio, ameno ritorno alla Casa della metamorfosi.
Saprà, in taglio obliquo, se sostare assente o, ad anima convessa,
convertire il corpo degli eventi in scie amebiche.
Un soleggiare lieve, di cui non sempre appare l’ambito raggio.
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera
.
Per struttura dissipativa (o sistema dissipativo) si intende un sistema termodinamicamente aperto che lavora in uno stato lontano dall’equilibrio termodinamico scambiando con l’ambiente energia, materia e/o entropia. I sistemi dissipativi sono caratterizzati dalla formazione spontanea di anisotropia, ossia di strutture ordinate e complesse, a volte caotiche. Questi sistemi, quando attraversati da flussi crescenti di energia, materia e informazione, possono anche evolvere e, passando attraverso fasi di instabilità, aumentare la complessità della propria struttura (ovvero l’ordine) diminuendo la propria entropia (neghentropia).
Il termine “struttura dissipativa” fu coniato dal premio Nobel per la chimica Ilya Prigogine alla fine degli anni ’60. Il merito di Prigogine fu quello di portare l’attenzione degli scienziati verso il legame tra ordine e dissipazione di entropia, discostando lo sguardo dalle situazioni statiche e di equilibrio, generalmente studiate fino ad allora, e contribuendo in maniera fondamentale alla nascita di quella che oggi viene chiamata epistemologia della complessità. In natura i sistemi termodinamicamente chiusi sono solo un’astrazione o casi particolari, mentre la regola è quella di sistemi termodinamicamente aperti, che scambiano energia, materia e informazione con i sistemi in relazione e, grazie a questo scambio, possono trovarsi in evoluzione.
Fra gli esempi di strutture dissipative si possono includere i cicloni, la reazione chimica di Belousov-Zhabotinskyi, i laser, e – su scala più estesa e complessa – gli ecosistemi e le forme di vita.
Un esempio molto studiato di struttura dissipativa è costituito dalla cosiddette celle di Bénard, strutture che si formano in uno strato sottile di un liquido quando da uno stato di riposo ed equilibrio termodinamico viene riscaldato dal basso con un flusso costante di calore. Raggiunta una soglia critica di temperatura, alla conduzione del calore subentrano dei moti convettivi di molecole che si muovono coerentemente formando delle strutture a celle esagonali (ad “alveare”). Con le parole di Prigogine:[1]
«L’instabilità detta “di Bernard” è un esempio lampante di come l’instabilità di uno stato stazionario dia luogo a un fenomeno di auto-organizzazione spontanea».
Le strutture dissipative
Alla fine del XX secolo, Ilya Prigogine ricevette il premio Nobel per le sue scoperte sulle “strutture dissipative”. Le sue ricerche sulle leggi che regolano il funzionamento dei sistemi l’avevano portato ad addentrarsi nel campo della termodinamica, dove da più di un secolo gli scienziati osservavano un’apparente contraddizione tra due leggi naturali. Infatti, la seconda legge della termodinamica dichiara che il grado di disordine, di casualità o di caos, chiamato entropia, cresce costantemente nell’universo. D’altro canto si osserva però che molti aspetti della vita, inclusa la Vita stessa, crescono e diventano sempre più ordinati, meno casuali. Da un bel pezzo gli scienziati si chiedevano come potesse accadere che alcune cose si evolvessero, si strutturassero sempre di più e crescessero, mentre la tendenza generale dell’universo sembrava andare nella direzione opposta.
Fu allora che Prigogine fu indotto a definire i cosiddetti “sistemi aperti”, cioè sistemi che hanno la capacità di scambiare energia e materia con il loro ambiente. Qualsiasi sistema “vivente” o in crescita nell’universo può essere considerato tale: un fiore che spunta, un’organizzazione che si arricchisce, una società che si struttura, un ecosistema che si sviluppa, un pianeta che si muove nello spazio, o… un essere umano che si evolve attraverso i continui scambi, a vari livelli, con il suo ambiente.
Una caratteristica comune di questi sistemi “aperti” è che sono in grado di mantenere la loro struttura e persino di crescere e di evolversi in sistemi ancora più complessi perché sono capaci di adattare le loro strutture in base agli scambi che effettuano con l’ambiente, il quale assorbe il loro disordine. In altri termini, ciò significa che hanno la capacità di “dissipare la loro entropia” nell’ambiente. In questo modo la quantità globale di entropia effettivamente cresce, rispettando alla fine la seconda grande legge della termodinamica. In compenso, questi sistemi mantengono il loro ordine, e addirittura lo accrescono, a spese, entropicamente parlando, del loro ambiente, e perché ciò accada i sistemi aperti devono possedere qualità come la flessibilità, la fluidità e la capacità di adattarsi alle fluttuazioni dell’ambiente.
Il punto di biforcazione
– Eppure, ed è qui che tocchiamo un primo punto chiave molto importante per il nostro discorso, questa capacità di adattamento ha i suoi limiti. Esiste una soglia di adattabilità oltre la quale il sistema non è più in grado di adattarsi, cioè di dissipare l’entropia per mantenere il proprio equilibrio e la propria crescita. Questo limite dipende dalla complessità del sistema, dal suo grado di evoluzione, dalla complessità e dalla flessibilità della sua organizzazione interna. Quando l’impatto esterno diventa troppo forte e viene superato questo limite di adattamento, il sistema, al suo interno, diventa instabile e caotico.
– Ed ecco un secondo punto chiave: se l’impatto continua ad essere troppo forte, il sistema registra una tale instabilità che si ritrova per un attimo in uno stato di fluttuazione estremamente delicato.
In quel momento la minima influenza può indurre un’infinità di risposte possibili, e il sistema diventa imprevedibile nelle sue reazioni. Alla fine, in queste condizioni molto particolari, il sistema, secondo l’espressione usata da Prigogine, giunge a un “punto di biforcazione”. Si presentano allora due possibilità:
– o collassa completamente e scompare, dissolvendosi nell’ambiente;
– o si riorganizza completamente, ma a un livello superiore.
– Ed ecco un terzo punto chiave: la caratteristica sorprendente di questa organizzazione completamente nuova è che non ha niente a che vedere con l’organizzazione precedente, e non ne costituisce affatto un miglioramento o una continuazione dotata di maggior capacità di adattamento. Viene ricreata su princìpi completamente diversi, che non hanno assolutamente alcun legame con quelli precedenti, perché funzionano all’interno di un’altra realtà. E quello che viene chiamato “salto quantico”.
Il concetto, dovuto a Prigogine, di “strutture dissipative” soggette a “biforcazioni” periodiche non lineari porta un contributo enorme alla comprensione scientifica del nostro mondo, permettendo di descrivere il processo evolutivo di qualunque sistema aperto, in qualunque punto del nostro universo. Tale processo si ripete milioni di volte ogni minuto nelle nostre cellule; presiede anche all’evoluzione dei regni della natura, dei pianeti, delle galassie, e in particolare… della nostra coscienza di esseri umani.
http://www.mauroscardovelli.com/PNL/Consapevolezza_di_se/Strutture_dissipative.html
L’utilità e l’importanza del concetto di entropia nei sistemi sociali, così come in quelli fisici e biologici, diventa evidente quando si fanno certe considerazioni. Nel mondo fisico la “freccia del tempo” sembra puntare verso un inevitabile aumento dell’entropia, in quanto gli atomi e le molecole di cui è costituito il mondo tendono verso la loro configurazione più probabile, e il disordine aumenta. La vita, al contrario, dalla sua prima apparizione fino allo sviluppo e all’evoluzione delle società umane complesse, rappresenta una diminuzione, invece che un aumento, di entropia, cioè partendo dal disordine tende verso un ordine sempre maggiore. La seconda legge della termodinamica sembra implicare un decadimento finale dell’universo, mentre la vita è un movimento nella direzione opposta.
Talvolta la vita viene considerata semplicemente una manifestazione locale di diminuzione dell’entropia, senza implicazioni per l’intero universo, cioè soltanto come una via più tortuosa verso la fine inevitabile. Tuttavia alcuni scienziati contestano questa ipotesi. A esempio il chimico belga Ilya Prigogine ha dedicato i suoi studi ad allargare il campo della termodinamica in modo da includere gli organismi viventi e i sistemi sociali. Prigogine, che ha vinto il premio Nobel per la chimica nel 1977, ha sviluppato modelli matematici di quelle che lui chiama strutture dissipative, cioè sistemi in cui l’entropia decresce spontaneamente. Tali sistemi sono stati osservati in certe reazioni chimiche e trasformazioni fisiche, così come nel fenomeno della vita. Il termine dissipativo si riferisce alla loro capacità di dissipare entropia nell’ambiente circostante, aumentando perciò il loro ordine interno. Le idee matematiche di Prigogine, e le conseguenze riguardanti l’interazione creativa fra energia e materia, hanno attirato l’attenzione dei sociologi e degli economisti, così come dei fisici e dei biologi. *
* da https://statidicoscienza.wordpress.com › 1967/04/18 › strutture-dissipative
Paola Renzetti
Il poeta si trova a suo agio tra le stranezze. Da sempre è un “trovatore” casuale ed estraneo ai più (perché così è fatto-costituito) di cose che differiscono tra loro e dall’insieme dato, convenzionale, delle forme di vita unanimemente condivise.
E’ anche un dissipatore di energia, fino allo stremo. Un creatore o ricreatore?! Come sono tutti gli umani (poveri tutti) e in particolare gli artisti. L’artista è uno degli esseri più fragili, più “esposto” che esista. Per questo a volte non gli rimane che il silenzio o il nascondimento, o la comunicazione fra “pari”.
Penso al polittico, come composizione in parti, un discorso, una “storia”, materia, colore, scansione, ordine, proposta, celebrazione, polifonia, pretesa di durata oltre i tarli del tempo. Forse lo era anche La tempesta di Giorgione.
Tipico della pittura o della poesia (Poliziano? Stanze – qualcosa che delimita e insieme apre), non può prescindere dall’immagine, dalla visione, dalla metafora – linguaggio-gesto-fantasia come fecero i nostri antenati nelle grotte. Siamo quelli là, ancora, in un certo senso. Da là veniamo. Dissipazione e sempre nuova creazione.
Franceso Paolo Intini
A mio parere una metafora non è altro che un cristallo dotato di simmetria per cui due concetti come due parti di un oggetto si corrispondono. Ed è davvero incredibile come il linguaggio poetico possa intrecciarli! Un esempio di quello che penso:
(…) Io ho sponde basse
Se la morte sale di due centimetri vengo sommerso
(Carillon, T. Tranströmer)
La prima corrispondenza è tra soggetto e barca con le sponde basse.
La seconda è tra l’acqua di un fiume o del mare e la morte.
La terza tra la possibilità di turbolenza o marea e l’ineluttabilità della morte
La quarta tra la fragilità della condizione umana e il viaggiare in barca.
Un cristallo, per stare a Prigogine, tra le forme organizzate è l’oggetto che forse più di tutti, dissipa entropia.
Infatti, il terzo principio della termodinamica, non meno importante dei primi due, recita che allo zero assoluto il valore della sua entropia è zero.
Non è difficile osservare la deposizione di cristalli. Il ghiaccio ne è un esempio. Nella sua formazione c’è una parte di calore che si disperde e fa aumentare l’entropia dell’ambiente. Nel bilancio finale tra diminuzione nel cristallo e aumento nell’ambiente c’è sempre un segno positivo che spinge spontaneamente il processo portando ad un aumento complessivo del disordine nell’universo.
Lo stesso calore lo si riconosce nella costruzione del verso di sopra come qualcosa che scioglie l’attenzione e coinvolge i sensi fino a presentarsi alla vita del lettore, scompaginando le sue strutture portanti.
Sottopongo a tale proposito una mia vecchia poesia, pubblicata su web nel 2017 e dunque in epoca non NOE. Un caro saluto.
Poeti, strane creature (2017)
Poi ci sono i poeti, tra le stranezze e le fonti di calore.
Recitano, scrivono, imbrattano muri come colombi felici
e incendiano le notti nelle periferie.
Non c’è pace tra loro ed il patrimonio.
Faranno le loro cose sempre nell’erba,
porgeranno la mano tra le auto e allatteranno i bimbi al seno.
Incuranti dei gas ai semafori,
si faranno attraversare dalla follia dell’estraneità verso qualunque società.
Non c’è più grande storpiatura di una cravatta al collo di un colombo di città.
Gendarmi vengono per mettere ordine.
Sono numeri. Non c’è pace tra numeri e poeti.
Non è il timore delle persone,
ma la paura che l’errore venga preso per modello.
Il calore-non tutto-è soltanto scarto,
irrecuperabile degrado di una forza che spinge in un seme di margherita.
I numeri hanno il manganello, il fascismo scritto nelle menti,
il potere di scrivere punto nella natura delle cose.
L’esattezza ed il rigore del calcolo costituiscono il “fatto”, non il verso.
La guerra ha visto perdite incolmabili!
Nei fumi delle ciminiere sono passati Rimbaud, Baudelaire, Campana, Majakovskij e gli altri scheletri
Perché fanno conferenze su questi signori?
Perché hanno rifiutato il potere, si sono messi di traverso?
Che soffi un sottile caldo spirito nella serpe del mondo?
Niente è eccezionale, niente sfugge alla potenza delle cifre.
Fa così piacere spargere lacrime dunque,
che vien voglia di conservarle, pesarle e venderle.
L’organizzazione è perfetta.
Il logo dice: sterminateli tutti e vendetene gli occhiali, le protesi d’oro…
C’ è più Mein Kampf in un’equazione di primo grado che nel Novecento.
Ma la matematica è molto di più di una proporzione a portata di bambino
Ed i poeti?
Sono in questo tentativo di dare addosso alla forza che scrive morte, dissolvimento.
Rispondendo:-Bellezza!
e recuperandola dal secchio dell’inservibile.
Ecco, tutto qui: potere contro potere,
lotta tra chi ha più diritto sulle leve del comando.
E la bellezza è il potere supremo,
la moneta con cui il poeta diventa padrone del disordine universale
Sottrarla alla spontaneità del dissolvimento è la posta in gioco.
Giuseppe Talìa
A proposito della questione metafora, se essa sia precedente al linguaggio, dentro il linguaggio stesso, oppure collocata in una zona fluida quindi in sé e al contempo fuori di sé, mi pare che l’affermazione di Linguaglossa, “è la metafora che fonda il linguaggio”, sia pertinente. Se la metafora precede il linguaggio, allora essa lo fonda, senza di essa non ci sarebbe linguaggio (realtà,come la traduci? Il pensiero, come lo comunichi? attraverso il linguaggio impregnato di metafora). Di conseguenza, fondandolo il linguaggio lo permea e quindi la metafora è dentro il linguaggio stesso. Ma la metafora è anche fluida, essendo fondazione e permeazione, nel senso di penetrazione e moltiplicazione, essa è dentro e fuori al contempo.
Leggendo un saggio di Raffaella Scarpa, Secondo Novecento: lingua stile metrica, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011, riguardo alle tecniche reticenti, essendo la “reticenza” affidata alla capacità interpretativa, «se si considera l’ampiezza della mossa cooperativa prevista da alcune figure quali l’ellissi, la litote, la preterizione, la perifrasi, l’eufemismo si vede come nella reticenza tale ampiezza sia massima» (C. Caffi, Reticenza, in Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica, a cura di G.L. Beccaria, Torino, Einaudi, 1994)
Ecco che la reticenza diventa la figura del “silenzio” per eccellenza. La pausa tra un frammento (rumoroso) e l’altro, come può essere la pausa tra un distico di pensiero concluso e l’altro successivo legati non solo dal silenzio reticente come anche da un successivo fragore pensiero che del primo ne riprende o ne lascia totalmente soggetto e oggetto.
Questa è una parola che si aggirava accanto alle parole,
una parola sul modello del silenzio
(P. Célan)




















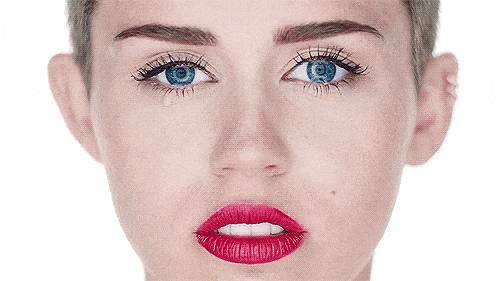
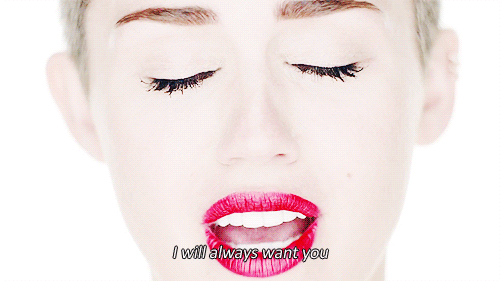


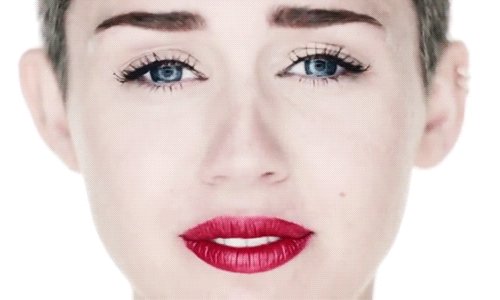








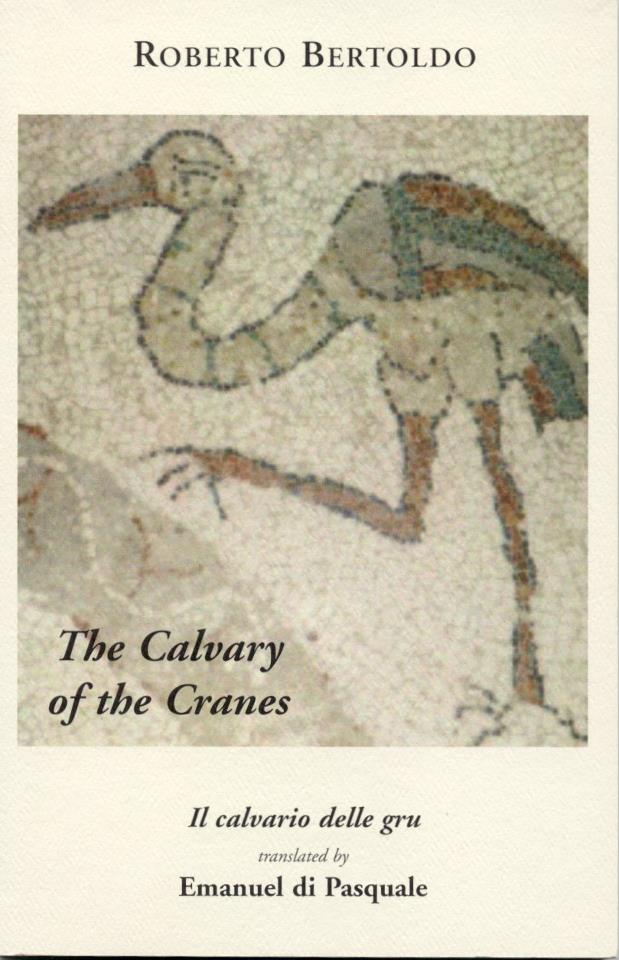
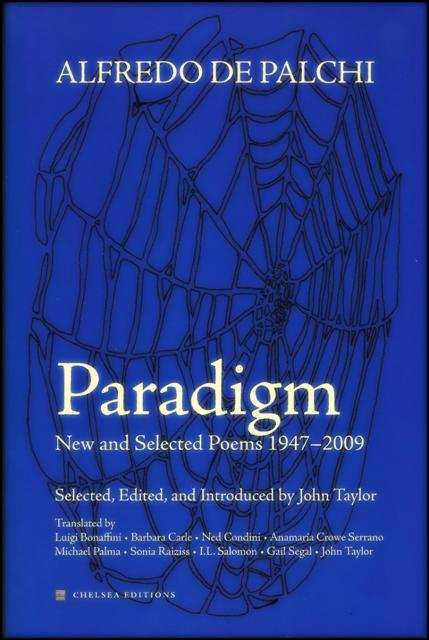


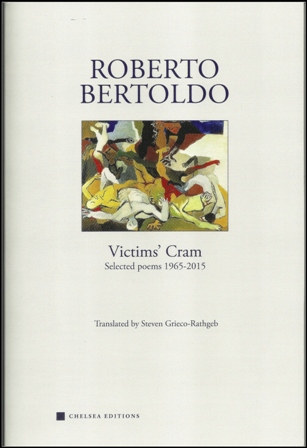





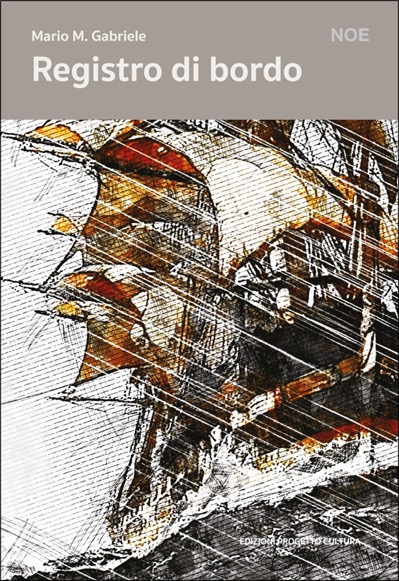

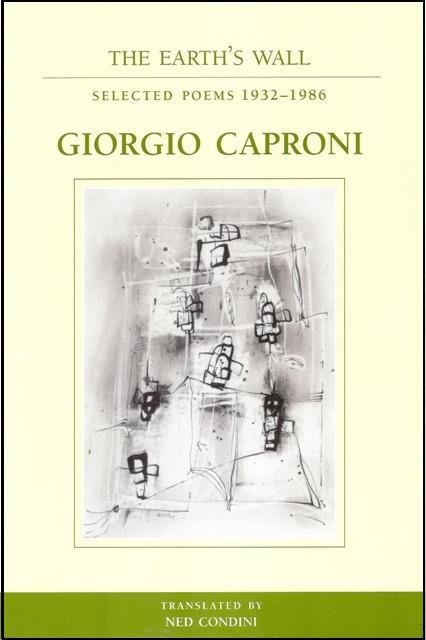
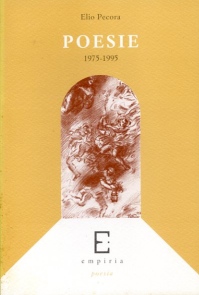

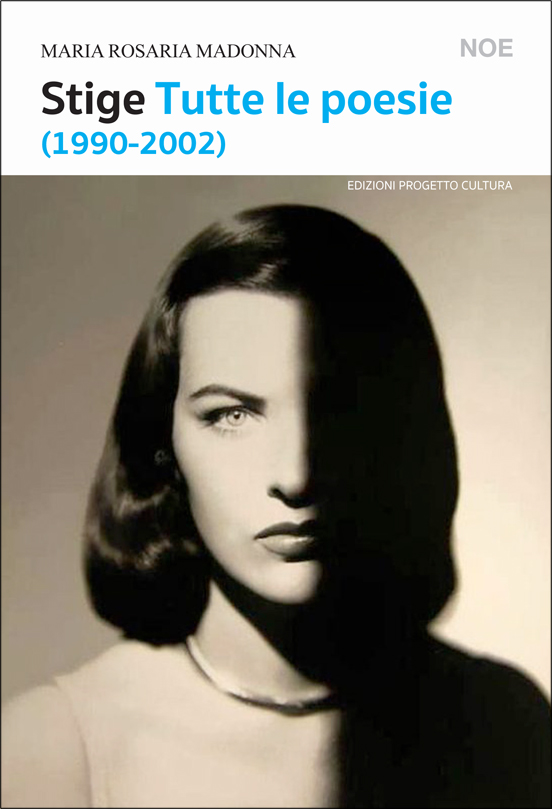

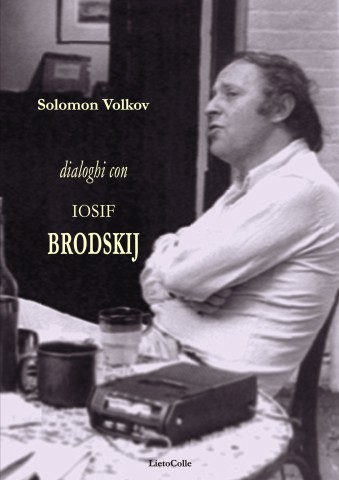




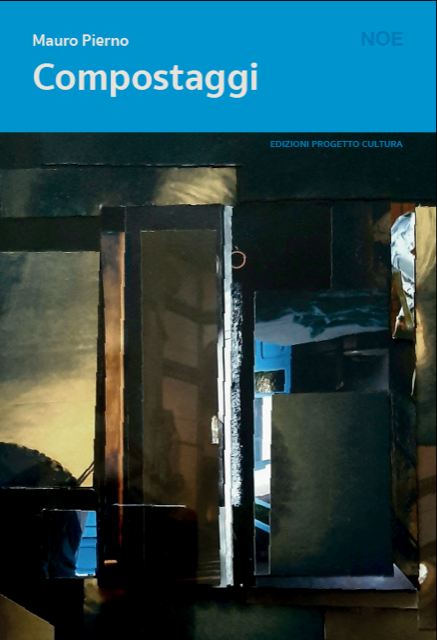




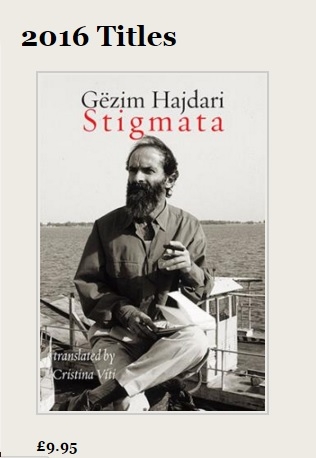






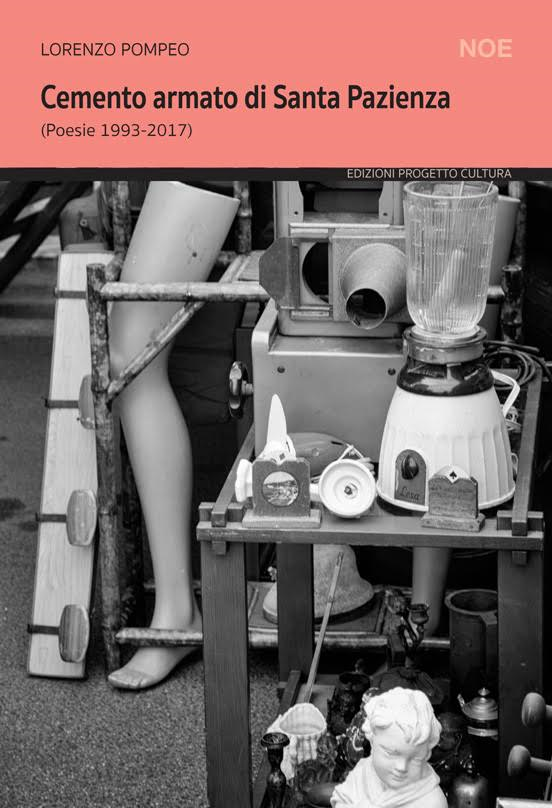







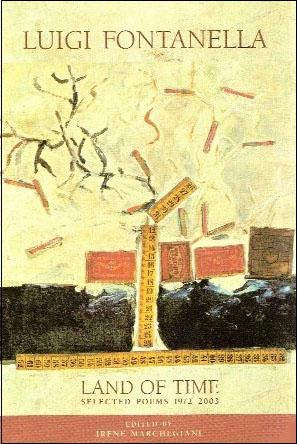








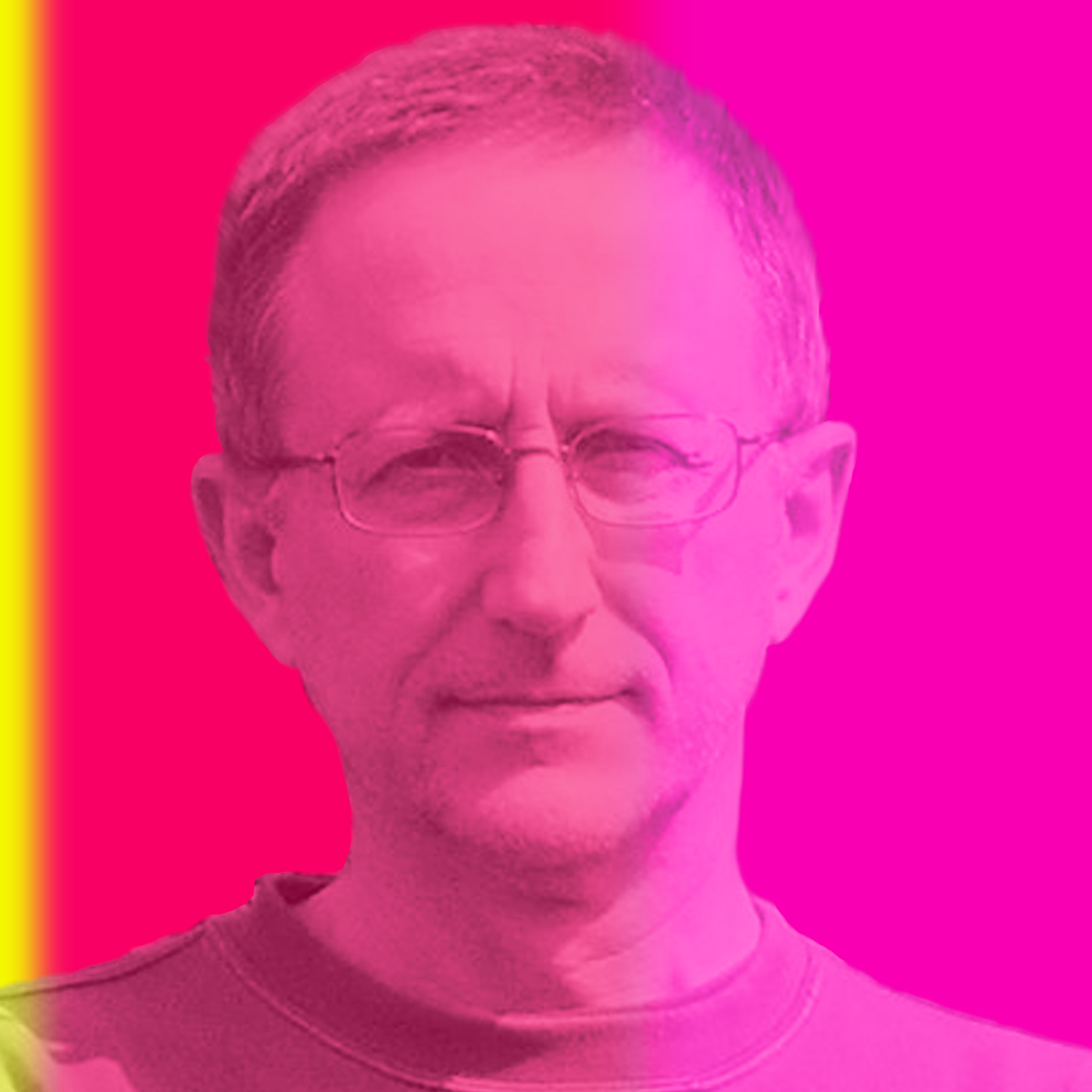







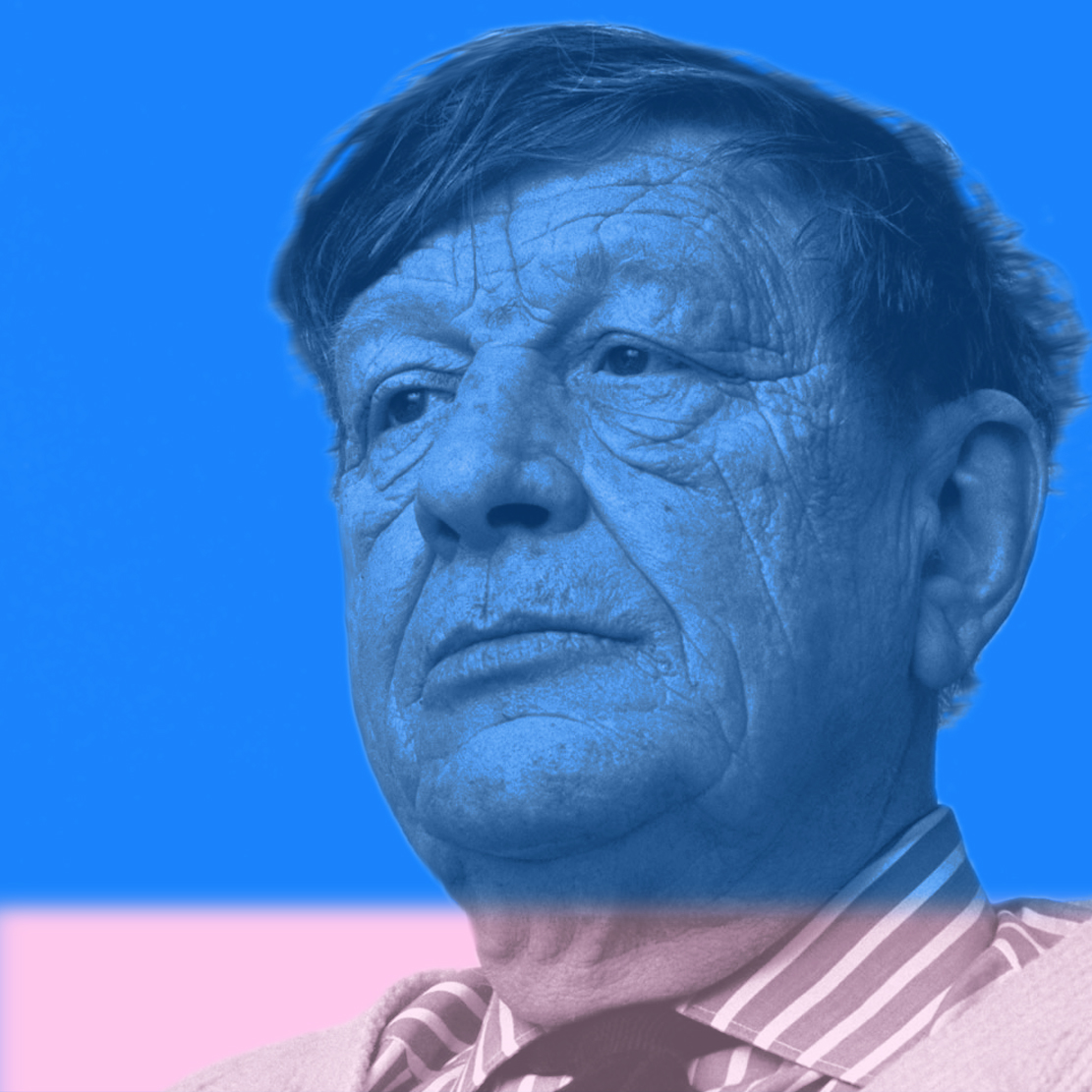





















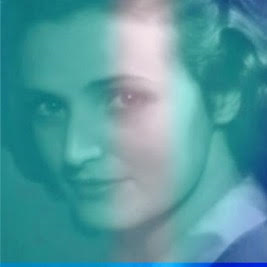































Questi modelli teorici delle scienze sono affascinanti. Pur nella grande ignoranza che ci connota (parlo in prima persona) sentiamo che riguardano la nostra stessa vita, concepita nella sua interezza. Gettano ogni volta uno sguardo su noi stessi, sul funzionamento dei sistemi sociali,sulle nostre interazioni con l’ambiente e gli effetti che esse producono. Le scienze stesse sono soggette a queste continue ridefinizioni del loro procedere. Si trovano di fronte all’imprevisto, alla necessità di dover abbandonare man mano sistemi di interpretazione di funzionamento del reale, perché superati. Quello che vale per le scienze, perché non dovrebbe valere anche per le nostre esistenze, per la scrittura? A un certo punto l’equilibrio raggiunto (anche sotto la spinta di influssi esterni, apparentemente insignificanti o sconvolgenti) non regge più, si trovano strade nuove, e non senza fatica. Se materialmente si resta dove si è, si è comunque diversi. Anche per la scrittura( la forma espressiva umana più complessa), per la poesia, si può assumere accanto ad altri, il modello teorico (sempre parziale non definitivo) della “dissipazione”. Dissipazione con infinite sfaccettature. Il nesso, il legame sta prima di tutto nella consapevolezza del processo stesso, che può generare così (o comunque?!) un senso, a parte la stanchezza serale!
"Mi piace""Mi piace"
Confesso che non riesco a comprendere cosa Agamben, citato da Linguaglossa, voglia dire quando afferma che il soggetto “perdendosi come soggetto, si costituisce come-forma-di vita”.
Zona gaming 16
Quanti sogni fanno un uomo?
Bla bla bla… occasione lampo, occasione flash.
La luce in fondo al tunnel
è un aspirapolvere di anime.
Ci sono gli uccelli della notte e quelli del giorno.
E attraversano il tempo a colpi d’ala.
Dov’è la metafora? Ancora bla bla bla…
oppure bel blu bli blo bil bol bul o bal o ble…
Zona gaming
… compra una vocale o una consonante?…
Lilli era rimasto senza…
aveva gli occhi oscuri.
Anche il colubro s’attorce sulle proprie spire
e s’incurva per spiare l’enigma che indossa.
-Ti faccio male?
-Ancora no! Ma potresti!
Zona gaming
…Nemo submovit peplum meum…
Adesso sposerò una strofa. E sarà la mia morte
dentro lo specchio della nostra assenza.
-Ti faccio male?
-Un po’!
C’è un silenzio di roccia intorno ai tasti.
L’aria stremata non respira.
Ai semafori un andirivieni di cyborg anemici…
-Perché mi fai male?
Zona gaming
… fesbucchiamo! Fesbucchiamo… ancora…
"Mi piace""Mi piace"
Ilya Prigogine ha allargato il campo di applicazione del concetto di “struttura dissipativa” ben oltre il campo della termodinamica, alle strutture biologiche e sociali.
Anche noi, penso, dobbiamo arricchire il nostro bagaglio concettuale con concetti presi dalla ricerca scientifica. Perché no? Perché dovremmo rinunciare alla esplorazione intellettuale? Io, ad esempio ho composto in questi ultimi anni una serie di quadri astratti dove non compaiono forme figurative ma forme eidetiche, striature, strisce, spigoli illuminati, risvolti di forme oscurate, e anche semicerchi o forme pseudo rotonde che si rivelano da un fondale oscurato o in via di oscuramento totale.
Mi sono chiesta spesso cosa significassero queste formazioni a-figurative.
A un certo punto della mia ricerca ho capito che ero (e sono) impegnata nella stipulazione di senso, di un senso, o di sensi, ma non di significati, che il senso o i sensi sono indipendenti dai significati… A un certo punto della mia riflessione ho capito che quelle forme che si muovono in uno spazio di albume, in uno spazio liquoroso altro non erano che “strutture dissipative”, strutture che tendevano alla stabilità, che nascevano da una instabilità, diciamo così, termodinamica e che apportavano alla instabilità generale un quantum di fugace stabilità, subito insidiata dalla instabilità delle masse bio-energetiche. Ed è ovvio che in questo movimento di masse biodegradabili o dissipative ciò che risulta assente sia il soggetto, il soggetto come riferimento del senso o dei sensi. Allora, ho compreso che quelle figurazioni astratte si erano liberate del soggetto, erano state rese indipendenti dal soggetto.
Bisogna “perdersi come soggetto” per giungere ad una forma superiore di soggettività… E così ho capito che i miei lavori erano delle strutture dissipative.
"Mi piace""Mi piace"
da Focus
L’uomo che sfida Einstein
Un fisico olandese, Erik Peter Verlinde, ribalta secoli di studi sulla gravità. Per chiarire un mistero irrisolto: la materia oscura
Il fisico Erik Peter Verlinde, dell’Università di Amsterdam. Afferma che non vediamo la materia oscura perché non esiste.
La gravità è un’illusione. La materia oscura non esiste. E l’universo funziona come un ologramma. A queste radicali conclusioni è giunto, dopo uno studio di sei anni, Erik Peter Verlinde, fisico teorico all’Università di Amsterdam, le cui idee sulla gravità sono radicalmente diverse da quelle accettate, che si rifanno a Newton e Einstein.
Affermazioni azzardate? Provocazioni? Non la pensa così l’European Research Council, la più importante istituzione dell’Unione Europea nel campo della scienza, che ha finanziato la ricerca con oltre 2 milioni di euro. E dall’astronomia arrivano i primi risultati a favore di Verlinde. C’è già chi lo acclama come l’Einstein dei nostri giorni.
Focus gli ha chiesto di spiegare la sua rivoluzionaria interpretazione dell’universo.
CAUSA O EFFETTO.
«La mia è una nuova teoria della gravità», racconta il fisico olandese. «Per Isaac Newton era la forza con cui due corpi dotati di massa, per esempio la Terra e la Luna, si attraggono reciprocamente. Invece la relatività generale di Albert Einstein descrive la gravità grazie alla geometria: una massa deforma lo spazio-tempo nelle sue vicinanze e quindi, per esempio, la Luna orbita attorno alla Terra perché si muove lungo questa curvatura». Un po’ come una biglia segue la pista disegnata sulla sabbia.
Le due differenti visioni sono accomunate dal fatto che considerano la gravità una forza fondamentale. Invece Verlinde ritiene che la gravità sia… un’illusione. Attenzione, questo non vuol dire che non sia reale, altrimenti la proverbiale mela non ci cadrebbe in testa! Però non sarebbe più la causa dei movimenti di stelle e pianeti, bensì un effetto: «Pensiamo alla temperatura. Ritenuta per tanto tempo una grandezza fondamentale, si è poi compreso che deriva dai movimenti di ciascuna della miriade di atomi e molecole che ci compongono». Ma toccando una teiera piena di acqua bollente avvertiamo il calore del recipiente (e magari ci scottiamo), senza percepire i moti delle singole particelle. Allo stesso modo, secondo Verlinde, la gravità è il prodotto di processi microscopici.
INFORMAZIONE.
Che cosa c’è sotto, allora? La risposta si nasconde in uno dei concetti più all’avanguardia della fisica contemporanea: i bit quantistici. Per capire di che cosa si tratta bisogna partire dai “bit”, cioè quelle sequenze di 0 e 1 che sono l’unità base dell’informazione per computer e telecomunicazioni (infatti la velocità della nostra connessione internet si misura in bit al secondo). Le particelle elementari seguono le regole della meccanica quantistica, che per esempio consentono loro di essere contemporaneamente in luoghi e stati diversi (una sorta di “ubiquità”, v. Focus n° 293). Quindi anche le loro caratteristiche devono essere espresse in termini di bit quantistici, o qubit, con i quali si possono svolgere operazioni inaccessibili con i bit classici (v. Focus 295).
Verlinde ha sviluppato una complessa trattazione matematica per analizzare la trasmissione dei qubit a livello microscopico. «Le informazioni associate alla materia e alla sua posizione si influenzano a vicenda», spiega. «Alla nostra scala umana non percepiamo il flusso di informazioni, che cambia istante per istante, ma solo il risultato, cioè materia che muta posizione nel tempo. Ecco come emerge la gravità». Questa visione porta con sé un’altra bizzarria: il cosmo può essere descritto come un enorme ologramma, cioè una rappresentazione in due dimensioni di un oggetto 3D. Verlinde, infatti, esprime l’universo e le relazioni tra le particelle che lo compongono in termini di qubit disposti su un piano: in pratica, è come dire che il cosmo può essere trascritto in un enorme foglio.
OSCURO.
La teoria è ardita, ma ha un punto di forza: spiega in modo naturale le osservazioni astronomiche senza chiamare in causa la materia oscura, oggi ritenuta necessaria dalla maggioranza degli studiosi per spiegare certi fenomeni. Per esempio, in una galassia le stelle sono più addensate verso il centro. Quindi ci si aspetterebbe che, nelle zone periferiche, la forza di gravità diventi più debole e la velocità con cui le stelle orbitano attorno al centro diminuisca, perché sono meno attratte
"Mi piace""Mi piace"
E’ arduo ripensare alla centralità del soggetto (forse non più possibile) ma altrettanto difficile sostenere la sua scomparsa, nella ricerca del senso. Sarebbe la completa disumanizzazione. Qui i poeti ( e non solo loro) si ribellano.
"Mi piace""Mi piace"
cara Paola Renzetti,
cosa vuoi che ti dica?, i letterati che pensano ancora con le parole dell’io mi fanno tenerezza, sono digiuni di cultura, pensano in modo convenzionale e comunicazionale. Se leggessero qualcosa di filosofia…
"Mi piace""Mi piace"
Riscopriamo l’etica. Agamben: “Provate a vivere secondo le vostre idee”
intervista a Giorgio Agamben
a cura di Franco Marcoaldi (la Repubblica, 8 febbraio 2011)
In cosa crediamo? Quali sono le credenze civili, religiose, politiche, scientifiche, su cui si regge la società? La risposta si fa particolarmente difficile in un mondo come il nostro, che vede le credenze tradizionali – oggetto di una costante erosione – trasformarsi in surrogati, con il conseguente dilagare delle più diverse forme di superstizione. Oppure, per converso, il trionfo di uno scetticismo e di un’indifferenza che rasentano il nichilismo.
Proveremo a trattare la questione “credere, credenza”, affrontandola da diversi punti di vista. E partiremo chiedendo l’aiuto di un filosofo italiano di fama internazionale: Giorgio Agamben. «Nella nostra cultura esistono due modelli di esperienza della parola. Il primo modello è di tipo assertivo: due più due fa quattro, Cristo è risorto il terzo giorno, i corpi cadono secondo la legge di gravità. Questo genere di proposizioni sono caratterizzate dal fatto che rimandano sempre a un valore di verità oggettivo, alla coppia vero-falso. E sono sottoponibili a verifica grazie a un’adeguazione tra parole e fatti, mentre il soggetto che le pronuncia è indifferente all’esito.
– Esiste però un altro, immenso ambito di parola del quale sembriamo esserci dimenticati, che rimanda, per usare l’intuizione di Foucault, all’idea di “veridizione”. Lì valgono altri criteri, che non rispondono alla separazione secca tra il vero e il falso. Lì il soggetto che pronuncia una data parola si mette in gioco in ciò che dice. Meglio ancora, il valore di verità è inseparabile dal suo personale coinvolgimento».
Il senso profondo del credere andrebbe dunque ricercato proprio qui?
«Certamente. Anche se, nel corso del tempo, il trionfo del primo modello, quello assertivo, ha di fatto cancellato il secondo. Mi fanno sorridere i confronti, oggi molto in voga, tra credenti e non credenti: veri e propri dialoghi tra sordi, visto che preti e scienziati condividono da versanti opposti lo stesso modello di verità. Poco importa che si discuta di leggi fisiche o teologiche, che naturalmente si elidono tra loro. Si tratta in ogni caso di proposizioni assertive. La confusione tra ciò che possiamo credere, sperare e amare e ciò che siamo tenuti a considerare vero, oggi ci paralizza».
Quando sarebbe stato cancellato il secondo tipo di esperienza con la parola?
«Nella tradizione dell’Occidente, è stato Aristotele ad affermare che la filosofia deve occuparsi soltanto delle proposizioni che possono risultare vere o false. Eppure esisteva ed esiste un’altra esperienza della parola: quella della promessa, della preghiera, del comando, dell’invocazione, che è stata esclusa dalla riflessione filosofica. Naturalmente, ciò non significa che essa non abbia continuato ad agire: il diritto e la religione si fondano su di essa».
Un esempio?
«Il più importante di tutti: San Paolo, che definendo la parola della fede, non fa riferimento a criteri di verità, ma parla di vicinanza tra cuore e labbra. È significativo che, tranne una volta, egli usi sempre l’espressione, da lui inventata, “credere in Gesù Cristo” e non, come sarebbe stato normale in greco, credere che Gesù è il figlio unigenito di Dio, eccetera. -La differenza è sostanziale. La Chiesa, attraverso i suoi concili, ha cercato di fissare la fede in dogma, in un’esperienza di tipo assertivo. E così si è smarrito un tratto fondamentale della natura umana, che esige una fede estranea a una logica puramente fattuale. La vera fede non aderisce a un principio prestabilito ed è singolare che proprio la Chiesa, che doveva preservare questa idea, se ne sia dimenticata. Da qui la formula “Credo perché è assurdo”».
Quali sono i riflessi negativi di tale logica assertiva sulla nostra vita sociale?
«Infiniti. Pensi all’etica: si afferma che per agire bene bisogna disporre di un sistema di credenze prefissato. Dunque, agirebbe bene soltanto colui che ha una serie di principi a cui deve conformarsi. È il modello kantiano, ancora imperante, che definisce l’etica come dovere di obbedire a una legge. Quando lavoravo sull’idea di “testimonianza”, mi colpì la storia di una ragazza che, sottoposta a tortura dalla Gestapo, aveva rifiutato di rivelare i nomi dei suoi compagni. A chi più tardi le chiese in nome di quali principi era riuscita a farlo, rispose soltanto “l’ho fatto perché così mi piaceva”. L’etica non significa obbedire a un dovere, significa mettersi in gioco: in ciò che si pensa, si dice e si crede».
Anche perché, travolta la credenza nell’infallibilità di quella certa legge, rimane un campo di rovine.
«Prima o poi accade a tutte le credenze di tipo oggettivo. E difatti: le credenze politiche si sono letteralmente sbriciolate, quelle teologico-religiose si fossilizzano in dogmi contrapposti. Per quanto riguarda quelle scientifiche, esse risultano completamente irrelate rispetto alla vita etica dei singoli individui».
In Credere e non credere Nicola Chiaromonte formula una domanda secca: si può credere da soli?
«È una domanda pertinente. Che io riformulerei in questo modo: com’è possibile condividere una verità o una fede che non siano di tipo assertivo? Io penso che questo accada nei territori dell’esistenza in cui ci si mette in gioco personalmente. Se la veridizione è lasciata ai margini e il solo modello della verità e della fede diventano la scienza e il dogma, la vita diventa invivibile. Di qui l’indifferenza e lo scetticismo generalizzato, oltre che la tetraggine sociale dilagante. Soltanto procedendo a ritroso, ricercando quella diversa esperienza di parola, si può tornare al rapporto originario con la verità, irriducibile a qualunque sua istituzionalizzazione.
– Le faccio un esempio: la scienza guarda al passaggio dal primate all’uomo parlante unicamente in termini cognitivi, come se fosse soltanto una questione di intelligenza e di volume cerebrale. Ma non c’è solo questo aspetto. La trasformazione deve essere stata altrettanto gigantesca dal punto di vista etico, politico, sensibile. L’uomo non è solo homo sapiens. È un animale che, a differenza degli altri viventi, i quali non sembrano dare importanza al loro linguaggio, ha deciso di correre fino in fondo l’azzardo della parola. E da qui è nata la conoscenza, ma anche la promessa, la fede, l’amore, che esorbitano la dimensione puramente cognitiva».
È una strada ancora aperta?
«L’uomo non ha ancora finito di diventare umano, l’antropogenesi è sempre in corso. Menandro ha scritto: “com’è grazioso – cioè capace di gratuità – l’uomo quando è veramente umano”. È questa gratuità che dobbiamo riscoprire. Tanto più che i modelli di credenza che ci vengono proposti non ci persuadono più. Sono, come diceva Chiaromonte, mantenuti a forza, in malafede».
Proviamo dunque a perimetrare il novero di queste credenze più genuine, anche se sotterranee, sommerse.
«Prendiamo la politica: perché non interroga finalmente la vita delle persone? Non la vita biologica, la nuda vita, che oggi è continuamente in questione nei dibattiti spesso vani sulla bioetica, ma le diverse forme di vita, il modo in cui ciascuno si lega a un uso, a un gesto, a una pratica. Ancora: perché l’arte, la poesia, la letteratura, sono museificate e relegate in un mondo a parte, come se fossero politicamente e esistenzialmente irrilevanti?».
Anche lo scrittore russo Alexandr Herzen lamentava a suo modo la cancellazione dell’esperienza vitale soggettiva. Affermando che crediamo in tutto, tranne che in noi stessi.
«Viviamo in società abitate da un Io ipertrofico, gigantesco, nel quale però nessuno, preso singolarmente, può riconoscersi. Bisognerebbe tornare all’ultimo Foucault, quando rifletteva sulla “cura di sé”, sulla “pratica di sé”. Oggi è rarissimo incontrare persone che sperimentino quella che Benjamin chiamava la droga che prendiamo in solitudine: l’incontro con sé stessi, con le proprie speranze, i propri ricordi e le proprie dimenticanze. In quei momenti si assiste a una sorta di congedo dall’Io, si accede a una forma di esperienza che è l’esatto contrario del solipsismo. Sì, penso che si potrebbe partire proprio da qui per ripensare un’idea diversa del credere: forme di vita, pratica di sé, intimità. Queste sono le parole chiave di una nuova politica».
"Mi piace""Mi piace"
VERITA’ E VERIDIZIONE: PAROLE PER UNA NUOVA POLITICA. — Giorgio Agamben “Il regno e il giardino” (di Antonio Lucci).
10 luglio 2019, di Federico La Sala
Giorgio Agamben “Il regno e il giardino”
di Antonio Lucci (Doppiozero, 14 Giugno 2019)
Michel Foucault, nel suo breve saggio (uscito nel 1984) sui “Luoghi altri”, definì il giardino “un’eterotopia felice”: una definizione forse anche troppo positiva, ma comunque indicativa del fatto che il giardino, per il filosofo francese, rappresentava la realizzazione di una serie di caratteristiche utopiche in un luogo reale, assumendo caratteri spaziali e simbolici fortissimi. Del carattere di luogo simbolico, che dà da pensare, proprio del giardino sembra che i filosofi siano da sempre stati ben coscienti: dal giardino in cui si ritiravano (secondo il motto “vivi nascostamente”) gli epicurei, a quello che consigliava – come ricorda nell’epigrafe al suo ultimo libro anche Giorgio Agamben – di coltivare Voltaire alla fine del suo Candide, passando per il giardino di Herrenhausen ad Hannover, in cui non solo Leibniz amava passeggiare e filosofare, ma che egli stesso contribuì a progettare grazie alle sue conoscenze di matematica e di ingegneria, per fare solo qualche esempio.
Si potrebbe addirittura arrivare a dire che, per comprendere come le società antiche hanno immaginato la propria versione ideale – il proprio paradiso – bisogna guardare al modo in cui esse hanno pensato i propri giardini: il giardino ad Atene era un luogo per la discussione e l’agone scientifico, che corrispondeva agli ideali di democrazia e di paideia propri della cultura greca, mentre il giardino cristiano era hortus conclusus, un luogo in cui le mura proteggevano e al contempo separavano l’uomo dall’esterno, dandogli la sua precisa posizione nel mondo (un mondo in cui la percezione delle barriere, sia fisiche che sociali e culturali, era un tassello psicostorico fondamentale). Il giardino barocco era una sorta di “panottico esterno”, in cui le vie rigidamente disegnate, le piante piegate in forme bizzarre dalla mano umana e l’universale visibilità dall’istanza centrale costituita dal palazzo corrispondevano alla società assolutistica di cui era espressione, quello inglese, invece, con il suo avvicinarsi alla naturalità di una selva, rispecchiava in qualche maniera gli ideali di una società che aveva abolito la monarchia assoluta e cominciava a credere che l’uomo non dovesse essere necessariamente, per natura, indirizzato in maniera univoca nei suoi spostamenti nel mondo.
Non a caso, la parola “paradiso” significa, originariamente, “giardino”: è questo il punto di partenza dell’ultimo libro di Giorgio Agamben. Il filosofo romano rinuncia a un’analisi dei rapporti tra le concrete forme storiche del giardino e i diversi regimi immaginari e ideali politici che le hanno prodotte, per concentrarsi invece su uno specifico giardino: quello dell’Eden.
Tutto Il regno e il giardino, infatti, è una serrata analisi di come, in particolare nella letteratura teologica tardoantica e medievale, il giardino dell’Eden – il paradiso terrestre – sia stato un importante operatore teoretico, usato da autori centrali del canone teologico cristiano – come ad esempio Agostino – al fine di descrivere che cos’è, nella sua struttura più profonda, la natura umana. “Giardino” (o meglio, “Paradiso”) – ci dice Agamben – è il nome che tanto affascinanti quanto spesso dimenticati autori del periodo protocristiano (come Efrem Siro e Sant’Ambrogio) hanno dato alla natura umana, in particolare a quella prima del peccato. Come è noto, a causa del peccato siamo stati banditi dall’Eden, dal Paradiso terrestre: secondo Agamben è proprio questo bando il punto centrale, quando si parla dell’Eden.
Non tanto che esso esista, o il fatto che noi vi abbiamo dimorato (pare, secondo la tradizione teologica, non più di sei ore), quanto il nostro esserne stati cacciati: «Non il paradiso, ma la sua perdita costituisce il mitologema originario della cultura occidentale, una sorta di traumatismo originario che ha segnato profondamente la cultura cristiana e moderna, condannando al fallimento ogni ricerca della felicità sulla terra» (p. 19). Agamben vede nella concezione di Sant’Agostino del peccato originale l’origine della tradizione che si affermerà nel cristianesimo successivo, per cui noi tutti erediteremmo la colpa di Adamo per via fisiologica, e quindi indipendentemente dalle nostre azioni: noi tutti siamo da sempre condannati all’esilio dal Giardino, e questo per colpe non nostre, così come per colpe non nostre siamo condannati al peccato e alla morte. Su questa concezione si basa anche l’idea di una natura umana corrotta per sempre, in tutte le generazioni a venire, da un’azione unica, operata da un singolo: «L’uomo è il vivente che può corrompere la sua natura, ma non risanarla, consegnandosi così a una storia e a un’economia della salvezza, in cui la grazia divina dispensata dalla Chiesa attraverso i suoi sacramenti diventa essenziale» (p. 32). (Se anche Agamben non prende in considerazione qui il tema, si potrebbe allargare il discorso ponendo la domanda relativa a quali conseguenze sulla concezione della colpa e del debito quest’idea agostiniana abbia avuto nella storia del pensiero occidentale). Partendo da quest’idea agostiniana (e anselmiana) Agamben analizza l’affascinante ipotesi connessa con l’idea di una natura umana irrimediabilmente corrotta: quella che – fatta eccezione per le sei ore in cui l’uomo vi abitò felicemente – il Paradiso terrestre sia un giardino vuoto, silenzioso …e fondamentalmente inutile.
Contro quest’idea Agamben analizza il semidimenticato Scoto Eriugena, che – contro Agostino – legge allegoricamente la narrazione della Genesi biblica, interpretando l’Eden come una figurazione della natura umana prima della sua corruzione. La tesi di Eriugena è il doppio specularmente opposto rispetto alla teoria agostiniana del peccato originale ereditario ed eternamente corruttore della natura umana: quest’ultima è stata creata secondo Eriugena da Dio incorrotta e incorruttibile, come lo è il Paradiso terrestre, e solo il peccato è corruzione, ma corruzione legata all’atto e non alla natura dell’agente. L’uomo, col peccato, è uscito dalla propria vera natura, quella assegnatagli da Dio, perché ne ha abusato: in termini metaforici è uscito dal Paradiso, o meglio, non vi è mai stato.
Quindi, non esisterebbe, per Eriugena, una natura corrotta: la natura è da sempre salva, solo che noi ne siamo fin dall’inizio usciti.
Le dispute dei teologi sul Paradiso terrestre, in ultima istanza, ci dice Agamben, sono delle dispute mirate ad articolare il rapporto tra natura e grazia quali dispositivi teorici reciprocamente connessi tramite l’operatore logico del peccato (diversamente interpretato a seconda della direzione che si vuole dare al rapporto tra queste due istanze), e che definiscono la posizione dell’uomo sia nel mondo, che nell’aldilà.
Uno dei capitoli più interessanti del libro è sicuramente quello dedicato alla Divina Commedia di Dante. Agamben decide (non risparmiando alcune righe ferocemente critiche verso la tradizione dantista) di leggere la narrazione dantesca dell’Eden al di fuori e contro il canone interpretativo tomistico e in generale teologico medievale, in quanto vede in esso un «significato immediatamente politico» (p. 68), che fa del Paradiso terrestre una «figura della beatitudine terrena» (p. 71), a cui «Dante – che rappresenta l’umanità – può acceder[e] senza alcun impedimento» (p. 75). Il rapporto tra beatitudine di questo mondo e Giardino viene ripreso anche nell’ultimo capitolo del suo libro da Agamben, che analizza – partendo da Francisco Suárez – la questione di una possibile “politica del Giardino”, ossia l’esperimento mentale per cui – se non avessimo peccato con Adamo – saremmo potuti restare nell’Eden, dovendo poi sviluppare un qualche tipo di organizzazione sociale.
Agamben rileva come le descrizioni di questa possibile “società politica edenica” nei teologi medievali siano assolutamente carenti, derivandone la conclusione che «il paradiso terrestre non costituisce in alcun modo per i teologi un paradigma politico» (p. 106). Da qui ne segue una discussione, tanto teologicamente avvincente quanto complessa da seguire per i non addetti ai lavori, sulle tensioni chiliastiche del cristianesimo, vale a dire sulle interpretazioni date del passo dell’apocalisse per cui Cristo, tornato alla fine dei tempi, regnerà per mille anni con i giusti su questo mondo prima del giudizio finale. La questione è vicina a quella del giardino terrestre, a volte interpretato, nel corso della storia, come allegoria e a volte interpretato come luogo fisico, presente da qualche parte sulla Terra. Ed entrambe le questioni rimandano a quella – per Agamben sempre centrale – della felicità: è possibile, intravedibile, intravista in alcune epoche della storia del pensiero una felicità vissuta, una felicità della vita, di questa vita in questo mondo?
Il libro di Agamben si chiude con questa domanda, quella sulla dantesca «beatitudine di questa vita» (p. 120), una domanda consegnata al lettore di questo bel saggio, da intendere come un ulteriore tassello nel tentativo agambeniano di portare alla luce le categorie centrali del pensiero occidentale, di cui – sicuramente – il giardino è una delle più importanti, e forse sottovalutate.
"Mi piace""Mi piace"
Più che “perdersi come soggetto”, sarebbe meglio “sottrarsi”;
dunque la sottrazione non la perdita.
"Mi piace""Mi piace"
L’uomo è interrogato, è gettato nel mondo. Se tenta una risposta, non sa quel che gli accade. Ogni volta è un’incognita. La sfida comporta anche questo rischio.
"Mi piace""Mi piace"
Forse nella mia richiesta di delucidazioni sono stato troppo reticente. Ciò che mi premeva delle affermazioni di Agamben riguardava l’emersione de “la forma-di-vita”, scomparso il soggetto. Quali sono le forme di vita, oggi, che abitiamo noi, che siamo senza casa? Infatti Giorgio Linguaglossa ha creduto opportuno riproporre l’intervista ad Agamben il cui attacco è proprio nella direzione che avevo cercato di puntualizzare. “In che cosa crediamo?” La questione “credere-credenza”. Confesso che io mi trovo a sperimentare questa incertezza paralizzante. “Poco importa che si discuta di leggi fisiche o teologiche, che naturalmente si elidono a vicenda. Si tratta in ogni caso di proposizioni assertive. La confusione tra ciò che possiamo credere e ciò che siamo tenuti a considerare vero, oggi ci paralizza”. E questa paralisi costringe anche me a dichiarare “che i modelli di credenza che ci vengono proposti non ci persuadono più”. Ovvero: la forma di vita che mi trovo a vivere è un inganno. È questo inganno, allora, che devo denunciare? Oppure andare oltre? Tagliare i ponti e azzerare qualsiasi rapporto con la quotidiana esistenza di materia e di pensiero, di fattualità e di “datità”? Devo, veramente rifugiarmi in qualche “paradiso” intellettuale o continuare a raspare il bitume che calpesto? È chiaro che nessuno mi può dare la risposta fatidica… Anche perché chi pensa di possederla e di poterla elargire, dice lo stesso Agamben, è in una situazione di “malafede”. Allora? Allora richiamo quanto ho scritto In Zona gaming 16, già postata…
Quanti sogni fanno un uomo?
Bla bla bla… occasione lampo, occasione flash.
La luce in fondo al tunnel
è un aspirapolvere di anime.
Ci sono gli uccelli della notte e quelli del giorno.
E attraversano il tempo a colpi d’ala.
Dov’è la metafora? Ancora bla bla bla…
oppure bel blu bli blo bil bol bul o bal o ble
……………………………………………………………
…fesbucchiamo. Fesbucchiamo… ancora
"Mi piace""Mi piace"
Gentile Gallo,
Le rispondo con alcuni vers miei che, credo, siano pertinenti coi Suoi “disperanti” interrogativi.
—————————————————
alla Terra
Portavo la mia immagine per la città come un retrattile vessillo.
Il tripudio dei miei passi scavava un sentiero di note austere,
non avevo con me una reliquia da barattare con la santità
e nemmeno una nicchia mi era data per un conforto da accattone.
Gli svolazzi della mia mente erano capricci di stiletti spuntati a malincuore,
da una accidia di laguna vedevo un puntino azzurro come tanti da Saturno
– era la Terra che miravo! – e non sapevo il suo millennio quel giorno estivo
di lei che mi sorrise con Cassini. Quale gioia la conoscenza che compresi
dai miei occhi, e come Dio fosse a sua volta una creazione della Rota,
l’emorragia di una clessidra ai tempi della mia innocente trasparenza.
Le contrade come una sinfonia d’infanzia in quel sarcofago: tabernacolo pinto
da epitaffi e necrologi… per fissare, in una partitura, gli anelli della Storia.
antonio sagredo
Roma,
all’ora terza del 29 gennaio 2014
e 3/01
————————————————–
(da Parole Betae – 2015)
——————————–
E voltai lo sguardo mio verso me stesso – sarebbe stato meglio non vedersi – dentro!
Per non giocare più coi loro spiriti di cartapesta
E ricordai i miei versi che su Saturno trovarono un rifugio… amato!,
E mi insegnarono loro di non mirare più la Terra,
Di scordare la sua storia che da tempo non era più la mia,
Di scordare infine – e qui io piansi – la mia progenie
Padre mio! Madre mia!
Chi ero io su quella Terra ora che Saturno m’accoglie
coi suoi anelli?
Che potevo fare, io, se il mio corpo era una squarciata bocca
che urlava alle stagioni recidive le sue variopinte maschere?
L’umido malumore delle foschie autunnali,
Le mortali e desolate primavere dei lillà,
Le terrifiche nevi che tracciano le assenze di abbandonate civiltà
E i soli che liberati dai propri raggi la Terra divoravano come Saturno!
Così su Saturno o altrove possiamo rinascere davvero nuovi
Come se a numeri infiniti un numero altro
Non infinito o la sua negazione…
Sarebbe leggerezza…
E poi essere lieve come uno dei qualsiasi numeri nei cristalli dei fiocchi
Di neve… e sciogliersi,
forse così la partenza, gli arrivederci e gli addii…
Lievezza, ovunque.
————————————————–
"Mi piace""Mi piace"