
 [Antonio Riccardi è nato a Parma nel 1962. Ha studiato fiosofia all’Università di Pavia. Dalla fine degli ani ottanta è stato impegnato nella Mondadori di cui è stato direttore editoriale degli Oscar. Per la poesia ha pubblicato: Il profitto domestico, 1996; Gli impianti del dovere e della guerra 2004; Acquarama e altre poesie d’amore, 2009. Ha curato il volume di saggi Cosmo più servizi. Divagazioni su artisti, diorami, cimiteri e vecchie zie rimaste signorine, 2015]
[Antonio Riccardi è nato a Parma nel 1962. Ha studiato fiosofia all’Università di Pavia. Dalla fine degli ani ottanta è stato impegnato nella Mondadori di cui è stato direttore editoriale degli Oscar. Per la poesia ha pubblicato: Il profitto domestico, 1996; Gli impianti del dovere e della guerra 2004; Acquarama e altre poesie d’amore, 2009. Ha curato il volume di saggi Cosmo più servizi. Divagazioni su artisti, diorami, cimiteri e vecchie zie rimaste signorine, 2015]
Appunto critico di Giorgio Linguaglossa
Dopo Composita solvantur (1995) di Franco Fortini, si profila l’Epoca della stagnazione stilistica
Come è noto, dopo Composita solvantur (1995) di Franco Fortini, la poesia italiana diventa sempre più piccolo borghese: si democraticizza, impiega una facile paratassi, la proposizione si disarticola e si polverizza, diventa semplice insieme di sintagmi allo stato molecolare, il tutto legittimato dall’imprimatur del governatorato dell’io; si risparmia, si economizza sui frustoli, sui ritagli, sui resti del senso, si ha in mente un senso implausibile ed effimero, come se il senso non sortisse fuori da una ricerca del senso; si scommette sulla facile semantica che si apre tra gli spezzoni, i frantumi di lessemi, di sillabe e di monemi. Sarà questa la via verso la de-fondamentalizzazione del discorso poetico. Subito si spalanca davanti al lettore la «mantica», la cosa fatta di semantica: la poesia dell’io e delle sue problematiche nel quotidiano. Accade così che si diffonde a macchia d’olio una poesia fatta di esternazioni dell’io, di ipotiposi dell’io. La poesia italiana degli anni settanta cercherà l’«assenza» tra l’affollamento degli oggetti del quotidiano, nasce così una poesia del «pieno», non più inquietante ma rassicurante, il «pieno» delle parole della «comunicazione».
La problematica derridiana della «traccia» viene sproblematizzata e interpretata come discorso narrativo dell’io che ha perduto le fondamenta, di qui l’erranza dell’io, l’ipertrofia dell’io. La poesia oscilla tra una lingua che ha dimenticato l’Origine e ha de-negato qualsiasi origine, tra la citazione culta, la citazione ironica e la accettazione di una poesia del «pieno», di cose dette, di oggetti conosciuti, di faccende domestiche. Si disse in quegli anni che la poesia doveva cessare di produrre «valore», di produrre «senso», di produrre qualsivoglia «valore». Dati questi presupposti, la poesia didascalica del quotidiano ne è stato il risultato naturale. La poesia italiana degli anni settanta, quella dell’esordio di Patrizia Cavalli, Valentino Zeichen e Valerio Magrelli si muoverà in questo orizzonte di idee; si adatta alle nuove circostanze che richiedono una poesia democratica, o meglio, demotica, fungibile, comunicabile che finga ogni manomissione del «senso» e del «valore». La conseguenza di questa situazione sarà che chi viene dopo questi poeti non potrà che continuare a produrre fraseologie dell’io, frasari distassici, combusti magari con allegria per re-impiegarli nell’economia stilistica imposta dalla dismetria dell’epoca della stagnazione e della recessione. Si profila così la Grande Crisi della poesia italiana che ha prodotto gli ultimi tre decenni di «leggibilità» della forma-poesia, al punto che non si sa più cosa si debba intendere oggi per forma-poesia, che cosa si intenda per dismetria, che cosa sia rimasto dell’economia dello spreco e dello sperpero, delle neoavanguardie e delle post-avanguardie agghindate, traumatizzate e tranquillizzanti.
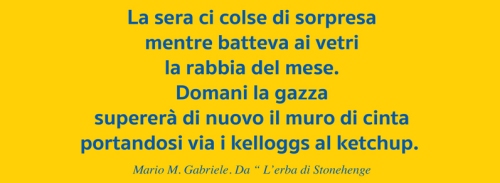
 La poesia non ritiene più indispensabile edificare su Fondamenta solide,
La poesia non ritiene più indispensabile edificare su Fondamenta solide,
equivoca, prende l’abbaglio di credere che si possa costruire su Fondamenta instabili o, addirittura, sulla mancanza di fondamenta.
È un fatto che la poesia italiana di questi ultimi decenni sembra aver perso energie, non crede più possibile ricreare le coordinate e le condizioni culturali di una poesia che voglia comunicare con parole «nuove» con il pubblico (e poi: quali parole?, quale vocabolario?). Si assiste alla scomparsa del pubblico. La poesia parla del non-senso?, del senso?, del pieno tra le parole?, del pieno e del detto tra le parole?, del pieno e del detto prima delle parole?. Si ha l’impressione di una gran confusione. Ma qui siamo ancora all’interno delle poetiche del disincanto del tardo Novecento!. La poesia ironica?, la poesia giocosa?, il ritorno all’elegia?, la poesia come battuta di spirito?, la poesia degli oggetti?, la poesia come aneddoto?, la poesia della riproposizione del mito?. Il campo appare disseminato di mine, è un campo minato di rovine del pensiero poetico.
La poesia italiana dagli anni novanta ad oggi ha tentato di, in qualche modo, orientarsi tra gli smottamenti, le faglie, i deragliamenti del senso, ha tentato il piccolo cabotaggio tramite una facile dismetria, una facile procedura ironica, quando sarebbe occorsa una seria riflessione sulla difficoltà del fare poesia nella nuova condizione della materia lessicale combusta, dei materiali esausti, degli isotopi di un lessico usurato, della situazione di detrito permanente della forma-poesia. Siamo così arrivati alla «dissolvenza» di tutti i concetti saldamente ancorati ad una idea forte di forma-poesia, ci si è accontentati di navigare a vista per il tramite del referenzialismo e di una «narrativizzazione» ad oltranza della forma-poesia.
Così è accaduto che, durante questi ultimi decenni, per la precisione dagli anni settanta ad oggi, la poesia italiana ha seguito la moda di un referenzialismo che poggiava sullo zoccolo duro del linguaggio del quotidiano con l’idea invalsa che le frasi-proposizioni potessero esistere isolatamente e fossero intellegibili in sé sulla base di una interpretazione letterale; si è creduto che la strada di una poesia metaforica fosse un azzardo. Così è nato l’equivoco che la poesia dovesse «narrare» il quotidiano. Dopo Satura (1971), la scelta fra il letterale e quotidiano (Montale) e il figurato metonimico (Fortini) sarebbe andato a vantaggio del piano inclinato di un quotidiano acritico e acrilico. Di fatto, dalla poesia italiana viene espulsa la metaforizzazione di base, il metaforico e il simbolico.

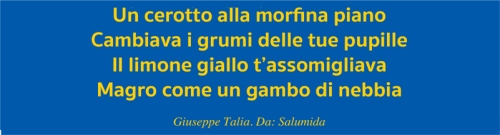 Riguardo a Pier Vincenzo Mengaldo
Riguardo a Pier Vincenzo Mengaldo
Riguardo alla affermazione di Mengaldo secondo il quale Montale si avvicina «alla teologia esistenziale negativa, in particolare protestante» e che smarrimento e mancanza sarebbero una metafora di Dio, mi permetto di prendere le distanze. «Dio» non c’entra affatto con la poesia di Montale, per fortuna. Il problema è un altro, e precisamente, quello della Metafisica negativa. Il ripiegamento su di sé della metafisica (del primo Montale e della lettura della poesia che ne aveva dato Heidegger) è l’ammissione (indiretta) di uno scacco discorsivo che condurrà, alla lunga, alla rinuncia e allo scetticismo. Metafisica negativa, dunque nichilismo, una equivalenza alimentata da una cultura male assemblata. Sarà questa appunto l’altra via assunta dalla riflessione filosofica e poetica del secondo Novecento che è confluita nella positivizzazione della forma-poesia. La positivizzazione sarà stata anche un pensiero della «crisi», crisi interna alla filosofia e crisi interna alla poesia, ma rimarrà una risposta insufficiente. Di qui la positivizzazione del filosofico e del poetico. Di qui la difficoltà del filosofare e del fare «poesia». La poesia del secondo Montale si muoverà in questa orbita: sarà una modalizzazione del «vuoto» e della rinuncia a parlare, la «balbuzie» e il «mezzo parlare» saranno gli stilemi di base della poesia da Satura in poi. Montale prende atto della fine dei Fondamenti (in questo segna un vantaggio rispetto a Fortini il quale invece ai Fondamenti ci crede eccome!) e prosegue attraverso una poesia «debole», prosaica, diaristica, cronachistica, occasionale. Montale è anche lui corresponsabile della parabola discendente in chiave epigonica della poesia italiana del secondo Novecento, si ferma ad un agnosticismo-scetticismo mediante i quali vuole porsi al riparo dalle intemperie della Storia e dei suoi conflitti (anche stilistici), adotta una «positivizzazione stilistica» che lo porterà ad una poesia sempre più «debole» e scettica, a quel mezzo parlare dell’età tarda. Montale non apre, chiude. E chi non l’ha capito ha continuato a fare una poesia «debole», a, come dice Mengaldo, continuare a «de-metaforizzare» il proprio linguaggio poetico.
Quello che Mengaldo apprezza della poesia di Montale: «il processo di de-metaforizzazione,
di razionalizzazione e scioglimento analitico della metafora», è proprio il motivo della mia presa di distanze da Montale. Montale, non diversamente dal Pasolini di Trasumanar e organizzar (1971), da Giovanni Giudici con La vita in versi e da Vittorio Sereni con Gli strumenti umani (1965), era il più rappresentativo poeta dell’epoca ma non possedeva la caratura del teorico. Critico raffinatissimo, privo però di copertura filosofica, Montale aveva terrore della cultura di massa del Ceto Mediatico. Montale ha in orrore la massificazione della comunicazione. Vicino in ciò ad alcuni filosofi esistenzialisti o di estrazione esistenzialista (come Heidegger o Husserl) i quali sostenevano che l’uomo moderno vive nella ciarla, nel mondo del «si» ed quindi confinato nella inautenticità, sommerso dalla straordinaria quantità di messaggi che lo bersagliano, il poeta ligure vede in questa condizione il dissolvimento ultimo del linguaggio (e del linguaggio poetico) come strumento della comunicazione. L’idea è quella che ogni tipo di rapporto linguistico sia costretto a realizzarsi in presenza di un fortissimo rumore di fondo, che sovrasta la parola, la distorce e la rende infine un segno non più idoneo alla comunicazione. La poesia è un atto linguistico, storicamente determinato, nel senso che risente, come qualsiasi atto umano, delle condizioni di civiltà nelle quali si manifesta. Di qui il pericolo incombente che la perdita di senso afferisca anche al linguaggio della poesia.
La de-fondamentalizzazione del discorso poetico
Montale compie il gesto decisivo, pur con tutte le cautele del caso apre le porte della poesia italiana a quel processo che porterà alla de-fondamentalizzazione del discorso poetico. Con questo atto non solo compie una legittimazione indiretta e consapevole dei linguaggi dell’impero mediatico che erano alle porte, ma legittima una forma-poesia che ingloba la ciarla, la chiacchiera, il lapsus, la parola interrotta, la cultura dello scetticismo, la disillusione elevata a sistema, a ideologia. Autorizza il rompete le righe e il si salvi chi può. La forma-poesia andrà progressivamente a pezzi. E gli esiti ultimi di questo comportamento agnostico sono ormai sotto i nostri occhi.

 Positivizzazione del discorso poetico*
Positivizzazione del discorso poetico*
Il problema principale che Montale si guardò bene dall’affrontare ma che anzi con la sua autorità approvò, era quello della positivizzazione del discorso poetico e della sua modellizzazione in chiave diaristica e occasionale. La poesia in forma di elettrodomestico, la poesia in sotto tono, quasi nascosta, in sordina. Qui sì che Montale ha fatto scuola!, ma la interminabile schiera di epigoni creata da quell’atto di lavarsi le mani era (ed è) un prodotto, in definitiva, di quella resa alla «rivoluzione culturale» del Ceto Medio Mediatico come poi si è configurata in Italia.
*[C’è una «logica» delle metafore e delle metonimie. Un linguaggio poetico privo di logica è un linguaggio poetico scombiccherato, claudicante, incomprensibile. Per questo un poeta come Valéry parlava della poesia che ha la precisione di una «matematica applicata». Anche nel linguaggio poetico c’è una «logica».
La logica è la grammatica profonda del linguaggio, al di là della sua grammatica concettuale che ne è la sintassi. È Essa che pone in evidenza le relazioni di senso (che non si dicono in quel che si dice ma che si mostrano, e che ciascuno è in grado di comprendere in quanto semplice utilizzatore di lingua naturale).
Il linguaggio poetico è la tematizzazione esplicita di ciò che è contenuto nel linguaggio naturale; per cui il secondo viene prima del primo. È un linguaggio in quanto scritto, decontestualizzato, in cui tutto è chiaro, univoco, intelligibile da subito perché costruito per questo scopo. Il prodotto della riflessione del linguaggio su se stesso, l’esplicitazione delle sue strutture di senso soggiacenti alle relazioni dei parlanti immersi nel linguaggio naturale.
Dal linguaggio relazionale del linguaggio naturale al linguaggio poetico c’è una frattura e un abisso, un salto e un ponte.
La problematizzazione del linguaggio poetico si esprime (quale suo luogo naturale) in metafore e immagini. Tutto il resto appartiene al demanio discorsivo-assertorio che ha la funzione politica di convincere un uditorio. A rigore, si può sostenere che un linguaggio poetico privo di metafore e immagini non è un linguaggio poetico. E con questo scopriamo l’acqua calda, ma è indispensabile ripeterlo, anche adesso in tempi di semplicismo filosofico-poetico.
Lo scetticismo – che data da Satura (1971) in giù nella poesia italiana, ha dato i suoi frutti avvelenati: ha ridotto la poesia italiana ad ancella dei mezzi di comunicazione di massa, ad un surrogato di essi; l’ha resa sostanzialmente un linguaggio non differenziato da quello della «comunicazione».
Rammento che circa alla metà degli anni novanta a Milano venne stilato un «manifesto», stilato, mi sembra da un certo Italo Testa e sottoscritto da personaggi noti, che sollecitava la rivalutazione della «comunicazione» in poesia. All’epoca, ci restai di princisbecco, adesso non mi meraviglio più di nulla.
Di fatto, da Satura in poi fino ai giorni nostri, non c’è stato nessun poeta italiano degno di stare allo stesso livello di un Tranströmer, questo è un nodo che finora non è stato sciolto dell’Istituzione poesia così come si è solidificata oggi in Italia.
La poesia che si fa oggi in Italia è un linguaggio ingessato (nel migliore dei casi) e un linguaggio comunicazionale (nel peggiore).
*

Antonio Riccardi
La prima sezione de Gli impianti del dovere e della guerra (2004) di Antonio Riccardi raffigura la città industriale colta per lampeggiamenti memoriali, c’è «mio padre… coperto dal camice di piombo», «con l’Alfa scendeva nell’oriente della pianura / verso il dominio di Cattabiano»; c’è «la sirena» che regola il tempo della città industriale, qui la positivizzazione del discorso poetico trova una modellizzazione in chiave realistica:
2.
La sirena copriva la città col sacrificio,
A lungo ho sentito solo sentito
la voce della sirena.
Saliva regolando la vita della pianura
e limava ogni cosa al dovere
voltando da sotto la città satellite.
3.
Con la sirena saliva al ferro
e al mattino la nostra città.
Mio padre vedeva gli organi e le ossa
degli uomini delle fabbriche.
Coperto dal camice di piombo
cercava dei segni dentro la carne
sentendoli al buio senza parlare.
Poi partiva per Cattabiano
con le bestie giocattolo per me.
4.
Veniva da Sesto con le bestie feroci
il puma, le pantere, al fine settimana
appena prima che il mondo voltasse sotto
andando al buio da questa collina.
da solo aspettavo sulla curva del castagno
che il giorno fosse senza mutamento
e nuovo di una nuova felicità.
5.
Con l’Alfa scendeva nell’oriente della pianura
verso il dominio di Cattabiano.
Questi sono gli anni a due teste,
bene e castigo.
Lo so da allora, l’ho visto
nell’orbita degli anelli del ciliegio
e nella resina che fa da morto.
Antonio Riccardi è nato a Parma nel 1962, fa parte di una generazione che ha vissuto in profondità la crisi di crescente narrativizzazione della poesia italiana; la sua lunga esperienza negli uffici stampa della collana di poesia della Mondadori lo ha reso edotto degli effetti di quel processo che abbiamo denominato «narrativizzazione» e «positivizzazione» del discorso poetico. La sua opera d’esordio, Gli impianti del dovere e della guerra, ne è un esempio probante; è una sorta di topologia del quadrato memoriale di Riccardi: la campagna parmense del podere di Cattabiano e quella che fu la «piccola Stalingrado», cioè Sesto San Giovanni, con i suoi quattro stabilimenti industriali (Concordia, Unione, Vulcano e Vittoria). Qui la «positivizzazione del discorso poetico» viene accettata come punto di partenza per una nuova ripartenza secondo gli intenti di una poesia intesa in chiave realistica, che abbia nel realismo topologico e didascalico il suo marchio di riconoscibilità. La parte centrale, titolata «Né salvi né morti» contiene questa significativa didascalia:
La forgia: assumevano 100 persone per averne 5 che rimanessero
perché era un posto terribile, la bolgia dei vivi…
io non ho vergogna a dire che spesso, alla mattina
prima di cominciare a lavorare ho pianto.
(testimonianza di M.S., operaio alla Breda Fucine)
Entriamo così nella zona centrale del libro, «Né salvi né morti». Ci troviamo di fronte ad una idea di poesia come realismo didascalico, testimonianza dell’Italia industriale, in aperta contro tendenza rispetto alla poesia dell’io, della poesia-confessione e della poesia degli oggetti di anceschiana memoria incentrata attorno ad un io posto come atto di verificazione indubitabile:

1.
Ogni anno si prepara un po’ di guerra.
Negli hangar le gru
bruciano carbone a tonnellate
olii combustibili, sabbie e terre.
Le terre da fonderia non sono terra
– come l’ombra che ci sprofonda
non è materia, non sono nomi –
ma semi di quarzo e argilla in proporzione
con ossido di ferro, soda, magnesio
mica, potassa e a volte organismi
come fortuna non è bene o male ma il seme
la materia che si vuole in condizione.
2.
Nell’impero delle presse e dei magli
ogni impianto è un corpo pieno.
in combustione l’aria si spina,
scintilla come quarzo e gas
e poi si gonfia con la polvere di fuori.
Presse idrauliche per forgiare e imbutire
se verticali da duemila tonnellate
per boccole e stantuffi
se orizzontali da duecento tonnellate
per proiettili di calibro medio
o usate in coppia parallela
nella fucinatura dei corpi cavi
ogni corpo è in attrito e resiste
alla totalità degli altri corpi.
Così – come dentro – è fuori
e poi nelle trincee.
3.
In fonderia si preparano le guerre.
Negli hangar di Breda e Falk
forni fusori elettrici e altoforni
per colate in staffa,
macchine di formatura e altri forni
per la ricottura dei getti di fusione
preparano carlinghe e convogli
per il fronte di guerra.
Ogni comparto è un corpo che produce
la trama degli adempimenti.
4.
In fonderia maestranze qualificate
lavorano valvole per condotte forzate
turbine idrauliche e alternatori elettrici
e pezzi in serie per armi da guerra.
La perfetta produzione
non consente tempi morti
ma l’intero di una sola verità
e armi da guerra in serie.
Nella parte centrale del libro, troviamo la sezione titolata «Elixir Borducan», la zona propriamente memoriale del libro, la zona nevralgica che ci rivela un Riccardi poeta post-lirico. Qui la positivizzazione del discorso poetico, entra nel vivo, grande parte viene svolta dalla macro metafora del «padre», «il padre di mio padre», «il dragone ha la testa d’oro»; infatti, in questa sezione abbondano le zone memoriali con il loro referente retorico naturale: la metafora:
1.
Oggi è il giorno che mio padre muore davvero
– la più vicina morte che capiamo è la seconda, è il tu
ha detto Jankélèvitch.
Da solo entrerò nel bosco di Cattabiano
per vedere la prima pianta del mondo
che passa da un figlio a un figlio a un altro figlio
da un primo, poco prima della nostra fortuna.
2.
Ogni fortuna è una forma
e dopo una memoria che non finisce.
Anch’io sono un borghese
come suo padre, il dragone.
Dal belvedere del Borducan
il suono della terra è come niente sulla terra
e dico solo una cosa vedo dalle quote.
3.
Da qui vedo la guerra e quello che è stato
di loro e di ogni campo del loro podere.
Il dragone ha la testa d’oro.
Vedo il padre di mio padre poco prima
dell’assalto, prima che il mondo
si cambi per tutti in un solo dovere.
4.
Niente somiglia davvero a come sono
a cosa so della guerra e degli eroi.
Vedo il dragone nel dirupo voltarsi
al lampo artificiale di un bengala,
un colpo di luce nel morso di un cavallo
sull’elmo e nella pianura dell’assalto.
Al ritorno sarò in pari col dovere di tutti.
5.
In grazia di un luogo conosco
come Dio non ha grammatica
e forgia solo i primi nomi:
dovere, sacrificio, verità.
Negli assalti sembrano sospesi
in un velo di polline e vapore.
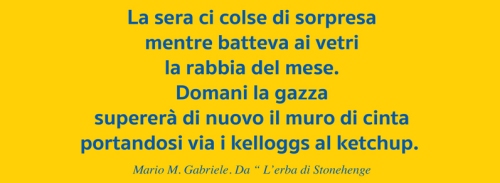 L’ultima sezione del libro segna l’abbandono del luogo memoriale degli avi per entrare nella storia della industrializzazione accelerata del paese; è titolata «VITTORIA l’impero delle nuove macchine». C’è una sorta di virile accettazione per quel che è stata la storia della industrializzazione forzata del paese, c’è un tono che ricorda, da lontano, quello di Franco Fortini di Composita solvantur, ma come decantato, risolto quasi in dichiarazione didascalica, priva di qualsiasi modellizzazione enfatica, sopra segmentale. I «luoghi» hanno un netto risalto: la geografia ingloba l’io, sostituisce la storia dell’io delle poetiche «deboli» del minimalismo romano milanese per commutarle in luoghi di una toponomastica memoriale imaginale. Va dato atto che Riccardi tenta qui una via sicuramente impervia, in salita, solitaria, piena di rischi stilistici, tenta una ripartenza che si rintraccia anche in alcuni pochissimi autori contemporanei tra i più attenti al cambiamento della stagione culturale in atto in questi ultimi lustri della storia d’Italia.
L’ultima sezione del libro segna l’abbandono del luogo memoriale degli avi per entrare nella storia della industrializzazione accelerata del paese; è titolata «VITTORIA l’impero delle nuove macchine». C’è una sorta di virile accettazione per quel che è stata la storia della industrializzazione forzata del paese, c’è un tono che ricorda, da lontano, quello di Franco Fortini di Composita solvantur, ma come decantato, risolto quasi in dichiarazione didascalica, priva di qualsiasi modellizzazione enfatica, sopra segmentale. I «luoghi» hanno un netto risalto: la geografia ingloba l’io, sostituisce la storia dell’io delle poetiche «deboli» del minimalismo romano milanese per commutarle in luoghi di una toponomastica memoriale imaginale. Va dato atto che Riccardi tenta qui una via sicuramente impervia, in salita, solitaria, piena di rischi stilistici, tenta una ripartenza che si rintraccia anche in alcuni pochissimi autori contemporanei tra i più attenti al cambiamento della stagione culturale in atto in questi ultimi lustri della storia d’Italia.
1.
Dice Elia di non entrare
nelle rovine.
Nella cinta degli stabilimenti di Sesto
c’è un bosco improvviso
tra l’area dei gasogeni e l’area dei forni
– niente che qui sia solo nostro
o vero una sola volta, in questa città.
4
Sono già di là gli operai del Vittoria
ultima squadra per la cerca tra i metalli
nel bosco che buca la città
nell’ultimo anno di fabbrica.
L’ultima metamorfosi è la macchina
o il sistema automatico di macchine
quando lo regola un automa.
Oh, città – uno pensa – perdendo le tue rovine
non resterà altra cosa…
poi vedono volpi e cani scappare sul fondo
del bosco catastale.
8
Strumenti meccanici per l’arte venatoria
nel podere di Cattabiano
I.
Vengono di notte nel bosco dei corvi
nel buco più fondo di questo dominio.
L’archetto a croce, il sacco di tela e i chiodi
poco prima dell’aurora.
Nel bosco converge il mondo
una notte di prima della prima guerra
e loro rasoterra dal prato
per prenderli nel sonno con le mani.
Uno penserà l’estate dopo
la prima estate di guerra e di malora
ai corvi alla moltitudine nel buio
scendendo le trincee sotto i bagliori
II.
Vengono al buio nell’erba lunare
da bosco a bosco con gli abiti leggeri
per avere una caccia fortunata
loro bianchi nella luna anche loro.
La notte più chiara è quella dei corvi.
precipitato da Minerva
si vede ancora tra le stelle il Drago
nel cielo tra l’Orsa e l’altra capovolta.
Uno è già morto al prossimo plenilunio
ma adesso, segnàti col sangue del sambuco
e uniti in un solo cavo astrale,
sentono al buio la ferma degli animali.






































































































































Per anni l’arte ha tentato la stasi
(versi non anti ma oltre il minimalismo)
Per anni l’arte ha tentato la stasi.
Ora cerca di mettere tutto in movimento.
I sei dipinti ornano i sei pilastri
della sala da pranzo d’una azienda.
Figure fluttuanti. Distesa di cielo
visibile appena dalle finestre alte della sala.
(Il mondo. La carne. O la Parola che comprende entrambi).
(…)
«Siamo tutti coscienti del fatto che…?»
L’amministratore delegato non risponde.
Ignora l’artista. Che insiste: «Siamo tutti coscienti del fatto
che se la polpa cade la conchiglia si svuota?
Chi o cosa riempirà questo vuoto?…»
Emilio, Edoardo, Armando.
(Rondine. Rendici eguali al tuo giugno).
(…)
Da un angolo della mensa aziendale rispondono:
«Se la polpa fugge la conchiglia resta vuota.
Il vuoto lo riempie la parola nuova del poeta».
L’amministratore delegato non si scompone.
Pensa da solo soltanto al profitto.
La conchiglia senza polpa resta vuota.
(Le immagini sono il silenzio inquinato).
Gino Rago
Art for years attempted the stasis
Art for years attempted the stasis.
Now it tries to put everything in movement.
The six paintings adorn the six pilasters
in the dining room of a company.
Floating pictures. A spread of sky
justbarely visible from the high windows in the room.
(The world. The Flesh. Or the word that comprehends both).
(…)
«We are all conscious of the fact that …»
The managing director does not answer.
He ignores the artist. Who insists: «Are we all conscious of the fact
that if the pulp drops out, the shell gets empty?
Who or what will fill up this void? …».
Emilio, Edoardo, Armando.
(Swallow. Make all of us the same as your June).
(…)
From a corner of the canteen they reply:
«If the pulp runs out, the shell remains empty.
The void is filled by the new word of the poet».
The managing director is not upset.
Alone, he only thinks of the profit.
The shell without the pulp remains empty.
(The images are polluted silence).
Traduzione originaria di Adeodato Piazza Nicolai.
Traduzione definitiva di Carlo Cremisini. La mia gratitudine a entrambi.
Nella sua nota critica, sui versi di Antonio Riccardi, Giorgio Linguaglossa, per efficacia interpretativa e lessico nuovo che introduce nel gergo pigro di certa critica letteraria stanca e grigia, suggella la validità ermeneutica del linguaglossiano Spazio Espressivo Integrale in virtù del quale ogni esperienza poetica può essere ricondotta agli effettivi suoi valori poetici
espressi, sdipanati dai versi scritti dal poeta ‘interpretato’.
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
Poesia dai temi industriali su ingranaggi e forni, comparti e alternatori elettrici delle grandi industrie di Breda e Falk e degli stabilimenti di Sesto: tutto integrato in una memoria incancellabile, in un continuo fluire verso il sistema lavoro dai contorni marxiani.
"Mi piace""Mi piace"
Ho pensato a quel terribile film con Sordi: “Finchè c’è guerra c’è speranza”
"Mi piace""Mi piace"
Poesia forte, dura combattuta…e imprevedibilmente intensa di nostalgia. il commento la amplifica, la rende risonante come un metallo percosso. Mi ha colpito la memoria del padre, tra opposti ricordi: materia, corpo, operai della Breda e…nostalgia dell’infanzia, quando il poeta aspettava il padre con i giocattoli alla curva del castagno:
Con la sirena saliva al ferro
e al mattino la nostra città.
Mio padre vedeva gli organi e le ossa
degli uomini delle fabbriche.
Coperto dal camice di piombo
cercava dei segni dentro la carne
sentendoli al buio senza parlare.
Poi partiva per Cattabiano
con le bestie giocattolo per me.
4.
Veniva da Sesto con le bestie feroci
il puma, le pantere, al fine settimana
appena prima che il mondo voltasse sotto
andando al buio da questa collina.
da solo aspettavo sulla curva del castagno
che il giorno fosse senza mutamento
e nuovo di una nuova felicità.
"Mi piace""Mi piace"
Quello che Mengaldo apprezza di Montale è proprio il motivo della mia presa di distanza da Montale… Giusto! Penso al commento fatto in una lettera dalla Guidacci dopo la sua esclusione dall’antologia dei “Poeti italiani del Novecento” curata da P.V. Mengaldo: ” l’esilio che m’ è dato onor mi tengo”.
Sabino Caronia
"Mi piace""Mi piace"
Interpretare la ‘ fabbrica’ in senso letterale rischia di essere un po’ scontato. Da quale pulpito viene la litania sull’alienante industrializzazione? Da una antistorica utopia georgica? Invece, la Macchina potrebbe allegorizzare qualcosa di molto più ampio di un discorso critico sul rapporto fra individuo e apparato produttivo: nella sua meccanica funesta e inesorabile, nei suoi ritmi necessari e nella sua logica d’acciaio, Essa potrebbe esprimere, insieme a tutte le immagini che ne fanno da metonimia (macina,puleggia,argano,cremagliera et simili…) un perfetto emblema di come l’uomo e ogni forma vivente si riducano a imbelli ingranaggi delle leggi naturali; in tal modo sventando anche la deriva ideologica di una scrittura che prende le mosse da un cosi realistico trampolino
"Mi piace""Mi piace"
LA QUESTIONE DEL DOPO MONTALE OGGI
riprendo da http://www.laletteraturaenoi.it un brano di un articolo di Romano Luperini che fa il punto della situazione del Montale oggi. Fermo restando che oggi non possiamo più leggere il secondo Montale con gli occhiali del canone, essendo esso canone da tempo dissoltosi in una molteplicità di direzioni per lo più epigoniche e di corto respiro. Probabilmente, dal secondo Montale se ne uscirà allorquando sarà chiaro il quadro di riferimento della tradizione del secondo novecento, la geografia post-montaliana, intendo. Ecco Luperini:
[…] Nei due libri successivi, Le occasioni e La bufera, la linea della poesia montaliana s’impenna: la scelta monolinguistica e, soprattutto, monostilistica diventa chiara (particolarmente nella prima raccolta), la metrica si fa classica, il tono è più eletto e rarefatto. Indubbiamente i due libri contribuiscono a modificare il canone del secolo: insieme con le opere di Ungaretti, di Cardarelli e degli ermetici lo riassesta su un profilo più alto, correggendo in modo determinante l’impronta prosastica lasciata dalle avanguardie primonovecentesche. Nello stesso tempo però la linea simbolista presente negli Ossi e nei primi testi delle Occasioni cede, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Trenta, a un allegorismo umanistico e cristiano e poi, nella Bufera, anche biologico-vitalistico. Il fatto è che la scommessa dell’incarnazione – la fusione del valore e del terreno – appare ben presto perduta, e la loro scissione fa crollare i fondamenti del sublime e della rivelazione epifanica e simbolica, preparando il loro tonfo nella palta e nello sterco. La tendenza al classicismo predomina largamente, ma è un classicismo moderno o “modernista”, che a poco a poco si fa sempre più contraddittorio e paradossale. Le ultime poesie della Bufera e i racconti di Farfalla di Dinard sono già indizio di una crisi. E classicismo da un lato si tende, si contamina, si screpola, dall’altro finisce per diventare decenza quotidiana, difesa psicologica, ma anche sociale, di uno stile di vita.
Con Satura il grafico tende decisamente alla discesa, l’abbassamento è costante, la direzione prosastica e desublimante prevalente. Nel linguaggio, nel tono, nella metrica si riprende la linea prosastica già affiorante negli Ossi. E nuovo libro riflette e provoca un nuovo assestamento del canone, in coerenza con i risultati dei «novissimi» e delle nuove avanguardie. L’allegorismo persiste, ma non è più propositivo, bensì apocalittico e giudicante: non canta il valore, ma prende atto del disvalore dilagante e attesta ormai solo un coraggio di vivere ridotto ad atto privato. Luci e barbagli del vecchio splendore s’illuminano solo a intermittenza, sempre più affievoliti.
Nei libri successivi il passaggio dalla prosa al diario disegna una linea ormai piatta e orizzontale, con bevi increspature, che vanno diminuendo di altezza e di frequenza verso la fine. L’allegoria ritorce la propria furia distruttiva su sé stessa: si passa dall’allegorismo pieno delle Occasioni e della Bufera e da quello giudicante di Satura alle macerie e ai relitti delle allegorie vuote che costellano i Diari e Altri versi. E in effetti, in quest’ultima raccolta, un testo dal titolo ormai inevitabile, L’allegoria, dichiara: «Il senso del costrutto non è chiaro / neppure per coloro che riguarda». La poesia dell’assenza di significato è, per l’appunto, l’allegoria vuota. Anche l’allegorismo apocalittico di Satura è ormai abbandonato e superato: «Alcuni suggeriscono marchingegni / che facciano crollare il tutto su se stesso. / Ma tu non credi a questo: la gioia del farnetico / è affare d’altri».
Montale e il simbolismo
[…] Se il diagramma ora tracciato è accettabile, il primo problema che esso pone è il rapporto di Montale con la grande tradizione del simbolismo, con la linea orfica, prima romantica e poi decadente, che da Novalis giunge a Mallarmé. Indubbiamente Montale muove dal simbolismo francese, appreso attraverso l’antologia di Van Bever e Léautaud Poètes d’aujourd’hui che aveva letto negli anni della formazione giovanile. Ma è un fatto non meno indubitabile che subito la corregge con Laforgue, con i crepuscolari, con Govoni e con Palazzeschi. Analogamente nelle Occasioni è evidente il riferimento all’alta tradizione metafisica della poesia francese, tedesca e soprattutto inglese, e tuttavia la tendenza progressivamente prevalente è a declinarla in senso allegorico, assimilando la lezione di Eliot e di Dante piuttosto che quella di Mallarmé, e puntando non già su una linea di poesia pura e analogica ma su quella di una poesia di pensiero. Lo stesso classicismo delle Occasioni e di parte della Bufera è niente affatto decorativo e appare anzi consapevolmente moderno: un testo arduo come il mottetto 5 (Addii, fischi nel buio…), pure così innalzato dalla sintassi e dal rigore metrico, è fitto di termini prosastici e quotidiani e si chiude con una parola brasiliana divenuta d’uso popolare.
Si può azzardare allora una prima ipotesi: il significato storico dell’esperienza poetica di Montale non sta nella sua continuità rispetto alla grande tradizione del simbolismo, ma nel fatto che egli dapprima la pone in discussione dall’interno e poi si colloca decisamente al di là di essa. Anche se considerassimo solo la funzione storica della poesia montaliana relativa al trentennio che va dall’uscita degli Ossi di seppia a quella della Bufera, dovremmo arrivare alla conclusione, di non piccola portata, che essa ha raggiunto il risultato di creare una linea di lirica alta e tuttavia estranea all’orfismo simbolista (Cfr. G. Simonetti, Dopo Montale. Le «Occasioni» e la poesia italiana del Novecento, Maria Pacini Fazi editore, Lucca 2002, pp. 7-113). Italia, rientrare nella grande tradizione lirica europea (è stato questo, in fondo, l’obiettivo della ricerca poetica montaliana fra anni Venti e Cinquanta) non ha comportato aperture di credito nei confronti del simbolismo romantico-decadente. Ne sono derivate, per la storia della nostra lirica, conseguenze non di poco conto. Infatti, in quegli anni, la centralità dell’esperienza montaliana nella nostra poesia e persino nella nostra cultura ha contribuito in modo decisivo a determinare i caratteri della poesia lirica italiana del nostro secolo, differenziandola da quella tedesca e soprattutto da quella francese (altra storia ha avuto quella inglese, più vicina alla nostra; e anche qui ha giocato la linea Eliot-Montale). Al posto di Char o di Jabès abbiamo avuto il Sereni di Gli strumenti umani o il Luzi di Nel magma o lo Zanzotto di La Beltà, o, per altra via, l’allegorismo civile di Fortini. Occorrerà attendere gli anni Settanta e Ottanta per trovare una generazione di poeti italiani – quelli della cosiddetta «parola innamorata» – che abbia cercato di ricollegarsi – con scarsi risultati, peraltro – al simbolismo francese e tedesco scavalcando mezzo secolo di storia della lirica italiana e recuperando, al di là di esso, la poetica dell’ermetismo e, ancora più indietro, D’Annunzio, il Campana «orfico» e alcuni aspetti del primissimo Montale (quello di Riviere).
E oggi?
E oggi? Si può parlare ancora di una centralità di Montale? La domanda, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, sarebbe apparsa persino retorica. Montale era infatti considerato il punto d’arrivo di una linea simbolista o ermetica o metafisica, senza che spesso si distinguesse bene fra queste diverse tendenze.
Cerchiamo di rispondere muovendo in prima istanza da una constatazione persino ovvia. La centralità di Montale è intanto quella di un autore che non appare mai bloccato su un’unica linea di sviluppo e si presenta invece sempre disponibile a infinite correzioni, ripensamenti, ritorni all’indietro, contaminazioni di esperienze diverse. Senza essere mai eclettico, e anzi mantenendo sempre un timbro suo inconfondibile, Montale è in qualche modo compartecipe di tutte le tendenze fondamentali del nostro secolo: sembra avvicinarsi alla grande tradizione orfica del simbolismo e subito la controbilancia in direzione prosastica ed espressionista; condivide la cifra ardua e chiusa della poesia ermetica, ma respinge sempre la poesia pura e analogica; approda a un classicismo che intende tutelare la nobiltà e la decenza della forma e immediatamente lo interpreta in senso “modernista”; opta per un realismo basso e comico che presenta diversi punti di contatto con la ricerca delle neoavanguardie degli anni Sessanta e nello stesso tempo lo orienta verso esiti – niente affatto eversivi bensì ironicamente lucidi e citazionisti – che saranno propri delle poetiche postmoderniste.
Questa duttilità va messa sul conto della grande capacità di Montale di confrontarsi apertamente con la storia del suo tempo, riflettendola nella propria poesia e talora persino anticipandola. Per i suoi contemporanei essa ha costituito, soprattutto a partire da un certo momento, un problema critico aperto e persino spinoso. Dopo l’uscita di Satura, infatti, il profilo dell’ autore, e in qualche misura anche la sua stessa identità poetica, sono apparsi alterati o modificati. Le diverse, e per certi versi opposte, stroncature di Fortini e di Pasolini nascono anche dallo sconcerto di lettori che vedono deluse le loro aspettative e che non riconoscono il loro autore. Ha contribuito a tale cambiamento d’immagine anche l’evoluzione dei cosiddetti “eredi” di Montale – cioè Sereni, Zanzotto, Luzi – che vivono tutt’e tre, nella loro produzione degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, il disfacimento del simbolismo, avvicinandosi a posizioni più realistiche e più sperimentali. Chi aveva chiuso Montale in una linea precisa e precostituita, ignorando le tensioni interne della sua ricerca e i contrastanti segnali provenienti non solo dagli Ossi ma anche da certe zone delle Occasioni e della Bufera, ha visto porre in dubbio le proprie certezze. Così, negli anni in cui la lunga esperienza poetica di Montale attraverso il secolo (dal 1920 al 1980) volgeva al termine, è diventato sempre più difficile collocarla in una formula univoca. Contemporaneamente, anche il modo di concepire il suo posto e il suo ruolo nello sviluppo della poesia del nostro secolo si andava progressivamente spostando e correggendo.
Con l’uscita degli ultimi libri non solo si modificava l’immagine di Montale, ma con essa andava modificandosi l’idea stessa di un secolo di poesia: cambiava, insomma, il canone del Novecento. Ne abbiamo una conferma dalle antologie di poesia, che fra gli anni Cinquanta e Ottanta hanno avuto la funzione di determinare il canone poetico del Novecento. Prima di Satura le interpretazioni che esse offrivano, per quanto di autori diversi per impostazione teorica e talora per poetica, erano tuttavia convergenti nella classificazione storiografica della poesia montaliana. Fra gli anni Quaranta e Sessanta, dalle antologie di Anceschi (1943) e di Anceschi-Antonielli (1953) a quelle di Contini (1968) e di Sanguineti (1969), si è continuato a indicare, come asse del canone novecentesco, la linea dei «lirici nuovi» ed ermetici culminante in Ungaretti e in Montale. E va da sé che Anceschi o Contini da un lato e Sanguineti dall’altro delineavano bilanci e progetti diversi del Novecento: i primi due avevano in mente un modello di evoluzione sostanzialmente unitario, ruotante intorno al simbolismo e al postsimbolismo, e cioè una linea che, muovendo da Campana interpretato in chiave prevalentemente orfica o da un primo Ungaretti letto già come simbolista e “poeta puro” giungeva, attraverso Montale, a Quasimodo, Luzi, Sereni, Zanzotto; invece Sanguineti ipostatizzava uno schema binario che poneva sì al centro Ungaretti, Montale e gli ermetici, ma per contrapporre loro il filone alternativo dell’avanguardia, che da Lucini, Gozzano e Campana, questa volta interpretato in senso espressionista, sarebbe giunto sino ai «novissimi».
In conclusione, dalle antologie, pure ben diverse fra loro, uscite prima di Satura, risulta un quadro della poesia novecentesca fondato sul predominio di un canone unitario in cui rientrerebbero sia Saba, sia Ungaretti e Montale. Ne risultavano così appiattite le differenze: tanto nell’antologia di Contini quanto in quella di Sanguineti non solo veniva sacrificato Saba (che non appartiene al novero dei poeti simbolisti e postsimbolisti e neppure aderisce alla linea delle avanguardie), ma lo stesso Montale veniva schiacciato su Ungaretti e imprigionato in una collocazione che al lettore d’oggi appare sicuramente troppo stretta. Non sembra privo di significato, per esempio, per restare nell’ambito dell’esplicito conflitto delle poetiche, che Montale non abbia mai nascosto le sue simpatie per Saba, o, in direzione diversa, per alcuni poeti sperimentali (da Govoni a Gozzano ai vociani), e la sua polemica lontananza, invece, dal postsimbolismo ungarettiano. Anzi, le obiezioni montaliane a una poesia che punti all’assoluto e che, in nome dell’essenza, dimentichi l’esistenza mostrano il carattere inconciliabile della sua contrapposizione a Ungaretti. L’opposizione Ungaretti-Montale indica dunque un’alternativa che, dagli anni Trenta agli anni Cinquanta, divide radicalmente la lirica “alta” della tradizione novecentesca, suggerendo due esiti ben diversi alla poesia successiva: non sarà certo un caso che i già ricordati poeti della «parola innamorata» optino decisamente per il primo contro il secondo.
Alla fine degli anni Settanta, dopo Satura e i Diari, s’imponeva dunque l’esigenza di ri-definire un modello di sviluppo diverso della lirica italiana del Novecento, più coerente con l’evoluzione della poesia di Montale e con la sua stessa complessità. In tale prospettiva è tornato utile il recupero di un paradigma interpretativo in parte già operante in Passione e ideologia (1960) di Pasolini. Già da questo libro appariva infatti un panorama della poesia italiana del nostro secolo più frastagliato e complesso: anche se il «novecentismo» (e cioè la linea del simbolismo e del postsimbolismo, in cui ancora Pasolini inseriva Montale) continuava a far la parte del leone, vi emergevano altri filoni, come quello sabiano, più figurativo e impressionista (che da Saba si prolunga sino a Bertolucci, Penna, Caproni), o quello dialettale che, in alcuni suoi esponenti di punta come Tessa (ma potremmo aggiungere anche i nomi di Noventa o di Loi), non è certo riconducibile alla linea lirica novecentista. E infatti, alla fine degli anni Settanta, chi ha ripreso, esplicitamente o implicitamente, le indicazioni pasoliniane, come il Mengaldo di Poeti italiani del Novecento (1978) o il Fortini di La poesia del Novecento (1977), ha finito con il proporre giustamente un Novecento poetico né unitario né binario, ma variegato e frastagliato, policentrico e multidirezionale, liquidando definitivamente il modello storiografico fondato sulla centralità del postsimbolismo.
Montale e il Novecento poetico
Alla fine del secolo e del millennio l’opera di Montale sta lì a documentare – ma anche a legittimare con l’autorità che ormai le è riconosciuta – una varietà di esiti e di soluzioni che non ha eguali nel Novecento e che costituisce la migliore garanzia della ricchezza e della libertà della nostra tradizione lirica. Nello stesso tempo, però, non si deve scambiare questa sua varietà con un’apertura indiscriminata e onnicomprensiva. Proprio la diversificazione di esiti che offre, unita peraltro a un’eccezionale coerenza di svolgimento che esclude occasionali omaggi alle mode di turno, costituisce una salutare rottura con Montale – il più “dantista” dei nostri poeti del Novecento – che viene finalmente liquidato, da parte di una tradizione lirica “alta”, il secolare modello chiuso e compatto del petrarchismo che pure giunge, attraverso Ungaretti, sin nel cuore del secolo, e viene invece rilanciato il modello aperto del percorso dantesco – dalle varianti stilnoviste a quelle comiche, dall’allegorismo cristiano a quello apocalittico -. Un modello in cui il significato non preesiste all’atto poetico né è insito in esso – come nell’ambizione orfica del simbolismo -, ma va cercato con un percorso imprevedibile, vario e accidentato e tuttavia moralmente e intellettualmente sempre rigoroso e coerente. Un modello in cui l’esistenza non è mai dimenticata in nome dell’essenza e in cui l’orizzonte del significato – anche nelle poesie più difficili – resta comunque storico.
Così la ricerca di Montale, lungi dal costituire il momento culminante di un’unica vittoriosa tradizione, rappresenta oggi l’aperto crocevia da cui non possono non transitare, incontrandosi e scontrandosi, i filoni più avanzati della ricerca poetica del nostro secolo. Se talora i suoi risultati più alti sembrano ancora prigionieri di un’ideologia e di una pratica poetica del “privilegio” estetico – e ciò può forse render conto della zona d’ombra o parziale eclisse in cui la sua opera pare entrata nell’ultimo quindicennio – e se, a differenza di Saba e di Ungaretti, Montale sembra oggi senza più eredi, almeno nella generazione nata dopo la seconda guerra mondiale, è anche vero che Ossi di seppia, da un lato, e buona parte della Bufera e di Satura, dall’altro, affrontano con grande determinazione e con spregiudicata apertura sperimentale i problemi che la crisi di quel “privilegio” ha posto. D’altronde le ferite e gli sconvolgimenti che l’esperienza montaliana – così centrale e tuttavia così poco «tipica» (Mengaldo) – ha provocato nel canone poetico del Novecento stanno appena ora cicatrizzandosi e riassestandosi.
Se ormai, alla fine del secolo, non sembra più proponibile né lo schema unitario di Contini né quello binario di Sanguineti e al nuovo millennio la poesia italiana si presenta con una varietà di modelli e di proposte che rispecchia la sua indubbia ricchezza, la figura di Montale non appare destinata a perdere, a causa di questo terremoto ermeneutico, la propria centralità, ma ad acquistarne un’altra, forse più duratura. Rompendo con i modelli chiusi, rilanciando la lezione allegorica di Dante e ponendo con forza la questione del significato – del suo bisogno, della sua ricerca, infine della sua mancanza -, Montale indica una strada nell’inferno meccanizzato, nel nuovo Medio Evo postmoderno in cui andiamo addentrandoci: più che alla fine di un percorso, sembra al suo inizio.
"Mi piace""Mi piace"
caro Guglielmo Aprile
Il Montale di Ossi di seppia e delle Occasioni ha alle spalle la sperimentazione linguistica e formale di D’Annunzio, qui non ci piove. Montale utilizza una sorta di continuità linguistica garantita dai suoi precedenti per effettuare il suo attraversamento critico, che lo porta ideologicamente al di là del «conservatorismo linguistico» (dizione di Mengaldo) di un libro come Ossi di seppia, che ad Ungaretti appariva un libro arretrato.
Il fatto è che è da almeno quaranta anni che alle spalle dei poeti di oggi non ci sono più né d’Annunzio né un Pascoli, quello che io definisco il processo inarrestabile di «narrativizzazione» della poesia italiana del secondo novecento e di questi ultimi lustri, è un dato di fatto non evitabile, né rimuovibile, per risolvere l’impasse di questa foce narrativa della poesia italiana di questi ultimi decenni, dobbiamo per forza di cose aderire ad un impianto di una nuova piattaforma estetica, è questo il senso della «nuova ontologia estetica» in cui siamo impegnati. È un processo ineludibile, non evitabile con facili smarcamenti monolinguistici e soggettivistici. È questo, credo, anche il senso della ricerca quasi «marxista» dice Mario Gabriele di Antonio Riccardi. Prima o poi, anzi, da subito, i nodi (stilistici) non possono non venire al pettine…
"Mi piace""Mi piace"
ANTONIO RICCARDI LEGGE GLI IMPIANTI DEL DOVERE E DELLA GUERRA
"Mi piace""Mi piace"
Per quanto mi riguarda, Montale non è stato mai centrale per me – in pensieri e poesia – anzi così periferico da scomparire del tutto; la stessa cosa per Ungaretti, a questi due e tant’altri come loro : discendenze ecc. oppongo i versi del Palazzeschi che almeno sono giocosi per quanto basta e seri nel loro sarcasmo.
—————–
Quella del Riccardi direi non poesia affatto con tratti marxsisti: è una etichetta che falsa il riconoscimento umanistico – rapporto filiale/paterno – dominante… anche, e ancora una volta – la periferia gioca le sue carte vincenti: rassegnazione attiva o passiva che sia dei soggetti trattati: il mondo operaio di una volta è trasfigurato in Riccardi dalla malinconia e dalla nostalgia – direi perfino sublimato poi che tende a sostenere la figura paterna per estirparla da una condizione sociale mortificante – ricordo (seconda metà degli anni ’60) i volti degli operai, manovalanze varie, impiegatizie uscire dalle fabbriche/industrie milanesi verso i tardi pomeriggi… li osservavo, e ne riuscivo a comprendere i loro stati d’animo, ecc. – processioni laiche e nulla di religioso che li sosteneva… io credo nemmeno quelle ideologie dominanti di allora… erano semplicemente creature con il capo e le spalle incurvate… coi loro sogni finiti in cocci nelle pozzanghere… disperazione? non credo affatto! Si accettava il reale e si andava avanti per i figli, ecc.
pensavo a mio Padre, giovanissimo garzone in una falegnameria salernitana
– fortunato lui, come pochissimi, che volgeva tutta la sua condizione in una comicità quotidiana disperante tipica di quelle zone campane… si arruolò per non morire di fame, si fece tutta la guerra e a 28 anni aveva già ogni cosa alle spalle… e ancora per tutto il resto della sua vita quella comicità nata dalle vicende amare/dolci concrete della vita, e avanti così per sopravvivere.
—
Ripeto la poesia del Riccardi merita attenzione pacata e vorrei che il critico la allontanasse dalle mistificazioni sociologiche ideologiche ecc. che sono soltanto puro ciarpame davanti a quelle vite vissute nella crudezza e nella crudeltà quotidiane…
…. è più difficile vivere che morire (Majakovskij)…
ma è sempre stato così: i Poeti lo sanno e in primis la Poesia… che cantano, che riescono ancora a cantare, nonostante…
grazie
"Mi piace""Mi piace"
UNA POESIA DI ANTONIO SAGREDO
Non avevi che un vessillo esangue e uno scudo bovino contro gli amori
inaciditi… il bronzo inutile dei tuoi occhi che raccattavano immagini invernali
per una emorragia di specchi e lacrime appuntite nei canali industriali, bambini che si giocavano l’infanzia scellerata e la gloria con astragali infetti e purulenti.
Le mie vie consolari raggelate dal sale e dalla pietà dei vinti!
Filologia spicciola dei sensi e di concetti mutati in fede analogica!
Processioni di bestiali credenze, confessioni vomitate dai supplizi!
Volontà dei corpi smembrata per un principio superiore e trascendente!
2009 – a.s.
"Mi piace""Mi piace"
«UNA POESIA CHE APPARENTEMENTE TENDE ALLA PROSA E NELLO STESSO TEMPO LA RIFIUTA», ebbe a dire Montale in una intervista su Satura. In modo paradossale e meta ironico Montale ci dà una chiave di interpretazione del suo libro e della «nuova poesia» che stava imperversando già in quegli anni (vedi le prove del primo Raboni e il linguaggio seriale della neoavanguardia). Quel libro, nella considerazione delle generazioni che verranno dopo, venne equivocato ed interpretato come un lasciapassare per la poesia che apriva alla «prosa» e ai temi del diario e delle occasioni; non venne recepita quella notazione, quel «rifiuta» con il quale il poeta ligure avvertiva della necessità vitale per la poesia di creare un contromovimento rispetto alla «prosa»…
Il fatto è che la poesia del Dopo Montale del minimalismo e del post-minimalismo
(Lamarque, Patrizia Cavalli, Zeichen, Magrelli ed epigoni) si è affidata ad una s-problematizzazione della forma-poesia, riducendo tutte le questioni al minimo comun denominatore della poesia-commento, della poesia descrittiva. Ha operato da «riduttore» stilistico, e le conseguenze di questa impostazione inconscia sono state la narrativizzazione sospinta all’estremo e la poesia come accompagnamento di un discorso laterale: discorso diaristico, occasionale, rapsodico, ludico, di intrattenimento.
Quando la S-problematizzazione
investe non solo il soggetto ma anche e soprattutto l’oggetto, ciò determina un duplice impasse narratologico, con la conseguenza della recessione del dicibile nella sfera dell’indicibile e la recessione di interi generi a kitsch. Mai forse come nel nostro tempo la dicibilità della poesia come genere è precipitata nell’indicibile: una grande parte dell’esperienza significativa della vita di tutti i giorni è oggi preclusa alla poesia, per aderire al genere romanzesco della narratività. Direi che l’ordinamento delle istituzioni poetiche con il suo semplice prescrivere il dicibile, bandisce tutto ciò che non è immediatamente dicibile nei termini della sua sintassi e del suo lessico. L’indicibile è ciò che non è più raggiungibile e possibile. Ecco spiegata la ragione del trionfo del minimalismo come cannibalismo della comunicazione.
Oggi i poeti non presentano più una «esperienza significativa»,
si limitano a comunicare il comunicabile, non fanno altro che fagocitare la tautologia. C’è oggi un’oggettiva difficoltà ad affrontare, in poesia, la problematica di un’«esperienza significativa». Che cos’è una esperienza significativa? Che cosa è un Evento?. La «scrittura poetica» contemporanea propone una sorta di registrazione del quotidiano o del passato del quotidiano o del passato della cronaca con l’impudenza della propria imprudenza. Conseguenza inevitabile dell’impasse in cui è caduta questa cosa chiamata poesia è che si parla molto più del «soggetto», dei suoi ruoli e del suo luogo, che dell’«oggetto», perché il soggetto ha cessato di funzionare come principio, come principio regolatore; per contro, si parla molto meno dell’«oggetto» che del «soggetto», così che il discorso poetico si dissolve in una miriade di appercezioni soggettive, in una fenomenologia delle sensazioni del «soggetto». Si scrive secondo un logos sproblematizzato, di conseguenza, i modi di espressione della soggettività vengono falsati, il logos subisce il tabù della nominazione.
La poesia dell’«esperienza»
A pensarci bene, è paradossale ma vero: la poesia dell’«esperienza» ha bisogno di un universo simbolico nel quale prendere dimora e di un rapporto di inferenza tra il piano simbolico e l’iconico; in mancanza di questi presupposti la poesia dell’io esperiente cessa di esperire alcunché e diventa qualcosa di terribilmente autocentrico ed egolalico, diventa la carnevalizzazione del soggetto, esternazione del dicibile sul piano del dicibile: ovvero, tautologia.
Se il senso della poesia manca, manca la poesia il suo bersaglio. Non v’è orientazione semantica senza orientazione del significato. La poesia esprime il senso che può, al di qua di ciò che intende e al di là di ciò che attinge. Il compito che oggi arride alla poesia dei «poeti nuovi» è appunto ricostruire una relazione tra il significato e il significante, ma in termini del tutto diversi rispetto a quelli che abbiamo conosciuto nel Novecento.
"Mi piace""Mi piace"
Riprendiamo uno stralcio dell’ampia discussione che ha avuto luogo in questo blog tra il 21 e il 29 dicembre scorso sulla vexata quaestio de “La componente innica e quella elegiaca del Novecento secondo Gianfranco Contini” e “la cartografia della poesia italiana del Novecento” sempre secondo Gianfranco Contini, perché a nostro avviso è qui che si concentrano, come in nuce, tutte le questioni e tutte le questioni come linguaggio, stile, canoni, modelli rappresentativi che avranno una ricaduta sulla poesia italiana del secondo Novecento determinandone gli esiti, fino ai giorni nostri.
(n.d.r.)
giorgio linguaglossa
21 dicembre 2015 alle 11:42
«Tra le cartografie della poesia italiana del Novecento, ve n’è una che gode di un prestigio particolare, perché è stata stilata da Gianfranco Contini. La caratteristica essenziale di questa mappa è di essere incentrata su Montale e sulla linea per così dire “elegiaca” che culmina nella sua poesia. Nel segno di questa “lunga fedeltà” all’amico, la mappa si articola attraverso silenzi ed esclusioni (valga per tutti, il silenzio su Penna e Caproni, significativamente assenti dallo Schedario del 1978), emarginazioni (esemplare la stroncatura di Campana e la riduzione “lombarda” di Rebora) e, infine, esplicite graduatorie, in cui la pietra di paragone è, ancora una volta, l’autore degli Ossi di seppia. Una di queste graduatorie riguarda appunto Zanzotto, che la prefazione a Galateo in bosco rubrica senza riserve come “il più importante poeta italiano dopo Montale” (…) Riprendendo un cenno di Montale, che, nella recensione a La Beltà, aveva parlato di “pre-espressione che precede la parola articolata”, di “sinonimi in filastrocca” e “parole che si raggruppano per sole affinità foniche”, la poesia di Zanzotto viene definita nello Schedario nei termini privativi e generici di “smarrimento dell’identità razionale” delle parole, di “balbuzie ed evocazione fonica pura”; quanto alla silhouette “affabile poeta ctonio”, che conclude la prefazione, essa è, nel migliore dei casi, una caricatura. (…)
L’identificazione di una linea elegiaca dominante nella poesia italiana del Novecento, che ha il suo culmine in Montale, è opera di Contini. Di questa paziente strategia, che si svolge coerentemente in una serie di saggi e articoli dal 1933 al 1985, l’esecuzione sommaria di Campana, il ridimensionamento “lombardo” di Rebora e l’ostinato silenzio su Caproni e Penna sono i corollari tattici. In questo implacabile esercizio di fedeltà, il critico non faceva che seguire e portare all’estremo un suggerimento dell’amico, che proprio in Riviere, la poesia che chiude gli Ossi, aveva compendiato nell’impossibilità di “cangiare in inno l’elegia” la lezione – e il limite – della sua poetica. Di qui la conseguenza tratta da Contini: se la poesia di Montale implicava la rinuncia dell’inno, bastava espungere dalla tradizione del Novecento ogni componente innica (o, comunque, antielegiaca) perché quella rinuncia non apparisse più come un limite, ma segnasse l’isoglossa al di là della quale la poesia scadeva in idioma marginale o estraneo vernacolo (…) Contro la riduzione strategica di Contini converrà riprendere l’opposizione proposta da Mengaldo, tra una linea “orfico-sapienziale” (che da Campana conduce a Luzi e a Zanzotto) e una linea cosiddetta “esistenziale”, nella polarità fra una tendenza innica e una tendenza elegiaca, salvo a verificare che esse non si danno mai in assoluta separazione. »
Sono parole di Giorgio Agamben (in Categorie italiane, 2011, Laterza p. 114). Tra gli stereotipi più persistenti che hanno afflitto i geografi (e i geologi) della poesia italiana del secondo Novecento, c’è quello della ricostruzione dell’asse centrale del secondo Novecento a far luogo dalla poesia di Zanzotto, già da Dietro il paesaggio (1951) fino a Fosfeni (1983). Di conseguenza, far ruotare la poesia del secondo Novecento attorno al «Signore dei significanti» come Montale ebbe a definire Zanzotto, dal punto di vista di fine secolo può considerarsi un errore di prospettiva. Ma se rovesciamo il punto di vista del secondo Novecento con cui si guarda alla geografia del primo, Campana appare come il poeta nella cui opera vengono a confluire i due momenti: quello innico e quello elegiaco…*
* Giorgio Linguaglossa Dopo il Novecento. Monitoraggio della poesia italiana contemporanea (2000-2013) 2013 Società Editrice Fiorentina, pp. 148 € 14.
"Mi piace""Mi piace"
Questa analisi è chiara di una situazione quale noi la ereditiamo oggi; e del dove oggi ci troviamo. Come aver vorticato in un labirinto in cui si percorre sempre lo stesso segno.
Voglio aggiungere che un motivo valido c’è stato, se all’estero i contemporanei parlavano di Ungaretti, e tralasciavano Montale. Penso ancora a Elytis (è il mio pane, il mondo greco, dunque la testa corre inevitabilmente lì), alla sua ricerca sulla lingua poetica; e al suo breve saggio su Ungaretti. Non si occupò certo di Montale, ciò che interessava erano i linguaggi che tentavano di scardinare il vecchio nella propria lingua, i tentativi di de-costringere la lingua poetica dalle maglie dell’infibulazione retorica.
Dall’altro lato, mi chiedo quale sarebbero stati i possibili sviluppi in poesia se le stroncature post mortem di Prezzolini nei confronti di Boine (stroncature poi ingiustamente riverberate da molti altri, senza quasi aver aperto una pagina del poeta di Portomaurizio), non avessero precluso una strada che era davvero innovativa: certo in fieri, ma già matura, già fruttifera… E Boine, Rebora e Campana facevan bella compagnia, in verità. Ognuno con la propria ricerca – e siamo agli inizi del secolo XX – che certo cantava il preludio di una diversità.
Ci siamo allontanati, questo è il mio sentire a riguardo, sempre più dal percorso che rinnova se stesso. Per paura di cosa, non so. O per tracotanza. Certo è che in Nord Europa, come nel bacino del Mediterraneo, troviamo vene pulsanti, spinta, azzardo.
Con i “se” non ci si raccoglie molto: “se la strada fosse stata un’altra…”, ma non lo è stata. Allora il lavoro nostro è un carotaggio nella lingua poetica, spostare strati di detriti, toccare la viva umidità della parola.
Vorrei postare, per chi potrà apprezzare l’uso della lingua inglese qui, la lettura del poeta irlandese Dave Lordan, che ho conosciuto anni fa a Bolzano. Qui la tradizione viene spezzata, il verso tirato fin quasi allo sfaldamento. E apre nella contemporaneità, conscio del passato, con qua e là citazioni foniche, occhieggiamenti necessari alla tradizione recente (cos’altro si può fare, se non riprendere dal punto più alto di dove il discorso s’è interrotto?):
"Mi piace""Mi piace"
L’ha ribloggato su RIDONDANZEe ha commentato:
Promemoria
"Mi piace""Mi piace"
Cari amici, una mia poesia…
Da qualche giorno
Da qualche giorno, il sospetto che il mare è là dietro.
Dietro lo schermo sbavato di case.
Tra loro si afferrano ai fianchi, come sostegno.
Qui, la persiana ha una fessura puntata sulla scala di ferro battuto.
Sale a chiocciola. Dal cortile, al terrazzo condominiale – testimonia la foto
scampata al massacro dei ricordi –.
Una perfezione fonda, inconoscibile, è forse oltre.
Lo lasciano intendere i gabbiani – stanno qui, da poco tempo, dentro i muri
Più grandi, sul terrazzo condominiale. Sforano la luce.
Ma non è concesso di seguirne i voli. Dall’alto ci sorvegliano.
Se intuiscono uno sguardo intento, scendono in picchiata.
Rasentano gli occhi.
"Mi piace""Mi piace"
“La remora, piccolo per statura e grande per la Potenza, costringe le superbe fregate del mare a fermarsi;
avventura che come ci racconta Plinio toccò alla quinquereme dell’imperatore Caligola.
Mentre questi ritornava dall’Astura ad Anzio, il pesciolino, lungo mezzo piede, si attaccò succhiando
al timone della nave, provocandone l’arresto.
Plinio non finisce mai di stupirsi del potere della remora.
La sua meraviglia evidentemente impressionò gli alchimisti al punto di indurli a identificare il pesce rotondo
del nostro mare proprio con la remora.
La remora divenne così il simbolo dell’estremamente piccolo nella vastità dell’inconscio.
Che ha un significato tanto fatale: esso è infatti il Sé, l’Atman, quello di cui si dice
che è il più piccolo del piccolo, più grande del grande.”
Carl Gustav Jung
(Ricerche sul simbolismo del Sé)
In questi tuoi versi recentissimi, Costantina cara, mostri di avere sconfitto
la remora. Brava.
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
Commento di Giorgio Linguaglossa alla poesia di Donatella Costantina Giancaspero “Da qualche giorno”
La poesia è un enigma ma un enigma è un labirinto che contiene innumerevoli percorsi, che non può essere sciolto da un atto di padronanza categoriale ma può soltanto essere percorso. La poesia indica questo, indica il percorso da seguire per risolvere l’enigma. Ed il percorso ha la struttura dell’esistenza, una struttura labirintica, soltanto esistendo si può sciogliere l’enigma. L’esistenza è sostanzialmente un vedere, capacità visiva, potenza della capacità visiva. Non è un caso che la poesia termina con l’accenno ai «gabbiani» i quali «sforano la luce», essi che «dall’alto ci sorvegliano», che hanno una suprema capacità di visione, e «scendono in picchiata», ci «rasentano gli occhi».
La poesia rappresenta l’impossibilità di vedere l’Altro,1] di vedere, afferrare il reale con occhio frontale. L’Altro come luogo della parola, è il luogo del reale. È impossibile vedere il reale guardandolo dritto negli occhi, previo il suo svanire. Non si può cioè fare del linguaggio l’oggetto di una visione diretta in quanto «il linguaggio è esso stesso quel presupposto che consente la visione». Il linguaggio, ci dice Giorgio Agamben,2] è ciò che deve necessariamente presupporre se stesso . Il che significa che, come tale, esso è ciò che un ultima istanza manca di presupposto, e questo mancare si dà come esperienza irriducibile, come condizione stessa affinché via sia linguaggio. Dire che non c’è metalinguaggio significa così affermare che ogni dire – e lo stesso ordine significante – si smarrisce una volta posto di fronte ai suoi presupposti.
È qui che ci viene in aiuto la nozione lacaniana di «fantasma», nozione singolare e alquanto oscura che Lacan introduce per descrivere la natura più profonda del desiderio umano, e cioè quel suo essere «desiderio di nulla» che presto si rovescia in un «nulla di desiderio», quel nulla in cui la parola scava la sua dimora e in cui il soggetto fa esperienza della sua propria mancanza a essere. Il soggetto della poesia scopre il proprio svanire come soggetto nel momento in cui vede per la prima volta il «reale», ma, per farlo deve necessariamente sogguardarlo da «dietro lo schermo», dal riparo di un nascondiglio.
Un pensiero ricorrente, ricorsivo, si presenta, anzi, si insinua nella soggettività «da qualche giorno», e con esso il «sospetto che il mare è là dietro», che la soggettività sia un nonnulla, un vuoto che si riempie con gli sguardi. E infatti, l’io si trova a sbirciare da dietro una «persiana»: «qui, la persiana ha una fessura puntata sulla scala di ferro battuto». La poesia ci dice che c’è una «scala di ferro battuto [che] sale a chiocciola». È un preciso frammento di realtà. Una indicazione segnaletica. Soltanto un frammento può illuminare un altro frammento. È possibile sogguardare un frammento di «reale» sostando in un altro frammento del «reale». Tra i due «reali» c’è un collegamento: il soggetto, che si scopre vuoto, che evanesce una volta posto sotto l’imperio dello sguardo, del significante. La poesia deve sfuggire all’imperio dello sguardo-significante e, per far questo, deve procedere come se la parola fosse muta, come un sogno, o meglio, un incubo silenzioso.
La rappresentazione è nitida e precisa come una pittura iperrealista, il lettore deve solo seguire i nessi e ripercorrere il percorso dello sguardo.
Pensiero ed essere sono reciprocamente estranei, non possono comunicare se non da una distanza abissale. La poesia ci narra questa distanza abissale, l’assenza del pensiero. Infatti il pensiero è nello sguardo, fuori dello sguardo il pensiero semplicemente non esiste, non c’è, in quanto l’essere del soggetto appartiene all’esperienza della parola, che è l’esperienza della mancanza. Il soggetto è cioè costantemente rimandato al di là, per la natura stessa del linguaggio, dello sguardo, alla ricerca di una significazione che lo racchiuda. Il suo essere non è, pertanto, lì dove la soggettività pensa, non è lì dove il soggetto si dice e si afferma come cogito, ma lì dove non c’è, dove si dà allo stato come mancanza, come mero sguardo.
[…]
1] Si veda, J. Lacan, Écrits, Édition de Seuil, Paris 1966; trad. it. a cura di G. B. Contri, Scritti 2 voll., Einaudi, Torino 1970; in particolare Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell’inconscio freudiano, pp. 815-16: “Partiamo dalla concezione dell’Altro come luogo del significante. Ogni enunciato d’autorità non trova in esso altra garanzia che la sua stessa enunciazione, perché è vano che la cerchi in un altro significante, che in nessun modo potrebbe apparire fuori da questo luogo. Cosa che formuliamo col dire che non c’è un metalinguaggio che possa esser parlato o, più aforisticamente, che non c’è Altro dell’Altro ”. deve necessariamente presupporre se stesso. Il che significa che, come tale, esso è ciò che un ultima istanza manca di presupposto, e questo mancare si dà come esperienza irriducibile, come condizione stessa affinché via sia linguaggio. Dire che non c’è metalinguaggio significa così affermare che ogni dire – e lo stesso ordine significante – si smarrisce una volta posto di fronte ai suoi presupposti
2] Agamben G, La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza, Milano 2004, p. 28.
"Mi piace""Mi piace"
Nell’«esame di coscienza di un letterato», nel 1915, Renato Serra scriveva:
«La guerra non mi riguarda. La guerra che altri fanno, la guerra che avremmo potuto fare… la guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo, è enorme, ma è quello solo; accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia nulla, assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura.
[…]
ripetiamo dunque, con tutta la semplicità possibile. La letteratura non cambia. Potrà avere qualche interruzione, qualche pausa, nell’ordine temporale: ma come conquista spirituale, come esigenza e coscienza intima, essa resta al punto cui l’aveva condotta il lavoro delle ultime generazioni; e, qualunque parte ne sopravviva, di lì soltanto riprenderà, continuerà di lì. È inutile aspettare delle trasformazioni o dei rinnovamenti dalla guerra, che è un’altra cosa: come è inutile sperare che i letterati ritornino cambiati, migliorati, ispirati dalla guerra… per il resto, ognuno rimane quello che era. Ognuno ritorna… al lavoro che aveva lasciato».
Se oggi ripenso all’altra «guerra», quella combattuta dall’Italia industriale degli anni Cinquanta e Sessanta, allora mi dico che quella fu una vera «guerra»; ma, stranamente, quella guerra fu combattuta da altri. I letterati erano occupati in altre questioni e nella poesia italiana dell’epoca non v’è traccia di altoforni, di acciaierie, della Breda, della Falck e degli uomini che vi andarono a lavorare. Quella realtà la ritroviamo, invece, paradossalmente, oggi, in un poeta che non ha vissuto in prima persona quella «guerra» ma che l’ha saputa rimemorare dalla memoria ancestrale collettiva, dandole un significato che va molto al di là del valore memoriale individuale per attingere un valore paradigmatico, che ci coinvolge tutti.
Paradossalmente, quella «guerra» di cui la poesia italiana dell’epoca non si è accorta, rivive oggi in un libro di poesia a distanza di cinquanta anni.
"Mi piace""Mi piace"
Effettivamente testimonianze di fabbriche, acciaierie, industrie, vita operaia o questioni sociali furono affrontate da scrittori quali Vittorini, Volponi o Ottieri che con i suoi “taccuini industriali” coniò il filone della letteratura industriale. Libro denso di implicazioni dunque questo di Riccardi, in quanto segna il passaggio dall’economia industriale all’economia finanziaria, (come afferma l’autore stesso nell’intervista postata sopra) e aggiungerei anche il passaggio ad un capitalismo assoluto e ad una finanza estremistica e virtuale…e ciò che colpisce nei testi è anche l’ intensificazione semantica del “corpo” e delle sue variazioni e isotopie, le materie, i materiali, i macchinari, la concretezza che in una società sempre più liquida, sembra già memoria storica. Memoria storica di quei “trenta anni gloriosi” di cui parla Hobsbawm (1945 – 1975) di stabilità lavorativa, di lavoro fisso anche se alienante e “fordista”.
Vorrei qui ricordare il caso del poeta Di Ruscio, operaio metalmeccanico nella fabbrica fordista di Oslo dal ’57, che visse la condizione operaia come autentica condizione esistenziale: (Da “Poesie operaie”,Ediesse, 2007)
Il colpo di martello che spezza il mattone
O il verso allucinato che smaglia
Guardare la cosa mentre ci acceca
L’improvviso bagliore della fiamma ossidrica
O quello che cadde nella vasca della cale viva
Scavata la fossa scaricate le pietre cotte
Poi con l’acqua tutto ribolliva e fumava
Il ribollire delle pietre cotte fu l’ultima cosa che vide.
Lo strazio della fabbrica risultava indicibile
Chi era dentro l’inferno della condizione operaia non diceva niente
E chi era fuori della condizione poteva dire tutto però non sapeva niente
Quindi il poeta doveva calarsi nell’inferno quotidiano
Ungersi le mani in quaranta anni di putiferi
Partire alle cinque del mattino con la bicicletta
Anche con venti gradi sotto zero verso la fine del mondo…
"Mi piace""Mi piace"
scusate qualche refuso: “nella vasca della calce viva”
"Mi piace""Mi piace"
correva l’anno 1989, la corrida tra Valerio Magrelli e Margherita Guidacci…
"Mi piace""Mi piace"
Già “Il profitto domestico” (1969, Mondadori) aveva rivelato una figura centrale, Antonio Riccardi, di un nuovissimo modo di fare poesia.
Un modo che si incardina “nel controllo morale di una rigorosa sobrietà di dettato e di un ampio progetto di cui ‘Gli impianti del dovere e della guerra’
sono parte nucleare…”
La geografia poetica di Antonio Riccardi è precisa, tra la campagna di Cattabiano intorno a Parma (i luoghi poetici, non dimentichiamolo, anche di Attilio Bertolucci) e Sesto San Giovanni ovvero “la piccola Stalingrado” dell’Italia industriale post-bellica. Eppure, questa tutto sommato ristretta geografia diventa “tutto” nella narrazione in versi di Antonio Riccardi il quale, frugando nella sua mitologia personale, ci consegna i memorabili segni d’una mitologia industriale nella cui “bolgia dei vivi” si muovono, come segnala in un suo vivo commento Giorgio Linguaglossa, uomini veri destinati a consumarsi nel loro quotidiano dovere tra “i bagliori dei forni e dei laminatoi”. Congegni, automi e macchine che consumando uomini presi
dal senso del dovere preparano “pezzi in serie per armi da guerra…”
E’ un esempio di personalità forte questo libro di Antonio Riccardi che è in grado “di riscattare alla poesia una realtà oscura e opaca, ma nondimeno terribile e grandiosa” in una esemplare e rara e saggia “pacatezza dei suoi accenti” cui viene affidata l’originale “potenza epica” tra complessità della Storia e contraddizioni drammatiche del moderno.
Ecco i segni della “guerra” di cui parla Giorgio Linguaglossa nella parte finale
del suo precedente commento, segni che a noi giungono grazie alla narrazione in versi del Riccardi de “Gli impianti del dovere e della guerra”.
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
la Poesia della Giancaspero e quella della Catapano sono per me una sorpresa senza fine ogni volta e sono felice di conoscerle personalmente e di leggere i loro versi: ambedue sono armate come la mia pupilla di visioni estemporanee che fanno vividi i loro versi: ciascuna secondo le loro peculiarità liriche.
Per ritornare al Riccardi… ripropongo che il critico davvero analizzi la sua poesia distanziandosi da analisi pseudo-socialisteggianti ecc.
grazie
"Mi piace""Mi piace"
caro Antonio Sagredo,
ho scelto di presentare le poesie di Impianti del dovere e della guerra perché mi davano la possibilità di esercitare un lungo excursus sulla poesia italiana dagli anni settanta agli anni Dieci del nostro secolo e di soffermarmi su alcuni nodi irrisolti che vengono da lontano. Avrei potuto soffermarmi su Il profitto domestico del 1996 o su Acquarama e altre poesie d’amore del 2009, ma erano libri sui quali non avrei potuto dire quello che ho detto, avrei dovuto dire magari altre cose interessanti, ma a me stava a cuore mettere in evidenza certi «nodi». Certo, se tu cerchi nella poesia di Antonio Riccardi quella che Mandel’stam chiamava negli anni Dieci del novecento la «colonna sonora» della poesia simbolista russa o, per tornare a noi, una orchestrazione di significanti sonori come quella di D’Annunzio, o, per altri versi, come quella di Zanzotto, si rischia di andare fuori strada, qui non c’è alcuna colonna sonora, alcuna «anima sinfonica» (alla maniera di Claudio Borghi), qui siamo in una poesia che si attesta e si arresta ai significati, i significati vengono richiamati con i nomi propri, i nomi dei luoghi e i nomi delle persone; in questo tipo di poesia i nomi tentano di avvicinarsi alle cose. Questo è importante. È una poesia che va verso la stabilizzazione dei significati. In tal senso ho parlato di «realismo», come di un contro movimento rispetto alla poesia che si fa da molto tempo in qua in Italia e che si affida, di solito inconsapevolmente, alla retorizzazione del soggetto. Qui ad essere retorizzato è l’oggetto. E il cambio di marcia, anzi, di direzione rispetto alla poesia di moda mi sembra evidente e significativo.
Un’ultima annotazione: con i libri di Antonio Riccardi siamo fuori della invalsa abitudine di confezionare delle miscellanee, libri di poesia-diario, poesia delle occasioni o, peggio ancora, poesia, come si dice ora, del corpo, poesie della oralità (come si dice con corriva sproblematizzazione delle parole).
"Mi piace""Mi piace"
Poesia di piombo e ferro, quindi preclusa alla metafisica, di ricerca esistenziale più che politica; con esiti che sanno di futurismo russo, quindi ben diversi da quelli di Di Ruscio ( cit. L. Leone). Tentativo in parte riuscito di smarcamento rispetto a tanta lirica, italiana ma non solo: non del tutto riuscito perché gli strumenti di piega, fusione e incastro delle parole sono ancora di tipo tradizionale, più adatti alla carpenteria leggera che all’industria pesante. A tratti pare di stare al Museo della scienza e della tecnica di Milano. Ovvio che queste mie sono soltanto impressioni per quanto scritto su questa pagina. Però i complimenti li faccio: bravo Riccardi. E ora torniamo al lavoro.
"Mi piace""Mi piace"
Condivido tutto quanto affermato e proposto da Linguaglossa.
Inoltre, mi ripugna “l’arte per tutti”, è solo una perifrasi per “che si può vendere a tutti”: guardali, questi venditori di passione e idee bisognosi di travisare il loro mestiere come filantropia (vale per tutta la cultura mainstream, e, in verità, per la poesia meno che per tutte le altre forme di espressione: non per nulla la poesia è relegata a dietro le quinte, e le è proibito di camminare sul palcoscenico).
Però, sarebbe bello se ogni autore aggiungesse una sintetica chiarificazione dei passi meno facilmente decrittabili, e del significato complessivo della poesia.
Ho benissimo presenti molte ragioni per cui tutto ciò sarebbe un gravame, e una sofferenza. Ma offrire, anzi: servire, un’interpretazione non impedirebbe a chi può di, indisturbato, rintracciare (e sognare!) mille altri significati.
Insomma, un coraggioso, umile tendere la mano da parte di chi è qualche gradino piú in alto.
Pensando a una lettura recente dico che mi sarebbe piaciuto, ad esempio, essere aiutato a venir… contagiato dall’acqua.
"Mi piace""Mi piace"
No, caro Giorgio, non cerco la “colonna sonora”, affatto! – se mai il suo contrario!
as
"Mi piace""Mi piace"
Caro Antonio Sagredo,
la dizione «colonna sonora» non era riferita a te, ma in generale.
"Mi piace""Mi piace"
“”Ma se rovesciamo il punto di vista del secondo Novecento con cui si guarda alla geografia del primo, Campana appare come il poeta nella cui opera vengono a confluire i due momenti: quello innico e quello elegiaco…*…
Bene hai scritto, e per questo che Campana senza ombra di dubbio è il maggiore poeta italiano del secolo trascorso, proprio perché non solo confluiscono quei due momenti ma si fondono talmente che è poi impossibile separarli: perciò osmosi, simbiosi e infine fusione generano quel “gorgo sublime” che ci attanaglia e a cui restiamo talmente avvinghiati che ne siamo assoggettati fino alla fine di una lettura p.e. di una sua poesia come capita in “Genova”…. così a me capitò giovanissimo quando lo scoprii , così ancora adesso ne sono attratto, ancora!
E che devo dire? > quei due momenti mi appartengono alla stessa maniera!
—–
Bene Carmelo lo sapeva benissimo ed è per questo che lo declamò superbamente… ad altri poeti italiani (specie i futuristi) a cui rivolse la sua attenzione fu soltanto per distrarsi. per uscire dunque da un disagio… provate ad ascoltare :
“Oro, farfalla dorata polverosa perché sono spuntati i fiori del cardo?”
a.s.
"Mi piace""Mi piace"
Mi accodo anch’io al coro di approvazione per le poesie di Riccardi qui proposteci da Giorgio, espresso dagli amici che mi hanno preceduto. Non è una scoperta totalmente nuova per me, ma avevo avuto finora solo delle occasioni sporadiche di approfondirne l’opera. In realtà condivido l’osservazione di Lucio sulla natura in qualche modo ibrida della versificazione di Riccardi, in bilico tra la morfologia e direi la sintassi tradizionale ed il nostro percorso di ricerca innovativo; direi anzi alla luce dei brani testé letti che probabilmente prevalga nel complesso una struttura “cognita”, ma con degli sprazzi, delle intuizioni, delle visioni che gli attribuiscono a pieno titolo un’etichetta di innovatività. Senz’altro non consueti sono poi i temi sviscerati, al di là del sottofondo di denuncia sociale (che comunque non abbonda nella nostra tradizione poetica) ma anche per le atmosfere che oserei definire da “neo-realismo” lirico, ma decisamente essenziale, diretto, scabro, senza possibilità di catarsi alcuna rispetto alle dure realtà ritratte e per l’ambientazione che sembrano rimandare per un verso a Testori per la cornice della periferia milanese degli anni del grande processo di industrializzazione ed al filone narrativo – industriale di Parise, Volponi ed Ottieri dall’altro, contesti non sono proprio abituali nel panorama poetico italiano. Nel complesso la trovo un’esperienza poetica molto interessante.
"Mi piace""Mi piace"
Pingback: Emilia Barbato Poesie Scelte da Capogatto (puntoacapo, 2016), con un Commento impolitico di Giorgio Linguaglossa | L'Ombra delle Parole Rivista Letteraria Internazionale