
Grafiche di Lucio Mayoor Tosi
Giorgio Linguaglossa
Il «frammento» è il luogo privilegiato in cui si mostra la modernità
Il frammento è l’Estraneo. Il dio che è morto ha prodotto una gigantesca esplosione di frammenti dall’Uno originario dove l’identità coincideva con il senso. Il capitalismo con il suo sviluppo tumultuoso ha decretato la morte di dio. Il mercato, il nuovo Moloch, ha sostituito dio ed è diventato la nuova fede post-moderna. Il nuovo Moloch con le sue leggi autoregolantesi ha fatto sloggiare dio dal mondo.
Walter Benjamin intuisce acutamente che il filosofo e l’artista devono diventare dei «pescatori di perle», devono soffermarsi su oggetti apparentemente non degni di attenzione, sugli «stracci», su aspetti generalmente ritenuti trascurabili e negletti dallo sguardo ufficiale degli addetti alla cultura. Questi oggetti, questi luoghi privilegiati sono i frammenti che la metropoli moderna mette in mostra nelle sue vetrine e nei suoi passages capaci di investire i passanti con continui choc percettivi. Il mondo moderno è un mondo di frammenti impazziti che sostituiscono la contemplazione statica da un punto di vista esterno con la «fruizione distratta» di un punto di vista in movimento.
Per Walter Benjamin l’immagine è dialettica nell’immobilità. Le immagini si danno soltanto in “costellazioni”
Scrive Walter Benjamin:
«Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’ora in una costellazione. In altre parole: immagine è dialettica nell’immobilità. Poiché, mentre la relazione del presente con il passato è puramente temporale, continua, la relazione tra ciò che è stato e l’ora è dialettica: non è un decorso ma un’immagine discontinua, a salti. – Solo le immagini dialettiche sono autentiche immagini (cioè non arcaiche); e il luogo, in cui le si incontra, è il linguaggio».1]
Il concetto di «costellazione» è importantissimo anche per la NOE., le immagini si danno soltanto in “costellazioni”, in mosaici. Alessandro Alfieri in un saggio afferma acutamente che l’immagine dialettica si oppone alla epoché fenomenologica, è una diversa modalità di percepire gli oggetti attraverso la «fruizione distratta». La «contemplazione» del soggetto eterodiretto, e la «percezione distratta» sono fenomeni tipici della modernità che la poesia di Baudelaire tenne ben presente all’alba della poesia del Moderno.
Dal punto di vista della NOE, il ripristino e la valorizzazione delle benjaminiane «percezione distratta» e della immagine come «dialettica della immobilità», sono elementi concettuali importantissimi per comprendere un certo tipo di operazione estetica della poesia e del romanzo moderni: Salman Rushdie, OrhanPamuk, Mario Gabriele, Tomas Tranströmer, Kjell Espmark e, più in generale la poesia della NOE, non sarebbero comprensibili senza tener conto della rivoluzione molecolare della percezione in atto dall’alba del Moderno ad oggi.
Tanto più oggi che viviamo in mezzo ad una rivoluzione molecolare permanente (quella della proliferazione delle emittenti linguistiche… anche le immagini sono percepite dall’occhio come icone segniche, immagini linguistiche, lampegggiamenti segnici e semaforici…), oggi la percezione distratta è diventata il nostro modo normale di interagire con il mondo, anzi, il mondo si dà a noi sub specie di immagine in movimento, frammento, processualità di dettagli… con buona pace di chi pensa ancora la poesia con schemi concettuali pre-baudeleriani…
Così commenta Alessandro Alfieri:
«I frammenti sono da un lato prodotti della cultura del consumo, della moda, della meccanizzazione dell’agire, ma su un altro livello sono anche promessa di futuro, possibilità offerta agli uomini di scardinare la storia dei vincitori e il tempo mitico del sempre-uguale.
La frammentarietà che caratterizza il mondo moderno, oltre ad essere il contenuto ovvero il tema di gran parte della produzione benjaminiana, è al contempo anche fondmento formale e stilistico; Benjamin non ha più alcuna fiducia per il trattato esauriente e per il sistema, ed è la sua stessa produzione a essere espressione della medesima frammentarietà di cui parla, prediligendo per esempio la scrittura saggistica su determinati argomenti o autori. Ma è soprattutto nella sua ultima grande opera, rimasta incompiuta, che tale frammentarietà assurge alla sua più piena espressione, ovvero i Passages, un “montaggio” di impressioni, idee, citazioni, “stracci” appunto, che nel loro accostarsi fanno emergere significati inediti, elementi che contribuiscono a sconfiggere quella fantasmagoria seduttiva in grado di anestetizzare il pensiero critico».2]
Stante quanto sopra, non è chi non veda la stretta attinenza di questa problematica con il metodo compositivo della poesia di Mario Gabriele, la sua strategia compositiva è più simile al mosaicista che sistema con tenacia e pazienza le singole tessere di un mosaico-puzzle piuttosto che ad un amanuense che scrive i suoi endecasillabi sonori e i suoi ipersonetti. Gli «stracci» e i «tagli», le citazioni,, le faglie, le schisi e i titoli da cartellone pubblicitario di Gabriele sono tessere iconiche e semantiche di un mondo frammentato e frammentario abitato non già da una nicciana «verità precaria» ma dalla stessa precarietà della nozione di verità e della sua umbratile condizione ontologica nel moderno avanzato.
1] W. Benjamin I “passages” di Parigi, Einaudi, Torino 2007, p. 516
2] Alessandro Alfieri In Aperture, n. 28, 2012
Lucio Mayoor Tosi, Mario Gabriele
Citazioni di Jacques Lacan, Giorgio Linguaglossa, Vincenzo Vitiello, Pier Aldo Rovatti
Il soggetto è quel sorgere che, appena prima,
come soggetto, non era niente, ma che,
appena apparso, si fissa in significante.
L’io è letteralmente un oggetto –
un oggetto che adempie a una certa funzione
che chiamiamo funzione immaginaria
il significante rappresenta un soggetto per un altro significante
J. Lacan – seminario XI
*
L’«Evento» è quella «Presenza»
che non si confonde mai con l’essere-presente,
con un darsi in carne ed ossa.
È un manifestarsi che letteralmente sorprende, scuote l’io,
o, sarebbe forse meglio dire, lo coglie a tergo, a tradimento
G. Linguaglossa
Il soggetto è scomparso, ma non l’io poetico che non se ne è accorto,
e continua a dirigere il traffico segnaletico del discorso poetico
G. Linguaglossa
La parola è una entità che ha la stessa tessitura che ha la «stoffa» del tempo
G. Linguaglossa
La costellazione di una serie di eventi significativi costituisce lo spazio-mondo
G. Linguaglossa
Con il primo piano si dilata lo spazio,
con il rallentatore si dilata e si rallenta il tempo
G. Linguaglossa
Con la metafora si riscalda la materia linguistica,
con la metonimia la si raffredda
G. Linguaglossa
Non l’atto è prima della potenza, non l’essere è prima del possibile,
ma questo – il possibile, il possibile non la potenza –
è prima del mondo, della vita, dell’essere.
“La possibilità più in alto della realtà” mette in giuoco tutto…
*
Il più grande pericolo del pensiero è – il pensiero.
L’onnifagia del pensiero. Là più pericolosa, dove si cela.
*
il linguaggio di Celan sorge quando il linguaggio di Heidegger muore,
volendo dire che il linguaggio della poesia – della ‘nuova’ poesia –
può sorgere soltanto con il morire del linguaggio tradizionale
che la filosofia ha fatto suo, o – forse – che si è impadronito della filosofia
Vincenzo Vitiello
L’evento è prima dell’essere, è più antico e originario dell’essere.
E questo dipende da quello come la possibilità
viene prima dell’evento e lo fonda
G. Linguaglossa
L’enigma non può essere sciolto con un atto di padronanza categoriale
ma può solo essere percorso
Pier Aldo Rovatti
-
Letizia Leone, Anna Ventura
- Lucio Mayoor Tosi
28 aprile 2017 alle 16:59 Modifica
Questo articolo era necessario, contestualizza il frammento e, di conseguenza, mette in chiaro che la Nuova Ontologia Estetica non sta inventando nulla che non sia già nella realtà. Si potrebbe aggiungere che gli autori NOE sono forse i primi ad aver focalizzato la loro attenzione sulla percezione del frammento come forma-pensiero.
Ne deriva un nuovo e diverso modo di concepire la poesia. Bisogna però riconoscere alla critica – a Giorgio Linguaglossa – il merito di aver messo la chiarezza necessaria in autori che già andavano in questa direzione, individualmente e, diciamolo, senza tante speranze di poter essere capiti nel giusto modo.
A Enrico Castelli Gattinara, che ringrazio per l’esauriente excursus sul frammento, vorrei dire che le esperienze artistiche del novecento, in particolare quelle prese in esame (Mimmo Rotella) si muovevano con altri intendimenti, perlopiù dovuti al sentimento di modernità che ha segnato il secolo scorso. Fino alle macerie. Ora non si tratta di lavorare creativamente sui reperti ma di crearne appositamente di nuovi. E’ questa la luce che sta animando le poesie di Gino Rago, per dire forse del più classico tra i nuovi autori NOE, di Mario M. Gabriele che i reperti li usa come gomma da masticare… il pensiero arioso di Steven Grieco mentre che si libera dai secoli, e lo stesso Giorgio Linguaglossa, di pensiero-in pensiero. Sembra di assistere a un’evasione in massa, se non dalla galera, dal retrobottega di tanta tradizione resa asfittica dalla ripetitività nonché dal mondo che sta guardando altrove, in evidente trasformazione del proprio DNA. L’impresa è disperata e lo si sente quasi in ognuna di queste nuove poesie.
In pittura io lavoro con quei “mattoni, destinati a diventare muro, precariamente accatastati” per dirlo con le parole di Castelli Gattinara. Ma sono mattoni nuovi, creati apposta per costruire qualcosa che non so nemmeno io quando inizio; li creo singolarmente, uno ad uno e poi li accosto; vedo quel che potrebbe accadere, quale narrazione ne può derivare; lascio aperti i significati; dormo, aspetto e poi aggiusto. E’ un’invenzione continua. Alcune opere finiscono, e allora ci metto un titolo – Freezer, Pablo… delle sciocchezze, dei nomi, mai dei concetti, tutt’al più un verso breve – altre opere sono destinate a restare aperte a infinite altre possibilità di accostamento.
Ringrazio Giorgio per averne esposta qualcuna su questa pagina. Ne approfitto per invitare i lettori a venirmi a trovare alla prossima mostra che farò a Milano, in via Savona 99. Dal 2 al 10 maggio prossimi.
-
Antonio Sagredo, Gino Rago
- Gino Rago
28 aprile 2017 alle 18:46 Modifica
Lodi al frammentato excurs sul frammentismo di Enrico Castelli Gattinara e alle venature sociologiche, musicali, artistiche della sua relazione.
E nulla da aggiungere all’acutezza dei commenti di Francesca Dono,di Costantina Donatella Giancaspero, di Mario Gabriele, di Lucio Mayoor Tosi, di Luciano Nanni e dello stesso Giorgio Linguaglossa che instancabilmente adocchia, sceglie e propone relatori e relazioni a hoc rispetto alla economia estetica della NOE che ormai, piaccia o no, è una realtà poetica in cammino e ben riconoscibile nel nostro panorama poetico.
Dunque, i poeti della NOE che si muovono nello Spazio Espressivo Integrale mai più – con Mario Gabriele a più riprese lo abbiamo fermamente sostenuto e quasi urlato – devono avvertire il benché minimo bisogno di doversi giustificare nei riguardi di nessuno dei vari sabotatori o guastatori d’assalto i quali, lungi dal bonificare presunti campi minati, saltano l’uno dopo l’altro sulle mine antiuomo che pretendevono di bonificare…
Piuttosto, voglio esprimere la mia totale adesione agli esiti dei cromatismi della ricerca d’arte di Lucio Mayoor Tosi, al suo modo di combinare le “tessere” dei suoi mosaici postmoderni nei quali l’osservatore ( o il fruitore ) gioca un ruolo attivo, potendo a sua volta ri-combinare le stesse tessere, senza alterare la generale economia estetica dell’opera d’arte.
Ri-propongo per l’interpretazione dell’arte tosiana questa sorta di “manifesto”, sintetizzato così:
“Filosofia del frammentismo”: verso una nuova Estetica nella ricerca artistica di Lucio Mayoor Tosi
( Moonlight, Composizione in rosso ruggine, altre composizioni)
– L’arte di Lucio Mayoor Tosi, in quanto complesso fenomeno artistico-filosofico-edonistico-sociale, è rivolta verso forme giocose, disgiuntive,
dislocate, indeterminate.
– Questa stessa arte va verso una poetica di frammenti e fa di una
ideologia della frattura e di una volontà di disfacimento le basi delle
artistiche invocazioni di silenzi, ma senza esclusioni delle antitesi
e dei contrari.
– I segni dello sfacelo sono la cifra di autenticità dell’arte contemporanea.
– Dalla ‘morte di Dio’ e dalla crisi della visione platonico-cristiana, l’arte contemporanea registra la fine del ‘centro’ e della verità dogmatica, con la conseguente deflagrazione del senso.
– L’arte contemporanea assume il ‘frammento’ come sigillo nella condizione attuale del mondo e della moltiplicazione della prospettiva.
– Il ‘frammento’ è l’intervento della morte nell’opera d’arte.
– La filosofia del ‘Frammentismo’ non è una tecnica ma è la visione del mondo dell’Artista.
– Il ‘frammento’ quindi è nella nuova estetica la Weltanshauung dell’artista, da tradurre in opera d’arte. Anzi, ne è lo stato d’animo
e il modo stesso dell’artista di sentirsi egli stesso “frammento” nel mondo.
– Il ‘Tutto’ è ormai frantumato, disperso. Può essere ritrovato soltanto in forma di frammento.
– Il frammento, dunque, come parte del ‘Tutto’, ma come parte compiuta e finita.
– Pertanto, spostando nell’opera su una tela un frammento da una posizione a un’altra, l’economia estetica generale dell’opera rimane intatta, inalterata.
– L’Opera nell’arte contemporanea fondata sulla filosofia del frammento annulla l’effetto d’ogni dislocazione sulla tela d’un frammento da un punto a un altro e conserva inalterata tutta la sua resa estetica poiché tale filosofia assume l’assioma che ‘ogni frammento contiene in sé il tutto disgregato’. Da qui il dolore nell’arte contemporanea frammentata.
– Non l’arte contemporanea è in crisi ma è la crisi nell’arte contemporanea. Ciò impone un rapporto nuovo tra arte e società.
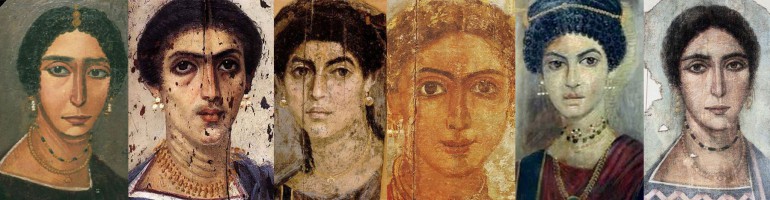












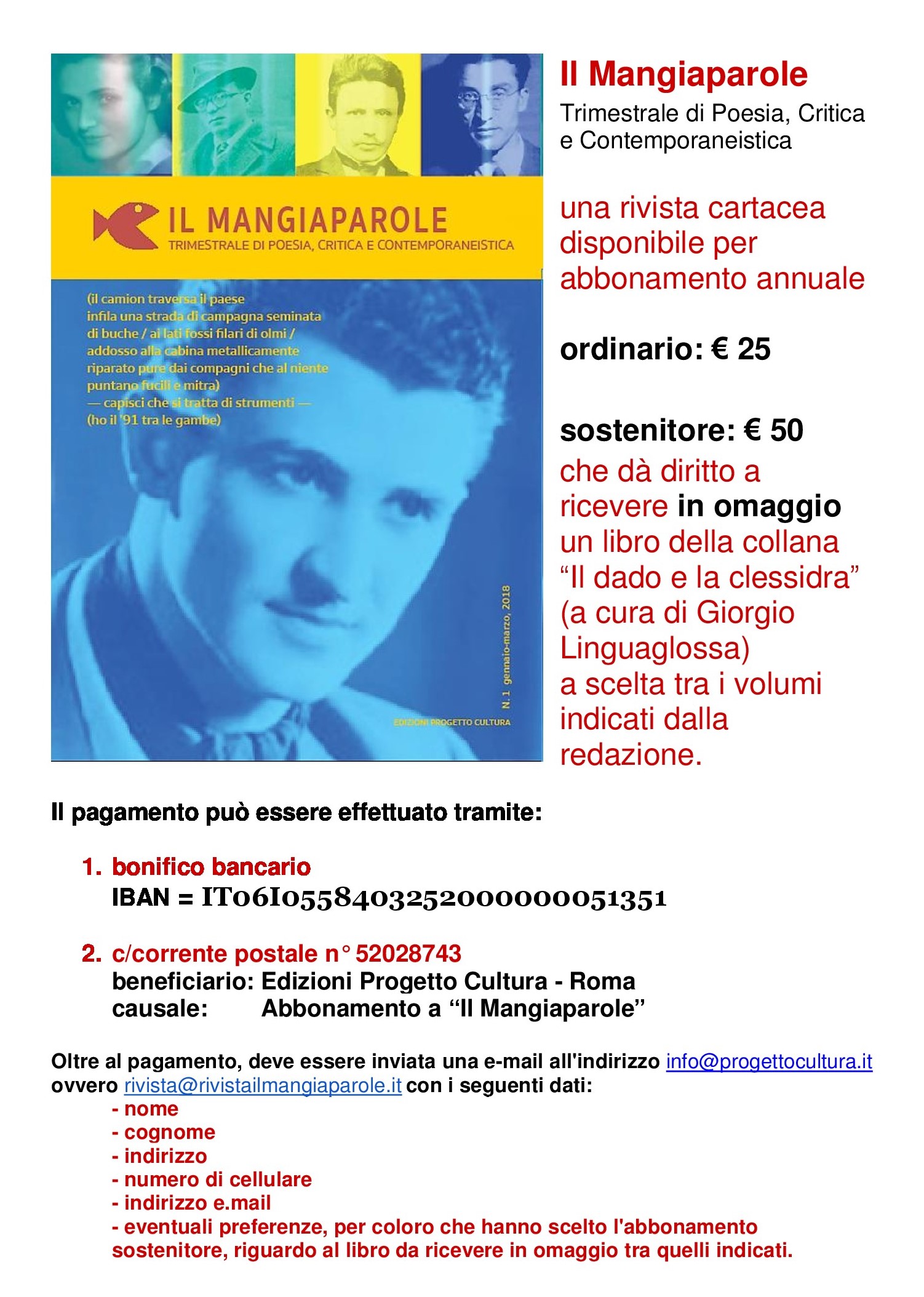
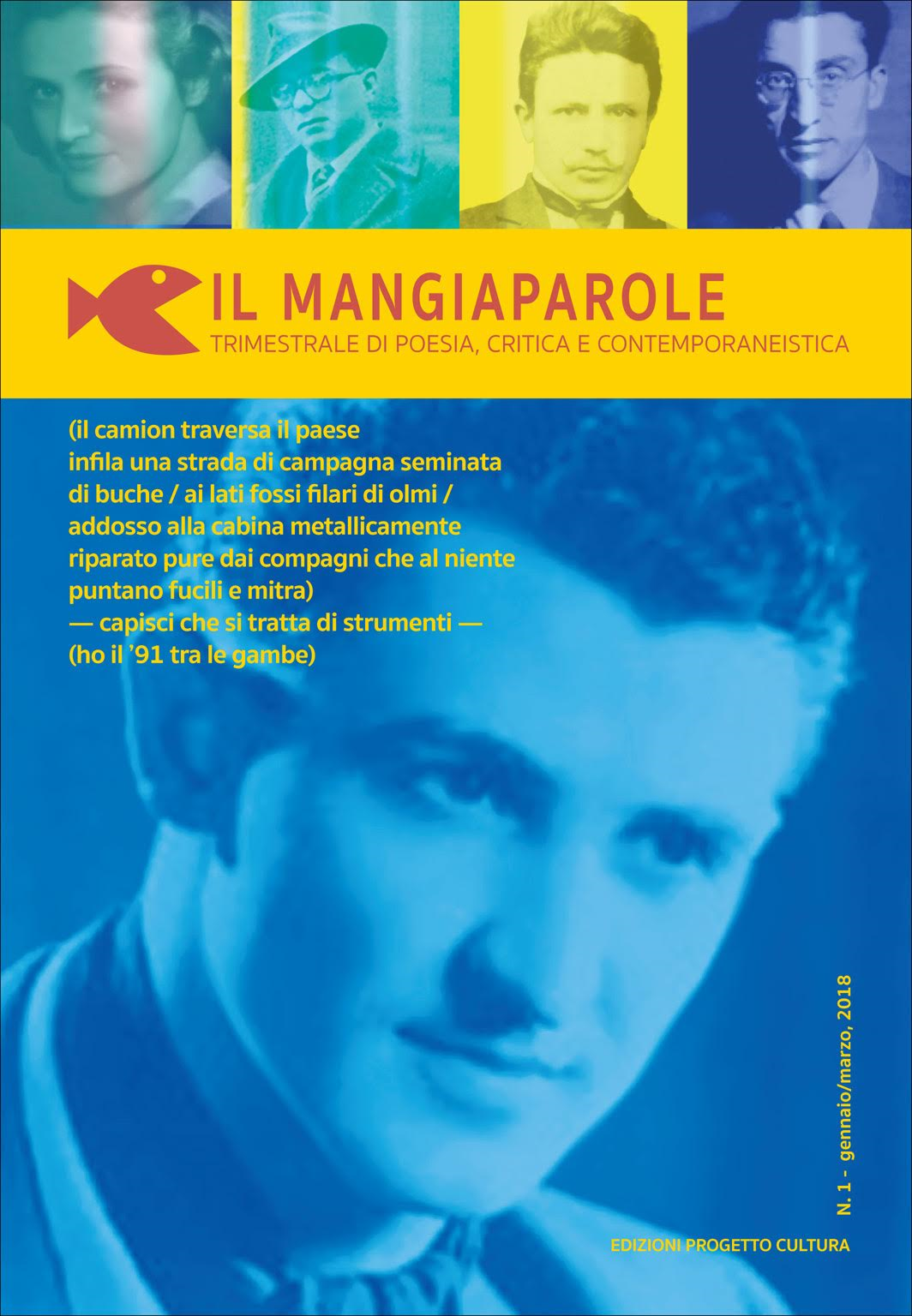

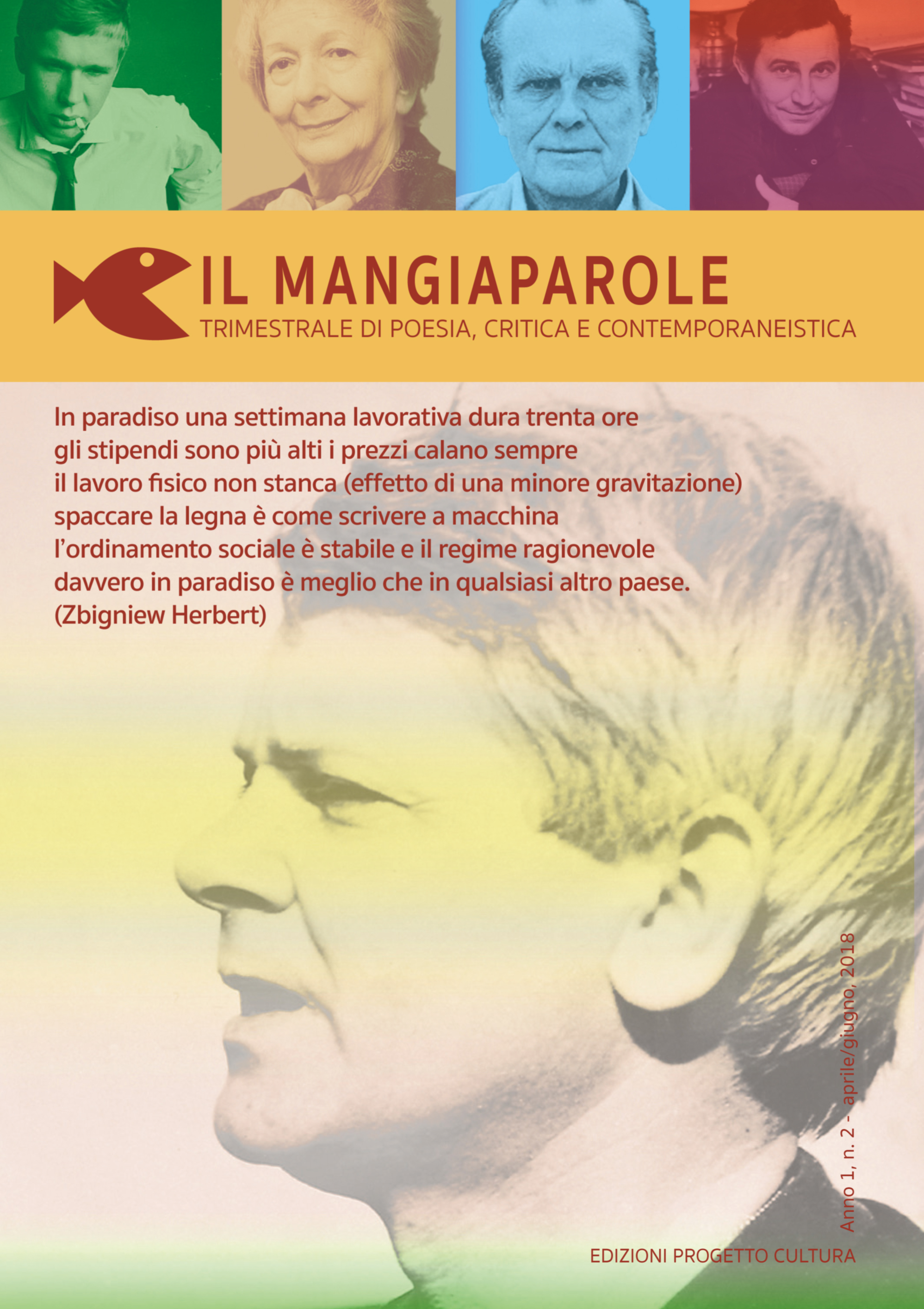



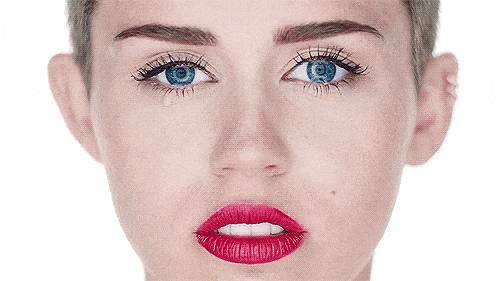
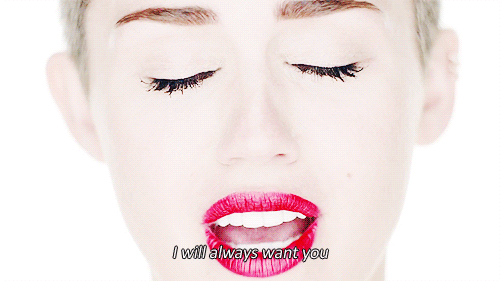
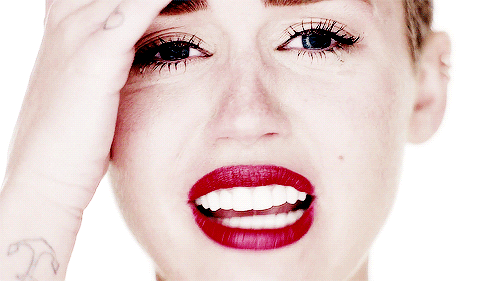
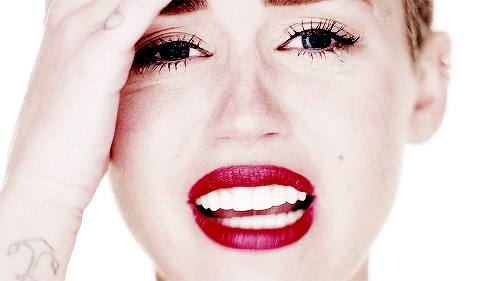
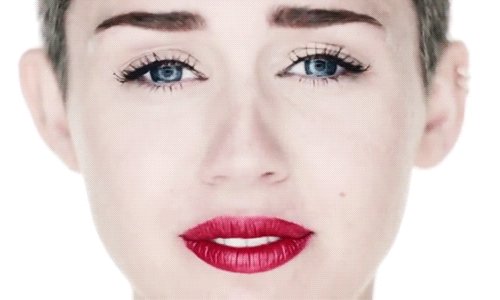



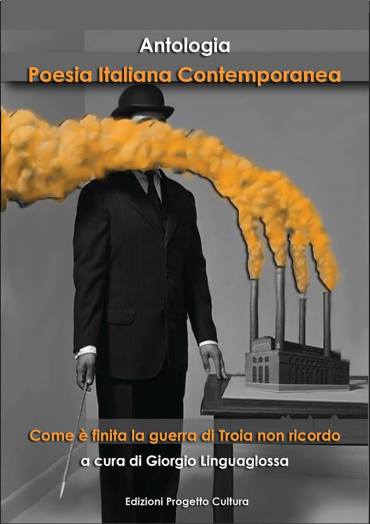




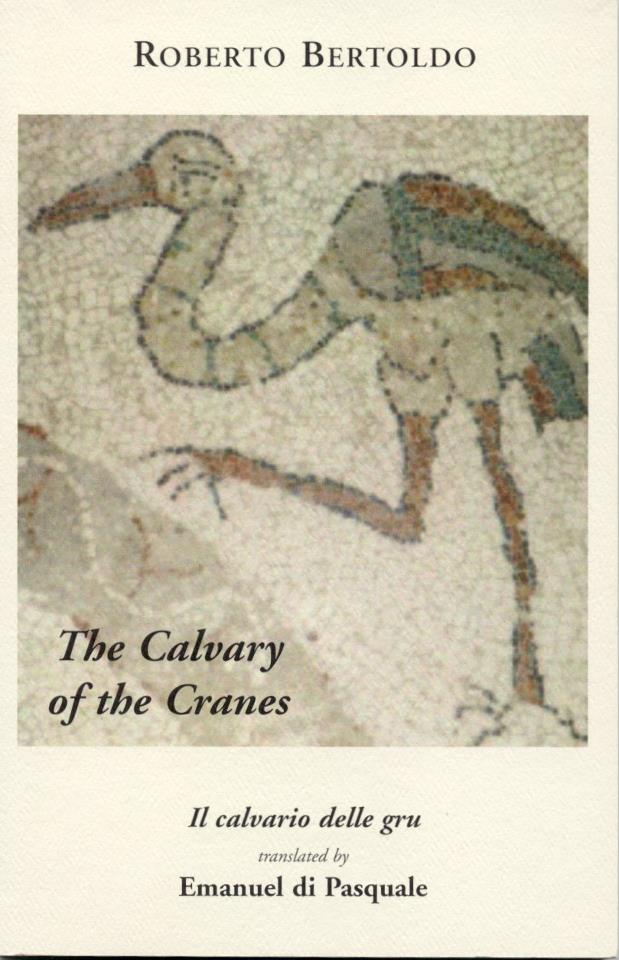
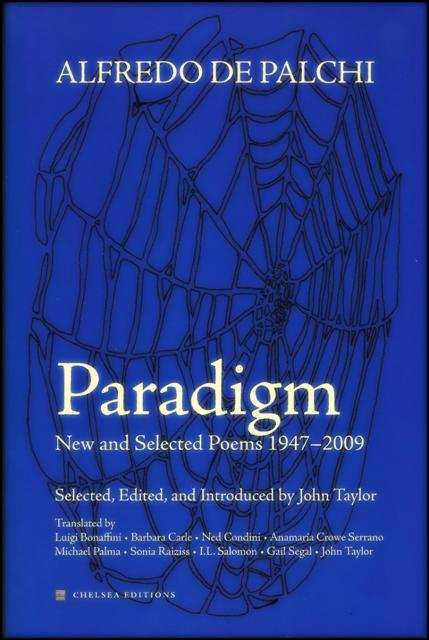


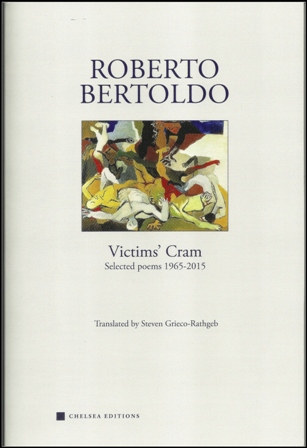





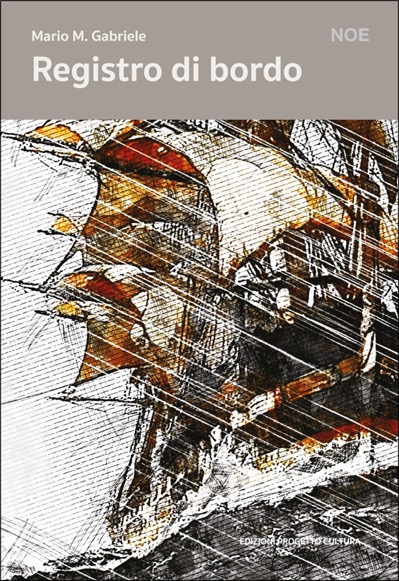

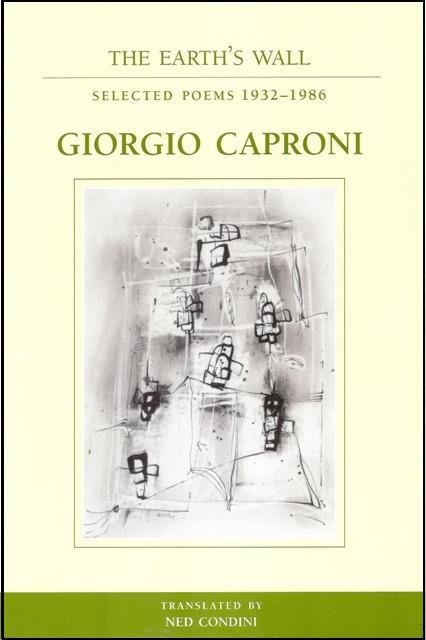
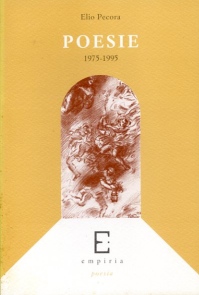

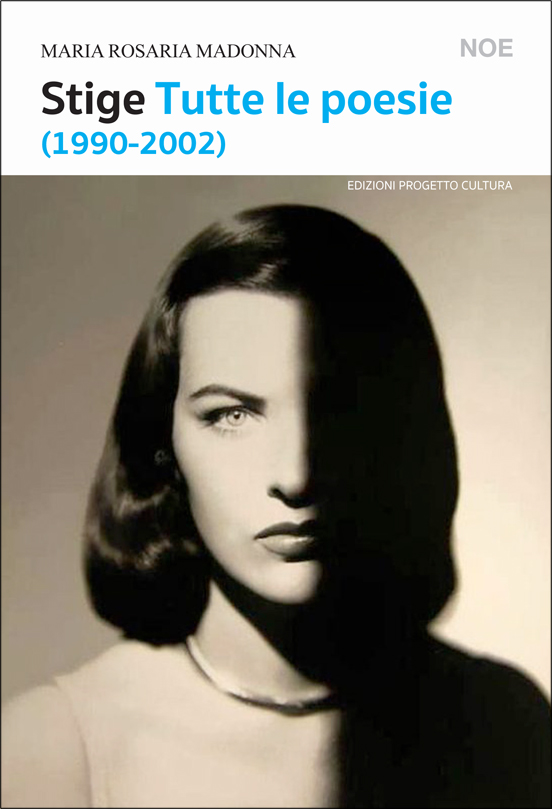

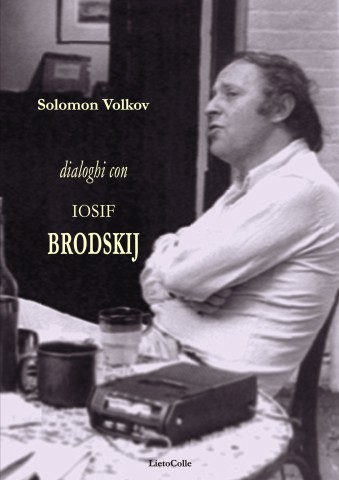




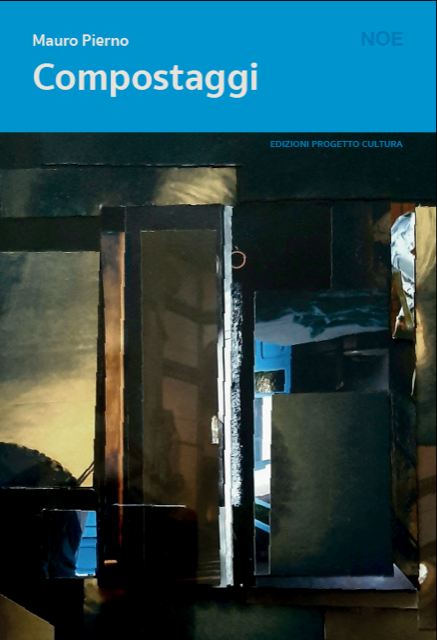
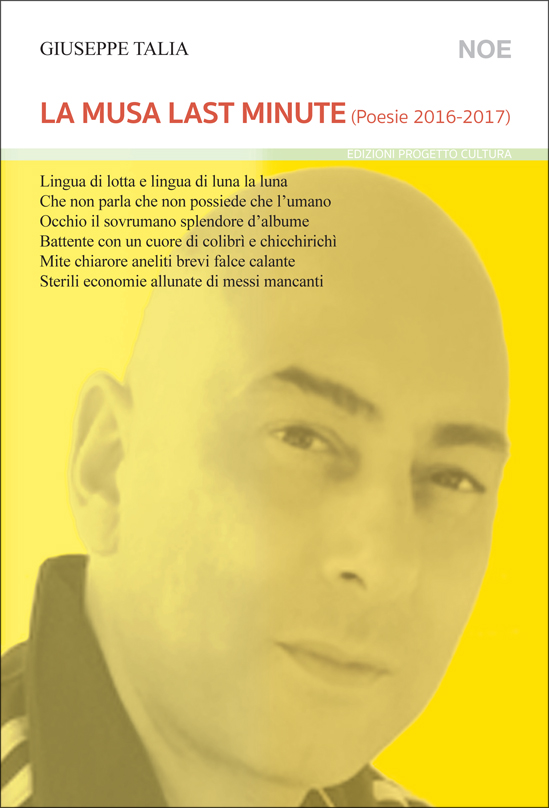


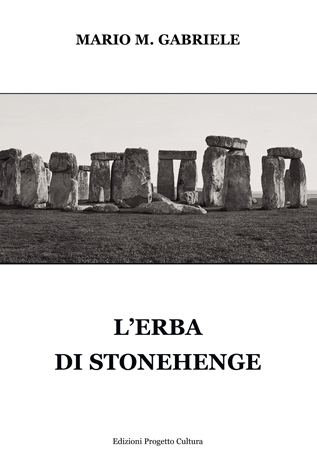
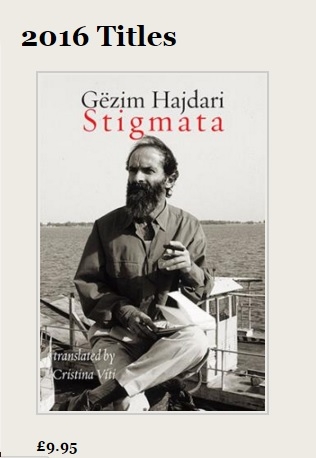
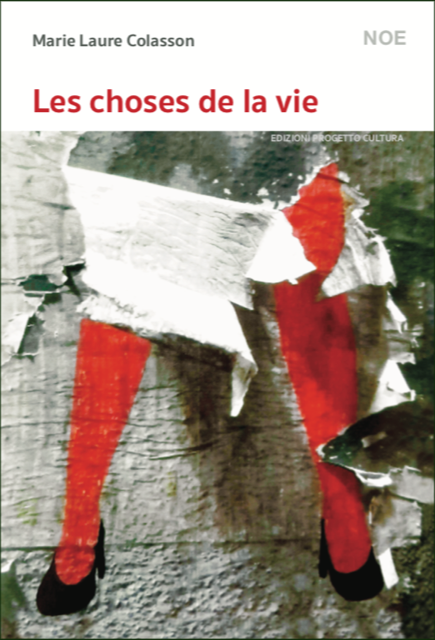




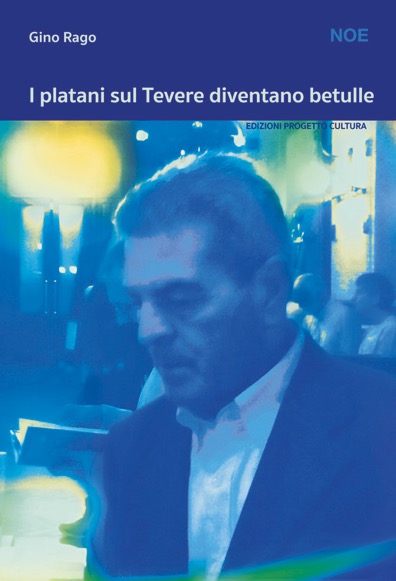
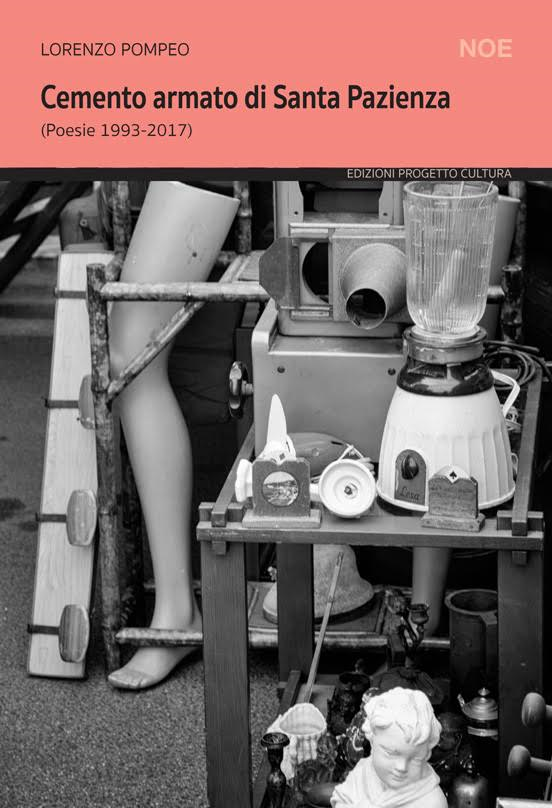
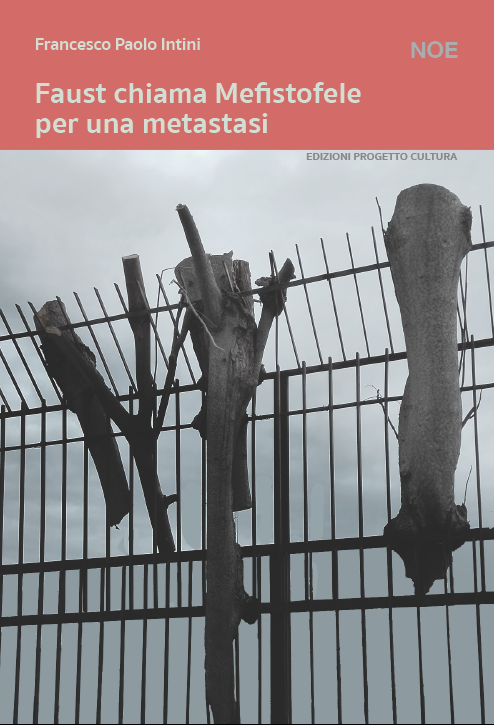

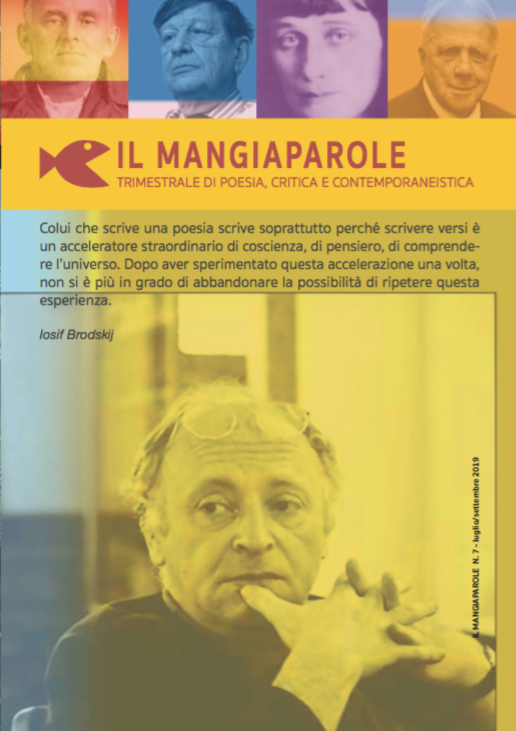




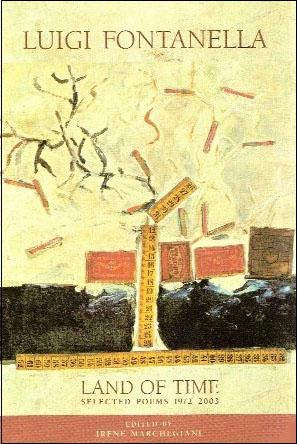








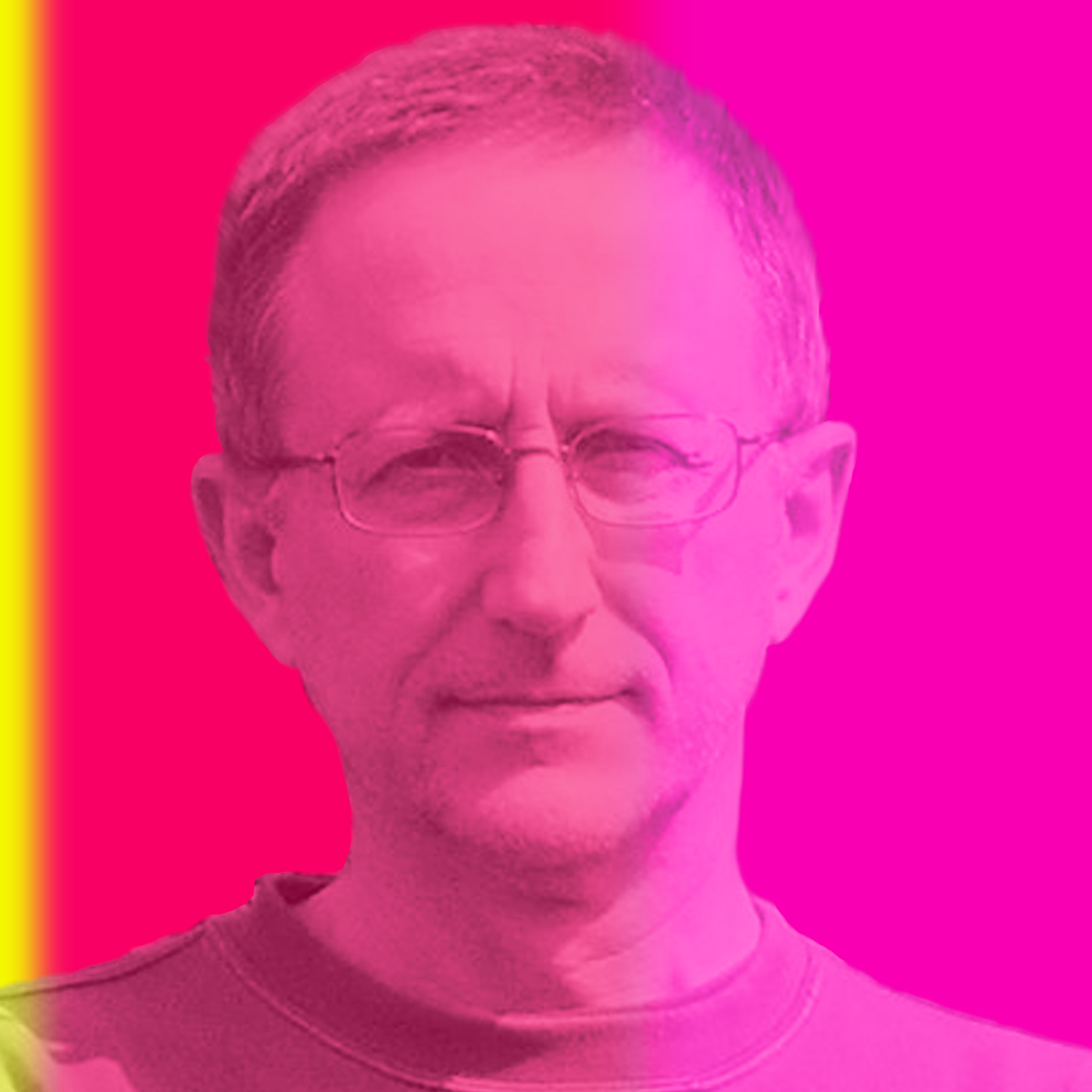







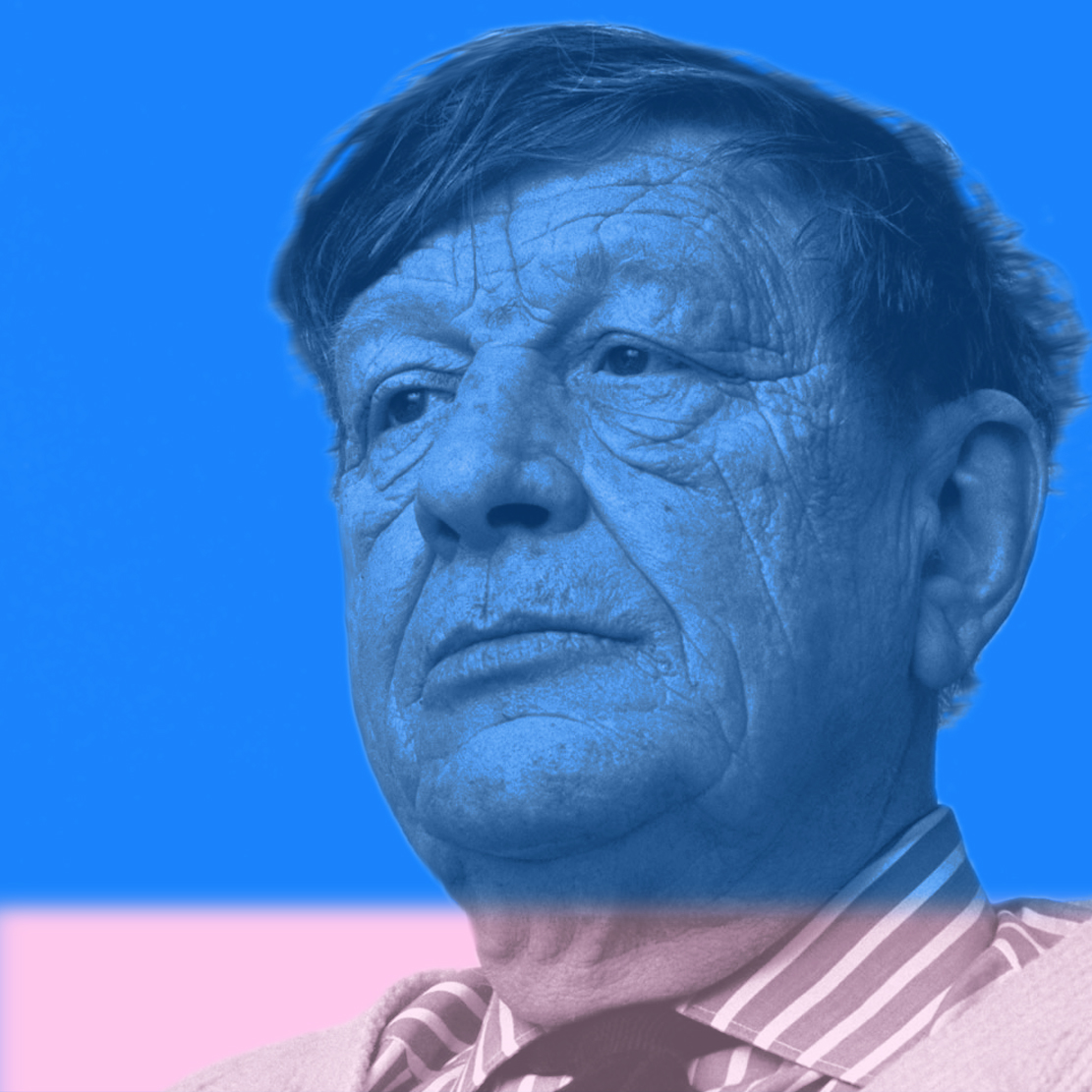



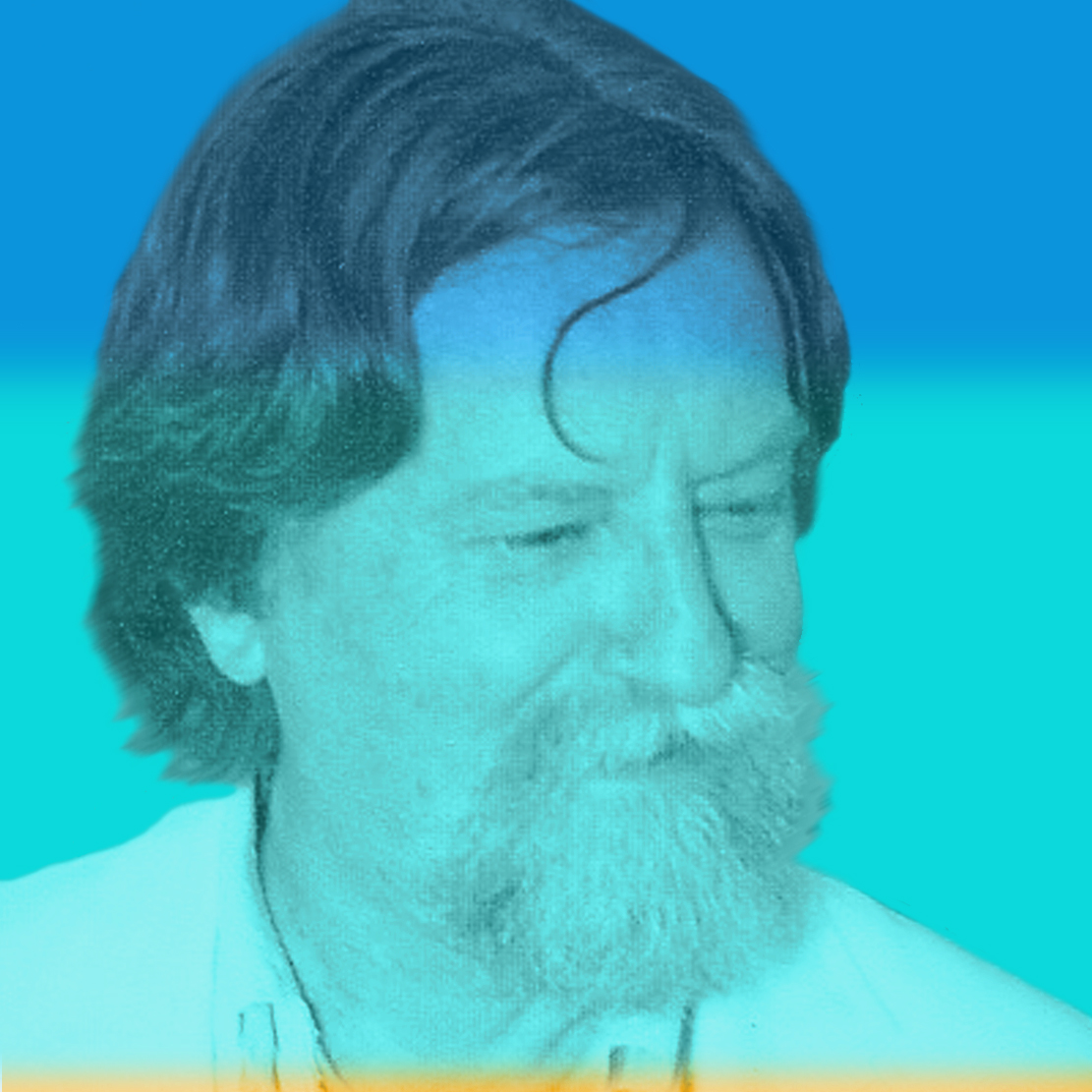
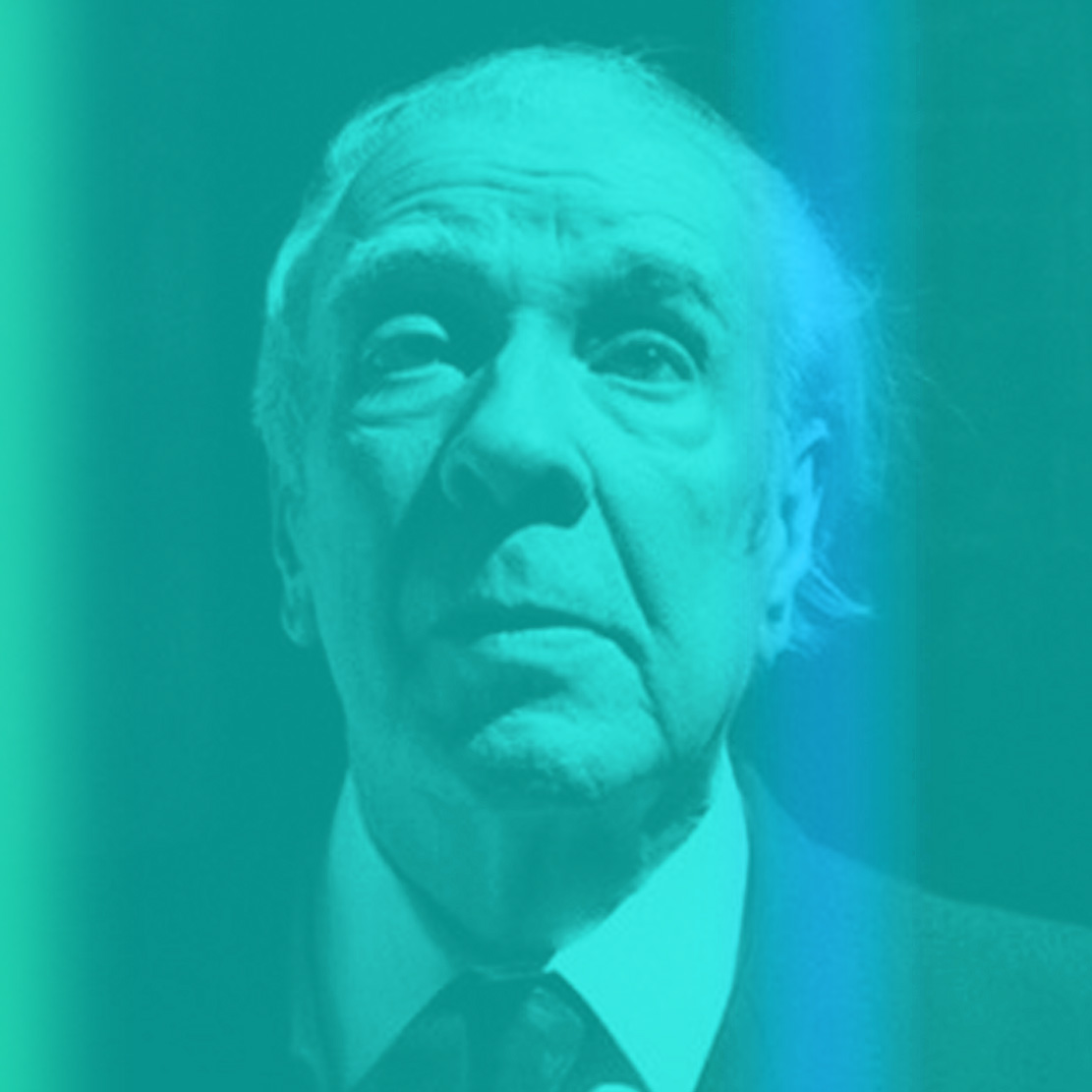




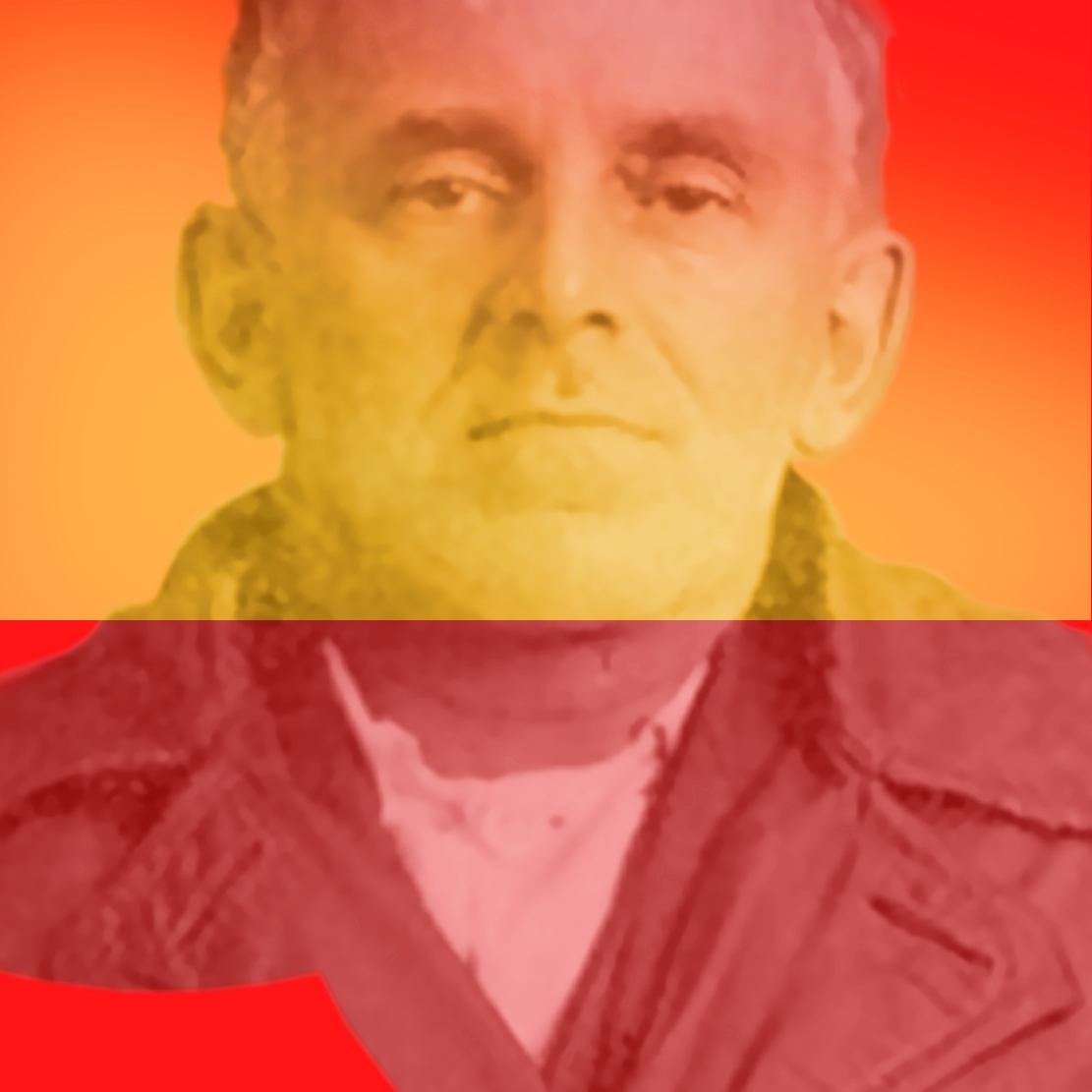






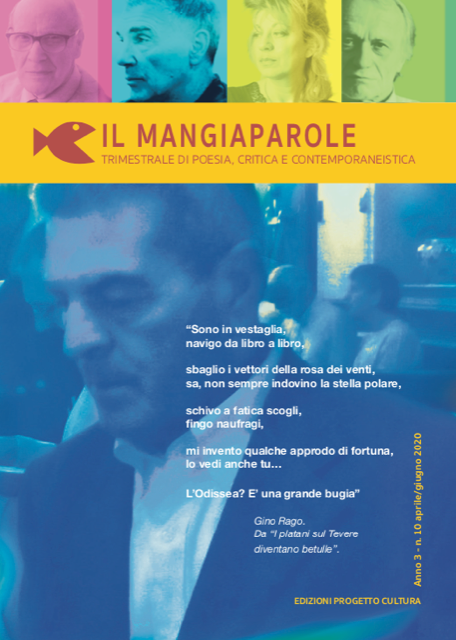




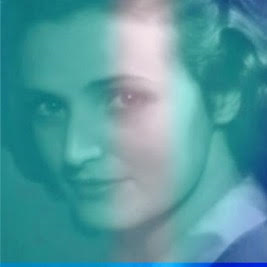
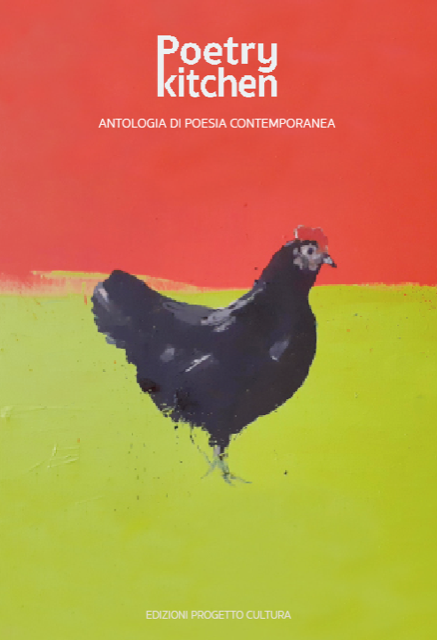



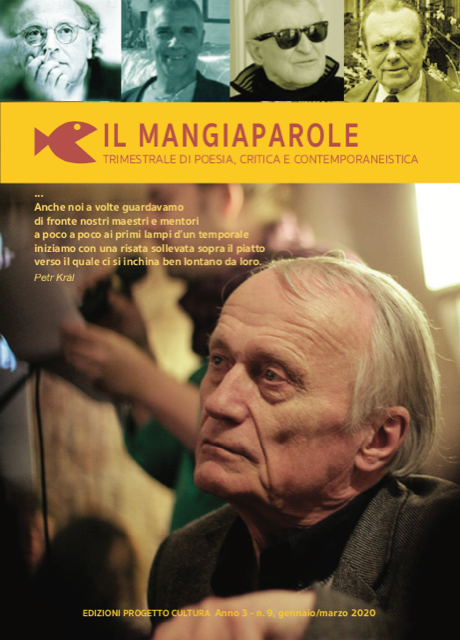











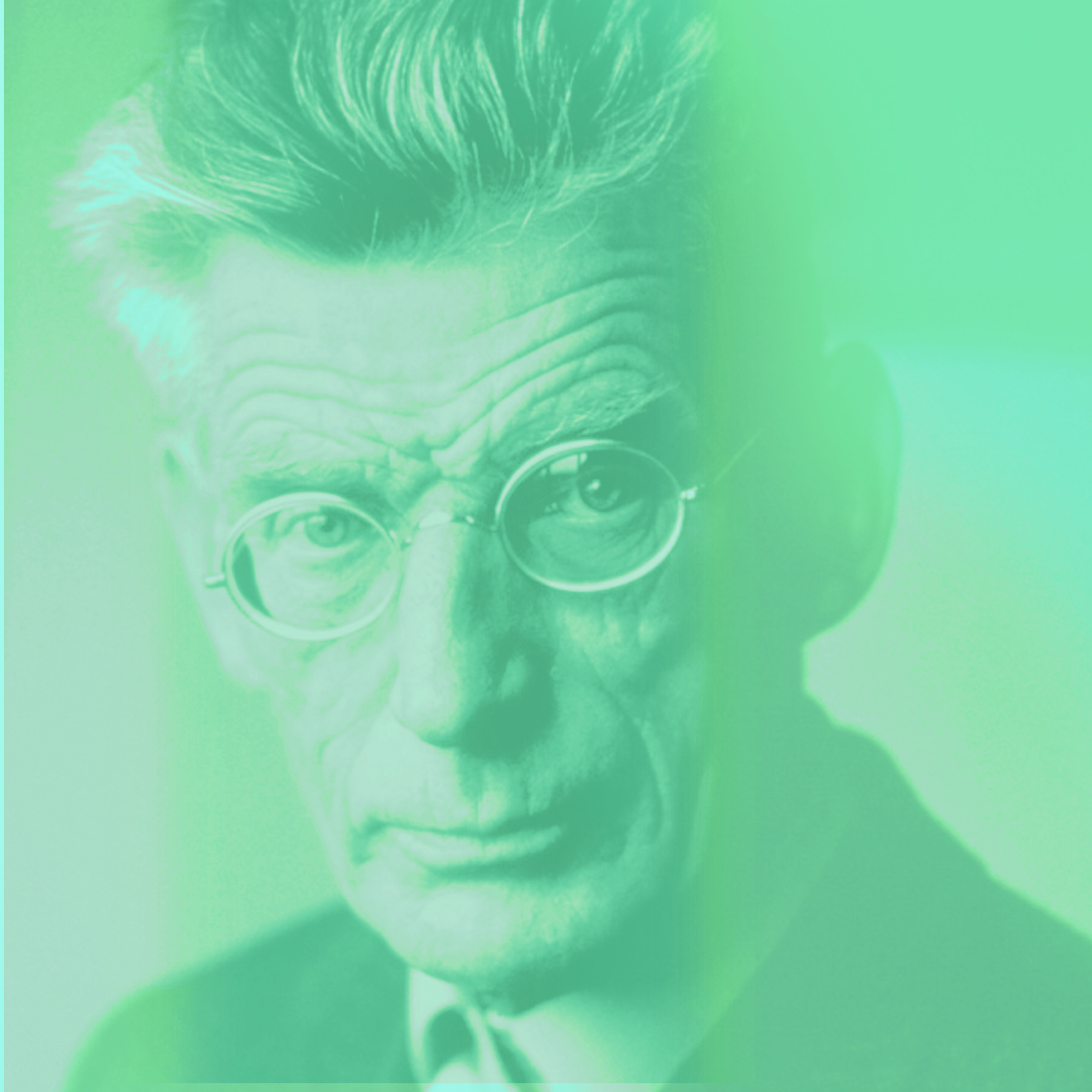
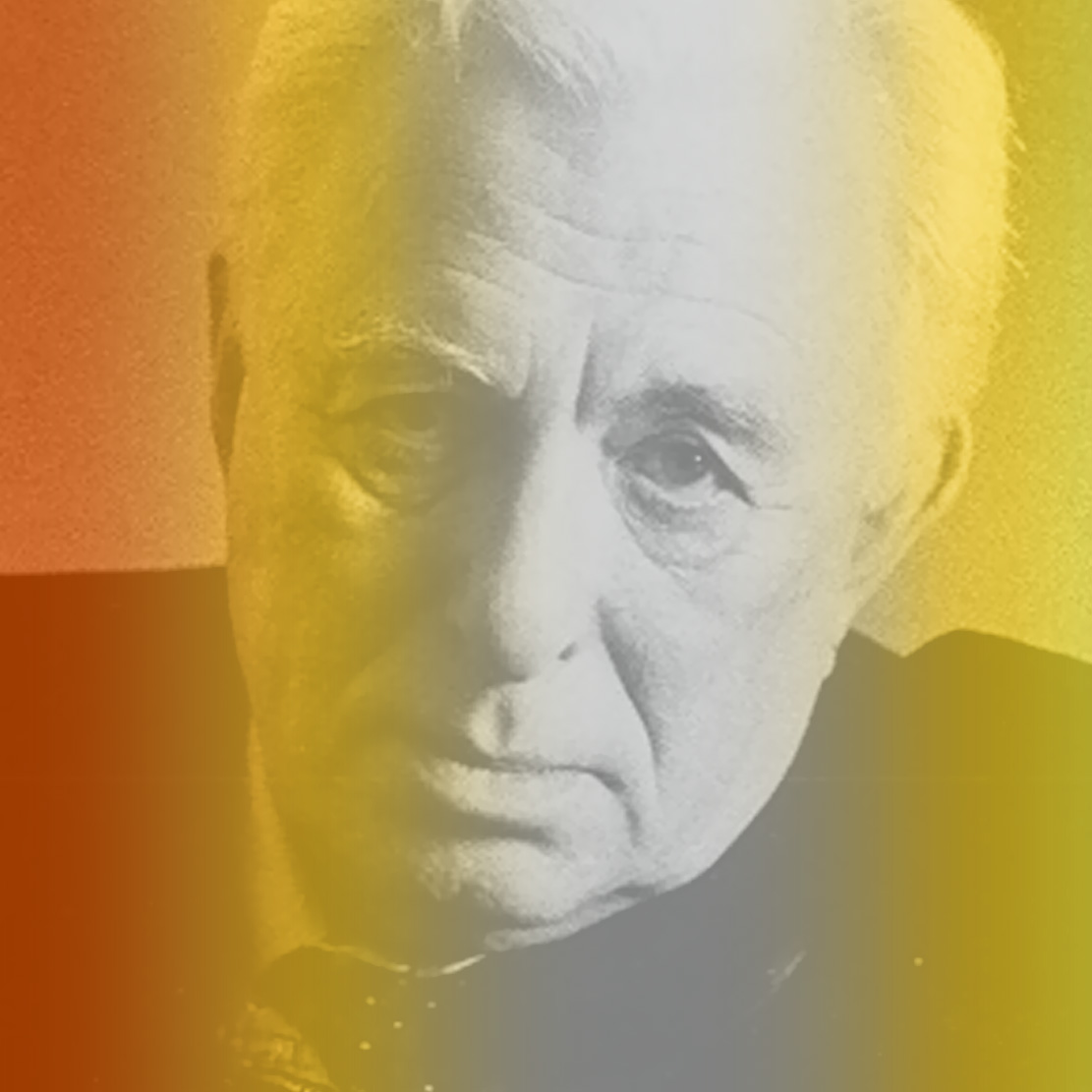









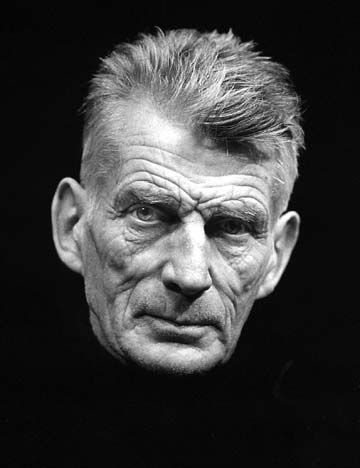


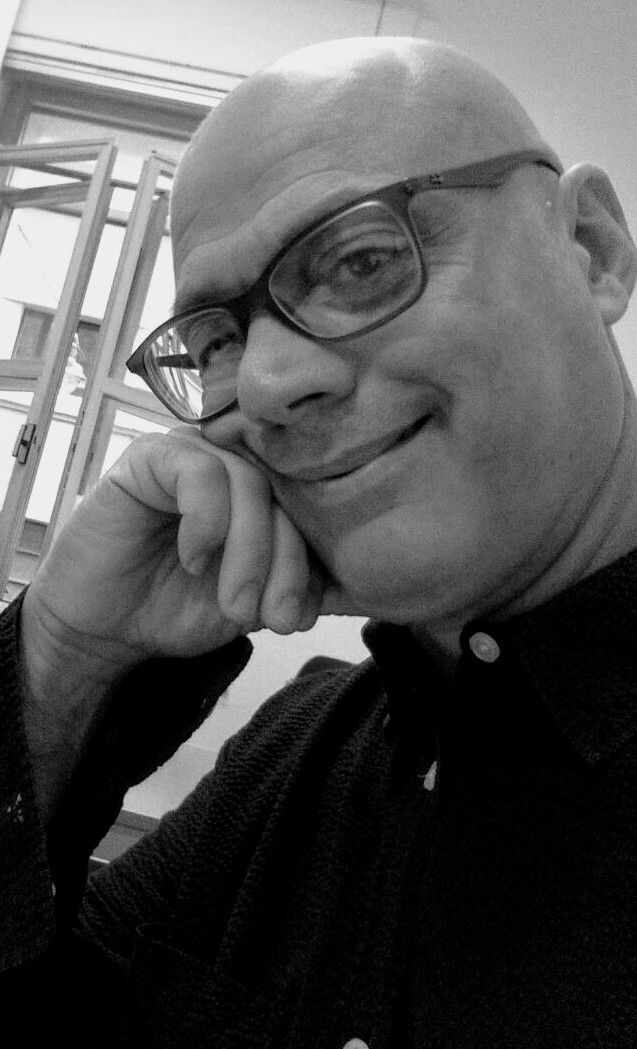
Trovo molto opportuno l’aver dato un nome (NOE) sotto il quale si potrà dialogare da spiriti liberi,ma resi gruppo per una spontanea affinità di vedute morali ed estetiche.Ci saranno, inevitabilmente, delle critiche, che non dovranno alimentare rivalità e risentimenti, ma contribuire a migliorare quanto già asserito ,con serenità e competenza.
"Mi piace""Mi piace"
Leggiamo tre versi di Werner Aspenström:
Il frutto che cade si ferma a metà strada
tra ramo e erba e chiede:
Dove sono?
questi versi ci mettono in guardia, noi non ci poniamo mai la domanda: «dove sono?», diamo per scontato che siamo qui ed ora, in questo istante di tempo, alla confluenza tra Aion e Cronos. Ma questo punto, questo qui e ora è sfuggente, in realtà non esiste, non può esistere una realtà così sfuggente, il fatto è contrario a tutte le nostre evidenze. L’esserci è un non-esistente. L’esserci del soggetto è il nullo fondamento di un nullificante, fatto di quel solido nulla che è il soggetto degli oggetti.
Cara Anna, condivido il tuo pensiero, ciascuno è libero di fare quello che vuole e di scrivere come vuole, il nome della NOE (la sigla) è stato una invenzione di Mario Gabriele prontamente accolta da Lucio Mayoor Tosi che ha fabbricato la nuova grafica della collana di poesia di Progetto Cultura di Roma e le immagini (deboli) dei poeti. È una grande trovata di Lucio, l’abbiamo anche giustificata filosoficamente commentando che le immagini, come le parole, sono diventate «deboli», scoloriscono, sembrano sbiadire… e invece proprio in virtù di questo scolorire… assumono maggiore evidenza, le sentiamo più nostre… più vicine, più autentiche…
Sono immagini che sembrano porsi la domanda di Werner Aspenström: «Dove sono?»
"Mi piace""Mi piace"
Caro Giorgio, mi sembra molto interessante il tuo approfondimento sulla poetica del frammento: hai esposto con grande chiarezza gli argomenti e citato autori di estremo interesse. A poroposito della citazione che segue: “Il mondo moderno è un mondo di frammenti impazziti che sostituiscono la contemplazione statica da un punto di vista esterno con la «fruizione distratta» di un punto di vista in movimento.” Verissimo: ma , secondo me, è possibile integrare il frammento nella Nuova Ontologia Estetica CERCANDO DI SOLLEVARLO DALL’AMMASSO DI FERRI VECCHI MATERIA IN DECOMPOSIZIONE, DEGRADO URBANO E COSì VIA (perdonate le maiuscole involontarie) grazie al tempo della memoria , alla quadrimensionalità dello spazio-tempo, al recupero dell’essere originario delle cose, natura ed emozioni umane, al tentativo di ritrovare di un rapporto o collegamento con l’Essere…non credi?
"Mi piace""Mi piace"
Ecco un’altra pagina di notevole contributo informativo, che viene ad aggiungersi alle precedenti, con le quali Giorgio Linguaglossa illustra il significato e la funzione del frammento, attraverso collegamenti, citazioni, ed elaborazioni critiche, ecc., informando il lettore anche sul significato della NOE. Trattasi di un lavoro notevole da parte di Linguaglossa, che si è assunto il compito di dialogare con altri poeti al fine di rendere meno ostico il concetto di fare poesia oggi, così come hanno fatto Alessandro Alfieri, che ha interpretato molto bene la mia poesia e che ringrazio sentitamente, e Lucio Mayoor Tosi e Gino Rago, senza dimenticare i precedenti commenti di altri autorevoli autori. Noto con piacere che il discorso sulla nuova poesia si sta convogliando verso un Progetto reale e non più dichiarativo, e questo non può che fare bene al Programma, volto a sostituire la poesia del Secondo Novecento.Lo confermano i fatti, le adesioni di poeti, che si sono resi conto della necessità di un ricambio linguistico e formale, ormai necessario, nonostante i pareri contrari di alcuni lettori e poeti, poco inclini ad accettare il rinnovamento.
"Mi piace""Mi piace"
Per un excursus veloce sulla nuova ontologia estetica invito a cliccare qui:
http://mariomgabriele.altervista.org/
"Mi piace""Mi piace"
Pubblico qui una poesia, su invito di Gino Rago – malgrado si parli di Lui forse un po’ troppo irrispettosamente –
Il cuneo.
– Ah! che piacere che piacere
dice questa mia voce nella testa.
Benvenute maledizioni!
Il carro funebre si sposta con lentezza esasperante.
Un cuneo di versi indica strade nuove da percorrere.
Voi che leggete non siete poeti – i “poeti” starebbero ancora al primo verso –
I “versi” sono, per la scolastica, il tabellario delle parole messe liberamente
in ordine. Se con cappello inclinato sembreranno ladri. O di ladre affascinanti.
Così è suddiviso il mondo in uno dei suoi tantissimi ripiegamenti.
L’immagine del cuneo andrebbe spiegata:
la forma è data dalla pressione su una delle parti del triangolo
ad opera di una forza esterna.
Il poeta Gino Rago è un classico vero, visceralmente classico.
Squilli di tromba sul portello della gattaiola.
Ma dove fa male il cuneo?
La Cina che pressa sull’economia occidentale.
Con una freccia si collega al vuoto (morte) della disoccupazione.
Finestre di pesante smeriglio viste all’interno di una camera mortuaria.
Un lento pomeriggio. Dico la Cina ma è una dei tanti.
L’emozione sta nello stomaco come una pesante palla di cannone.
Cos’è il cuneo?
Non vedo l’ora di finire questa poesia. E mandarvi tutti affanculo!
Mentre il poeta Gino Rago giace all’ombra del Partenone
un altro poeta, il signor Mario M. Gabriele
osserva come un bambino attraverso la rete. Occhi taglienti, di serpente.
Sempre ho avuto per amici, ladri e borderline.
Questo mondo senza di noi finirebbe. Se non in campo di concentramento,
sicuramente in un immenso manicomio. Più grande di quel che è adesso.
Ma poesia mi fa dire baci.
"Mi piace""Mi piace"
LA BORSA VALORI DELLA POESIA
Gorbaciov istituisce in Unione Sovietica poco prima del suo tracollo Una Borsa Valori e la inaugura con una solenne cerimonia con gli auspici benevoli della Chiesa ortodossa.
Una grottesca Borsa Valori a Mosca
grottesca perché in Unione Sovietica non c’erano valori né denaro per comprare valori. Né valori o azioni né denaro, denaro vero, non rubli !!! Una assurdità.
La situazione della poesia italiana è che c’è una Borsa Valori (gli uffici stampa degli editori maggiori) ma non ci sono i valori veri, non ci sono poeti presentabili né poesie presentabili… nondimeno esiste in italia una Borsa valori. Una cosa che ha del grottesco.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Vorrei esprimere come posso il più sinteticamente possibile, la parola ad entrare in scena
"Mi piace""Mi piace"
scusate) se é la parola ad entrare in scena un significato sopraggiunge,a volte però ho come l’impressione di entrare in un circo in cui il domatore é tuttologo doma le scimmie le tigri,le colombe,i gatti si alza la grata e tutto irrompe nello spazio scenico ammassandosi e “impallando” l’uno il significato (il significato concordato)dell’altro,allora é casino,in alcuni versi della NOE avverto questo chiaramente.
"Mi piace""Mi piace"
Credo sia dovuto al troppo entusiasmo, cara Egillarosabianca. Qui non c’è nulla di concordato.
"Mi piace""Mi piace"
Scusi, ma cosa dice, intendo il linguaggio Tosi Il linguaggio !
"Mi piace""Mi piace"
Ora ci siamo: il linguaggio! Certo che anche lei…
"Mi piace""Mi piace"
Si Tosi non parlo molto e non scrivo bene,mi scuso,spero nonostante questo sia arrivato il senso,la parola é il personaggio in scena,ecco.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Se si riferisce alla poesia che ho postato poc’anzi, ecco come Mario Gabriele l’ha commentata ( ed era la prima stesura): “hai affondato il mestolo portando alla luce porzioni di pensiero di vario materiale estrattivo.” L’espressione “hai affondato il mestolo” le dà ragione. Si conferma che scrivere per frammenti non è per niente facile, e che il domatore – ma io lo chiamerei ricettore, o il ricevente – ha il suo bel da fare per tenere a bada scimmie e tigri senza che ci sia più una gabbia – tempo e pensiero lineare – che gli dia sicurezza.
"Mi piace""Mi piace"
Non mi riferivo a lei ne a “Il cuneo” che é teatro
"Mi piace""Mi piace"
Il lettore sa, e considera l’opera come gli pare. Saluto rispettosamente.
"Mi piace""Mi piace"
Condivido l’impressione di Egillarosabianca…c’è tantissimo da lavorare ancora. e questo è il bello! Però non bisogna prendere il “frammento” come una nuova formula (teoricamente così ben identificata ma, nella scrittura ancora incerta) come un programma a cui attenersi in modo rigoroso, ma come l’approfondimento di un’intuizione già avuta da altri e un passo avanti (uno solo, salvo casi eccezionali), verso il graduale rinnovamento della poesia che non è cosa da poco, ma da pochi missionari e “calzolai” della parola. All’inizio bisogna lanciarsi, successivamente sprofondare in molte dimensioni orizzontali e verticali, poi riemergere…
"Mi piace"Piace a 1 persona
Lo so ho il rinnovamento… solo che ancora non ho capito qual’é… la parola é il personaggio insieme ad altri in scena per significare o segnare meglio, “qualcosa” e questo qualcosa che dico sono entità, e mutano
In fondo essere radar captare che cosa e dove se non nel nostro “mondo” come Stockhausen capta il sottofondo,non si può giocare combinare parole a “freddo” cosa muove il poeta? Grazie per l’attenzione
"Mi piace""Mi piace"
Rispondo a Mariella Colonna (e non solo): credo che non ci sia più tempo o spazio per il naïf nel rinnovamento… Dopodiché si può tranquillamente salire sulle montagne russe e “sprofondare in molte dimensioni orizzontali e verticali, poi riemergere…”
"Mi piace""Mi piace"
Signore é “non solo” che parla. Credo non si debba confondere naif con autenticità, purezza. I fisici usano un linguaggio semplice prendono ad esempio palline gocce d’acqua,enti semplici chiari a tutti non sospetti,per addentrarsi a semplificare concetti complicati (formule escluse) a volte mastodontici,perchè un mastodontico c’é esiste. In poesia altrettanto si tenta con la parola di avvicinarsi a questo significato di noi che sfugge
Converrà che tutti noi abbiamo la capacità di distinguere un vivo da un defunto e per quanto questi sia stato ben trattato truccato,é evidente é proprio morto! Nessuna ironia la NOE é un esperimento esprime una crisi un esperimento già fatto, é il metodo dei cercatori d’oro del Klondike, nel setaccio un pò d’oro resterà ma sarà sempre l’oro di qualcun altro nel terreno di qualcun altro.
"Mi piace""Mi piace"
cari amici e interlocutori,
io mi permetto di ribadire quello che ho già detto molte volte, che cioé scrivere secondo il pensiero della NOE è oltremodo più difficile che scrivere secondo i dettami della poesia italiana di questi ultimi 50 anni. Il fatto è che la poesia italiana si è disabituata a scrivere poesia, si scrivono filastrocche, commenti, argomentazioni varie, perifrasi varie,, idilli vari… ma tutto ciò appartiene ad un modo di concepire l’impiego del linguaggio poetico di un tempo lontano, bisogna munirsi, se si vuole scrivere poesia secondo i principi della ontologia estetica di Tranströmer, di nuovi occhi e non semplicemente cambiare gli occhiali scegliendo una gradazione maggiore…
"Mi piace""Mi piace"
Se mi da un quarto d’oro a partire da quando vuole le scrivo una poesia secondo il dettame della Noe
"Mi piace""Mi piace"
A PROPOSITO DEL DECALOGO DELLA NUOVA ONTOLOGIA ESTETICA
Ringrazio vivamente Giorgio Linguaglossa per l’efficace evidenza che su questa pagina, importante a favore della NOE, ha dato a quella sorta di
decalogo-manifesto, da me concepito per la ricerca artistica di Lucio Mayoor Tosi, è vero, ma che può evidentemente benissimo essere esteso
a certe esperienze d’arte attualmente in corso nella storia di numerosi
artisti italiani e anche stranieri, e che vale anche per coloro che lavorano
con la parola, da Giorgio Linguaglossa stesso a Mario Gabriele, dallo stesso Lucio M.Tosi a Francesca Dono..
Sento di dovere dire grazie anche e ancora a Lucio Mayoor Tosi per avermi
ricordato nei suoi versi di questo “Il cuneo” che si fa correlativo oggettivo
di taluni aspetti della poesia della NOE.
Ma vorrei rilanciare, sulla scìa delle meditazioni di Giorgio Linguaglossa,
di Benjamin, di Alessandro Alfieri sul “frammento”, il dibattito fruttuoso
in corso con questa idea: il poeta italiano del nostro tempo si è reso conto
degli effetti del passaggio dal “Luogo antropologico” al “Non-luogo” in cui
l’identità anche del poeta, e dell’artista in generale, coincide con una tessera magnetica di riconoscimento?
(Forse soprattutto per questo, ma parlo soltanto della mia attuale ricerca
poetica, tento di trovare riparo nel metodo mitico, anche a costo di
essere obbligato a “squittire” – per dirla con un solare verso de
“Il cuneo” di Lucio Mayoor Tosi – “all’ombra del Partenone”.
Ma, poi, davvero è drammatico per tutti passare dal “luogo” al ” non-luogo”? Ecco il tarlo che mi rosicchia…
"Mi piace""Mi piace"
Lo hai scritto tu, caro Gino, nel tuo catalogo-manifesto, per il quale ancora ti ringrazio: “Il ‘frammento’ è l’intervento della morte nell’opera d’arte”. Quindi sì, penso che per alcuni possa essere drammatico.
Questo mi porta a ripensare a “Il cuneo”. Vi si nota infatti una presenza eccessiva dell’Io. Strano, solitamente ci sto bene attento. Sarà che penso troppo alla mostra che ho da fare. Poesia reclama, ed ecco la stizza, il perché di quel vaffanculo! Si tratta di una ripresa in diretta, tutto sommato veritiera. La registrazione di un accadimento.
"Mi piace""Mi piace"
UN ESEMPIO DI POESIA DEL FRAMMENTO DEL 2001: ANNA VENTURA da “NOSTRA DEA”.
Ho scritto nel post: «Il frammento è l’Estraneo». È l’irruzione dell’Estraneo nel frammento. Mi hanno chiesto di esplicitare il senso di queste parole misteriose. Allora cercherò di essere più chiaro: Si dice comunemente che il diavolo si cela nel dettaglio, io correggerei dicendo che è l’estraneo che si cela nel dettaglio di quell’oggetto che credevamo di conoscere e che davamo per scontato… E modificherei la citazione affermando che è l’estraneo che si presenta nel frammento; anche il frammento si dà nella veste del dettaglio. Quello che ci si presenta alll’improvviso è un estraneo che fa ingresso nel nostro quotidiano, che so, un ricordo che non volevamo ricordare, un lapsus, un errore di dizione, un refuso di una parola che non volevamo scrivere, in una parola, l’estraneo è l’Altro per l’altro, si tratta di uno scambio di «persone», di una metonimia, di una sineddoche, di «maschere» di un teatro dove si presenta una «scena» simbolica, l’una prende il posto dell’altro, a nostra insaputa e magari anche contro la nostra volontà.
E questo effetto lo può dare soltanto la forma-poesia. La poesia (come anche l’arte figurativa) sono il luogo privilegiato nel quale si manifesta l’estraneo. Magari scriviamo di «un terrazzo bianco / chiuso da un muro bianco (…) sul verde del giardino…». Ed ecco che, all’improvviso, si staglia la figura dell’estraneo:
Sul terrazzo c’è un tavolo rotondo
con due poltrone.
Sul tavolo un cesto di frutta
Che cosa significa tutto ciò? Che cosa ci vuole dire quel «tavolo rotondo» «con due poltrone» (che si sottintendono vuote) che compaiono all’improvviso nella composizione? – C’è stata una scomparsa? Delle persone se ne sono andate? Che è rimasto un vuoto? E che noi apparteniamo in modo misterioso e segreto a questo vuoto? – Qui l’estraneo è il frammento, una immagine, alcuni oggetti noti (un terrazzo, un tavolo rotondo, due poltrone) che si imprimono nella nostra sensibilità e ci rivelano il baratro nel quale siamo sprofondati.
È una poesia che ha a che fare con l’estraneo, dunque.
Ecco cosa scrivevo in una nota di lettura ad un libro di Anna Ventura NOSTRA DEA (Firenze, Esuvia 2001 pp. 64) nel 2004, pubblicata su “Poiesis”:
«lo stesso impiego dello zoom di origine cinematografica costituisce un vero e proprio binario sintattico-semantico che è venuto a sostituire la vecchia e antiquata e polverosa impalcatura di matrice pascoliana che ha fornito, lo ammetto, nel bene e nel male, durante tutto il corso del Novecento, il traliccio entro il quale calare lo stampo sonoro-semantico. La poesia di apertura di Nostra dea, “La terra del Minotauro” è l’esemplificazione più pertinente di questo nuovo tipo di composizione. E’ come se una telecamera si introducesse dentro il palazzo di Cnosso e si posizionasse davanti al “terrazzo”; tutto quello che accade è una conseguenza di quel punto di vista. Non v’è nessuna impostazione ironica,come non v’è traccia di alcuna impostazione trascendentale-nobile, se così fosse, ciò segnerebbe l’introduzione di un “diminutivo” o di un “accrescitivo” tipicamente novecenteschi in un impianto di poetica invece tipicamente post-moderna. Dunque, nei testi di Anna Ventura non v’è mai alcun luogo di “aggressione” ironica, l’autore impone una distanza tra sé e il testo, è la distanza iconica qui ad essere significativa, non la distanza ironica come avveniva nei testi proto novecenteschi. Ma ora lasciamo spazio al testo:
Questo terrazzo bianco,
chiuso da un muro bianco,
ha una bifora aperta
sul verde del giardino,
sul rosso dei fiori d’ibiscus.
Il mare segna l’orizzonte,
oltre le cime degli ulivi.
E’ il mare fermo degli dei,
mentre la terra – del colore del sangue –
appartiene al Minotauro.
Sul terrazzo c’è un tavolo rotondo
con due poltrone.
Sul tavolo un cesto di frutta
uva e prugne, una mela –
ornato di foglie d’ulivo,
una brocca di coccio
col vino rosso e il bicchiere.
L’aria è tiepida e tersa,
la stessa del tempo del mito,
un tempo eterno,
che qui è nato e qui resta.
L’avevamo intuito
nel racconto dei libri,
nella fatica delle traduzioni.
Il lettore si introduce, attraverso “una bifora aperta”, “nel verde del giardino”, “il mare fermo degli dei” accoglie i visitatori. “Sul terrazzo c’è un tavolo rotondo/ con due poltrone”. L’atmosfera è sobria, quasi turistica, il viaggio nell’al di là è un mito di vecchie e polverose filosofie. Il viaggio, con tutti i suoi corollari di peripezie turistico-spirituali, è ormai una moneta fuori corso finita nei cassetti dei numismatici. Chi parla, oggi, di viandanze turisticamente attrezzate, è o un imbonitore o un minimalista inconsapevole».
"Mi piace""Mi piace"
Mi fa molto piacere rileggere, come nuova, una mia poesia di parecchi anni fa, osservata da un’ottica critica moderna,che mi conferma nella convinzione di quanto complesso sia il rapporto tra l’opera d’arte e i suoi fruitori, i quali in qualche modo ricreano l’opera stessa, secondo un meccanismo che aveva ben intuito Pirandello,tanto da riferirlo non solo all’opera d’arte, ma ad ogni occasione di vita.
"Mi piace""Mi piace"
una risposta a Lucio Mayor Tosi, col quale mi congratulo per la sua attività artistica e per i tentativi di realizzare una poesia del frammento: però mi sembra che siamo ancora nella preistoria di una realizzazione poetica che nuova, organizzata su elementi poetici discontinui, sintagmi destrutturati, simboli usati come metafore e così via…prima di tutto nessuno può partire dal nulla e prescindere dall’uso, sia pure liberato da vetero sistemi di scrittura, di un linguaggio-base che, volendo o non volendo l’autore, affonda le radici nella tradizione. Nulla si crea dal nulla, anche noi poeti usiamo in modo nuovo materiali di linguaggio preesistenti, citazioni, echi di Maestri del passato etc. quindi “classici”,, ma non inventiamo quasi mai: le parole, le immagini, i colori , le forme retoriche ci precedono: questo per dire che, ad esempio, Gino Rago non è così classico come tu lo definisci. Non c’è soltanto il frammento nell’Arca di NOE, c’è, appunto la NUOVA ONTOLOGIA ESTETICA: e le poesie di Gino Rago la rappresentano in modo esemplare, intenso, partecipativo e creativo: far rivivere toto corpore l’ultima notte di Troia, estrarre dal nulla ciò che è stato e riportarlo in ESSERE non è da poeta “che giace all’ombra del Partenone”.
A Gino Rago una sola osservazione: “Ma, poi, davvero è drammatico per tutti passare dal “luogo” al ” non-luogo”? Ecco il tarlo che mi rosicchia…” dici tu…
Caro Gino, ti prego di non farti rosicchiare dal tarlo: anche “il non luogo” è un luogo nella NOE! iO MI CI TROVO BENISSIMO! Nel non luogo c’è il non essere, ma c’è anche il non- tempo, la non-morte, la non vita (meglio non vita se è come quella che stiamo vivendo adesso!) Naturalmente sto scherzando. Se non ci troveremo bene nel NON-LUOGO potremo sempre imbarcarci sull’Arca (quella ci sarà sempre!) e sbarcare tutti insieme sull’ISOLA CHE NON C’E’!
"Mi piace""Mi piace"
Grazie per l’attenzione, Mariella. Hai ragione, penso anch’io di essere nella preistoria. E non hai idea della pazienza che mi occorre, non dico per voler fare dell’arte ma anche solo, talvolta, per uscire di casa… non fosse per la natura, i bambini, gli animali, lo spettacolo che si presenta è per me sempre deprimente.
Gino Rago è classico nel senso di classico-ellenistico, un po’ come si potrebbe dire oggi del filosofo Umberto Galimberti.
La poesia “Il cuneo” è una successione di pensieri, sempre che ci si intenda sul fatto che anche il pensiero possa essere inteso come accadimento.
"Mi piace""Mi piace"
Non l’ho detto ma,non c’é disordine in “Cuneo””il mestolo affonda” bene
un monologo- riflessioni -mentali-una sorta di Eraserhead
Trovo impulso poetico in quello che ha detto dopo in risposta alla sig Colonna…E non hai idea della pazienza…
"Mi piace"Piace a 1 persona
Caro Lucio, la parola “preistoria” non era rivolta soltanto a te: vale per tutti, in particolare per me. Certo Poeti come Mario Gabrielle e Giorgio Linguaglossa stanno ben oltre la preistoria! Capisco e condivido la tua “fatica di esistere”, ma è proprio questa fatica che ci “fa le ossa” ci mette alla prova, ci tiene bel legati alla terra e toglie via le nuvole dalla testa dei poeti. Per te forse è diverso perché sei anche pittore, hai a che fare con i pigmenti e la materia e combatti un dura battaglia per trovarle un’anima! A proposito di Gino Rago…io lo immagino vivo in mezzo alle fiamme di Troia…migliaia di anni fa…questo, in poesia con il tempo dilatabile all’infinito…altro che morto sotto il Partenone! BUON LAVORO E COMPLIMENTI!
"Mi piace""Mi piace"
https://lombradelleparole.wordpress.com/2017/04/29/decalogo-sulla-filosofia-del-frammento-di-gino-rago-il-frammento-quale-luogo-privilegiato-della-nuova-ontologia-estetica-testi-critici-di-giorgio-linguaglossa-gino-rago-lucio-mayoor-tosi-citaz/comment-page-1/#comment-19785L'acuta intelligenza che si coglie nei recenti commenti di Mariella Colonna, di Lucio
Mayoor Tosi e di Giorgio Linguaglossa, (quello in cui il critico letterario reinterpreta i versi di Anna Ventura, riconducendoli al nuovo gusto estetico della NOE) non merita di cadere nel nulla, per la ricchezza di spunti e di indicazioni di filosofia estetica nonché di socio-antropologia letteraria.
Non ho le risposte, ma me lo chiedo continuamente: che è successo all’uomo, all’artista in generale, al poeta in particolare, quando da un luogo di memoria e d’identità si è venuto a trovare in aeroporti, catene di alberghi, ristoranti, ipermercati, centri commerciali polivalenti e altro?
Io credo che il linguaglossiano “spazio espressivo integrale” ne sia la diretta
e inevitabile conseguenza. Ed è idea che funziona se gli stessi versi di
Anna Ventura, reinterpretati in un nuovo contesto di gusto estetico, rivelano
alla nuova lettura di Giorgio Linguaglossa quel “quid” che prima era sfuggito alla critica e che invece si fa cifra ospitabile nella NOE.
E perché quel quid venturiano era sfuggito a certa critica?
Qui la risposta credo d’averla perché la trovo in uno dei più riusciti
apoftegmi proposti su questa pagina da Giorgio Linguaglossa:
perché quella critica non era cosciente del fatto che
“la parola è una entità che ha la stessa tessitura che ha la “stoffa”
del tempo…”
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
caro Gino,
hai la vista acuta, la NOE non è soltanto un nuovo modo di guardare il mondo, non solo questo, ma è un nuovo modo di considerare le categorie base della nostra vita quotidiana: il Tempo, lo Spazio, il Quadri dimensionale, il Tridimensionale, e, in ambito propriamente poetico: la Parola, il verso e il metro.
È ovvio che io quando faccio critica vedo cose che un altro letterato educato alla tradizionale visione delle categorie su esposte, non vede, non le può vedere, perché vede con i vecchi occhi. Se poi non si mette in correlazione la parola e il tempo, la parola e lo spazio, la parola e i quadri dimensionale, non si capisce niente del nuovo modo di fare poesia, che poi non è molto diverso dall’atto che i popoli preistorici facevano quando incidevano dei segni sulle pareti delle caverne. Ci si dimentica che quei segni facevano parte di un universo simbolico, se cambia l’universo simbolico (e ogni civiltà cambia universo simbolico), cambiano anche i segni e il modo di considerare i segni, ovvero, come le chiama Lucio Mayoor Tosi, le tracce.
Ma è così difficile da comprendere? Sembra di sì.
La mia nuova lettura della poesia di AnnaVentura del 2000, rende evidente proprio questo, che la nuova lettura vede cose che nella mia lettura di quei medesimi versi del 2001 non aveva visto.
"Mi piace""Mi piace"
Presto posterò una mia nuova lettura delle poesie di Anna Ventura risalenti al 2001 dalla quale risulterà evidente che una nuova lettura è il prodotto della nuova concezione della poesia alla luce degli assunti della NOE.
"Mi piace""Mi piace"
Mirare alla padronanza non equivale a padroneggiare. Ciò che non si padroneggia ci soggioga tanto più distintamente quanto più tentiamo di sottrarci alla magia del padroneggiamento. Da qui hanno inizio le categorie deboli, e l’indebolimento progressivo della memoria. La poesia di Gino Rago proviene da questo infinito indebolimento, il suo peregrinare sotto le mura di Troia è il vero soggiorno del poeta di oggi, egli non può che soggiornare tra le rovine e i detriti della città distrutta senza alcuna speranza o utopia di sottrarsi al luogo della perdita. La perdita è la sua condizione esistenziale.
"Mi piace""Mi piace"
Lucio Mayoor Tosi ha ragione quando m’immagina giacere “all’ombra del Partenone” perché nell’intero poema del ciclo di Troia il poeta non giunge mai ad Atene, non tocca né neanche sfiora il territorio greco.
Mariella Colonna e Giorgio Linguaglossa, dal loro canto, fanno invece centro nel sentirmi, l’una, mariella Colonna, vivo e vegeto e cantante tra i fuochi e gli incendi troiani, e l’altro, Giorgio Linguaglossa, che mi vede peregrinare sotto le mura crollanti di Troia, cogliendo in ciò il punto centrale
del poema sul ciclo d’Ilio:le rovine, i detriti, le ceneri, i cadaveri come
simboli della perdita e dunque, come “vero soggiorno del poeta di oggi”.
Tant’è che l’ultimo verso, combinando le figure postmoderne del flaneur,
del turista, del vagabondo, del giocatore da contrapporre alla figura del
pellegrino della modernità, dell’ultima tessera del mosaico troiano,
dirà: “I frantumi di Troia sono i nostri frammenti…”
E’ davvero una stupenda e succulenta pagina questa di oggi della
nostra Rivista di Letteratura Internazionale per la ricchezza e l’importanza
che tutti i commenti sono riusciti a mettere sul tappeto.
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
Allora, la questione-poesia si può rimandare alla questione-tempo? Ecco una riflessione sulla questione del tempo, caro Gino, stiamo ancora dentro il cavallo di Troia, stiamo per uscire dal cavallo, dobbiamo decidere se uscire o no, se dare corso alla storia dell’Occidente o no… “né futuro né passato esistono” afferma Massimo donà… e così il tempo continua:
"Mi piace"Piace a 1 persona
Caro Gino,
grazie perché ti accorgi della presenza di tutti e non dimentichi mai di rispondere ai tuoi amici critici e poeti. Non condivido l’idea che tu “giaccia”, benchè in luogo privilegiato dell’Arte e della cultura, “all’ombra del Partenone” per il solo motivo che ci hai fatto sprofondare in un punto del tempo e della Storia che “giaceva”, lui sì, un po’ dimenticato un po’ “snobbato” nei sepolcri del tempo, ci hai fatto ricordare e vivere “da dentro” quanto siano attuali gli sconfitti e gli eroi morti sul proprio terreno di combattimento dopo anni di lotta per la difesa della Patria (una volta si scriveva così); insomma io, dopo la “lezione poetica” di Gino, sento le mura e le torri di Troia, le due fonti di fuoco e di ghiaccio, quasi come la sentiva Ecuba! Un mondo allora crollò con tutti i suoi personaggi, con le donne e i bambini, un mondo crolla ora in modo analogo peggiore di allora perché sono venuti a cadere valori morali e religiosi che mantenevano in piedi le civiltà, pur con enormi errori e contraddizioni che appartengono a tutti i tempi. Vivere questa sintonia tra uomini del passato che diventa presente e uomini del presente che sprofondano nel passato e si sentono finalmente vivi grazie ai morti è un’esperienza forte , indimenticabile. Smettiamola di crederci morti, facciamola finita con la crisi e impariamo tutti a guardare al di là del nostro piccolo io e racconti lugubri dei media: ci sono mondi e dimensioni infinite da scoprire, oltre la caligine dello smog, splendono le stesse stelle che splendevano nei cieli di Omero, se ci fermiamo un momento ci accorgiamo che è vero, è ancora inverno, ma il maggio e la primavera offrono ai nostri occhi rattristati dal male la consolazione della natura che si rinnova! Ci siamo noi poeti, sta a noi aprire gli occhi di fronte alla vita che continua e dirlo agli altri…
Grazie perché esistete tutti quanti e con opinioni diverse, voi dell’Arca della NOE, dove soltanto da poco tempo sono saltata su anch’io…e non appartenevo alla famiglia di Noe’…non mi avete notata subito perché ero mascherata da pecora, insieme agli altri animali… beh, sto soltanto cercando di sorridere…per carità non voglio offendere nessuno, neanche me stessa (anche perchè gli animali sono utili e…rispettabilissimi!). Buon mese di maggio!!!!
"Mi piace""Mi piace"
Sé positivo y relajado. http://robbinszccshoektn.webgarden.com/section-1/about-us/los-objetos-perdidos-de-la
"Mi piace""Mi piace"
Dichiaro la mia gratitudine verso Costantina Donatella Giancaspero per
l’arricchente occasione di ascolto delle meditazioni di Massimo Donà sulla
aporia del tempo, sulla sua non abitabilità, sulla necessità di frammentarlo,
sul suo lungo indugiare sull’idea agostiniana di passato – futuro – presente.
Dunque, parola e tempo, poesia e tempo s’intrecciano inestricabilmente, come del resto L’Ombra delle Parole sta sostenendo fin dalla sua apparizione problematica e stimolante nel panorama della nostra letteratura. Anzi, lo stesso fondatore e coordinatore della nostra Rivista
Giorgio Linguaglossa, ha collocato proprio il tempo al centro di quella sua folgorante intuizione ormai nota come Spazio Espressivo Integrale, sulla
cui importanza,anche nel campo degli esercizi di critica letteraria,
mi sono sempre – fin dalla interpretazione della linguaglossiana “Preghiera per un’ombra” nel Laboratorio di Poesia – con entusiasmo espresso.
Ma non posso tacere su quell’idea di Massimo Donà, idea che mi ha fatto
sobbalzare per la sua franca verità che contiene, secondo cui
“I libri esistono per non essere letti perché i libri sono soprattutto una
esigenza di chi li scrive… Poi si può verificare anche il miracolo che
qualcuno li legga…”. Che aggiungere.
Trovo poi strepitoso per verità e pathos il commento di Mariella Colonna
soprattutto in quel passaggio sull’analogia tra il crollo e lo sfarinamento
dell’intero universo troiano e l’incenerimento quotidiano di questo nostro
mondo che, così com’è, ci è toccato in sorte…Ma, e questo passaggio
di Mariella Colonna lo trovo carico di rivelazioni, sopra di noi “splendono
le stesse stelle che seppero splendere nel cielo sopra Omero…”.
Bellissimo.
Gino Rago
"Mi piace"Piace a 1 persona
Segnalo questi commenti degli studenti della IV A ad una mia poesia sottoposta loro dalla prof.ssa Tiziana Antonilli quale esemplificazione della Nuova Ontologia Estetica.
http://mariomgabriele.altervista.org/inedito-linguaglossa-ziosimo/
saluti.
"Mi piace""Mi piace"
Non siamo riusciti ad inserire il commento di Franco Campegiani alla mia poesia, lo inserisco qui:
Caro Giorgio,
ho provato ad inserire questo commento, ma non sono certo di esserci riuscito. Un abbraccio.
Franco
Commento:
“Colui che sa non parla, colui che parla non sa”. E’ un detto di Lao Tzu, fondatore del Taoismo. I parabolani (i verbivendoli) sbandierano la verità (Dio), ma non sanno che essa esiste solo nel silenzio. Bisogna tagliarsi la lingua per potervi attingere, ed è paradossalmente questa la condizione indispensabile perché la lingua possa riapparire. Non in maniere ripetitive, ma nei modi originali ed autonomi dello spirito creativo che vive in comunione con se stesso (non con Dio). Esattamente come il bambino.
Franco Campegiani
"Mi piace""Mi piace"
Carissimi,
ho provveduto a inserire il commento su Altervista. Grazie.
"Mi piace""Mi piace"
Io, Zosimo di Giorgio Linguaglossa viene bene interpretato dai ragazzi
coordinati da una brava e coraggiosa professoressa che li fa cimentare con un poeta contemporaneo. E tutti i loro commenti si soffermano sulla “scelta del silenzio”, un silenzio più eloquente delle parole vuote e insensate.
Franco Campegiani nel commento sopra riportato saluta con fervore la necessità del taglio della lingua di Io, Zosimo per una ri-apparizione o per una ri-fondazione della lingua stessa.
Ma sullo scenario intorno a Io, Zosimo Giorgio Lingiaglossa segnala anche l’incendio e l’incenerimento d’una Biblioteca, forse la più importante biblioteca d’un certo tempo (la Biblioteca Alessandrina…)
I temi o come si diceva un tempo i motivi dell’inedito di Giorgio Linguaglossa sono anche questi, fuor di discussione.
Ma i ragazzi, per una più completa penetrazione nel tessuto poetico linguaglossiano, dovrebbero sapientemente essere guidati a cogliere certe novità che il componimento introduce rispetto, possiamo ora dirlo senza offese per nessuno, al vecchio modo di fare poesia, novità prima di tutto costituita dal parlato che Giorgio Linguaglossa anche qui introduce come invito al lettore a entrare nei suoi versi senza sentirsene estraneo o rigettato. E poi, questo io colgo, resta il messaggio centrale che Io, Zosimo ci lascia: che fare contro la “vischiosita’” che tende a risucchiarci, ad avvolgerci nelle sue spire, fino a farci sentire impotenti?
Se la lingua non riesce ad esprimere più la comunanza di valori radicati, meglio il silenzio, silenzio che in Io, Zosimo si fa linguaggio universale da tutti compreso…
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
Copio e incollo questo messaggio inviato alla mia email di un giovane poeta Simone Carunchio (pseud. Enomis) sulla Nuova ontologia estetica
Simone Carunchio
00:11 (11 ore fa)
Caro Giorgio Linguaglossa,
Ti ricordi? Era il 23 marzo 2011 alla libreria AltroQuando in occasione della seconda presentazione del mio primo libro di Poesia che pubblicai con la Edilazio a nome di Enomis.
Mi permetto di disturbarti, scrivendoti a proposito della N. O. E.
Per prima cosa, a te, a tutti coloro che si danno il tempo di scrivere sulla rivista, non posso che porgere i miei più sentiti ringraziamenti; in particolare per lo stimolo che i vostri pensieri e le vostre riflessioni mi hanno procurato.
Davvero, non lo affermo con secondi fini, ma solo per il piacere che mi dà il sentire che intorno a me (che vorrà mai dire questo vocabolo? “me”) ancora si ragioni (si pensi e si rifletta) di questi argomenti.
Quali argomenti? Esattamente quelli che mi sembra siano dei temi di un movimento poetico (che non vuole essere una scuola!) estremamente attuale. Uno l’ho appena accennato: quello dello spossamento del sé. Questa problematica, per me, si accompagna strettamente al tema del giudizio.
Un tema, questo del giudizio, a me molto caro, e che mi ha portato a dedicarmi, con gioia e fatica, alla filosofia del diritto per anni. Una materia, purtroppo, decisamente bistrattata da chi pensa, come noi, credo, che la filosofia sia una delle basi fondamentali della poesia.
Che poi questa filosofia sia patente (il bello e il vero vanno sempre insieme – il Leopardi), come indica la tradizione italiana, o che essa sia latente (il bello fa trasparire il vero – il Baudelaire) , come vuole la tradizione francese, ciò implica una diversa visione (una necessaria diversa visione) della posizione del poeta nella società (vd. Apollinaire): In Francia i filosofi ci sono; in Italia no, e quindi qualcuno, da quella parti (ossia in Italia), filosofia dovrà pur farla! (a me pare che in Italia ci siano tanti storici della filosofia).
Ma già sto divagando …
Torno a bomba alla N.O.E. e a ciò che essa mi ha fornito per riprendere e (ri)sistematizzare alcuni argomenti che ho approfondito e che adesso fanno parte del mio bagaglio culturale.
Direi che aprile 2017 sia stato uno dei momenti più rilevanti del movimento.
Il 31 marzo 2017 esce un bell’articolo sul Pasolini e il Montale: finalmente, allegria! – penso io (ma io chi? ), ma parlando come il Buongiorno -: qualcuno che parla del Pasolini e di quell’incredibile libro che è Trasumanar e organizzar che leggo e rileggo da anni (nei miei libri di poesia è citato più volte) (anche in quello che hai commentato tu nel 2011) (sul Montale mi sono già espresso proprio nella rivista L’ombra delle parole)
E ma poi: a raffica:
Il 5 aprile compare l’articolo di Gino Rago su Rebora e Palazzeschi (ah, questi palazzi pazzeschi!): mi rimane impressa soprattutto l’esternazione del dolore … : della poesia come effetto del dolore (che io chiamerei sofferenza perché quando mi ferisco, e provo dolore, esce sangue e non poesia).
Questo collegamento è poi rinvenibile anche nell’articolo dello stesso Rago del 14 aprile. Ma c’è anche altro in quel breve ma intenso e lucidissimo articolo: parlando dell’Adorno e del Nietzsche, il Rago mette in chiaro che il sistema metafisico non c’è più e che quindi non ci rimane che il frammento.
Io (io chi?), come per il dolore, avrei utilizzato un’altra terminologia: non è la metafisica che è venuta a mancare ma è l’ontologia (il discorso permane e persiste – anche per frammenti -, è il discorso sull’essere che viene meno!, in quanto il discorso sull’essere è necessariamente un discorso sull’essere-umano come la letteratura artistica è sempre autobiografica); esattamente come afferma la N. O. E. (che però io avrei, pertanto, chiamato N. M. E.).
Il Rago poi continua mettendo in luce che il frammento si giustifica con le nuove scienze e che si è di fronte alla fine della visione platonico-cristiana.
Nello stesso giorno interviene anche la Giancaspero sul Non-Essere … dimenticando Sartre …
Due giorni dopo interviene il Linguaglossa (ti cito alla terza persona) con un bell’articolo sul Brodskji; il Brodskji migliore, capito e dispiegato alla perfezione: soprattutto nella contraddizione della perdita della memoria e quindi del sé e il fatto che quindi (dopo questo evento orribile a dirsi e a pensarsi – e io mi sono domandato: e perché?) “D’ora in avanti l’uomo dovrà fare i conti con se stesso” … Ma come – mi sono detto – ma non era proprio il sé che era stato perduto? E se l’ho perduto come faccio a fare i conti con lui?
Oh, non sto criticando negativamente; anzi, tutto il contrario: per me il giudizio ‘vero’ (e non falso) è quello che rispecchia fedelmente la realtà (la tensione); e dal momento che la realtà è inconoscibile e indescrivibile, soprattutto indescrivibile, nella sua totale assolutezza; chi ci ha provato non ha potuto far altro che renderla Fenomeno e nella logica e razionale descrizione che ne ha fatto, essa, la realtà non poteva che risultare contraddittoria (vd., ex plurimis, il Sartre con il fenomeno tempo e con il fenomeno dio; vd. il Kojève con il fenomeno diritto) ne risulta che, dal momento che ci muoviamo nel virtuale (ossia nella sola verità, ossia nella metafisica – che può essere vera o falsa) (qualsiasi cosa di cui parliamo è già perduta nel suo passato presente- il linguaggio è essenzialmente metaforico), l’unico giudizio sano (tra vero e giusto) è quello contraddittorio.
E dicendo questo non dico niente di nuovo: già i giuristi (gli interpreti) antichi ben sapevano che il torto e la ragione stanno da entrambe le parti in causa, e non da una parte sola.
A parte ciò, a livello poetico, il Linguaglossa pare allontanarsi dall’apoteosi del frammento: si parla di “poesia di ragionamento”, di “poesia di riflessione” …
Sempre del Linguaglossa mi sono poi ritrovato per le mani un suo (suo di chi?) articolo sul Gabriele. Purtroppo ne ho perso la data … In ogni caso, perfettamente in linea – almeno per me – con la poesia di ragionamento, si dice che “il soggetto quindi parla metonimicamente” … quanto sono d’accordo!!!
Io infatti non parlerei mai del frammento, ma il mio riferimento è al frattale del Mandelbrot; ossia l’ultimo ritrovato della geometria.
Il frattale: per me un concetto, nel mio sistema di costruzione di una visione del mondo, fondamentale. Se, come detto, l’analisi di un fenomeno non può che risolversi in una contraddizione, questo vuol dire che ogni fenomeno analizzato si trova in rapporto frattale con un altro; ossia, in termini retorici, metaforici, in rapporto di metonimia e sineddoche nello stesso tempo. Questo non vuol dire che gli autori dicano tutti la stessa cosa. Ognuno ha chiaramente i suoi argomenti preferiti. Solamente, è lo strumento che si usa per rappresentarli che è lo stesso, cioè: la logica (ed essa è rappresentata in modo più o meno patente e latente proprio dall’argomento, dal fenomeno).
In seguito ho poi trovato, il 22 aprile 2017, un articolo del Gabriele sulla sua poesia: apologia del frammento, rifiuto del lirismo … non sta a me dire se è giusto o no (eccoci sempre che torniamo al problema del giudizio) … a me (ancora co’ ‘sto me! – ma ‘me’ chi?) però, la poesia del Gabriele risulta (a tutto dire francamente) un po’ noiosa e soprattutto non vi trovo quel passaggio patente dall’estetica all’etica che, come asserito più su, permette … di non rappresentare la realtà come se si fosse un semplice specchio ma permette di indicare quella speranza che nella realtà si possa operare … Se leggere una poesia significa farsi una passeggiata nel proteiforme frammento, come mi accadrebbe di uscire di casa … beh, allora … esco di casa! Questa poesia, di contro, è però estremamente interessante perché dimostra invece uno sforzo di tecnica; e la tecnica, a mio parere (ho pubblicato in proposito un articolo su Lazio, Ieri e Oggi) è il luogo d’incontro tra l’arte e la scienza (in questo senso ultimamente mi sto sempre più dedicando alla metrica e alla prosodia – classica e non: mia figlia più grande, di otto anni, quando le chiedo che cosa per lei è poesia – ne sta già imparando molte a memoria – mi risponde che la poesia è la letteratura in rima …).
Non passano neanche sette giorni che, il 28 aprile 2017, compare il bel saggio del Gattinara sul frammento [non sono d’accordo sulla precarietà del lavoro: se il soggetto-oggetto è scomparso (o forse non c’è mai stato) – e su questo siamo tutti d’accordo -, è ovvio che si viva di lavoro precario: il problema non è questo tipo di lavoro, ma quanto esso viene retribuito!!!: io che sono per l’aseità e il giudizio contraddittorio non vorrei mai il cartellino – e infatti non ce l’ho e sono precario – ma vorrei essere pagato bene!!!] e il Rago che riprende il suo discorso insistendo sulla fine della visione platonico-cristiana …
E anche qui … purtroppo … non mi trovo d’accordo: la visione cristiana non ha neanche fatto in tempo ad affermarsi che già era scomparsa: gli insegnamenti di Gesù furono traditi poco dopo: bastò metterli per iscritto, come se fossero delle leggi, che già il suo messaggio (il passaggio dalla scrittura alla parola) era perso…
Che ne ho ricavato, oltre questi stimoli di ‘ragione’, dalla lettura degli articoli citati?
Primo: il nuovo movimento non è una scuola. E questo mi piace un sacco (sono stato cacciato dall’università perché non ero in linea con la scuola!): c’è chi è per il frammento e chi è per il ragionamento!!
Secondo: l’immagine che mi piace di più, tra le varie presentate, è quella del mosaico … e come sai già, nel libro che presentasti tu, in più occasioni, anche io (ovverosia: Enomis), mi rifeci al mosaico.
Terzo: rimane aperta la questione a cui ho più volte accennato, e che riguarda, in particolare, quel filone del movimento che si impegna nel frammento (ma che in generale riguarda qualsiasi pensiero che abbia a che fare con lo spossessamento del soggetto o aseità): se faccio scomparire dal discorso il soggetto-oggetto – ovvero: la significazione, il nucleo cangiante che calamita e capitalizza i sensi proteiformi -, chi è che giudica? dove va a finire il giusto (che forse è possibile far rientrare nella categoria dell’utile)?
Io la mia risposta ho provato a darla col giudizio contraddittorio e di equità, ma per far questo ho comunque bisogno di quel nucleo di cui sopra (anche mutante o cangiante, coe ci insegna la scienza – come mi hai insegnato tu).
Orbene, ecco il passaggio necessario e logico successivo, che ho tratto dallo studio delle biografie di tanti autori (vd. Leopardi o Enomis) comparate alle loro bibliografie: se passo dal discorso logico a ipotizzare la presenza di quel nucleo, non mi trovo più tra fenomeni in rapporto frattale, ma in rapporto inverso: l’etica (o l’estetica) da lui proposta, nel discorso, (mi) risulta il contrario della morale praticata di quel presunto nucleo (su quest’argomento ho scritto saggi su Derrida e su Leopardi e una ricerchina su diritto e morale- che non sono ancora pubblicati).
Insomma, caro Giorgio, per frammenti, ho cercato di dirti il perché del mio ringraziamento. Ti chiedo scusa per il tempo che ti ho rubato, ma spero che quanto ho finora espresso possa stimolare la tua curiosità e magari farti chiedere: “ma Simone Carunchio, come avrà risolto i problemi che abbiamo in comune?”
Se ti va, mi propongo di inviarti una selezione (breve – lo so che il tempo è poco e tiranno) dei miei scritti poetici in cui tento di risolvere diversamente che con il frammento (una Poesia è già un frammento e non mi pare che ci sia la necessità di frammentarla ancora di più – se no scriveremmo romanzi) il problema della rappresentazione senza l’ “io”. Anche io sono per una poesia di ragionamento. (Anche se qualche primevo e forse non riuscito esercizio in tal senso lo ritrovi anche nei libri che ho pubblicato a nome di Enomis che dovresti già avere) (Pecora dei miei scritti non ha mai capito niente).
Anzi, ti confesso, che proprio il Movimento mi ha fornito lo spunto per riorganizzare la mia opera secondo questo filo conduttore. Filo che da sempre, da quando ho cominciato a poetare mi ha accompagnato e che senza di voi non avrei così chiaramente dipanato.
A presto,
"Mi piace""Mi piace"
Gentile Carunchio salve,se la Giancaspero intervenuta su l’Essere ha dimenticato Sartre ha agito correttamente!
Le ricordo che in Italia abbiamo Emanuele Severino,senza dimenticare Gianni Vattimo
"Mi piace""Mi piace"