Trasalimenti logosferici dalle opere sparse di Emilio Villa. Performance recitativa di Pilar Castel. Creazione video di Gianni Godi

[Paolo Valesio nasce nel 1939 a Bologna. É Giuseppe Ungaretti Professor Emeritus in Italian Literature all’Università di Columbia a New York e presidente del “Centro Studi Sara Valesio” a Bologna. Oltre a libri di critica letteraria e di critica narrativa, a numerosi saggi in riviste e volume collettivi, e a vari articoli in periodici, ha pubblicato: Prose in poesia, 1979, La rosa verde, 1987, Dialogo del falco e dell’avvoltoio, 1987, Le isole del lago, 1990, La campagna dell’Ottantasette, 1990, Analogia del mondo, 1992, Nightchant, 1995, Sonetos profanos y sacros, 1996, Avventure dell’Uomo e del Figlio, 1996, Anniversari, 1999, Piazza delle preghiere massacrate, 1999, Dardi 2000, Every Afternoon Can Make the World Stand Still /Ogni meriggio può arrestare il mondo, 2002, Volano in cento, 2002, Il cuore del girasole, 2006, Il volto quasi umano, 2009 e La mezzanotte di Spoleto, 2013. È autore di due romanzi: L’ospedale di Manhattan, 1978, e Il regno doloroso, 1983; di racconti: S’incontrano gli amanti, 1993; di una novella, Tradimenti, 1994, e di un poema drammatico, Figlio dell’Uomo a Corcovado, rappresentato a San Miniato nel 1993 e a Salerno nel 1997]
Prefazione al volume Emilio Villa, la scrittura della Sibilla, a c. di Daniele Poletti, Viareggio, Edizioni Cinquemarzo / dia∙foria, 2017, pp. 13-25

L’utopia della poesia (un’utopia di tipo ermetico o alchemico) è quella di un linguaggio autosufficiente [Paolo Valesio]
L’utopia della poesia (un’utopia di tipo ermetico o alchemico) è quella di un linguaggio autosufficiente; l’utopia della critica di poesia d’altro canto è doppia: c’è quella razionalista che mira all’esplicazione, e quella (chiamiamola alchemica) che invece ricerca una sorta di mimesi dell’autosufficienza poetica. Entrambe queste utopie critiche sono necessarie; e del resto i loro confini si rivelano a volte porosi. Per esempio: vi sono autori in cui “scrittura” è sinonimo di “struttura”, e altri in cui scrittura significa profusione, diffusione, diffrazione. (Emilio Villa appartiene chiaramente a questa seconda categoria.) I critici letterari sembrerebbero schierati dalla parte della scrittura strutturata; ma non è sempre così.
In effetti, entrambe le “utopie” critiche sono rappresentate in questa raccolta di acuti saggi, la quale rende opportunamente più accessibile quello che era nato come “e-book”; aggiungendovi, per l’attenta cura di Daniele Poletti, oltre a uno “Pseudo-introibo” (di Fabrizio Biondi), due nuovi saggi, un’ intervista frastagliata (con Francesco Villa) e una singolare appendice; il tutto integrato da una minima ma molto utile antologia poetica. (Il discorso critico non può sussistere senza la voce della poesia.)
Il filo conduttore della poesia di Villa (filo su cui sarà inevitabile ritornare) affiora fin dallo “Pseudo-introibo”, secondo cui il poeta “abita consapevolmente la caduta gnostica dal pleroma”. Dopo di che, il tono di Aldo Tagliaferri (benemerito degli studi villiani, e autore di saggi fondamentali sul poeta) è più distaccato e di tipo universitario; come lo è anche il tono dell’altra benemerita studiosa villiana (vedi nota 1), Cecilia Bello Minciacchi, che qui presenta una miniatura di critica stilistica su un componimento latino di Villa. E questo tono continua nel saggio di Gian Paolo Renello, che sviluppa metodicamente un esame comparativo dei “verba sacra” di Villa; e anche nel saggio di Ugo Fracassa, che si sofferma su concetti come “luogo” e “senso e/o impulso” nell’opera villiana. Uno stile, insomma, filologico-universitario – non voglio dire “accademico” perché questo termine (che in inglese è innocente) ha acquisito in italiano, come sappiamo, una connotazione negativa. E invece questi saggi, di alto livello come gli altri nel libro, evitano la pedanteria.
Ma il volume provvede anche una benvenuta varietà, pertinente a quella critica di cui dicevo all’inizio, parlando di alchimia e di mimesi termini che preferirei al vecchio attributo di “militante”. E’ Carlo Alberto Sitta, con un brevissimo scritto ripreso da sue pagine precedenti, che provvede quest’altro approccio: «La critica non si scompone, per essa ogni irregolare è un alveo saldato agli argini. Non c’è gesto deviato che valga a spezzare l’erudizione, chi la nega la usa, chi la pratica ne fa scempio». Del resto – e a proposito dei confini porosi fra i vari modi di avvicinamento critico – la riflessione di tipo filosofico piuttosto che filologico può servire, fino a un certo punto, da ponte fra i vari metodi, come nel saggio di Ugo Barbaglia sul «ritorno labirintico». E un ponte di tipo filosofico è anche quello lanciato da Enzo Campi, all’insegna di una categoria tipicamente villiana come quella del “Chaos”, e con importanti riferimenti a esperienze teatrali. (Vi è infatti una profonda parentela fra la poesia e il teatro – parentela offuscata dall’infelice espressione ‘teatro di prosa’. )

Keith Haring, Image, polipo
Si torna poi alla filologia con il saggio di Chiara Portesine sulla “armonia dinamica”. L’autrice giustamente richiama una certa vicinanza fra il discorso villiano e la neoavanguardia; e allora, la polemica del poeta contro questa avanguardia, che l’autrice stessa poi nota? Non mi pare che sia una contraddizione, anche se il Villa critico e teorico pare tutt’altro che preoccupato (e va bene anche così) dalle contraddizioni .
Ma la divergenza Villa / neo (post)avanguardia dovrebbe esser vista al suo livello appropriato, che non è quello linguistico. Infatti i procedimenti espressivi considerati (dalla Portesine e da altri nel libro, e anche da Dominic Siracusa nella sua introduzione al volume delle poesie tradotte in inglese, per cui vedi più avanti) come tipicamente villiani appartengono in realtà alla tradizione modernistica dell’avanguardia – compresa l’eredità, indispensabile ma ancora non adeguatamente riconosciuta, del futurismo in generale e di F. T. Marinetti in particolare. Al di là comunque di ogni polemica, la differenza villiana va ricercata nella contestualizzazione culturale; diciamo pure, ancora una volta, che è una differenza di tipo filosofico, o più precisamente ancora ( è la coraggiosa “inattualità” di Villa) di tipo teo-filosofico.
Avevo auspicato che fosse possibile “andare al di là di ogni polemica” – e invece… Ma andiamo con ordine, come si diceva nei romanzi d’una volta. Una delle più deprimenti testimonianze che illustrano il persistere di una certa tendenza accademica alla parafrasi eulogistica piuttosto che alla vera e propria critica, mi si presentò quando udii la seguente domanda, rivolta da un collega a un altro suo collega che aveva appena finito di presentare una relazione in un convegno pirandelliano negli Stati Uniti, vari anni or sono: “Ma perché ti occupi di Pirandello, se non ti piace?” (specifico che il sottoscritto non era, né quel relatore né quell’obiettore – donde la mia posizione per così dire oggettiva.)
Parrebbe un’ovvietà, che ogni convegno o libro collettivo o simili (si tratti di critici letterari o di, per esempio, uomini politici) sia fondato sull’idea di un confronto critico fra valutazioni e posizioni diverse. E invece questa ovvietà – come tante altre – è tutt’altro che ovvia. In effetti, la difficoltà di trovare un‘autentica divergenza di posizioni tra i critici letterari che si occupano di un dato autore – la difficoltà di trovare dentro il coro almeno un critico o una critica a cui quell’autore “non piace” (uso quest’espressione semplicistica come abbreviazione approssimativa) – è solo uno dei tanti indizi (ma non è il minore) dello statuto ancora precario del costume democratico in Italia, al di là dei superficiali effetti di democrazia (penso all’ effet de réel di cui parlava Barthes) creati dall’ideologia, che comunque in Italia è generalmente a senso unico. Senza entrare nel merito dei singoli ideologhemi, mi limito a osservare che ogni posizione ideologica (compresa quella, molto diffusa in Italia, che consiste nel bollare come “ideologiche” le posizioni contrarie all’ideologia dominante nell’intellighenzia e fra i politici) è allotria rispetto a Villa, nemico dell’ideologia – come appare anche in un efficace neologismo di tipo joyciano «stupore idolologico» – e come forse traspare anche in una simile parola composta, «eidololatria» .
Tutto ciò porta al saggio in appendice di Fausto Curi – che è ancora il teorico più acuminato fra i molti eccellenti studiosi nel Dipartimento di Filologia Classica e Letteratura Italiana dell’università di Bologna (suo pari era Guido Guglielmi, ora scomparso). Va riconosciuto al curatore Poletti il merito di avere accolto questo saggio drasticamente anti-villiano in un volume dedicato all’opera di Villa. Non si tratta di mosse più o meno diplomatiche: quella che è in gioco è la possibilità (come detto) di consolidare lo spirito democratico nella critica letteraria italiana. E a Curi dev’essere riconosciuto il merito, innanzitutto, di contribuire a smitizzare la tradizione secondo cui Villa sarebbe stato un isolato. (D’altra parte, un senso di isolamento può contribuire a spiegare l’impazienza alquanto sprezzante spesso affettata da Emilio Villa – e che pare condivisa anche da alcuni dei suoi critici – verso la cultura italiana contemporanea, letteraria e non; atteggiamento però che veramente non convince: la cultura poetica, e non solo, del Novecento italiano è una delle più alte a livello internazionale – e ciò va chiarito, contro il provincialismo di ogni disfattismo suppostamente anti-provinciale.) In secondo luogo, Curi ha il merito di aver scritto un saggio nel pieno senso del termine, cioè un testo composto con un tono autenticamente personale. (Per il resto, il saggio comincia con una lucida analisi delle poetiche francesi alla giuntura fra Ottocento e Novecento, e poi si tuffa in un virulento pamphlet ideologico dal quale non sono assenti parole un po’ grevi.) Ma a questo punto tento semplicemente, senza presumere di offrire una sintesi finale, di allargare lo sguardo oltre ai questionamenti di avanguardia e non-avanguardia.

Herbert List, foto, Anna Magnani, 1960
Villa (d’ora innanzi EV) è un «autore decisamente “estroverso”» (Campi); d’altra parte questo libro a lui dedicato mi sembra un po’ “introverso”(il che comunque è una descrizione, non una critica). Introverso nel senso che esso è tutto concentrato sulla storia italiana di EV: sono dunque auspicabili per il futuro ricerche dedicate ai vari autori stranieri già menzionati. Oltre ai francesi, emergono nei saggi di questo volume i nomi di Joyce e di Pound – e a me sembra che Pound sia il riferimento villiano più pertinente, per il suo senso della poesia come costruzione di tutto un cosmo. Ma occorrerà anche seguire i destini traduttologici dell’opera di EV, come la versione inglese delle sue poesie (vedi nota 7; è menzionata dalla Bello nell’apparato de L’opera poetica).
L’introduzione del curatore/traduttore di quella versione inglese di Villa è interessante; anche per l’ambiguità, che oggettivamente appare a tratti nella sua analisi, tra: da un lato, la descrizione di una maniera di, per così dire, impossibilitazione, in linea con le esperienze fra il decostruttivo e il nichilista di buona parte della poesia contemporanea (e non solo della poesia – Villa come sappiamo era anche un critico poetico delle arti figurative); e dall’altro, una forma di trascendenza che traspare, si potrebbe dire, nonostante tutto: per cui l’indefinitezza incessante della ricerca non esclude necessariamente una qualche costruttività dell’esperienza .
Non ultimo infatti tra i paradossi in cui l’esperienza spirituale si intreccia a quella poetica è il paradosso (ma è poi tale?) secondo il quale un senso della trascendenza è anche ciò che rende possibile un dialogo rispettoso e comprensivo con l’esperienza nichilistica – la quale troppo spesso resta presa tra i due fuochi dell’intransigenza ideologica e di quella moralistico-religiosa. La poesia di EV, dunque, ci aiuta a chiarire quello che in ogni caso tante altre esperienze (artistiche e non) ci mostrano: anche il nichilismo – anche la “noche oscura” che non finisce mai – è un’esperienza che va accolta nella sua dignità umana e cognitiva.
Tuttavia, una volta chiarito che “nichilismo” non è qui considerato come un epiteto di obbrobrio, va anche detto che questa categoria non è la più appropriata per caratterizzare la poesia di EV; perché nichilismo sembra essere una categoria più laica che teologica, e EV è un poeta (come detto) teo-filosofico, anzi ateologico. Con quest’ultimo termine mi riferisco all’opera di Georges Bataille, La somme athéologique, il cui nucleo nasce negli anni Quaranta e a cui va riconosciuta la prelazione contemporanea di questa categoria – qualunque siano, al di là della terminologia, le anticipazioni poetiche e filosofiche di tale concetto – e qualunque siano i parallelismi con la poesia italiana dei contemporanei a Villa: in particolare Giorgio Caproni con la sua «patoteologia». Ma Caproni poetizza l’ateologia in modo ben diverso (più lirico, chiaramente) dalla tensione di EV, nel quale ultimo la poesia sfida continuamente la prosa – in linea con gli esperimenti più avanzati, da molti anni, nella poesia contemporanea .
L’ateologia, comunque, non dev’essere articolata solamente in base al prefisso privativo (a-teologia), che sembra essere la sola forma normalmente evocata; ma va anche divisa come parola composta: ateo-logia – e ciò evidentemente non è solo un gioco (a parte la consonanza di questo serio ludus con il linguaggio di EV). E’ ormai chiaro da tempo che l’ateismo, o diciamo l’assen-teismo, si annida nel cuore stesso del cristianesimo – come nodo problematico e come esigenza di dialogo. Questa connessione (a)(teo)logica fra Bataille ed EV non può essere soltanto una coincidenza, poiché essa trova il suo analogo anche nei procedimenti poetico-saggistici: somiglianze con il concetto batailliano di dépense, distanziazione dal religioso a favore del sacro, dilapidazione, sparpagliamento prolisso, irregolarità espressionistica, senso dell’interdisciplinarità, ecc. Elementi tutti che andrebbero anche verificati (altro progetto per saggi futuri) con precisi raccordi testuali. Ma urge una sintesi.

Keith Haring, image, 1983
Se lo gnosticismo potrebbe essere il filo conduttore nell’opera di EV poeta ateologico, che tipo di gnosticismo si può intravvedere nella sua vasta e sincretistica opera poetica? Sembra che lo gnosticismo di EV prediliga la tenebra rispetto alla luce, si concentri sulla caduta dal pleroma piuttosto che sulla risalita alla completa conoscenza (la gnosi), metta sostanzialmente tra parentesi la figura (strategica, in buona parte della tradizione gnostica) di Gesù. Uno gnosticismo, insomma, di tipo ateistico e nichilistico. (Non si può rifuggire da questo dialogo.) Ma, detto questo, tutto diventa più complesso, e le distinzioni si fanno più complicate. Se EV si comportava «in adesione a una forma del transeunte», colpisce allora che questo attributo appaia (pur attraverso l’inevitabile trafila di traduzioni/tradimenti) in una delle esortazioni del Gesù gnostico: «Gesù disse: “Siate transeunti!”» .
EV sta, più chiaramente che ogni altro poeta italiano dei suoi anni, al crocicchio del sacro e del profano; non è strano dunque che qui ricompaia la già menzionata esperienza del trascendente. La quale, in una poesia tutt’altro che solenne ed edificante come quella di EV, si manifesta a vari livelli espressivi – come appare in una delle categorie fondamentali della poesia villiana, il trou: il buco, il foro, l’abisso che si può vedere come l’abisso in cui sprofonda l’uomo caduto dal pleroma, in una «catena metonimica» (che a me pare, piuttosto, metaforica) che si estende ai «foramina (e dunque alle ferite di Cristo), al vuoto, al “nul originaire” (dal quale il Demiurgo ricavò Tutto), alla matrice (Origine du monde, secondo Courbet), allo zero, alla bocca, in cui nasce ogni suono, e ad altre dimensioni più o meno recondite», compreso l’ «utero verbale», per cui vedi le Sibyllae villiane. E il discorso sui trous si estende a quella peculiare forma di critica d’arte – che si affianca alla poesia nell’opera di Villa – per esempio nel saggio poetico-narrativo Lucio Fontana del 1961 .
Ma, appunto, la figura del trou è strumentata da EV con piena libertà di variazione poetica, e a diversi livelli espressivi, in un gioco vertiginoso tra il metafisico e il fisico. EV è un poeta misterico, e quando il misterico si fa poesia si insinua in esso un elemento lievemente isterico, distante dall’atmosfera di solennità con cui di solito perviene a noi la tradizione antica dei Misteri. Circola, nella poesia di Villa, un’aria di agitazione istrionica, buffonesca: (m)isterica, appunto. E’ in questa atmosfera che si introduce per esempio, nell’immagine del trou, un linguaggio di mescolanza carnale che non esita a cimentarsi con il carnevalesco e l’osceno (le «dimensioni più o meno recondite» eufemisticamente evocate sopra). Per esempio, nel «p. s.» in versicoli al citato saggio su Fontana: «le nul dans le nul // le cul dans le cul / le trou dans le trul» – dove la parola trul , che non sembra francese, potrebbe essere una reminiscenza dantesca («rotto dal mento infin dove si trulla», Inferno, XXVIII, 24).
Non si può non esplicitare insomma il ben noto, o notorio, sonetto del 1871 scritto a quattro mani da Paul Verlaine e Arthur Rimbaud. E’ un testo virtuosistico, un divertissement parodistico, come chiarisce il soprattitolo L’idole – il quale potrebbe anche far pensare anche a espressioni villiane citate sopra, come «idolologico» o «eidololatria».
Parrebbe allora che ci fossimo molto allontanati dal territorio della trascendenza; ma non è veramente così – e anche qui mi limito a un solo esempio. A un certo punto del grande dramma di Paul Claudel La scarpina di raso appare in scena San Giacomo, rappresentato come una figura gigantesca che tiene un monologo nella notte:
Moi, phare entre les deux mondes, ceux que l’abîme sépare n’ont qu’à me regarder pour se trouver ensemble.
Je tiens trop de place dans le ciel pour qu’aucun œil puisse se méprendre.
[…]
Les heureux et les assouvis ne me regardent pas. C’est la douleur qui fait dans le monde ce grand trou au travers duquel est planté mon sémaphore.
Basta la parola “dolore” (così poco villiana) a indicare che questo “grand trou” è diverso da quelli su cui si accanisce la poesia di EV – eppure si tratta pur sempre di un foro cosmico. Solo che questa volta il foro non segna soltanto la direzione precipite dell’abisso, ma anche quella della risalita – dunque una linea di trascendenza. Certo, si potrebbe dire che questo santo raffigurato come un enorme “faro” o “semaforo” ha in sé qualcosa di grottesco. Ma abbiamo visto come queste due dimensioni non siano incompatibili, anche nel discorso della trascendenza.

C’est la douleur qui fait dans le monde ce grand trou au travers duquel est planté mon sémaphore.
E in effetti la connessione villiana con cui concludo è la genealogia macaronica della sua poesia. Credo che il latino di Villa potrà venire adeguatamente analizzato solo quando se ne studierà la genealogia nella poesia macaronica in generale, e nei capolavori di Teofilo Folengo in particolare. La poesia macaronica, al di là della sua immagine vulgata, è una poesia (m)isterica, che combina una teofilosofia – se non ateologica, certo piuttosto eterodossa – con un senso geniale della comicità e del grottesco. Tutto ciò meriterebbe un lungo saggio, o addirittura una breve monografia.
Per finire: niente bilanci e niente sintesi, come promesso – ma soltanto un’osservazione. Un poeta (G. P.) ha parlato recentemente con preoccupazione di una poesia che “s’intenebra”; e ha espresso, se ho capito bene, la speranza che la critica possa portare luce in questa tenebrosità. Pur avendo evocato senza ambagi l’esperienza del trascendente, io preferisco qui una prospettiva fenomenologica: c’è la poesia della luminosità (in Italia vien subito da pensare, per esempio, a Mario Luzi), ma c’è anche la poesia che potremmo definire dell’intenebramento, cui appartiene EV – e la critica, se vuole veramente servire il suo oggetto, dovrà pur seguire simpateticamente entrambi i tipi di poesia. Domanda non impertinente (sia nel senso di “non indiscreta” sia in quello di “non esterna al tema”): che cosa resta fuori, da una poesia come quella villiana? Ma, prima ancora di abbozzare una risposta, mi coglie il dubbio che tale domanda in fondo sia impertinente nel secondo dei sensi suddetti. Che, cioè, sia bene rispettare l’utopia ermetico-alchemica dell’autosufficienza del linguaggio poetico. La poesia di Villa è quello che è – non quello che non è.
La poesia villiana, come ogni poesia di tipo iniziatico che punta sulla gnosi (anche se in questo caso si tratta più precisamente della nostalgia di una gnosi non raggiungibile), non si interessa al rapporto con quella che si chiama (con un termine peraltro generico) la comune umanità. Anche la poesia della (neo)avanguardia rivela questo tipo di distacco. Ma il distacco neo-avanguardistico (e la dimensione della poesia villiana che più gli si avvicina) costruisce tale distacco come critica del linguaggio – con tutto i già notati limiti intellettualistici di tale critica. Mentre la parte più importante e caratterizzante della poesia di EV costruisce tale distacco su un’esperienza – un’esperienza di trascendimento. Non pare che quella che ho chiamato poesia del distacco (il termine “poetica” mi sembra troppo astratto) sia particolarmente coltivata nella poesia italiana contemporanea, che continua troppo spesso a sfiorare l’idillio (dolce-amaro, sì, ma che resta pur sempre idillio, perfino nei panni della declamazione “civile”). Ecco allora l’importanza che permane della poesia di EV, con l’ “inattualità” che è propria di ogni vera sperimentazione.
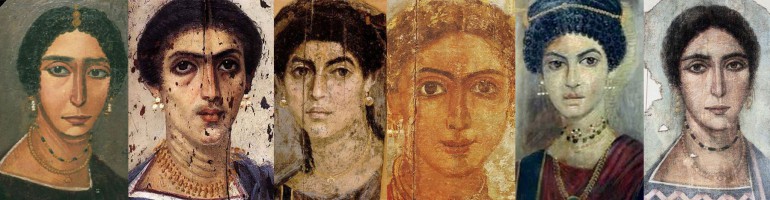
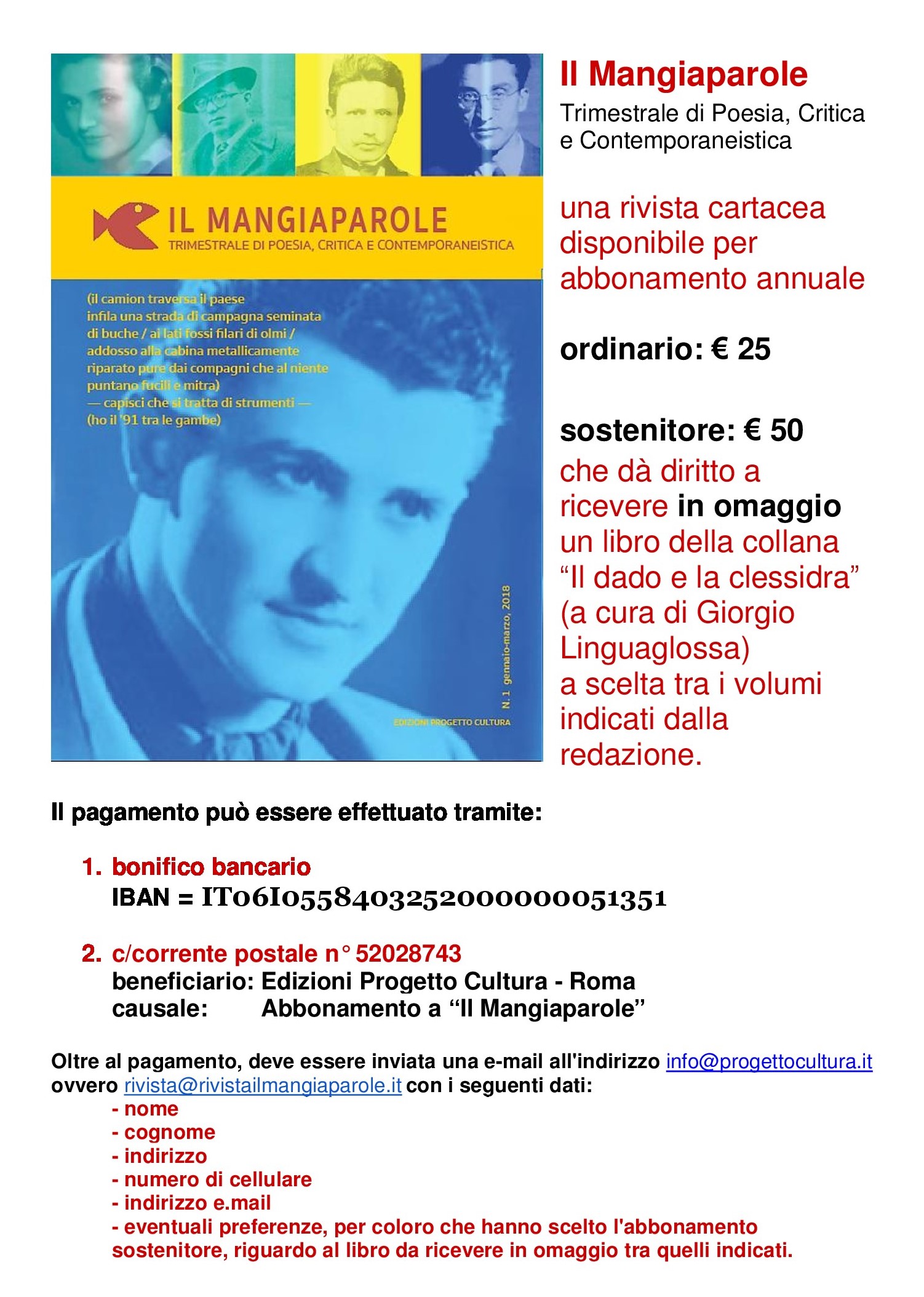
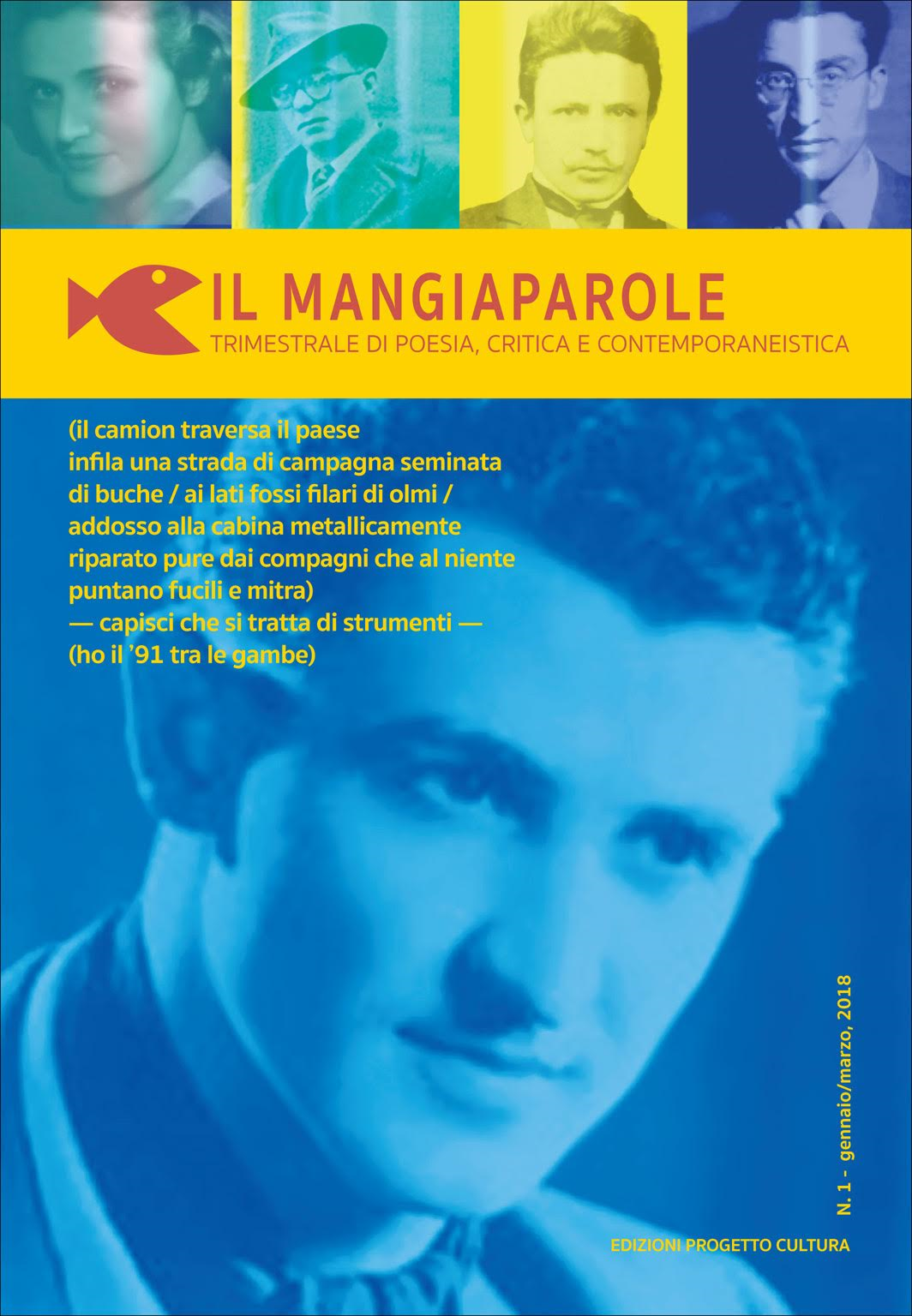

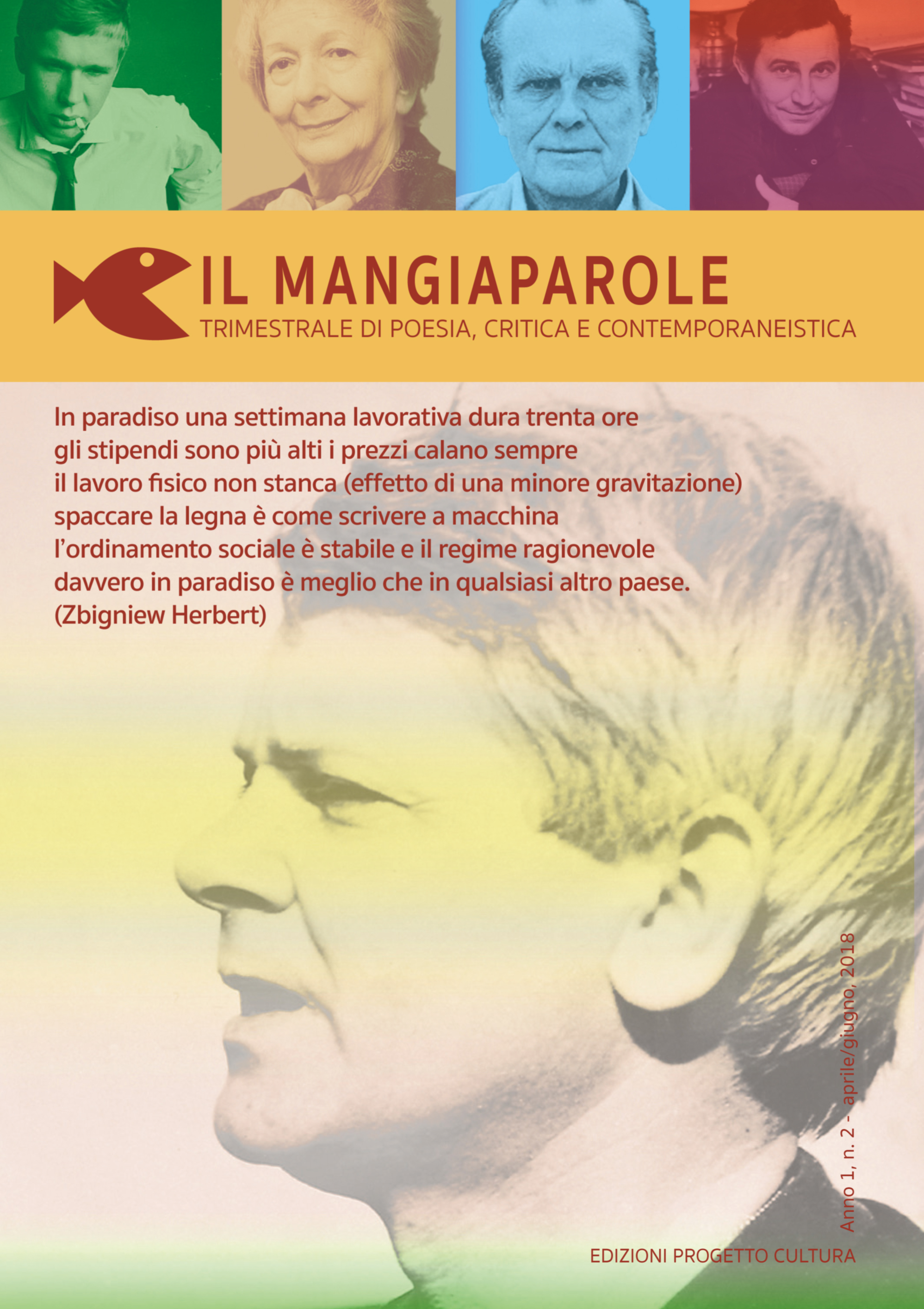



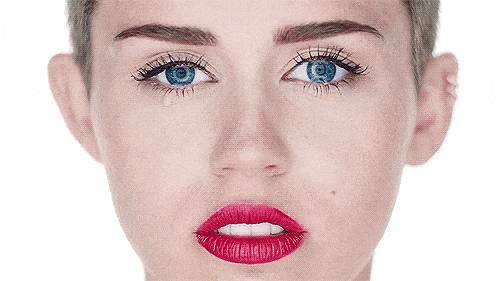
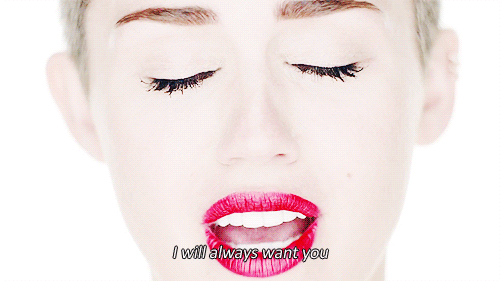
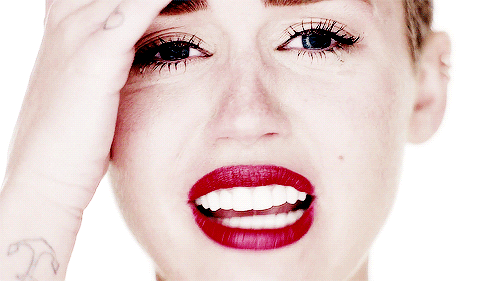
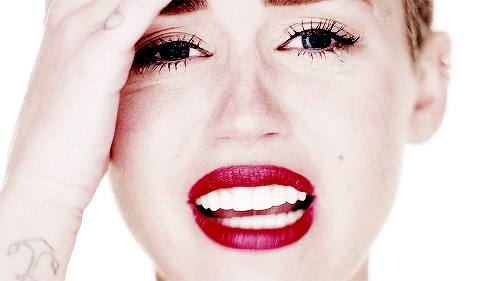
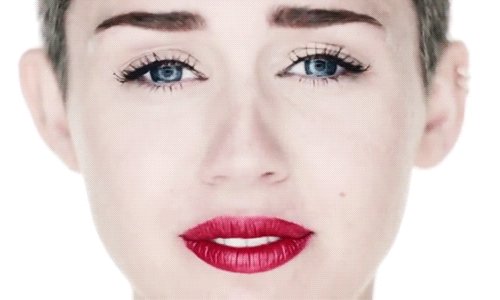



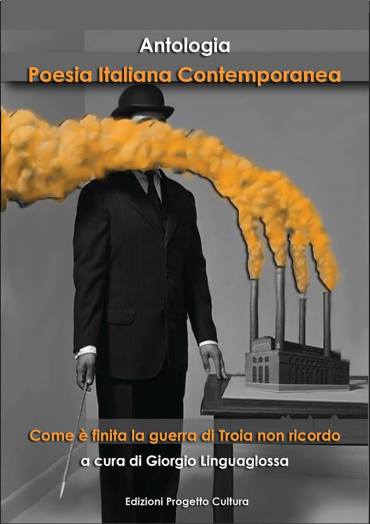




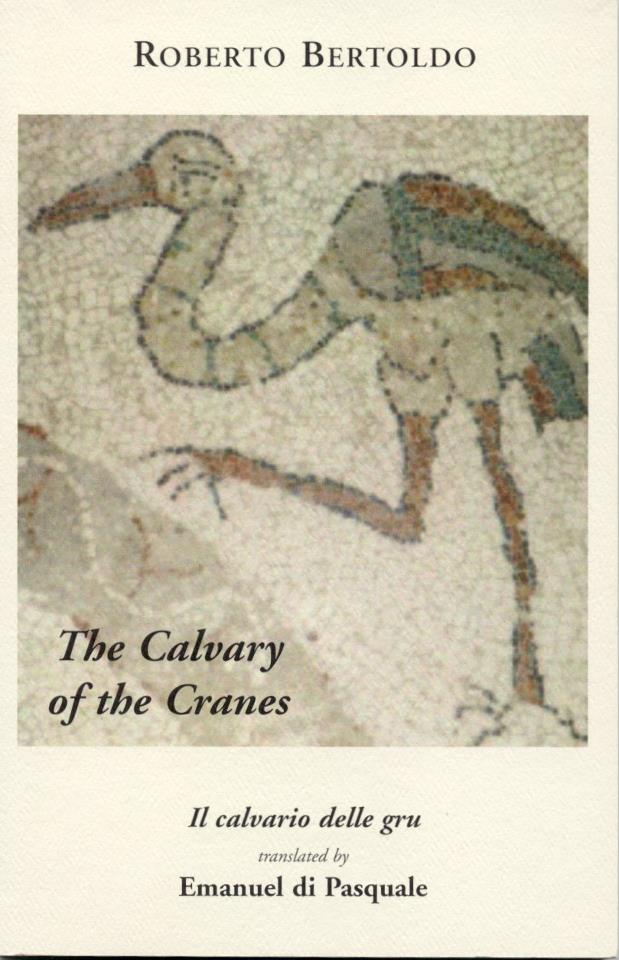
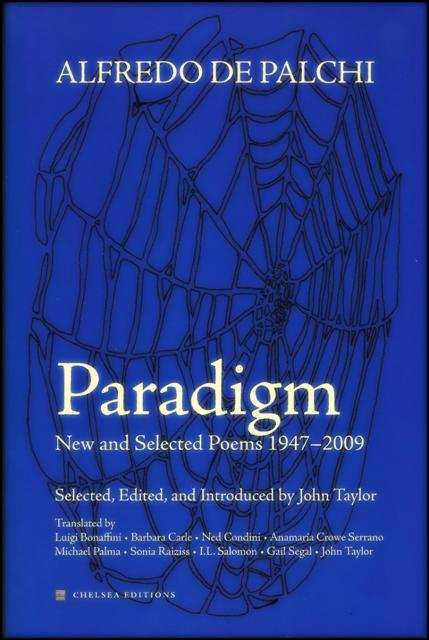


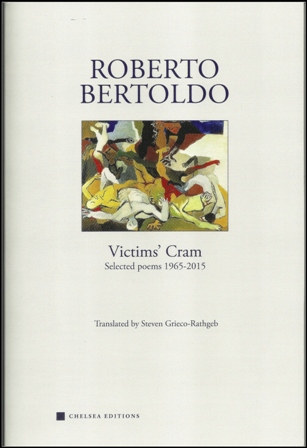





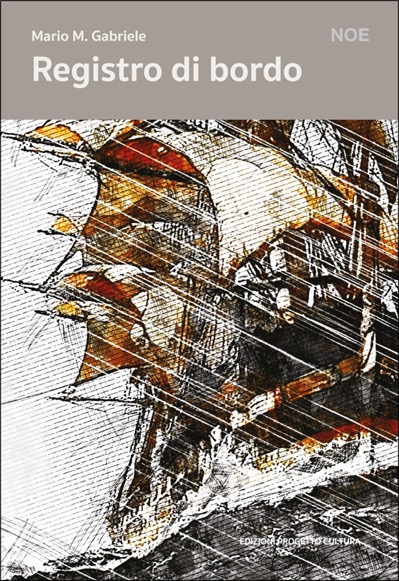

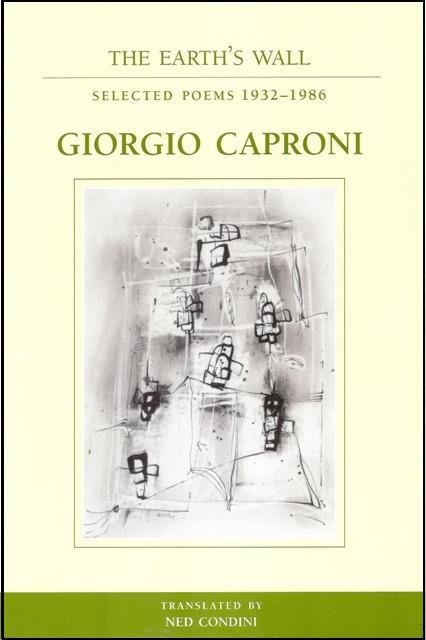
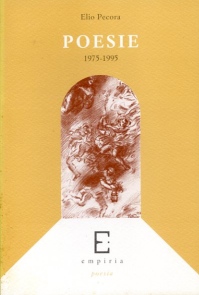

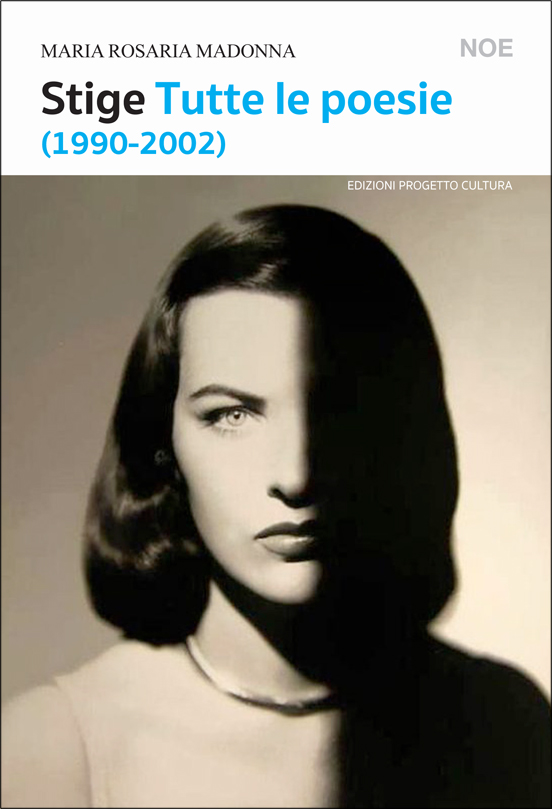

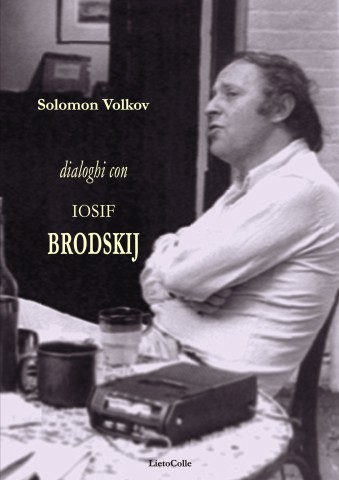




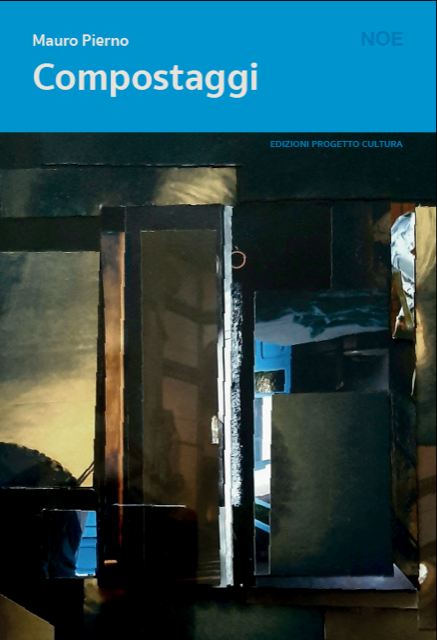
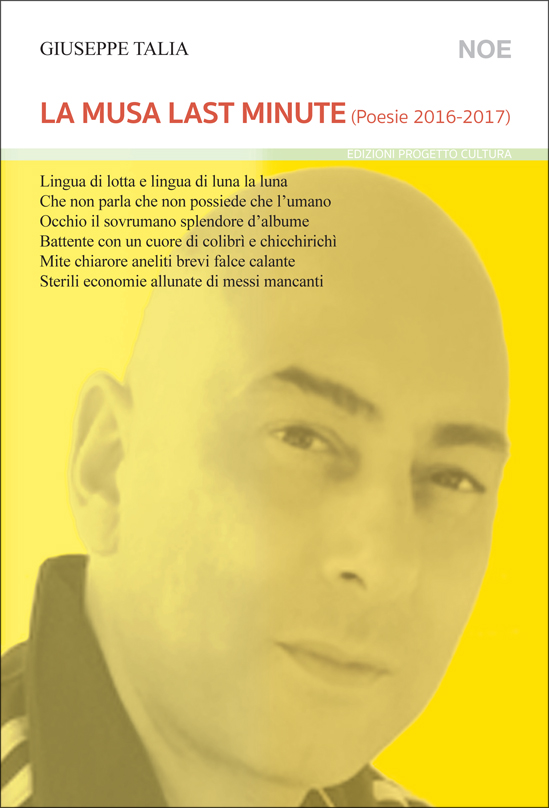


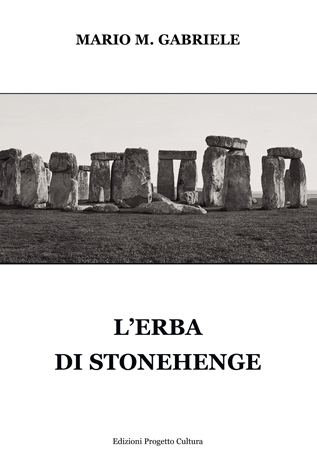
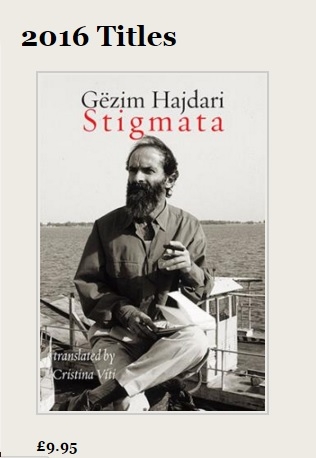
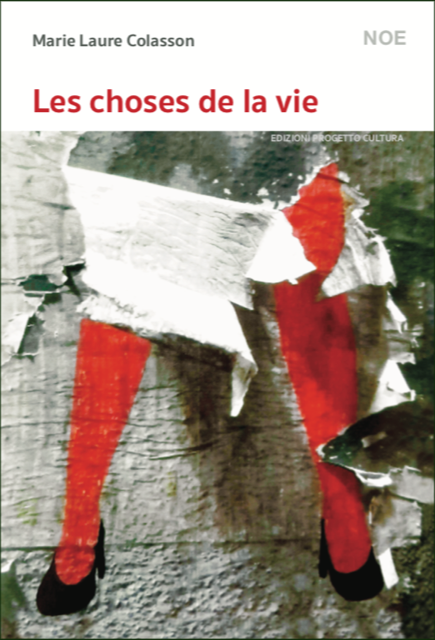




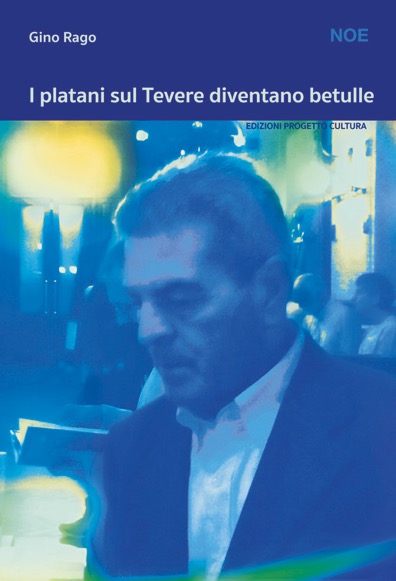
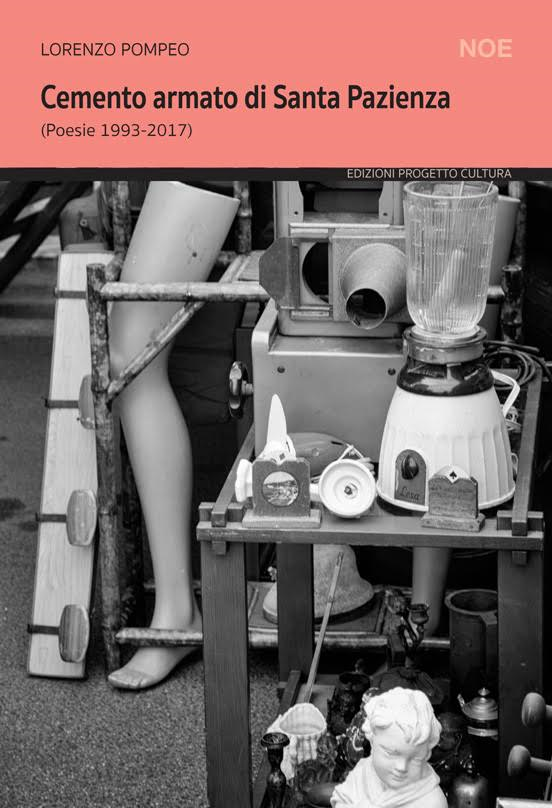
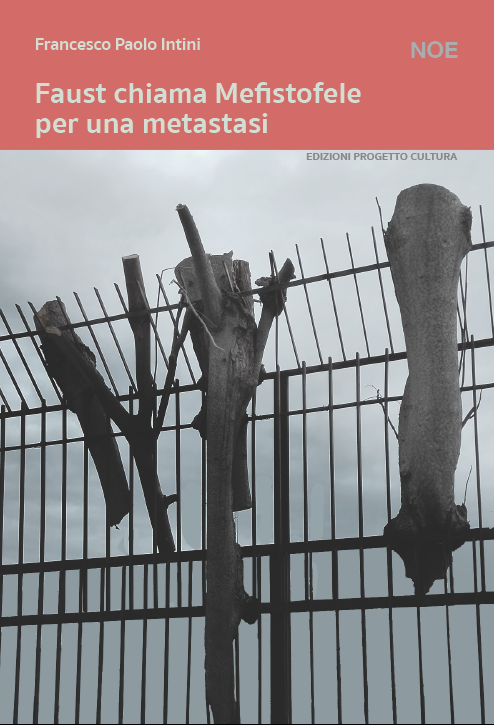

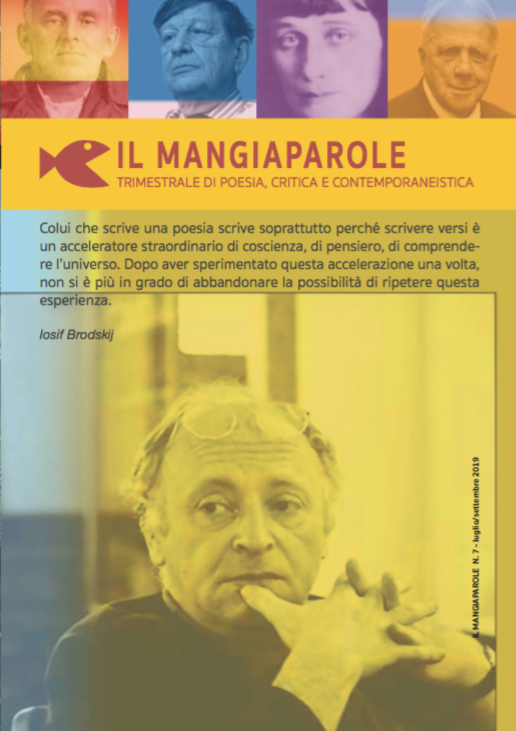




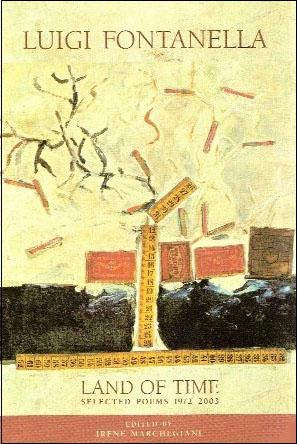








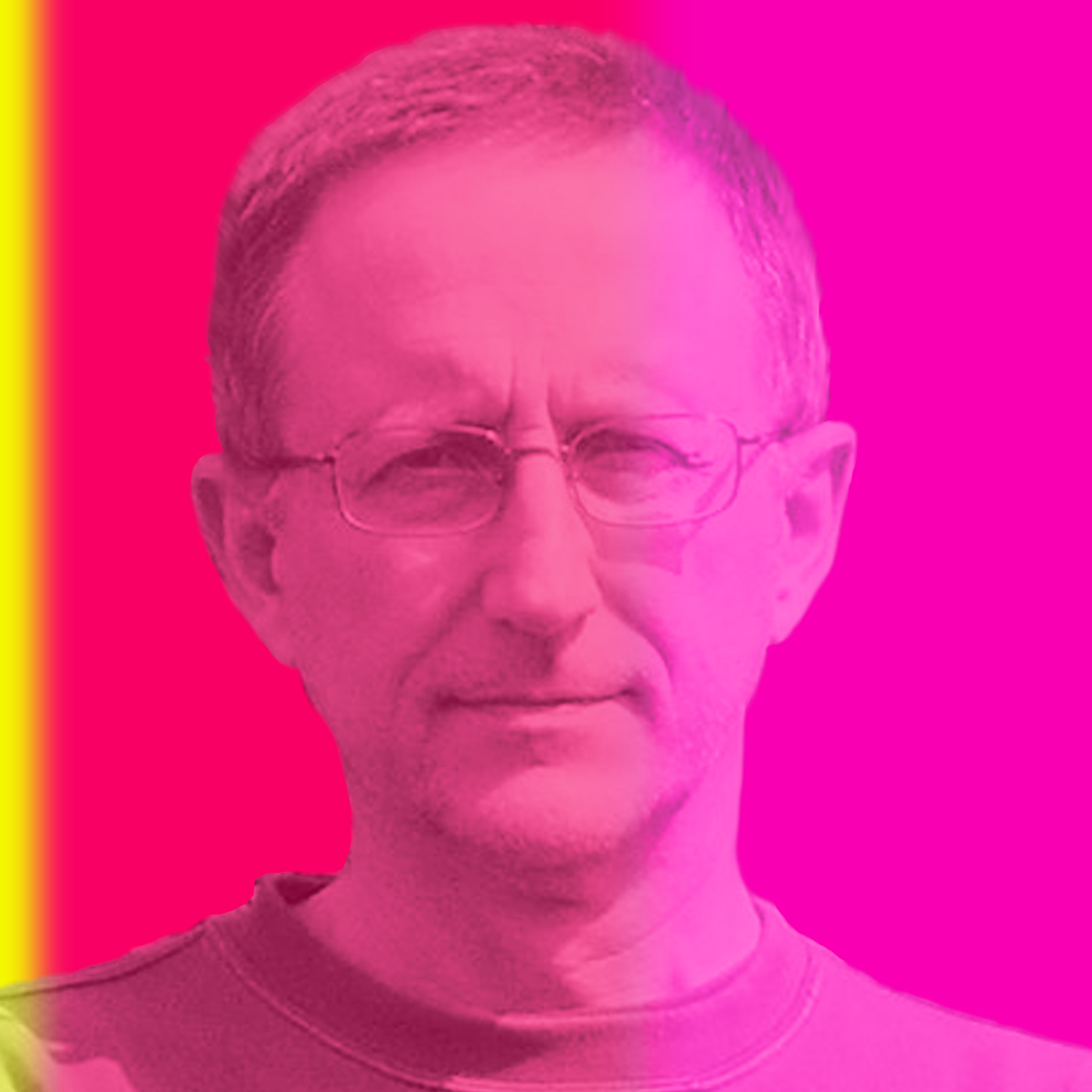







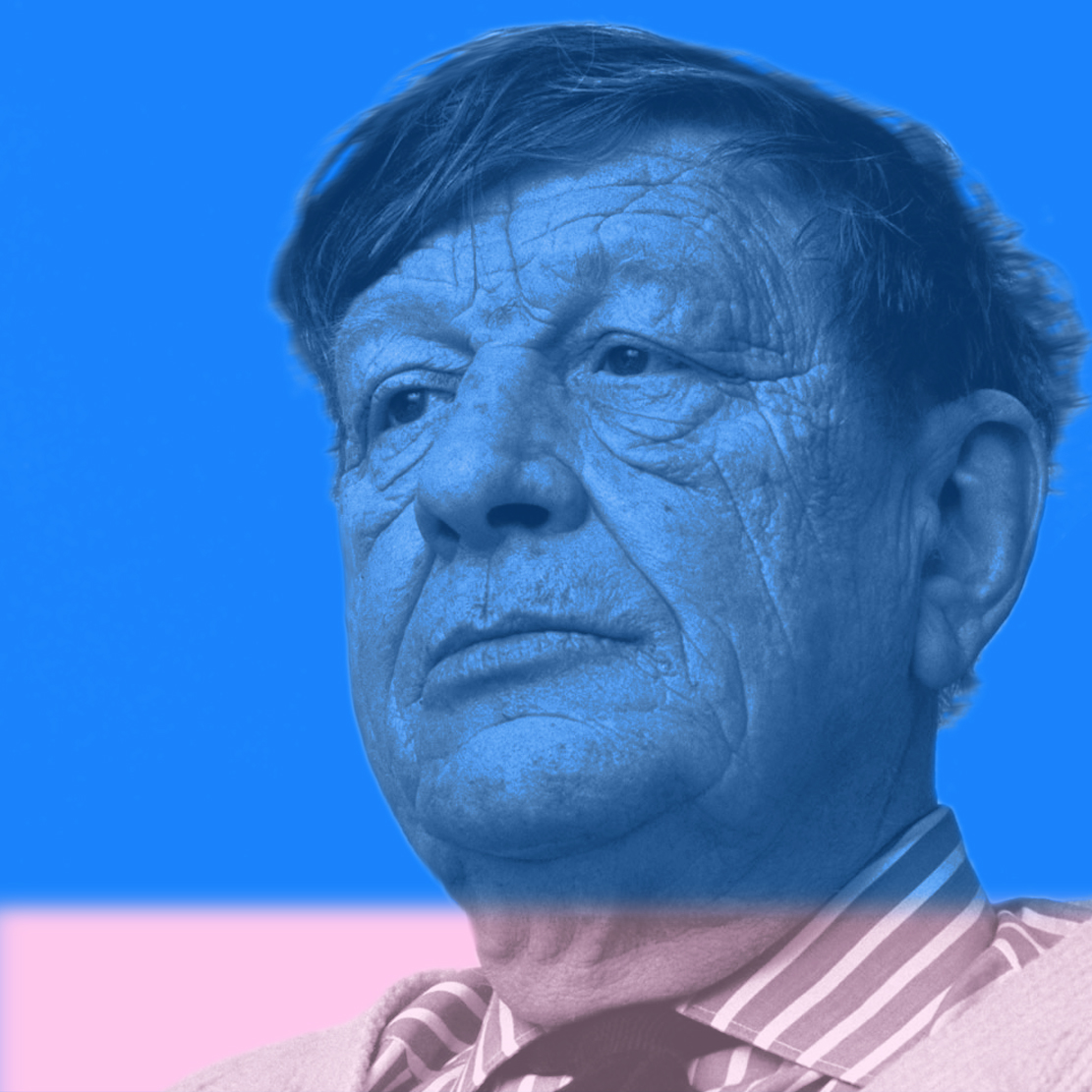



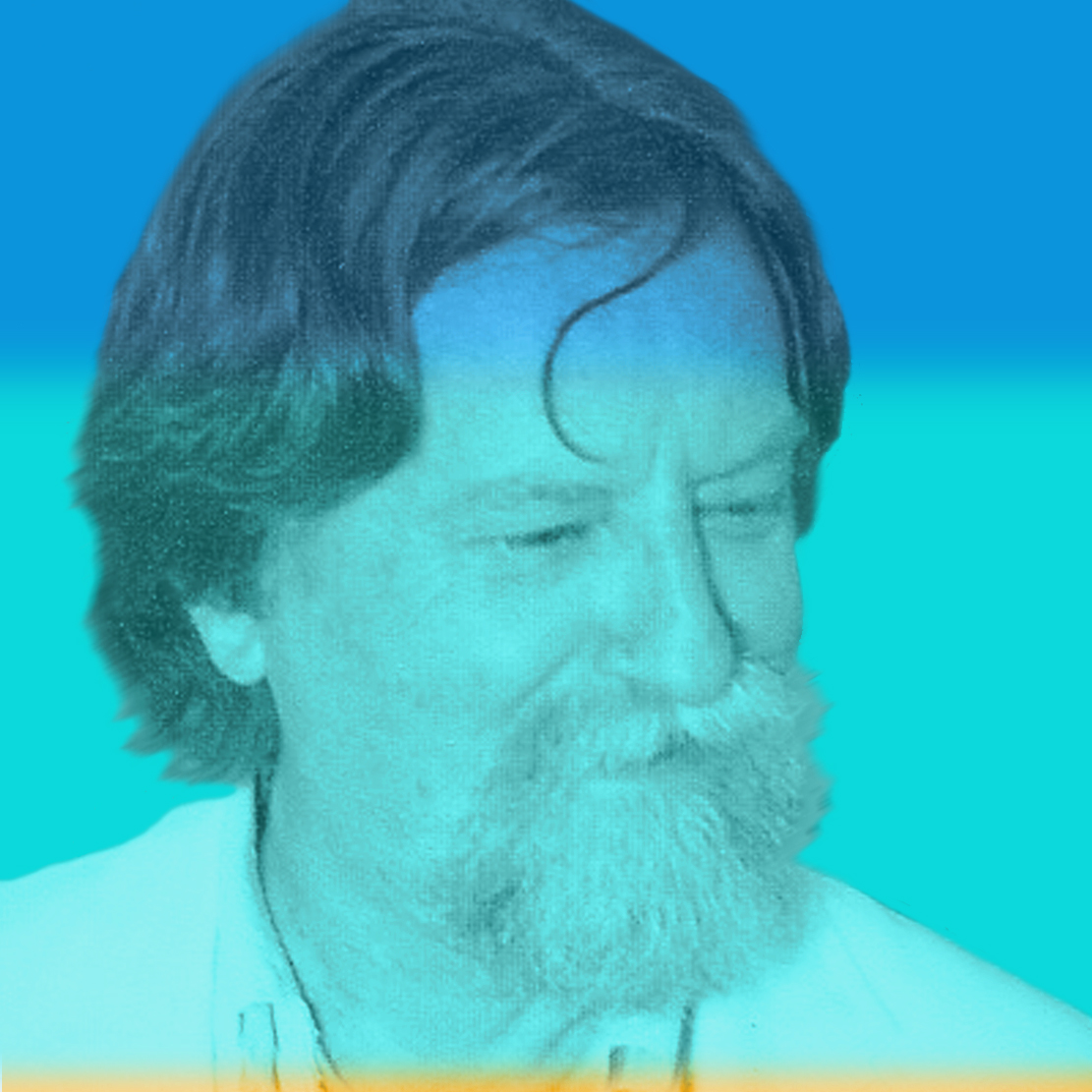
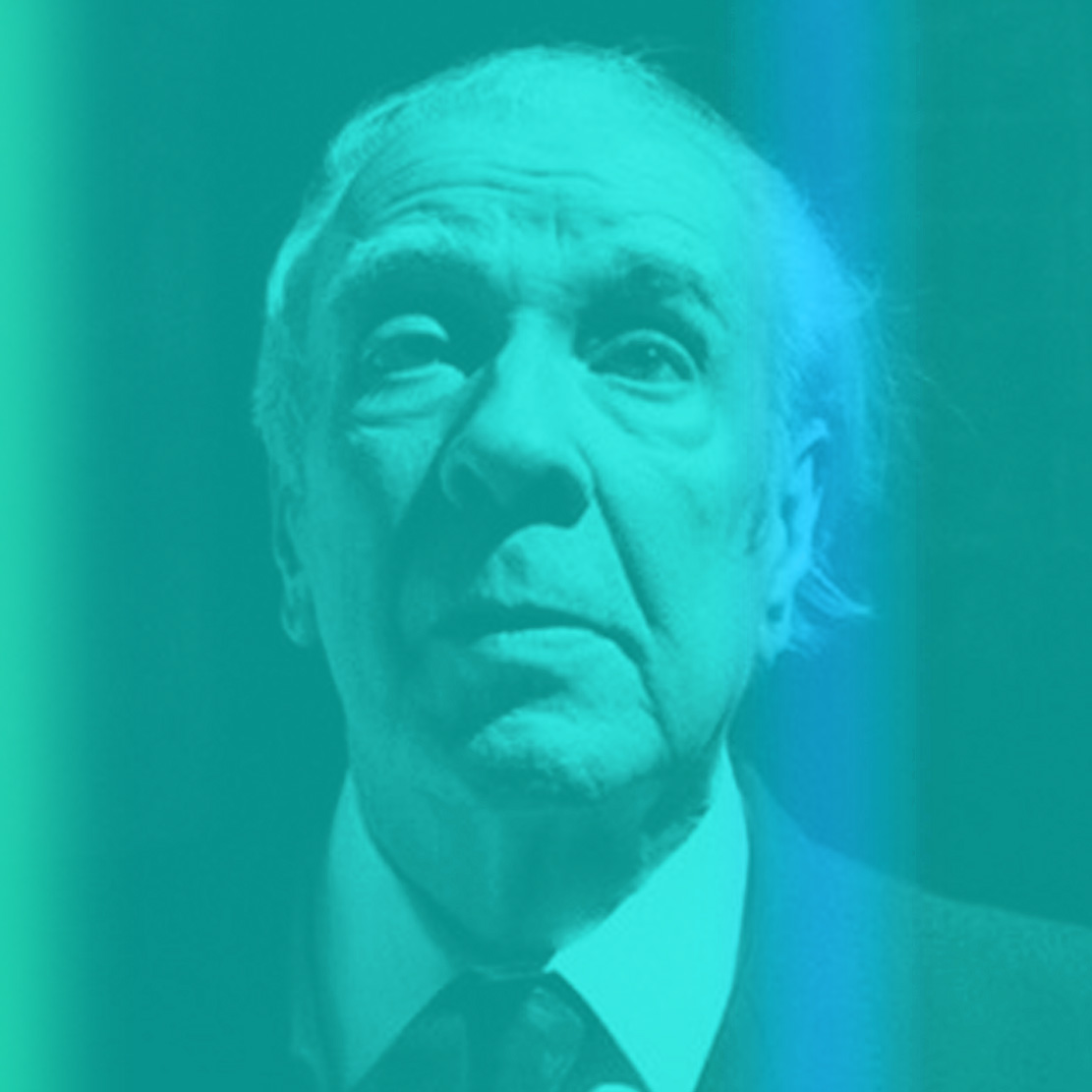




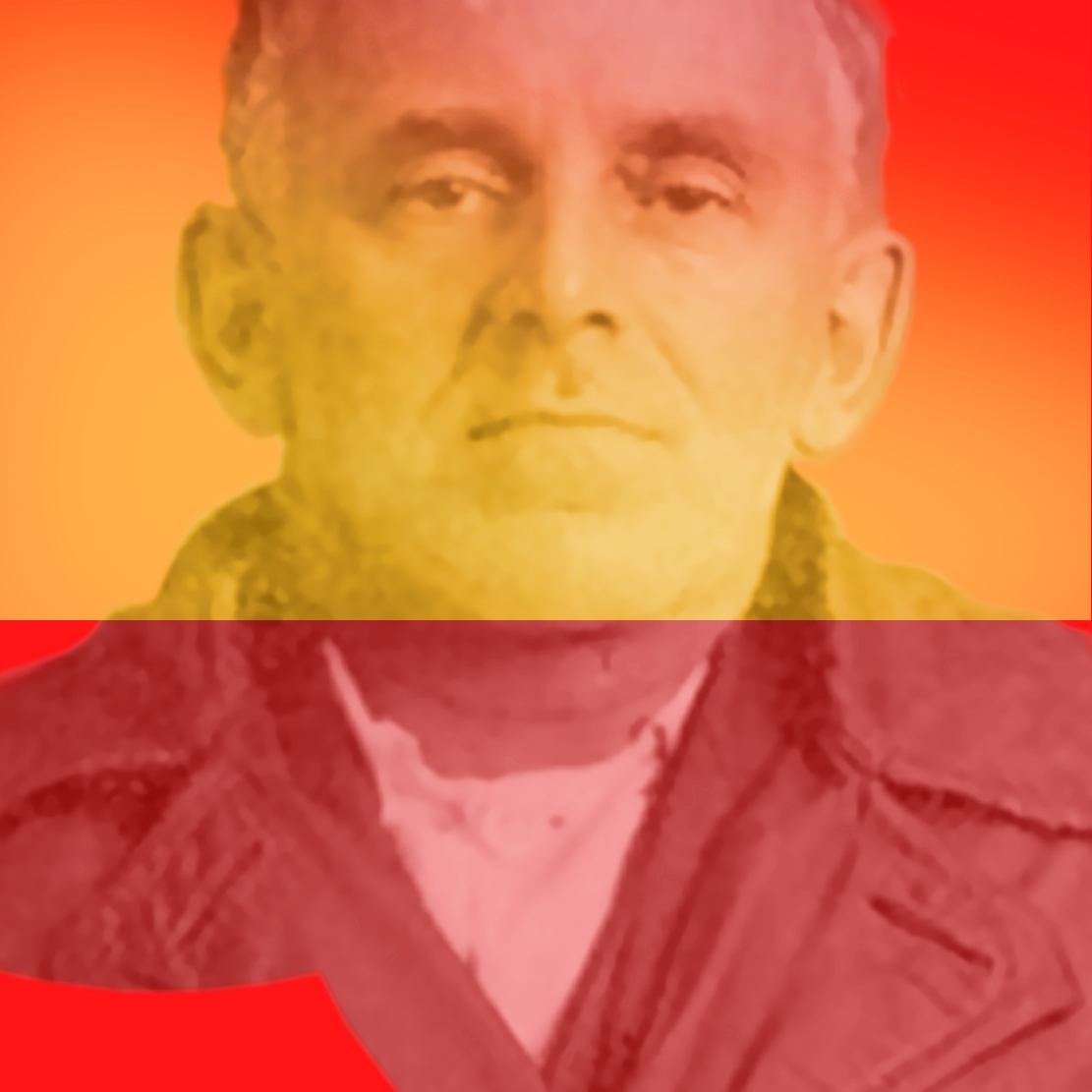






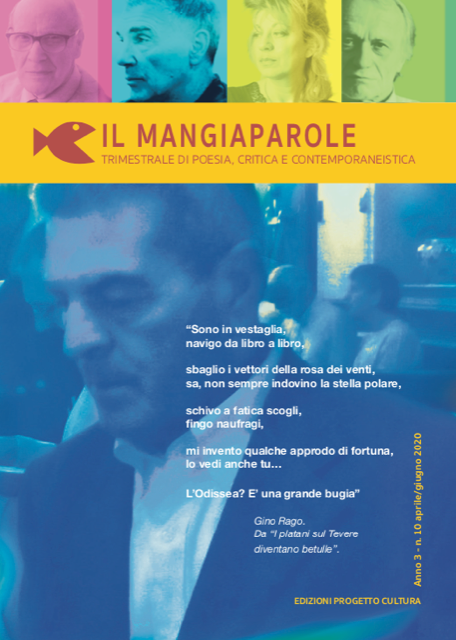




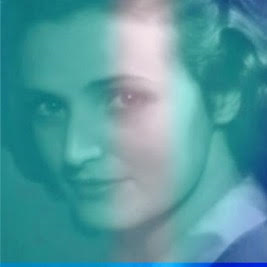
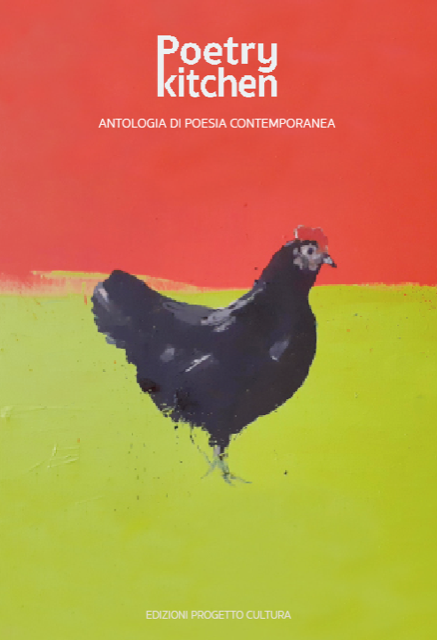



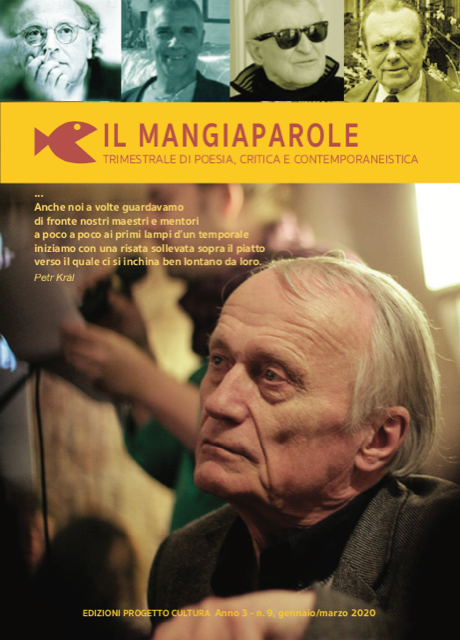











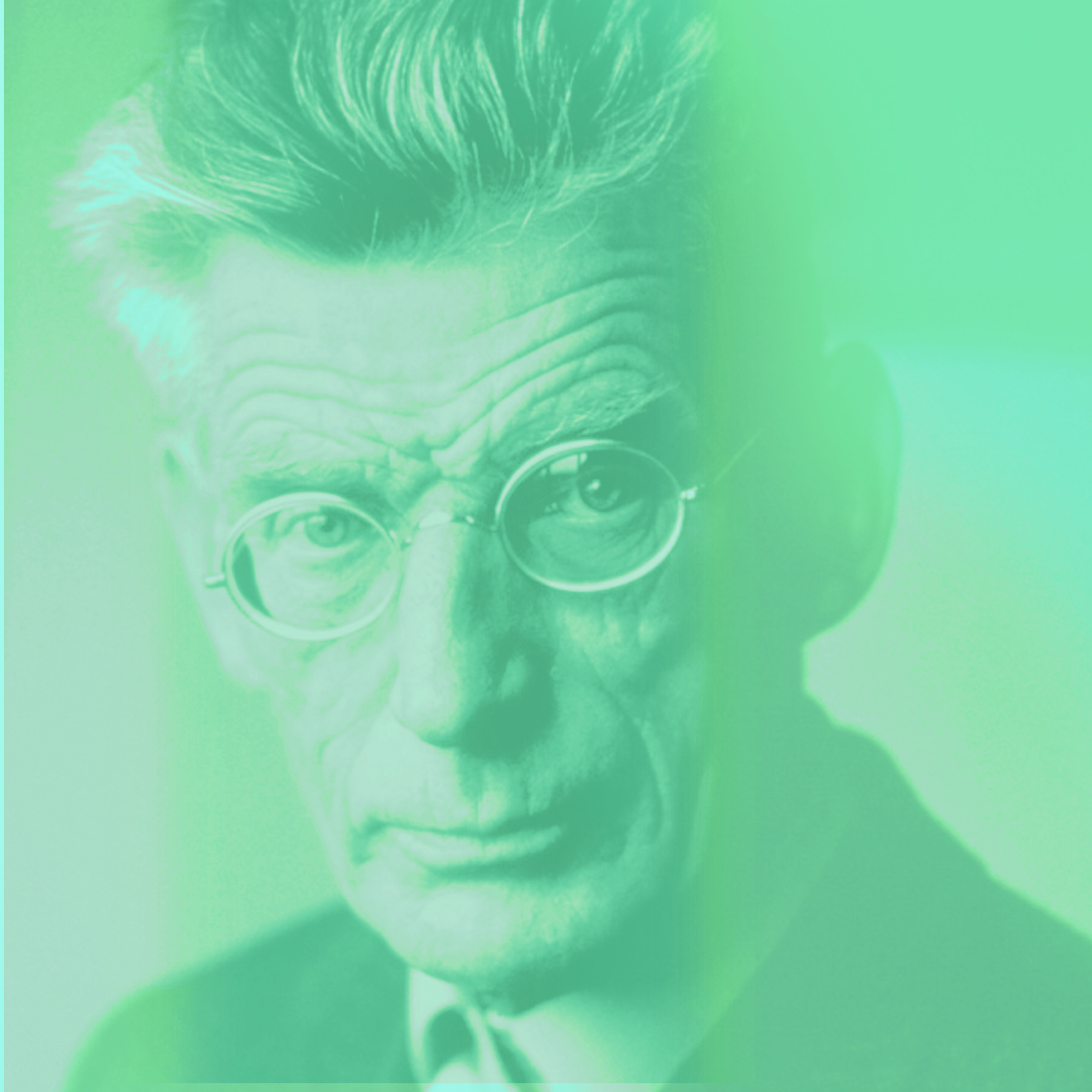
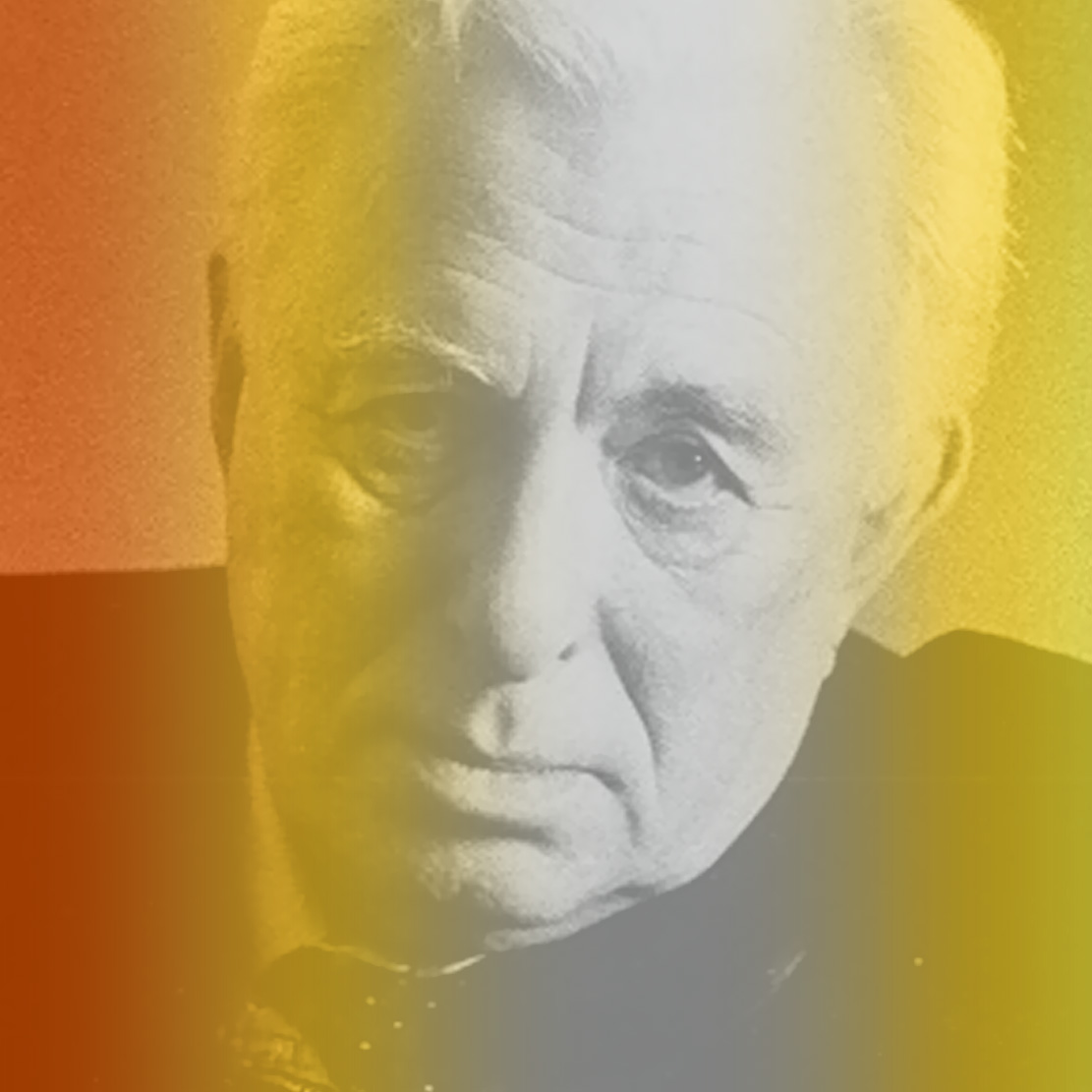









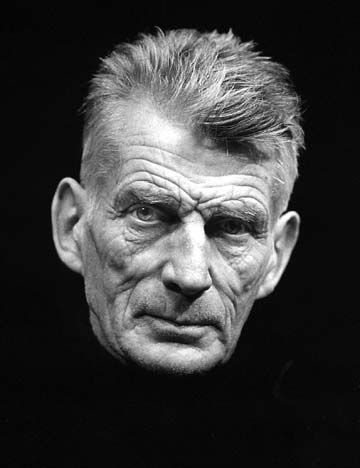


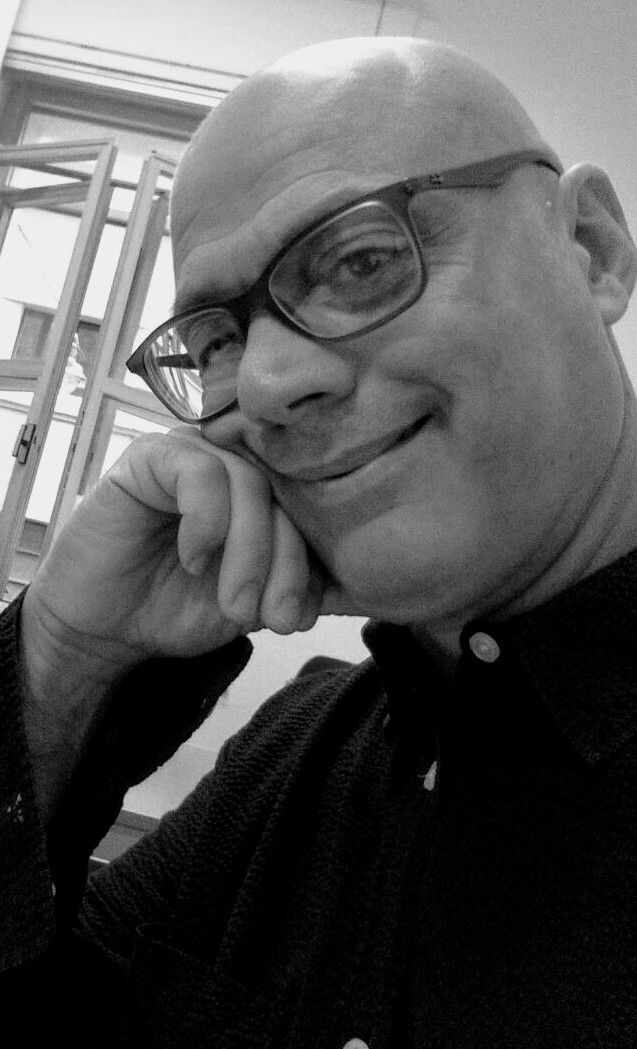
Ottima scrittura nei dintorni di intellettuale, Emilio Villa, a cui ho dedicato numerosi “fogli colorati” e complimenti all’Autore, Paolo Vanesio, che ne ha saputo ben cogliere lo spirito! Con stima
r. m.
ps: mi piacerebbe invitare l’Autore alla mia iniziativa “Ex Libris”.
"Mi piace""Mi piace"
Caro Giorgio, mi servo dell'”Ombra”per farti gli auguri, essendo ogni altro tuo accesso impraticabile.Auguri ,ma senza violini; preferisco l’arpa d’erba,più accessibile al mio immaginario,più vicina a quello che cerco di dirti..P.S.Avviso ai naviganti:scatolina dolce in viaggio,
mare tranquillo.Caramente, Anna
"Mi piace""Mi piace"
Ancora P.S.nche se lo sanno tutti, mi permetto di ricordare che il Latino ha una sola parola, RES,per indicare oggetti e cose.Un ritorno alla loro scarna “celeritas” potrebbe, forse, giovare a tutti
"Mi piace""Mi piace"
Come risponde a verità quello che dici carrissima Anna. Talvolta mi piacerebbe leggere anche una tua risposta ai miei interventi. Chiedo troppo?
"Mi piace""Mi piace"
Caro Salvatore, ti risponderò con grande piacere, alla prima occasione.Stiamo qui per parlare in amicizia, da tranquilli compagni di viaggio.Nessuno vuole asserire verità intangibili, tutti vogliamo soprattutto imparare.
"Mi piace""Mi piace"
Sei sempre terribilmente saggia carissima Anna, io soltanto da te mi aspettavo una risposta sulle mie oneste opinioni espresse sulla NOe.
"Mi piace""Mi piace"
“le cose esistono sì, ma fino a un certo punto”
(Emilio Villa)
"Mi piace""Mi piace"
cara Anna Ventura,
grazie del tuo pensiero…
Per quanto riguarda Emilio Villa, la mia impressione di questo poeta davvero singolare è quello di un poeta incompiuto che ha voluto fare una non-poesia (i motivi psicologici e ideologici di una tale presa di posizione non mi possono interessare in questa sede).
Ho letto i libri che un valente studioso come Tagliaferri dedica alla ricerca di Emilio Villa senza riuscire però a convincermi della utilità estetica, tattica e strategica dell’operazione villiana. Insomma, Emilio Villa ha fatto una poesia «inutilizzabile», e ci è riescito tanto bene che infatti tutta la sua operazione estetica è finita nell’estetismo e nell’esibizionismo snobistico, in una forma di elitarismo olistico.
E mi chiedo: è di qualche utilità oggi, dopo il Moderno e alla soglia di una guerra nucleare dalle conseguenze spaventose, in mezzo ai venti contrari che spirano da tutte le parti del globo verso il populismo e la demagogia, verso l’effetto serra con le conseguenze catastrofiche per il pianeta e per lo stesso genere umano, dicevo, e lo chiedo ai miei lettori, è ancora utile cincischiarci con una non-poesia? È di qualche utilità per gli sparutissimi lettori di poesia affidarci a questa non-poesia?
Credo che abbiamo il diritto e il dovere di prendere una posizione con estrema chiarezza. Qui credo non c’entra nulla il linguaggio baroccheggiante di Teofilo Folengo, lui sì che poteva giocare con le parole, i suoi tempi erano meno drammatici… ma noi?, ma noi, oggi?, ci possiamo ancora permettere di giocare e di scherzare con le «parole» e con le «cose»?
Paradossalmente, io credo che dobbiamo capovolgere di 180 gradi il nostro punto di vista e tornare a credere fermamente di voler tornare a fare una poesia «utilizzabile» (nel senso filosofico di Heidegger: «L’utilizzabilità è la determinazione ontologico-categoriale dell’ente così come esso è “in sé”».1]
1] M. Heidegger Essere e tempo op. cit. trad. it. p. 98
"Mi piace""Mi piace"
E’ un punto dolente, questo che sottolinei, Giorgio. Perché (nessuno vuol qui toglier nulla al genio di Villa), è anzi bene partir da spunti così alti, partire dalla cima e non soffermarsi nei bassifondi della poesia; bisogna partir dalla vetta per poter respirare aria pulita, e osservare “di nuovo” il reale, il mondo: l’abbiamo perso di vista, noi e i lettori di poesia, questo mondo.
Il risultato, che tutti conosciamo, è un atteggiamento autistico e autarchico della poesia.
Necessario è stato, nella seconda metà dl secolo scorso, muovere la lingua anche all’interno della sua immobilità – tentarne un movimento. Pochi l’hanno fatto, il resto è stato totale pantano.
Ora, è più che evidente che Villa ci ha regalato a piene mani il suo genio.
Ma davvero il punto su cui interrogarsi, come poeti, come lettori di poesia – anche partendo dal genio villiano – , è quale sia oggi il mondo intorno a noi? dentro di noi? c’è davvero impermeabilità, tanto che possiamo giocare con le parole, senza chieder loro altro che rispecchiamento in se stesse?
Non esiste una risposta pronta confezionata, per l’occasione; esistono però le ricerche di diversi poeti, che qui dialogano.
E questo è già molto più di un inizio.
"Mi piace""Mi piace"
Conobbi Emilio Villa alla fine degli anni sessanta presentatomi prima da Emanuele e Grassi e in seguito la nostra frequentazione continuò auspice il grande Corrado Cagli. Di entrambi i pittori Villa, straordinario conoscitore della materia, aveva scritto diffusamente.ll’uomo, nella sua totale originalità, che traspariva violenta dalla personalità stravagante e fascinosa, mi restò imresso per sempre nella rimembranza. I suoi scritti sull’arte erano singolari, coglievano al profondo l’anima e la tecnica e la trasmissione agli altri del messaggio che sulla tela, o in altre dimensioni, ii, l’artista lanciava ai fruitori della sua produzione artistica. Il linguaggio in apparenza non proprio chiaro , ad una lettura più attenta appariva lucido e tagliente, scavava ritmi insoliti, ignoti agli abituali critici d’arte, in una parola la sua singolarità si manifestava in pieno, come qualcosa che appartenesse soltanto a lui e all’opera d’arte che indagava. Quanto alla sua poesia non mi ha mai convinto appieno, con quella sorta di tentativo di strappare i veli e forse le ragnatele alla poesia tradizionale. Tutto partiva dal suo straordinario intelletto, dalla sua cultura prodigiosa, ma a mio avviso mai dalla profondità della sua anima. Per carità, una poesia a suo modo affascinante, con dettami stilistici sorvegliatissimi,nella stravaganza, non dei temi che apparivano sempre profondi, ma nella struttura, persino sintattica. Certo una goduria per gli amanti della poesia intellettualistica, non per me, che prediligo altra versione della poesia stessa. Certo le sue folgorazioni, il ritmo che comunque declinava ai suoi versi erano la spia di uno studio, legato all’indiscusso talento.
"Mi piace""Mi piace"
“La poesia di Villa è quello che è – non quello che non è”
( Paolo Valesio)
"Mi piace""Mi piace"
Caro Tosi di tutti si può affermare la stessa cosa
"Mi piace""Mi piace"
Dichiaro una mia ignoranza:non conosco la poesia di Villa.Mi pare interessante. Qualcuno può proporre qualche suo testo?Grazie
"Mi piace""Mi piace"
Ecco qua cara Anna, ci eravamo occupati qui di Emilio Villa:
"Mi piace""Mi piace"
Caro Martino,
ciò che scrivi di Villa corrisponde al vero E AL REALE, non al verosimile.
—
Lo sentii parlare personalmente più volte in incontri culturali e mi affascinò subito la sua debordante personalità e la qualità della sua cultura onnivora, profonda ed alta; insomma era talmente eccentrico in tutto che mi sentii per la prima volta davanti ad un uomo geniale – d’altra parte lo stesso Carmelo Bene di cui fu suo amico, nella sua Autobiografia confessa una propria soggezione, definendo il Villa, unico fra tante personalità che incontrò, un “genio”; ed è strano ancora oggi come non viene riconosciuto appieno, ma si comprende invece, perché il ciarpame intellettuale che ci circonda domina incontrastato e non ama confrontarsi, e non solo con Villa ma con tante altre personalità serie che si tengono alla larga dal letame! e dallo stazzo!
Nei miei versi più volte ho reso omaggio a Villa con sue citazioni che son divenute mie, e con allusioni non velate.
Dunque, ben venga sul blog dell’Ombra un tale fuoriclasse, e vorrei che fosse più spesso frequente poiché i campi culturali da lui arati con magistrale perizia sono tali che si avranno dei frutti prodigiosi; alcuni io già li ho visti e gustati!
NON FINIRO’ MAI DI STUPIRMI DAVANTI ALLA SUA MENTE.
"Mi piace""Mi piace"
Mi riempe di quasi felicità di trovare un compagno di viaggio in questa conoscenza di un protagonista assoluto e purtroppo quasi sconosciuto della temperie culturale che si è svolta in Italia nella seconda metà del secolo scorso. Ma troppi sono i dimenticati anche da questa Rivista. ne voglio citare alcuni: Gatto, Cattafi, Sinisgalli, Betocchi,jacobbi, Occhipinti, per citare solo quelli che salgono in questo momento alla mia fallibile memoria,in parte persino Luzi e Sereni,. Anche io, come afferma Linguaglossa, appartengo alla schiera dei trascurati, ma essendo ancora in vita e stupendamente produttivo ho qualche speranza di essere riesumato:
"Mi piace""Mi piace"
“(…) Beh, posso dire che che la mia attività di critico mi ha dato più dispiaceri che gioie. L’amo; ma non posso fare a meno di pensare che il mestiere di
critico nei confronti dei poeti, quando si conoscono di persona, diventa un
supplizio. O la persona è migliore della poesia, o la poesia migliore della
persona: in entrambi i casi uno squilibrio… (…) L’unico poeta vivente che mi
abbia lasciato ampio margine alla fantasia, il solo che riesco appena a seguire nella sua ‘distruzione’ della lingua, è però colui che accuratamente si cela agli occhi di tutti. Parlo di Emilio Villa, il fenomeno poetico che i nostri posteri studieranno dopo l’anno….”. Così Giacinto Spagnoletti in
“I nostri contemporanei”, raccolta di saggi del 1997
Paolo Valesio ci consegna una testimonianza su E.V. di primo ordine, con
una solida cognizione letteraria che gli consente una ri-cognizione di
percorsi ed esperienze del Novecento poetico italiano, che va a integrarsi
con le tante pagine ( una di queste appunto a suo tempo da Giorgio Linguaglossa tutta riservata alla poesia di Emilio Villa) in cui L’Ombra delle Parole sta indagando lo stato di salute della nostra poesia di articolo in articolo, da pagina ad altra pagina,
soprattutto nel confronto del nostro panorama poetico con quello internazionale, da quello polacco a quello scandinavo a quello boemo ecc.
Ma non si può fare a meno di ricordare, accanto a Emilio Villa, almeno
i nomi di Edoardo Cacciatore, di Armando Patti, di Juan Rodolfo Wilcock e di Angelo Maria Ripellino come esempi di poeti che in vita non hanno ricevuto
ciò che la loro poesia meritava…
Anche per timore che queste ingiustizie possano ripetersi tragicamente,
chi tenta d’interpretare certe esperienze poetiche allorché sente di ricevere
un dono di poesia deve necessariamente rimarcalo, diffonderlo, quasi imporlo. Come è “In viaggio con Godot” di Mario gabriele. Libro-poema da inserire nel meglio della poesia pubblicata negli ultimi 15/20 anni in Italia.
Ed i meriti sono etici ed estetici, stilistici e linguistici, ecc. con una abilità del poeta di nominare con esattezza e leggerezza luoghi, situazioni. occasioni,
personaggi, giornali, riviste, libri, esperienze musicali, opere d’arte visive, in uno stile che definirei ‘adamistico’, pensando all’inevitabile collegamento con la corrente più significativa dell’acmeismo mandelstamiano:l’ “adamismo “.
Ma nei 69 pezzi de ‘In viaggio con Godot’ ho sentito vibrare un’adesione
gentile, consapevole, cordialissima alle dinamiche contorte del mondo e della vita che l’autore (Mario Gabriele) interpreta e segnala giocando sulla asimmetria spaziotemporale, all’insegna della indeterminazione del vivere
e altro…L’esito estetico finale è una poesia, rubando le parole a Giorgio Linguaglossa, autore del saggio introduttivo, “atetica, non-apofantica, pluritonica, varioritmica”
Il resto di tanta poesia apparsa anche su L’Ombra delle Parole tutto sommato può essere scritta, e senza grandi sforzi, ma senza intenzioni offensive verso nessuno, anche da pasticcieri, da gelatai, da pensionati,
da elettrauti, da idraulici, da impiegati della agenzia delle entrate, da uscieri e impiegati comunali, da insegnanti e medici, da Ufficiali dell’Esercito in congedo illimitato, da politi trombati o ancora attivi e da altri e altri ancora per quelle parole disabitate e morte che circolano in quelli che in tanti si ostinano a chiamare ” versi…” Credetemi, l’autore di “In viaggio con Godot”
ha letto Our Afterlife, i Canti di Pound, Al di là del bene e del male, Genet,
Il partigiano Johnny, Le Illuminazioni, innamorato com’è de Le Demoiselles
d’Avignon e dei versi di Spring and All di W.C.W.
(Ci saranno imperfezioni in questo mio commento.Me ne scuso. L’ho scritto
estemporaneamente. Mi molestava da giorni agitandosi dentro di me e dovevo liberarmene).
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
Caro Gino, svegliandomi di buon’ora questa mattina, trovo il tuo commento su Godot e ti ringrazio. Leggere un libro di poesia è fatica, figuriamoci poi quando uno come te ci si immerge con tutta la passione del critico, allora mi piace immaginarti come un cacciatore che entra nella giungla (la poesia) e ne esce con la preda tra le mani, (il disvelamento del verso e dell’opera). E’ come prendere la mano al lettore avvicinandolo al senso delle cose. Credo che la figura del critico abbia ancora un ruolo importante, e lo si vede in Linguaglossa che dà il meglio di sé ad ogni presentazione di autore.In Godot ho voluto inserire volontariamente tutto il percorso critico di Giorgio sulla mia poesia, pregandolo di accettarlo, anche perchè non vi sarà più occasione in futuro, di parlarne ancora. I tempi si restringono. Questa scelta ha incontrato in qualche lettore,una posizione distaccata, dando un giudizio troppo avversativo sull’estetica del libro, non andando al cuore della poesia, che necessitava invece di un suo parere. Chiedo scusa ai lettori per questo eccesso nella Introduzione, in quanto lo porta su diversi piani estetici. Ancora una volta, colgo l’occasione, caro Gino, per formularti i migliori auguri nella poesia e nella critica, e per l’attenzione che hai voluto dare sfogliando le pagine del mio volume.
"Mi piace""Mi piace"
Leggo solo adesso il commento di Rago che in qualche modo mi da ragione circa i trascurati. concordo con i nomi da lui fatti.
"Mi piace""Mi piace"
And before the original sin? Lilith
Second Part
(Lilith narrates Lilith)
This way I tell of myself
Thinking of the poets of the NOE
I come back from exile. I return to the free fall.
This way I tell of myself.
My tongue is a beehive, I am the bride for seven nights.
No lover knows that if he runs from me
Running toward me he comes to me.
The one who hears me moves toward death.
So many do not want to listen to me
They dig their graves. The one who doesn’t hear me
Deserves death by remorse.
I am hand of the servant. Window of the virgin.
I am the first woman of Adam.
I know everything about the boredom of heaven and of the first man.
I know the throne of Balquis and the gift of Solomon.
I am the esmerald with no thread landed in the dust.
I am the center of the damnatio memoriae
Because I hold the secret of the tides.
And of the moon when she shines on my vertical lips.
© 2017 English translation by Adeodato Piazza Nicolai of the poem beginning “E prima del peccato originale?” by Gino Rago. All Rights Reserved.
Caro Gino, non potevo non provare a tradurre la tua incantevole “Seconda Parte (Lilith racconta Lilith)”. Prego soltanto che si avvicini per bellezza e profondità all’originale. Grazie e un caldo abbraccio dal freddo Cadore.
adeodato
(Ho da pochi minuti ricevuto sulla mia e-mail questo “dono” da Adeodato Piazza Nicolai. Lo ringrazio con gratitudine per le energie che sta dedicando
ai miei versi. Mi piace condividerlo con i raffinati e severi frequentatori de L’Ombra delle Parole).
G.R.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Paolo Valesio, per l’analisi approfondita e accurata dell’uomo-essere Emilio Villa!
Personalmente lo vedo come un precursore dell’era internet, molto utile è inutile allo stesso tempo. Volendo “leggere” il caos razionale internet e prentendere di spiegarlo, anche agli “addetti”, risulta essere estremamente difficoltoso se non impossibile. È come voler spiegare in modo “forzatamente” razionale il funzionamento caotico del proprio cervello e di quello degli altri esseri. Resta il fatto che il modo enigmatico di porsi di Emilio Villa affascina, così come e in maniera diversa, i film di Fellini.
Due anni fa, leggendo il capitolo “L’ircocervo Emilio Villa” dal volumetto “Le due scarpe sinistre dei poeti” di Donato Di Stasi, m’è venuto in mente di confezionare un riassuntino audio-video HD, alquanto parziale, del mia visione villiana.
Chi lo desidera e ha 10 minuti di tempo, anche per sorridere un po’, è “autorizzato” a guardare “Non significa” su YouTube.
L’audio-video ha richiesto un paio di mesi di lavoro artigianale.
Gianni Godi
"Mi piace""Mi piace"