

Laboratorio di poesia, 30 marzo 2017 Libreria L’Altracittà, Roma
Nel sogno l’io è ovunque
Freud
il soggetto è rappresentato da un significante per un altro significante
Lacan
Clemente Rebora (1885-1957)
La poesia è un miele che il poeta,
in casta cera e cella di rinuncia,
per sé si fa e pei fratelli in via;
e senza tregua l’armonia annuncia
mentre discorde sputa amaro il mondo.
Da quanto andar in cerca d’ogni parte,
in quanti fiori sosta, e va profondo
come l’ape il poeta!
L’ultime cose accoglie perché sian prime;
nettare, dolorando, dolce esprime,
che al ciel sia vita mentre è quaggiù sol arte.
Così porta bontà verso le cime,
onde in bellezza ognun scorga la mèta
che il Signor serba a chi fallendo asseta
(da Canti dell’infermità in Le poesie (1913-1957)
Questi versi di Clemente Rebora se da un lato non dimenticano la quasi classica istanza didascalica della poesia, aperti come sono alla tematica di quella “fratellanza” volta a trovare l’uomo solidale con Dio, dall’altro sono versi esemplari del ”frammentismo vociano”, troppo spesso e troppo superficialmente confuso con la N.O.E (nuova ontologia estetica) per frammenti.
La metafora reboriana miele-poesia-poeta-ape si sa che è di antiche origini. Ma nell’ars poetica di Rebora funziona come preparatoria alla parola-chiave della composizione: «dolorando». Ed è la dolorosa saggezza da consegnare agli uomini e al mondo, forse il messaggio più alto di Rebora…
(Il rispetto e l’ammirazione verso questo frammentista vociano sono fuori discussione. Ma oggi, a distanza di quasi 100 anni, un secolo, da questi versi, è inevitabile che la poesia esplori nuovi sentieri estetici, che viaggi verso altri approdi “formali”, sentieri e approdi che son chiamati a misurarsi con la idea lanciata da Giorgio Linguaglossa, che io trovo geniale, (perché finora da nessuno studioso di poesia era stata non dico pensata ma neanche sfiorata) tutta nuova di “Spazio espressivo integrale” con tutte le moderne percezioni di “tempo”, di “nome”, di “immagine”, di “proposizione” con cui il poeta contemporaneo deve fare i conti se vuole sottrarsi al ruolo misero, infecondo del “seguace”, del giacente supino nella stagnazione. Anche in poesia o si è candela accesa o specchio, nella stanza al buio del mondo…
Ogni giudizio critico sull’altrui poesia deve sempre partire dall’analisi dei versi e da qui articolarsi, senza condanne generiche, senza stroncature immotivate né lodi fuori posto).
Ars poetica? Un contributo alla rilettura del’900 lirico italiano
Per un Clemente Rebora che si cimenta con “La poesia è un miele…”, indaghiamo ora un Aldo Palazzeschi, pseudonimo di Aldo Giurlani, (1885–1974), impegnato sullo stesso tema dell’ars poetica:

Gino Rago, Rita Mellace e Giorgio Linguaglossa, Laboratorio di poesia 30 marzo 2017 Libreria L’Altracittà Roma
Aldo Palazzeschi (1885-1974)
Lo Scrittore
(da Via delle cento stelle, Mondadori, Milano)
Scrivere scrivere scrivere…
Perché scrive lo scrittore?
C’è modo di saperlo?
Si sa?
Per seguire una carriera come un’altra
o per l’amore di qualche cosa?
Chi lo sa.
Amore della parola
per vederla risplendere
sempre più bella, lucida, maliosa,
né mai si stanca di lucidarla.
Per questa cosa sola
senza neppure un’ombra
della vanità?
Scrive con la speranza
di trovare una mano sconosciuta
da poter stringere nell’oscurità
In questa lirica la «febbre» espressiva del poeta si fa quasi ansia di comunicazione, se non aspirazione ansiosa alla fratellanza, di un uomo, coincidente con l’Io-poetico, che manifesta il terrore della solitudine, di un uomo-poeta che non vuole perché non può sentirsi solo. Desidera febbrilmente l’accensione di un palpito di solidarietà con i fratelli (possiamo dire «i suoi lettori») smarriti, sperduti nell’oscurità del vivere in un mondo anch’esso senza luce.
Talune istanze didascaliche, più forti in Rebora, perdurano anche in questi versi . Ma in Palazzeschi vibra continuamente la domanda sul significato del proprio lavoro letterario, rincorrendo quasi la sentenza gelida, e saggia, nello stesso tempo, di colui che contempla gli uomini e le cose del mondo dall’alto di una specola , ovvero di un osservatorio speciale: quello del poeta consapevole.
Ma in questi versi non è difficile cogliere anche la requisitoria mordace contro inclinazioni classicistiche, contro istanze estetizzanti proprio nel ritmo prosastico e nel tono diciamo “iconoclasta”dei suoi versi e che anche per questo entra di diritto nel substrato della sensibilità contemporanea.
Un’ altra cifra, comune ai due “frammentisti vociani”, va individuata nell’adesione di Rebora e di Palazzeschi all’arcinota affermazione di Gertrude Stein: «Scriviamo per noi stessi e per gli sconosciuti». Affermazione che con Harold Bloom possiamo ampliare in un apoftegma direi “parallelo”:«Leggiamo per noi stessi e per gli sconosciuti», nell’atto della critica e nell’ardente speranza di imbatterci nel potere estetico di un’opera o più semplicemente in quella che Baudelaire definì «dignità estetica» di un’opera poetica.
Saltiamo a piè pari , da Palazzeschi e Rebora, frammentisti vociani della prima stagione prezzoliniana, le esperienze rondiste, ermetiche, post-ermetiche ed anche l’esperienza della vocazione realistica in cui si chiese al poeta e alla sua parola lo sguardo della comprensione, e della pietà, a catturare l’eco di miserie di guerra in un mondo sconvolto, attraverso il suo stesso assioma rivelatore : «Non la poesia è in crisi, ma la crisi è in poesia», consideriamo il sentimento di “ars poetica“ in Pier Paolo Pasolini:

Sabino Caronia, Laboratorio di poesia 30 marzo 2017 Libreria L’Altracittà Roma
Pier Paolo Pasolini
La mancanza di richiesta di poesia
( Da Poesia in forma di rosa, 1964)
Come uno schiavo malato, o una bestia,
vagavo per un mondo che mi era assegnato in sorte,
con la lentezza che hanno i mostri
del fango – o della polvere – o della selva…
C’erano intorno argini, o massicciate,
o forse stazioni abbandonate in fondo a città di morti
con le strade e i sottopassaggi
della notte alta, quando si sentono soltanto
treni spaventosamente lontani,
e sciacquii di scoli, nel gelo definitivo,
nell’ombra che non ha domani.
Così, mentre mi erigevo come un verme,
molle, ripugnante nella sua ingenuità,
qualcosa passò nella mia anima – come
se in un giorno sereno si rabbuiasse il sole;
sopra il dolore della bestia affannata
si collocò un altro dolore, più meschino e buio,
e il mondo dei sogni si incrinò.
«Nessuno ti chiede più poesia!»
E: «E’ passato il tuo tempo di poeta…»
«Tu con le Ceneri di Gramsci ingiallisci,
e tutto ciò che fu vita ti duole
come una ferita che si riapre e dà la morte!
Poeta per vocazione, per scelta, per sorte, per disgrazia , per necessità, il timore della perdita della poesia in Pasolini coincide con la paura della perdita della grazia.
Ma sebbene già insoddisfatto del linguaggio e della forma-poesia del suo tempo (su cui non è il caso di dilungarsi, dopo l’eccellente saggio di Franco Di Carlo su Trasumanar e organizzar) Pasolini immette negli ultimi versi di questa poesia una novità formale ed estetica : il parlato…
E benché i tempi non fossero ancora favorevoli per certe imprese, Pier Paolo Pasolini già avvertiva in sé l’aspirazione di far muovere i suoi versi in un’area espressiva più vasta di quella fino ad allora esplorata e attraversata, una area espressiva che fosse in grado d’accogliere le nuove istanze in fermento in una società in movimento, in tumultuosa trasformazione, una società già sottoposta a ciò che F. Di Carlo ha analizzato come “Mutazione antropologica“ e “Omologazione” anche linguistica. Da qui la necessità pasoliniana di una nuova forma priva di forma.
Il timore di perdere anche il diritto al sogno ovvero la possibilità stessa di fare poesia non è stata mai estranea a Pasolini che qui recepisce il mondo della civiltà moderna come «macchina livellatrice» in grado di creare schiavi malati. Per il poeta la città notturna , sentita come un labirinto di sottopassaggi e strade, di suoni ridotti a sciacquii, è un incubo. E la bestia affannata del poeta P A T I S C E l’incrinarsi del suo mondo di sogni ed è dolente il dileguarsi con i sogni di tutto ciò che fu vita… E se nessuno ti chiede più poesia, che metamorfosi può subire quell’essere fatto per ideali voli e improvvise Navigazioni
Franco Di Carlo, Rita Mellace e Giorgio Linguaglossa Laboratorio di poesia 30 marzo 2017 Libreria L’Altracittà Roma
Giorgio Linguaglossa
Preghiera per un’ombra
I
Questa è la preghiera per un’ombra.1
Gioca a fare l’Omero, mi racconta la sua Iliade,
la sua personale Odissea.
Ci sono cavalieri ariosteschi al posto degli eroi omerici
e il Teatro dei pupi.
L’illusorietà delle illusioni.
[…]
«Le cifre pari e le dispari tendono all’equilibrio
– mi dice l’ombra –
così, stoltezza e saggezza si equivalgono,
eroismo e viltà condividono lo stesso equanime destino.
Noi tutti siamo ombre fuggevoli, inconsapevoli
della nostra condizione di fantasmi.
Gli uomini non sanno di essere mortali, dimenticano
e vivono come se fossero immortali;
il pensiero più fugace obbedisce ad un geroglifico
imperscrutabile,
un fragile gioco di specchi inventato dagli dèi.
Tutto è preziosamente precario, tranne la morte,
sconosciuta ai mortali, perché quando viene noi non ci siamo;
tranne l’amore, una pena vietata agli Immortali».
[…]
«Queste cose Omero le ha narrate», mi dice l’ombra,
«come un re vecchio che parla ai bambini
che giocano con gli eroi omerici
credendoli loro pari, perché degli dèi irrazionali
che governano le cose del mondo nulla sappiamo
se non che anch’essi sono bambini che giocano
con i mortali come se fossero immortali;
perché Omero dopo aver poetato gli immortali
cantò la guerra delle rane e dei topi,
degli uccelli e dei vermi,
come un dio che avesse creato il cosmo
e subito dopo il caos.
Fu così che abbandonò Ulisse alle ire di Poseidone
nel mare vasto e oleoso.
E gli dèi abbandonarono l’ultimo degli immortali,
Asterione, alle pareti bianche del Labirinto
perché si desse finalmente la morte per mano di Teseo.
In fin dei conti, tutti gli uomini sono immortali,
solo che essi non lo sanno.
Non c’è strumento più prezioso dello specchio
nel quale ciò che è precario diventa immagine.
A questa condizione soltanto gli uomini accettano di essere uomini».
[…]
«Giunto all’isola dei Feaci abbandonai Ulisse al suo dramma.
Perché il suo destino non era il mio.
Il suo specchio non era il mio».
[…]
«Il tempo è il regno di un fanciullo che si trastulla
con gli uomini e le Parche.
Non c’è un principio da cui tutto si corrompe.
Il firmamento è già in sé corrotto, corruzione di una corruzione.
Un fanciullo cieco gioca con il tavoliere.
Come ha fatto Omero con i suoi eroi omerici.
Come farai tu».
[…]
«Quell’uomo – mi disse l’ombra – era un ciarlatano,
ma della marca migliore
La più alta.
Egli era elegante,
e per giunta poeta…»2
*
1 Riferimento a mio padre calzolaio che mi raccontava da bambino storie di cavalieri ariosteschi
2 versi di Sergej Esenin “l’uomo nero” (1925)

Gino Rago, Laboratorio di poesia 30 marzo 2017 Libreria L’Altracittà Roma
Commento di Gino Rago
Noi tutti siamo ombre fuggevoli…
è l’apoftegma linguaglossiano che sostiene il componimento ove l’idea di “ombra” è già nel titolo. Conoscendo, da lunga frequentazione, la formazione culturale di Giorgio Linguaglossa posata su chiari e irrinunciabili punti di riferimento anche di filosofia estetica, un commento organico a questa Preghiera per un’ombra non può sottrarsi al mito platonico degli uomini incatenati in una caverna,con le spalle nude rivolte verso l’ingresso e verso la luce del fuoco della conoscenza. Altri uomini si muovono liberi su un muricciolo trasportando oggetti; sicché , questi oggetti e questi uomini, colpiti dalla luce del fuoco, proiettano le proprie ombre sulle pareti della caverna. Gli uomini incatenati, volgendo le spalle verso il fuoco, possono scorgere soltanto queste ombre stampate alle pareti della caverna. Nel mito platonico, la luce del fuoco è la “conoscenza”; gli uomini e gli oggetti sul muricciolo rappresentano le cose come realmente sono, cioè la “verità “ delle cose (aletheia), mentre le loro ombre simboleggiano l’”opinione”, vale a dire l’interpretazione sensibile di quelle stesse cose (doxa). E gli uomini in catene con lo sguardo verso le pareti e le spalle denudate verso il fuoco e l’ingresso della caverna? Sono la metafora della condizione naturale dell’individuo condannato a percepire soltanto l’ombra sensibile (doxa) dei concetti universali (aletheia), fino a quando non giungono alla “conoscenza”… Senza questa meditazione filosofica a inverare l’antefatto estetico, culturale, cognitivo che sottende l’attuale, febbrile ricerca poetica di Giorgio Linguaglossa non si comprenderebbe appieno l’approdo-punto di ripartenza di questa poesia e delle sue implicazioni, nominabili in poche ma singolari parole-chiave: forma di poesia senza forma; linguaggio di molti linguaggi; astigmatismo scenografico; stratificazione del tempo e dello spazio; metodo mitico per versi frammentati; intertemporalità e distopia. Il tutto compreso in quella invenzione linguaglossiana dello spazio espressivo integrale, l’unico spazio nel quale i personaggi inventati da Giorgio Linguaglossa (Marco Flaminio Rufo, il Signor K., Avenarius, Omero, il Signor Posterius, Ettore che esorta i Troiani contro gli Achei, Elena e Paride nella casa della Bellezza e dell’Amore, il padre, la madre, Ulisse, i legionari, Asterione, etc.) simili agli eteronimi di Pessoa, possono ricevere la piena cittadinanza attiva che richiedono al loro “creatore” quando, altra novità di vasta rilevanza estetica in questa poesia di Giorgio Linguaglossa, “parlano” nelle inserzioni colloquiali, o nel “parlato”, dentro ai componimenti linguaglossiani recenti.
Lo spazio espressivo integrale di Preghiera per un’ombra è il campo in cui “nomi”, “tempo”, “immagine”, “proposizione” vengono rifondati, ridefiniti, spingendo il nuovo fare poetico verso paradigmi fin qui esplorati da pochi poeti del nostro tempo (Mario Gabriele, fra questi, con Steven Grieco-Rathgeb, Antonio Sagredo, Letizia Leone e lo stesso Gino Rago) a costituire un “nuovo” poetico da far sentire “vecchia” ogni esperienza di poesia esterna a tale campo.
Nota.
Segnalo l’ottima interpretazione di Alfredo Rienzi a “Preghiera per un’ombra” (lapresenzadierato.wordpress.com) alla quale non mi sono voluto sovrapporre con il mio commento del 30 marzo 2017 – Roma, Laboratorio Poesia Gratuito, Libreria L’Altracittà, Via Pavia, 106
Gino Rago nato a Montegiordano (CS) il 2. 2. 1950, residente a Trebisacce (CS) dove, per più di 30 anni è stato docente di Chimica, vive e opera fra la Calabria e Roma, ove si è laureato in Chimica Industriale presso l’Università La Sapienza. Ha pubblicato le raccolte poetiche L’idea pura (1989),Il segno di Ulisse (1996), Fili di ragno (1999), L’arte del commiato (2005). Sue poesie sono presenti nelle Antologie curate da Giorgio Linguaglossa Poeti del Sud (EdiLazio, 2015) Come è finita la guerra di Troia non ricordo (Progetto Cultura, Roma, 2016) Email: ragogino@libero.it
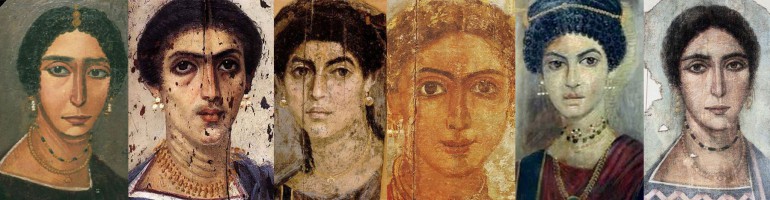




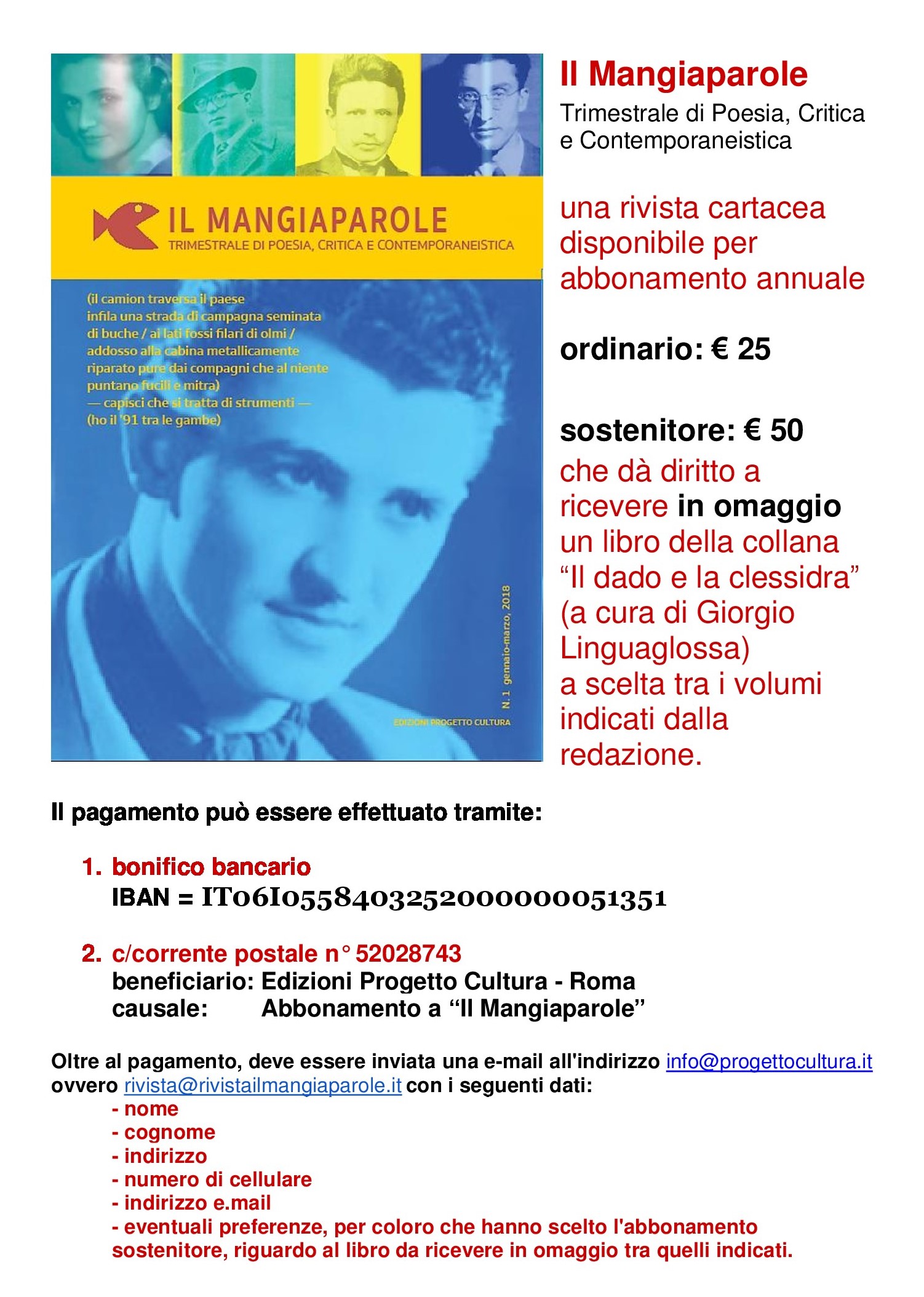
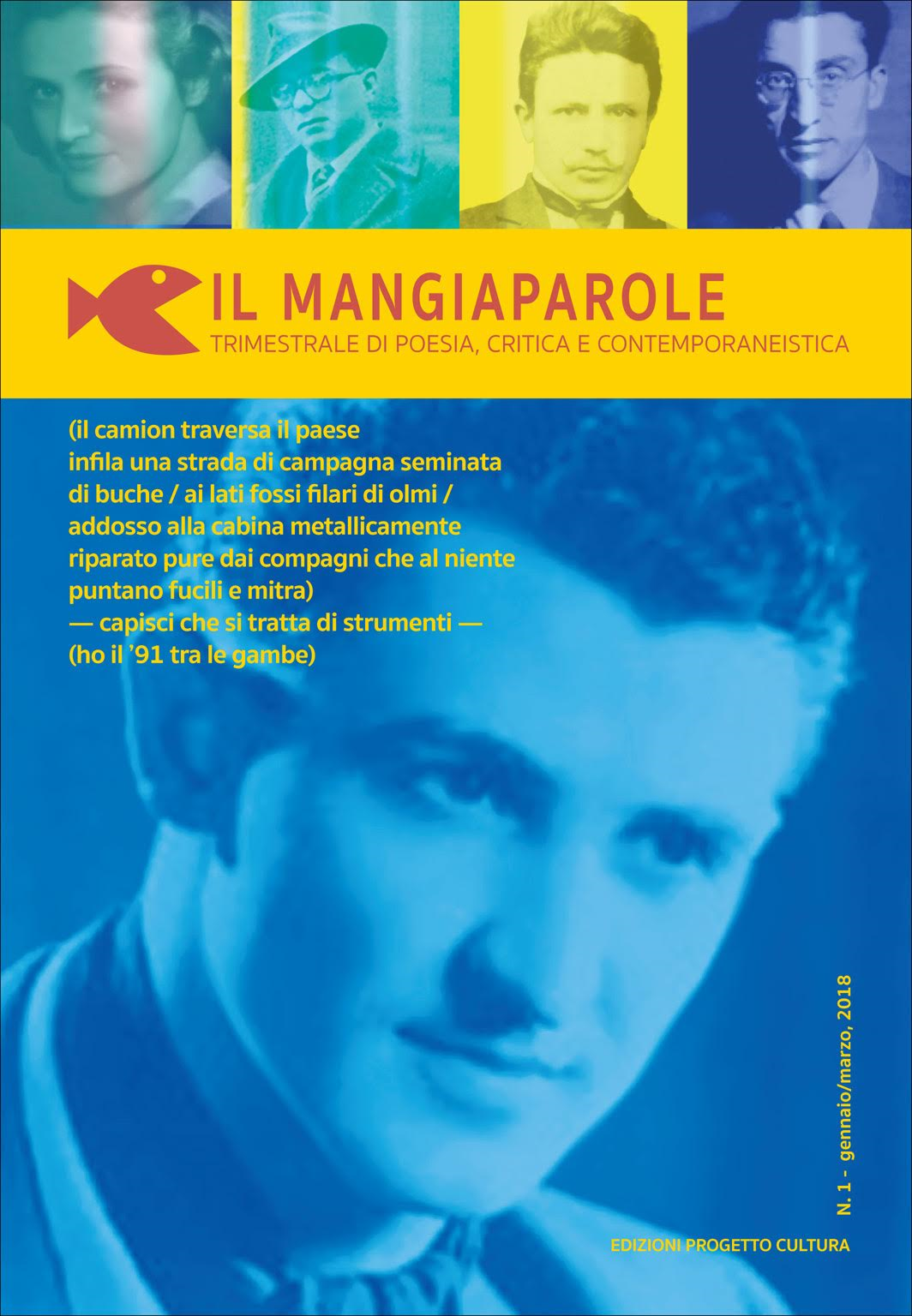

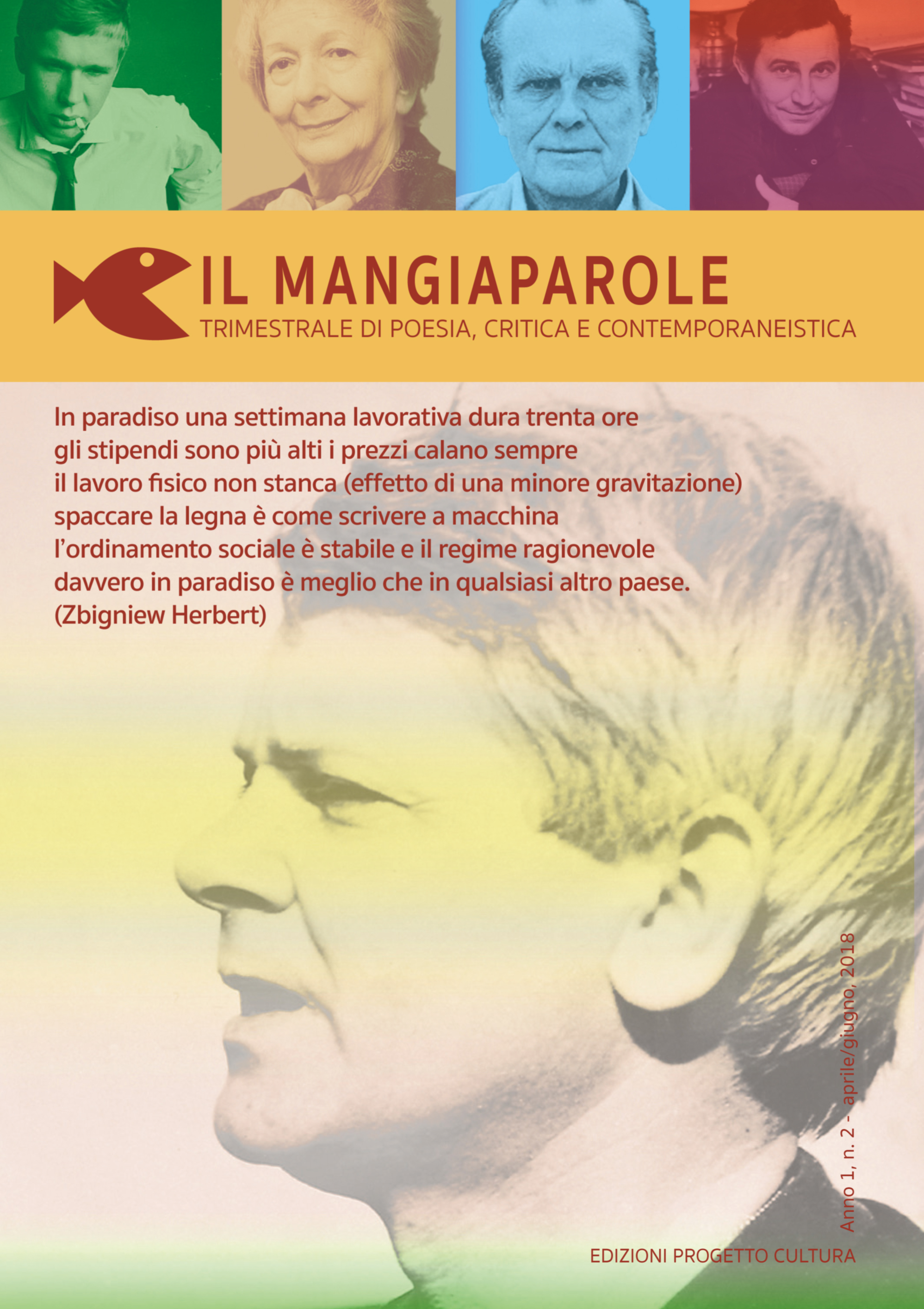



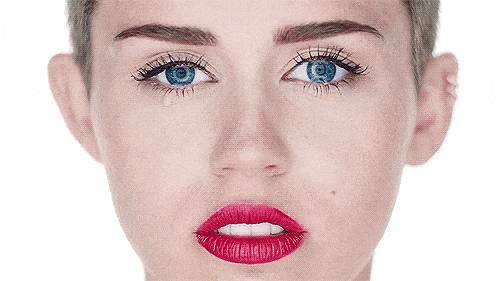
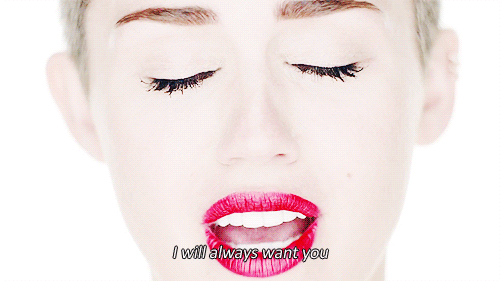
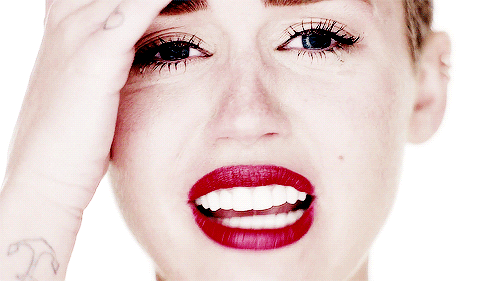
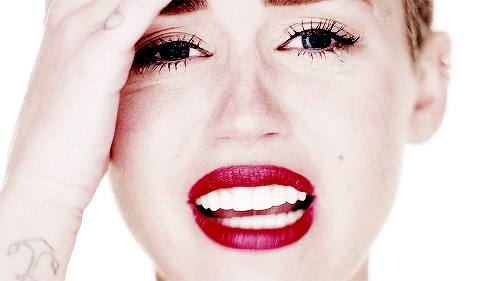
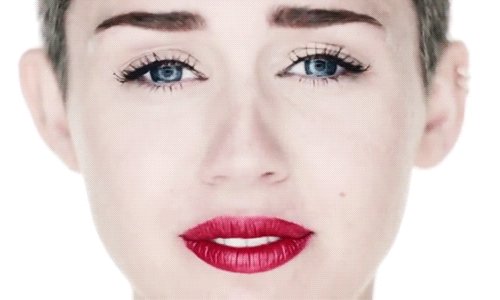



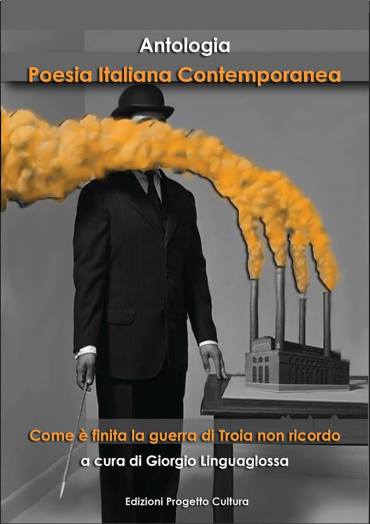




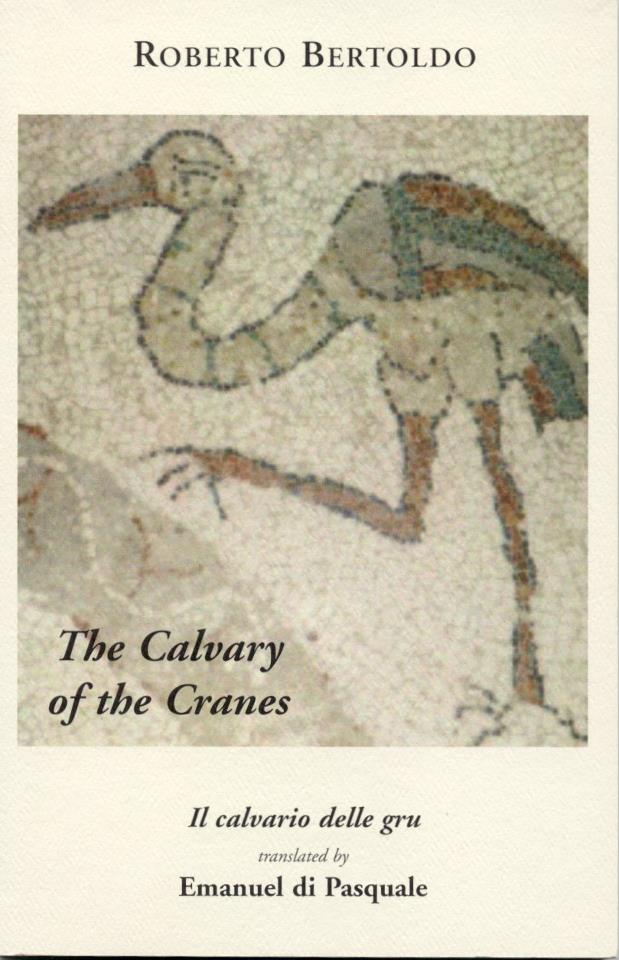
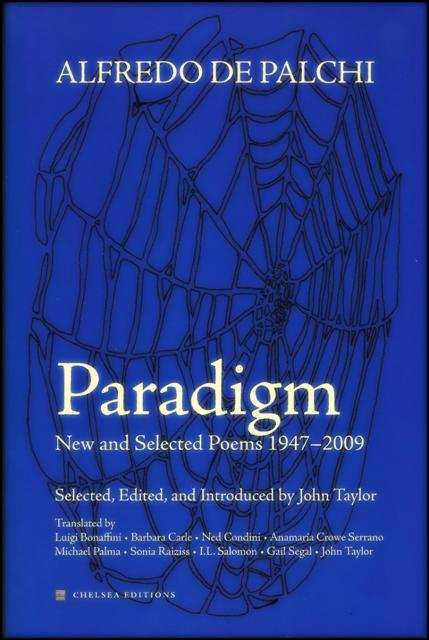


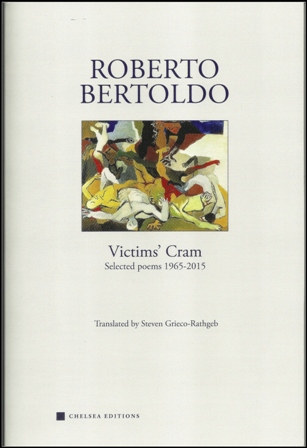





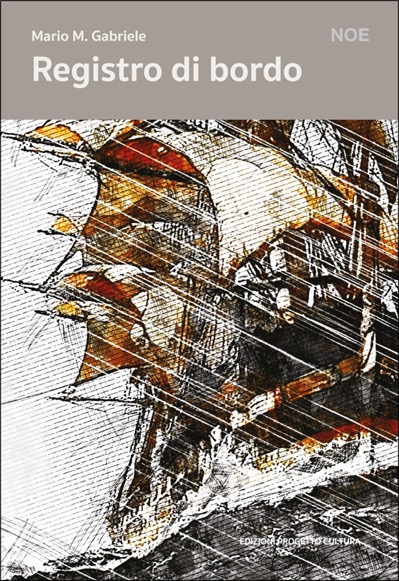

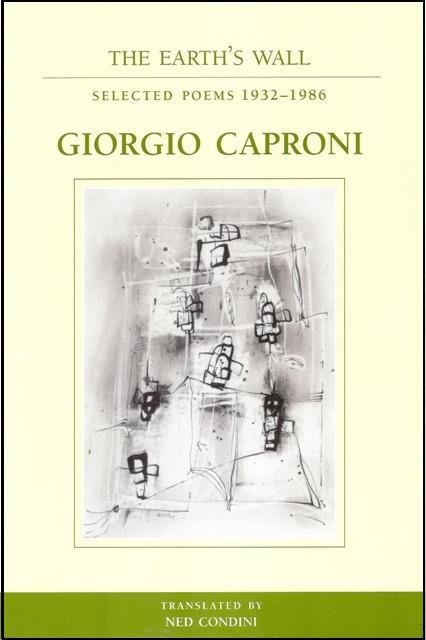
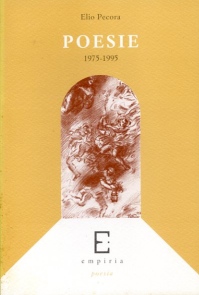

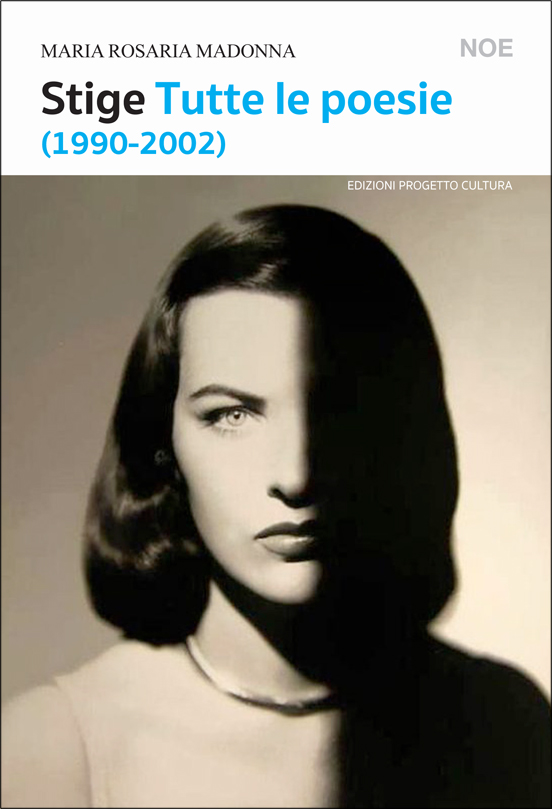

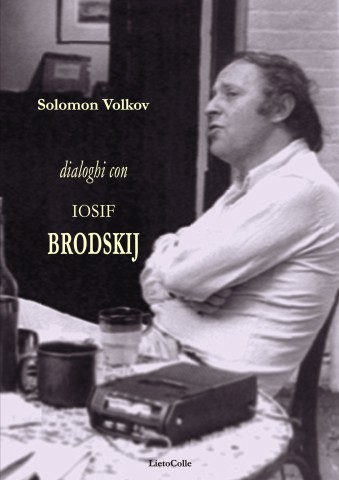




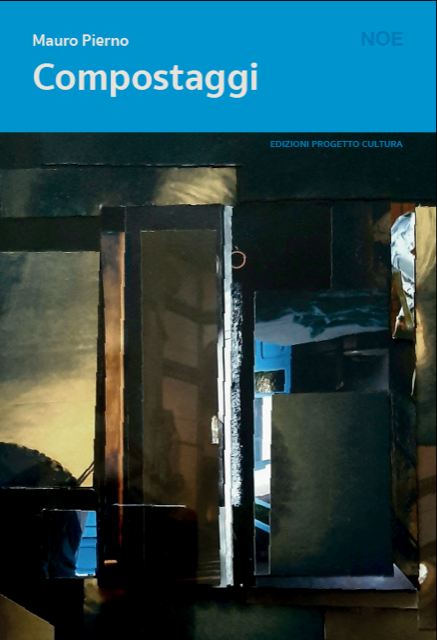
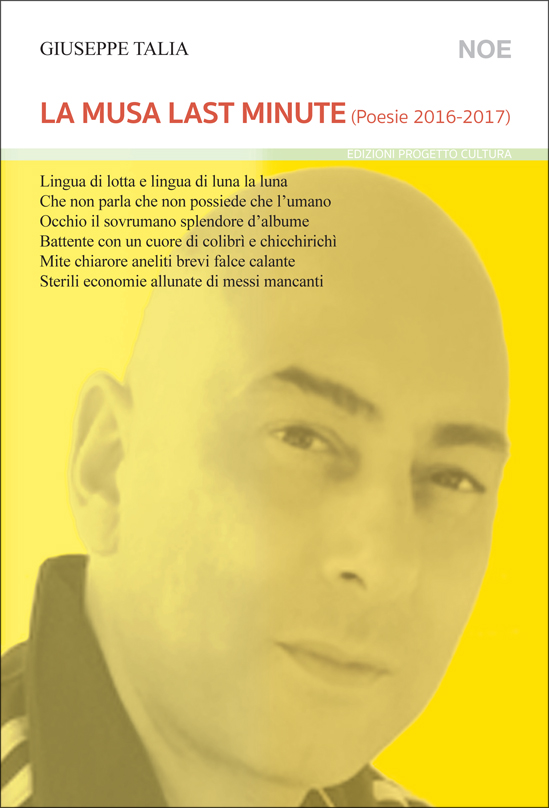


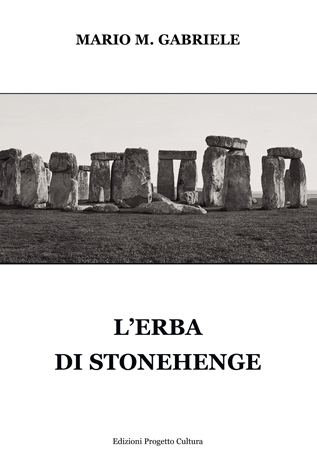
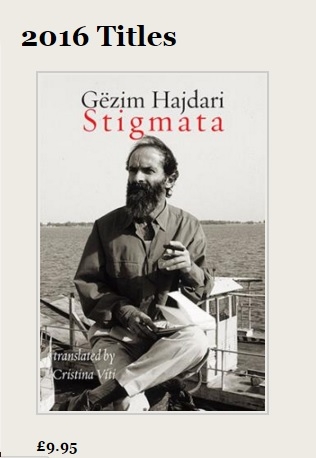
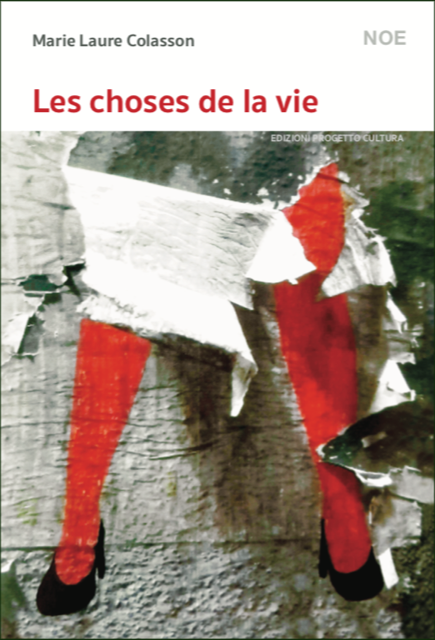




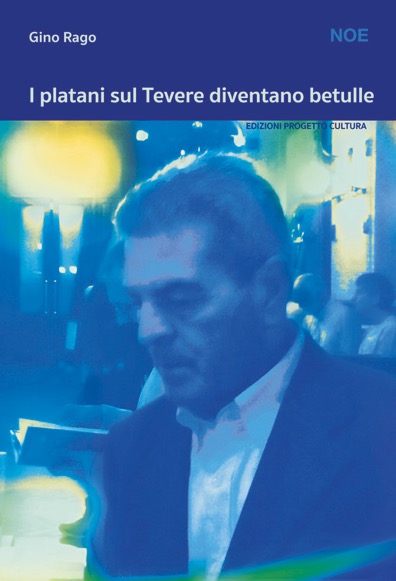
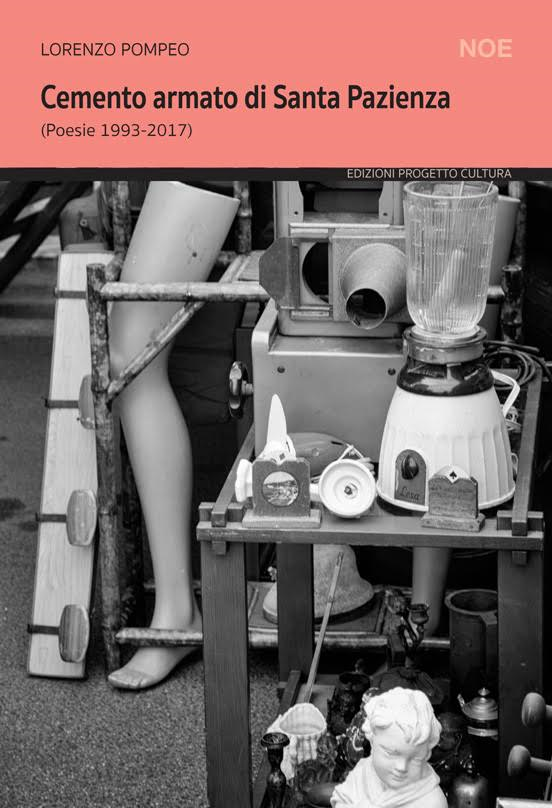
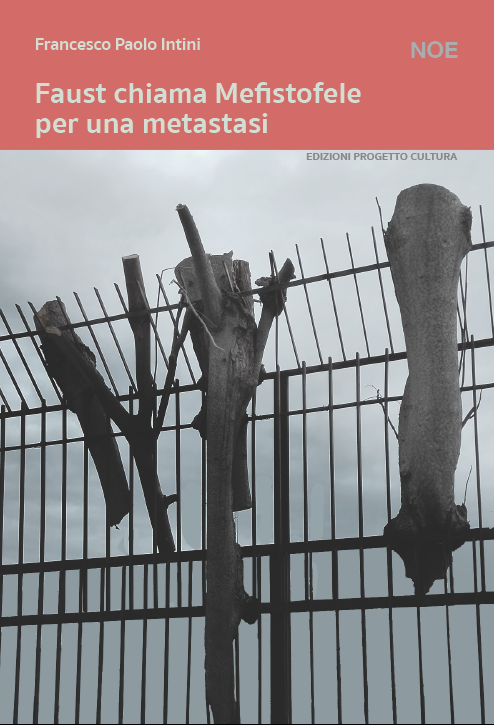

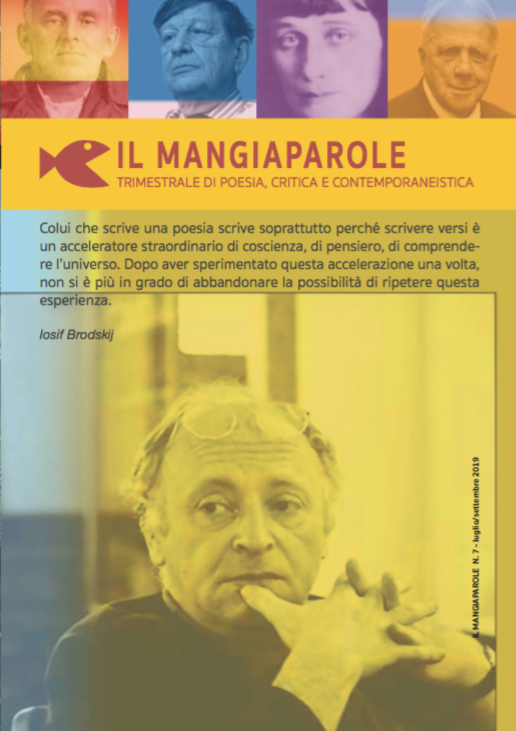




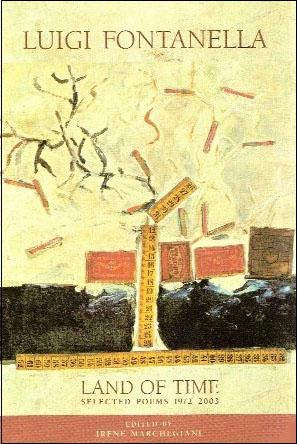








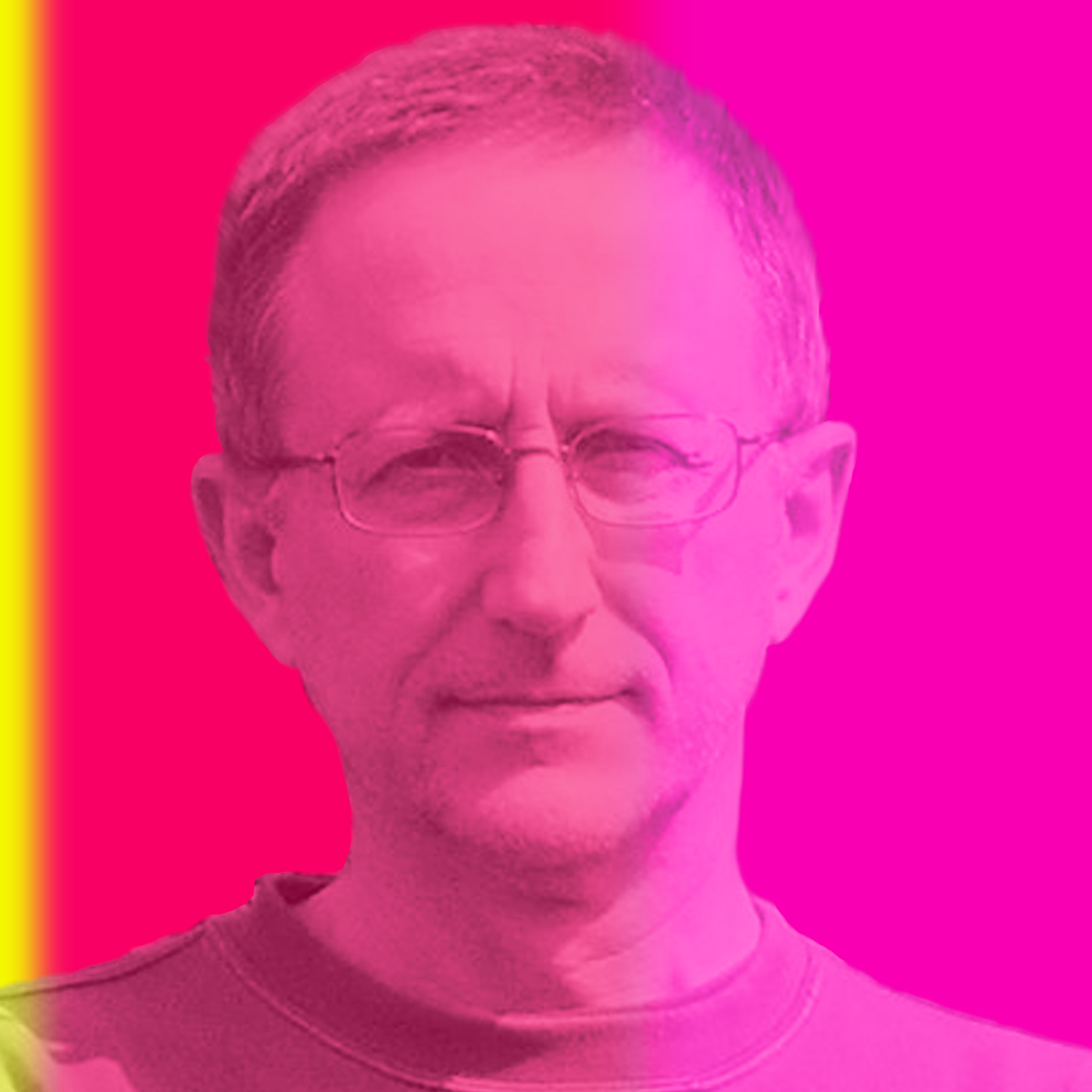







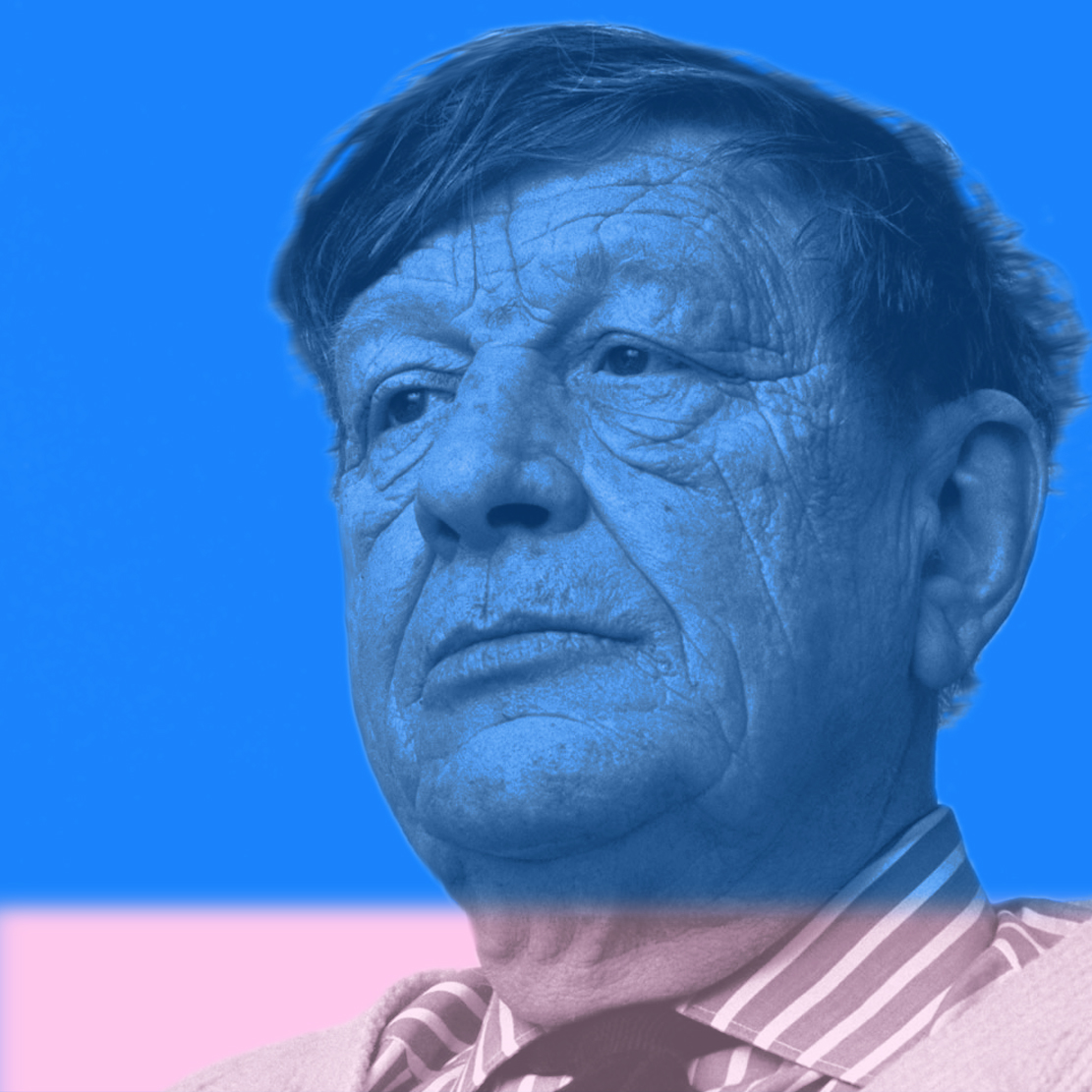



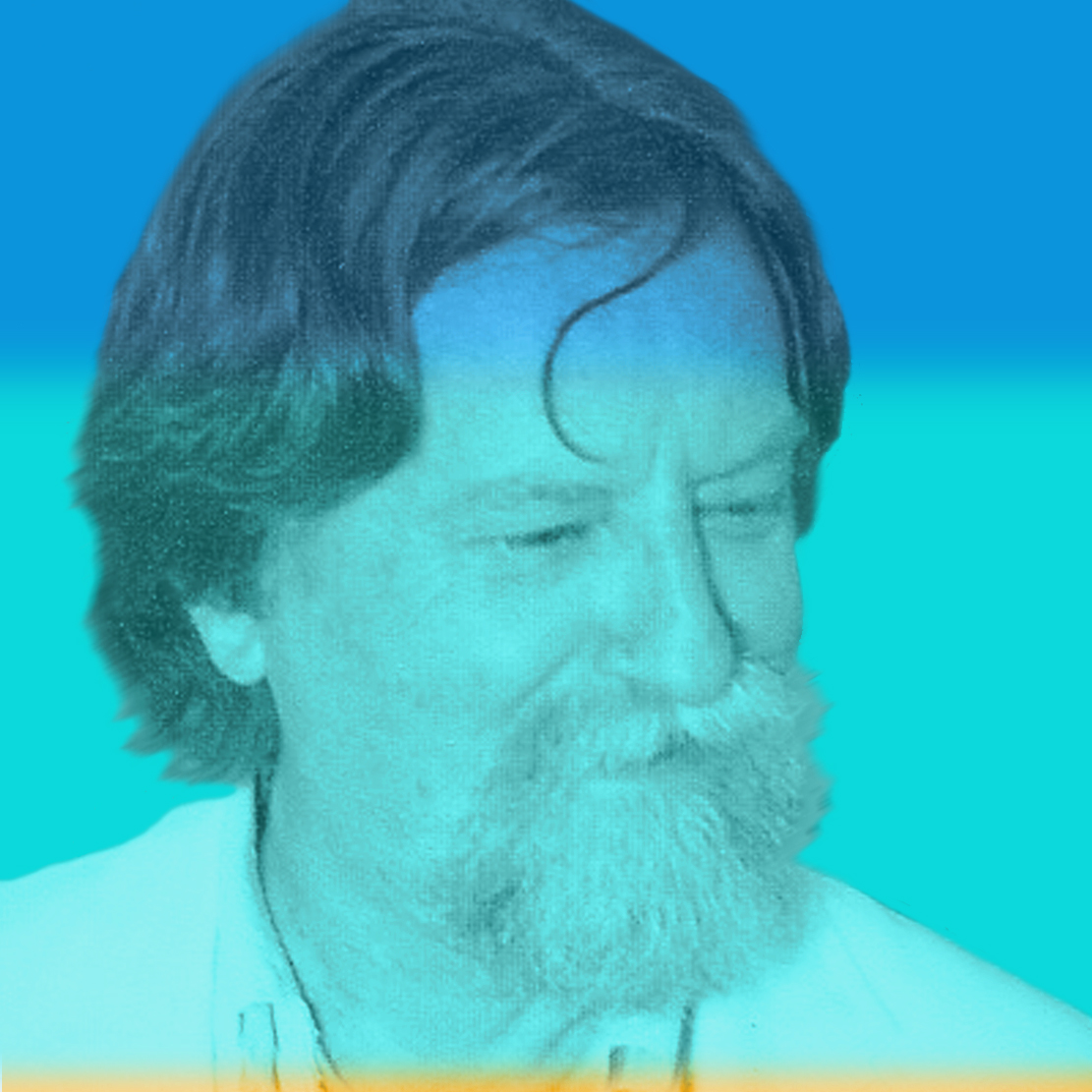
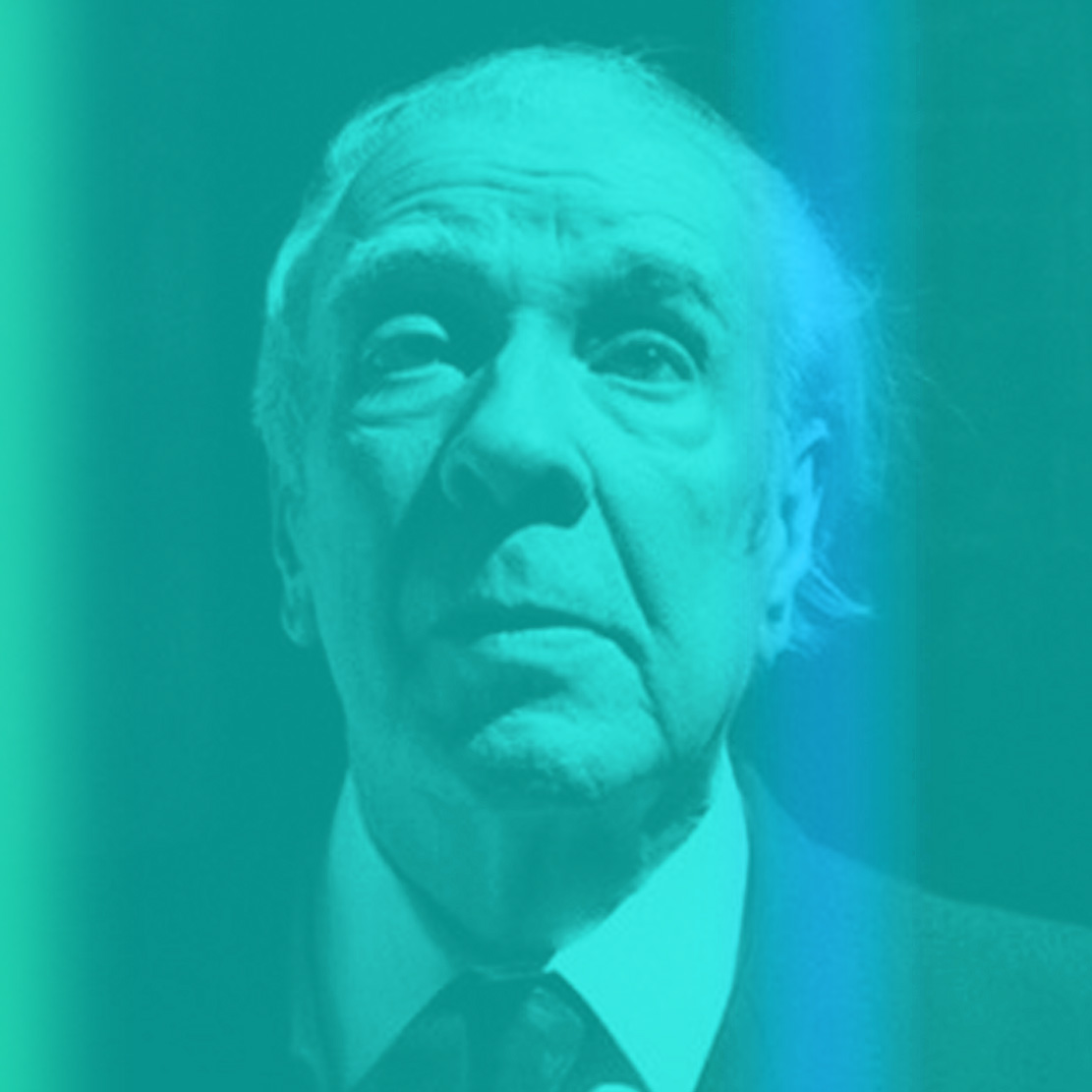




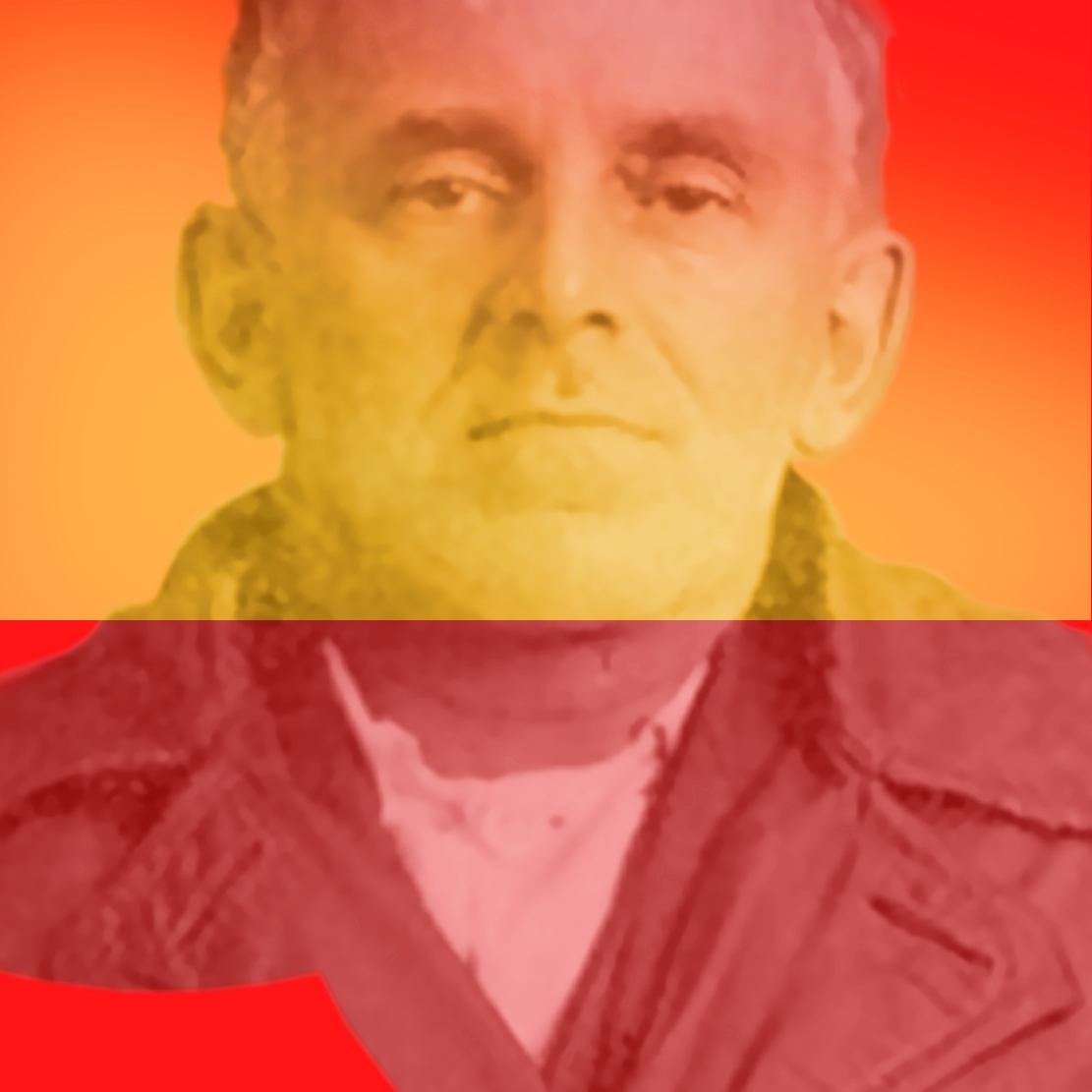






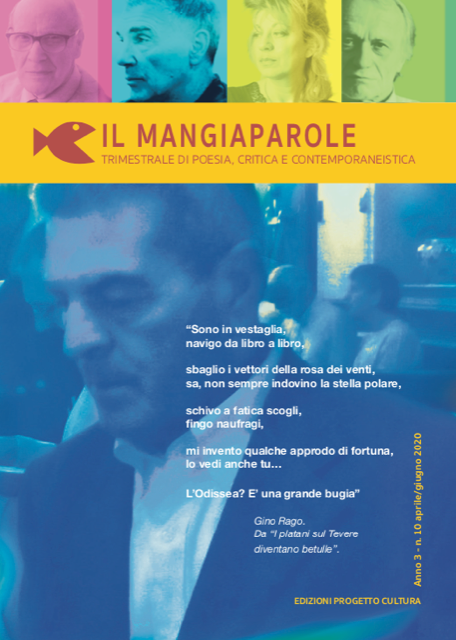




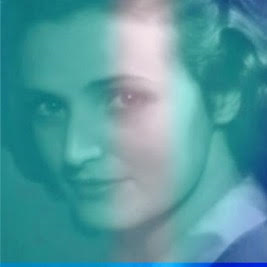
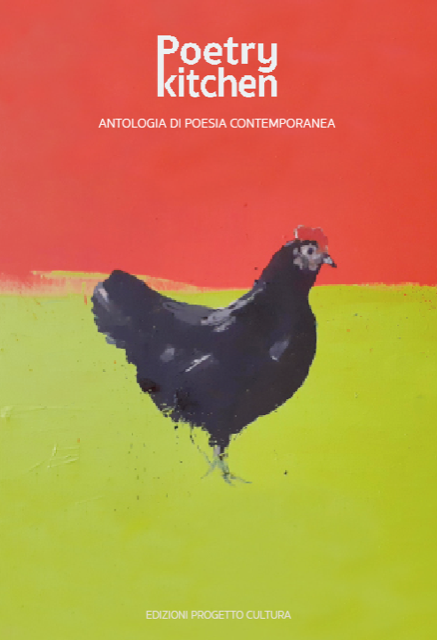



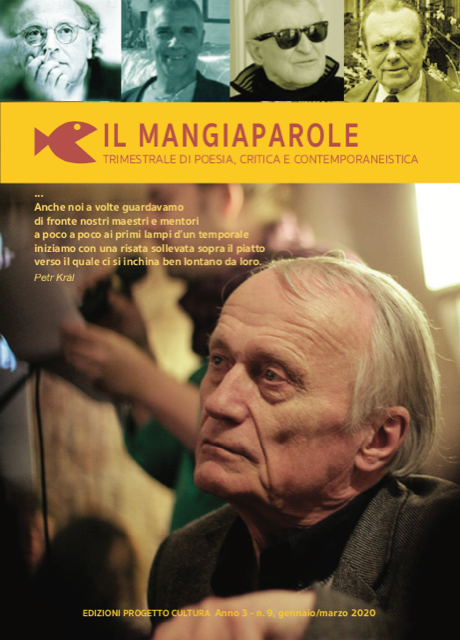











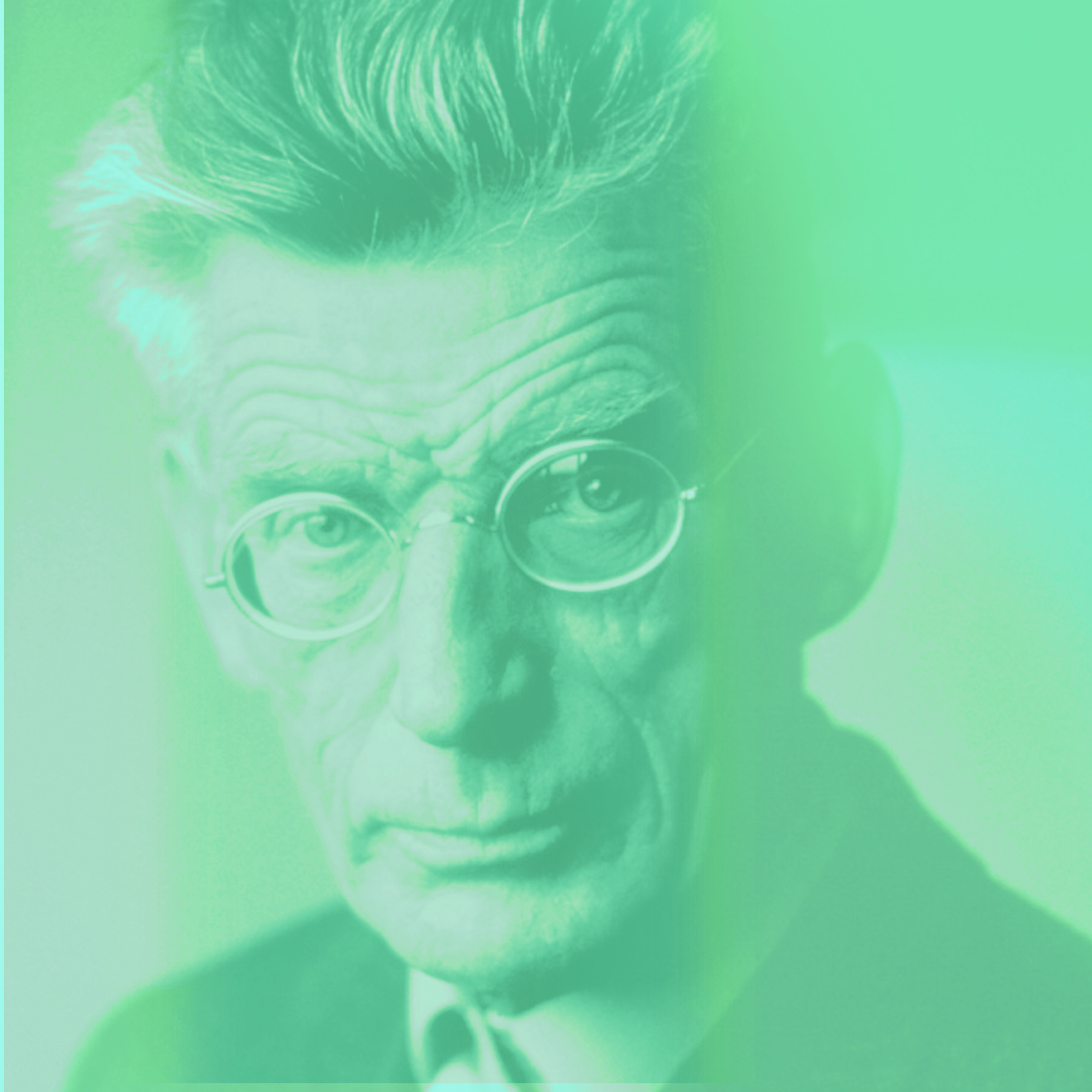
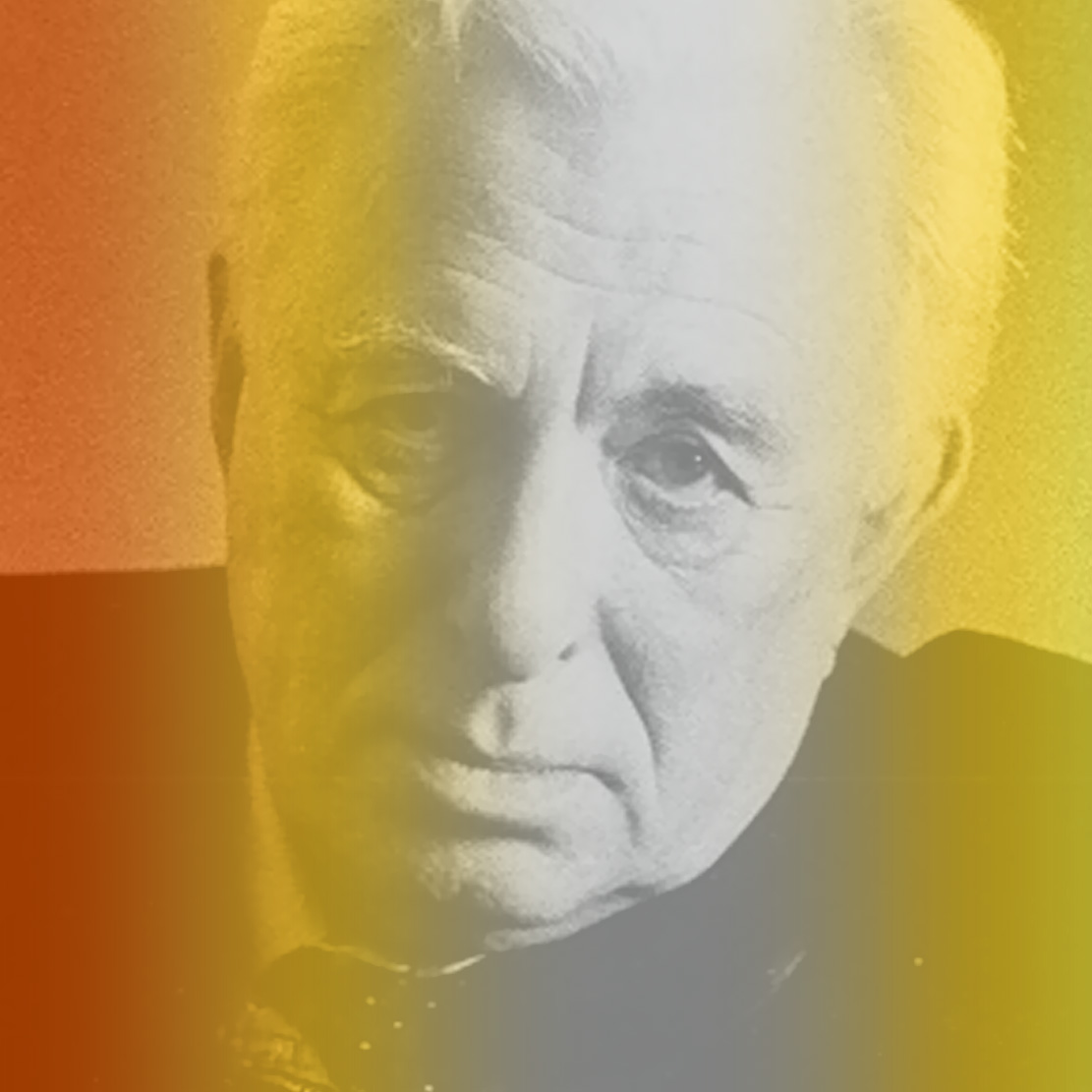









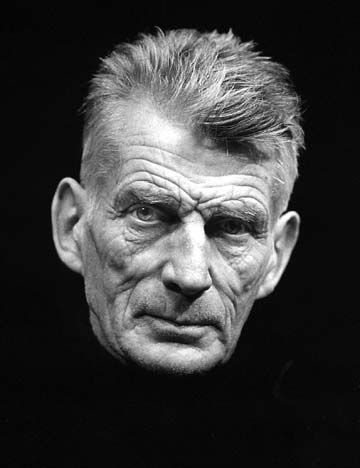


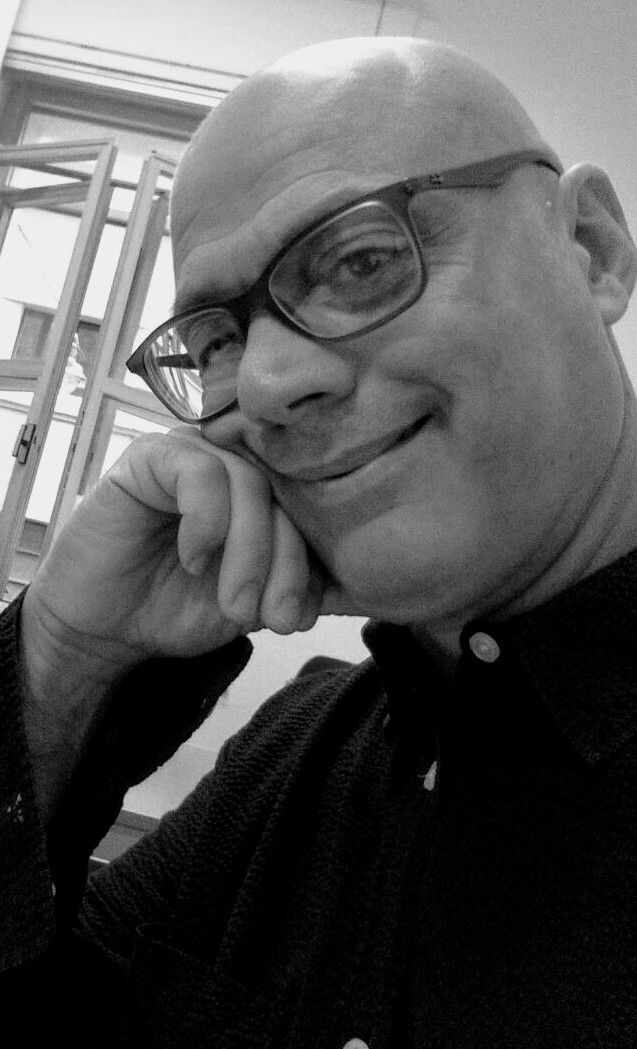
NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI @ IN POESIA https://lombradelleparole.wordpress.com/2017/04/05/gino-rago-arte-dello-scrivere-due-frammentisti-vociani-a-confronto-clemente-rebora-aldo-palazzeschi-e-pier-paolo-pasolini-un-contributo-alla-rilettura-del-novecento-poetico-italiano-e-un-c/comment-page-1/#comment-19042
Non la poesia è in crisi ma la crisi è in poesia. Il mondo è andato in frantumi. È andato in frantumi il principio di identità, quella identità si è poi scoperto che era una contraddizione e il soggetto non può che percepire gli oggetti in frantumi come altamente contraddittori e conflittuali. Lo stesso Severino, il filosofo per eccellenza della identità, ha rilevato che porre A=A è ammettere che A sia diverso da A. che cioè l’identità implica in sé la diversità e la non-identità. Anche Derridà invocava a pensare l’orizzonte della rimozione come dell’accadere di un evento, secondo «una nuova logica del rimosso». L’epoca in cui la crisi è in crisi, richiede alla poesia risposte nuove, che si affranchino dalle risposte che sono già state date, pensare l’orizzonte della parola come un orizzonte del rimosso, una parola che anche quando la riusciamo a profferire, risulta in sé divisa in schisi, solcata dalla scissione…
Gli oggetti esterni sono percepiti frantumati, al pari degli oggetti interni. Anche il metro della poesia ne è uscito frantumato, il metro della nuova ontologia estetica, per eccellenza. Per il fatto di avere questa relazione doppia con se stesso, il soggetto è sempre intorno all’ombra errante del proprio «io», ci gira intorno dall’esterno, lo circumnaviga, sospettoso e distratto. Quello che nella nuova poesia ontologica si presenta è l’allestimento di una scena, di varie scene nelle quali il soggetto e l’oggetto sono irrimediabilmente separati da se stessi come in preda di una diplopia, figura essi stessi della loro schisi, della loro deiscenza all’interno del mondo – quell’oggetto che per essenza distrugge l’«io» del soggetto, che lo angoscia, che non può raggiungere, in cui non può trovare alcuna riconciliazione, alcuna aderenza al mondo, alcuna complementarità. Tra «oggetto» ed «io» si è instaurata una scissione, una Spaltung.
La poesia della Nuova ontologia estetica eredita tutta questa frantumazione del frammento, questa polverizzazione dell’«oggetto», e non potrebbe essere altrimenti. E questa è la sua forza, la forza percussiva delle sue icone semantiche ridotte ai minimi termini dell’azione semantica.
"Mi piace""Mi piace"
“Non la poesia è in crisi ma la crisi è in poesia” (Linguaglossa).
————————————————–
———————————————————–
La testa-quintessenza
scoppia di bestemmie e di sollazzi.
Non posso restare così
tra le conifere del freddo
come una ghiacciata tartaruga
disperata e malferma
per un tizzone di parole
accese dalla rabbia.
Sono peggio di un cane randagio
nefritico, sterro sprocchi, ovunque
uso i denti come do-re-mi.
A nessuno importa del poeta-barbaglio.
Applausi per la crisi dei linguaggi,
ma tutti sono pronti
a canonizzare gli altari dei successi,
inutili come parole sferruzzate al vento.
Di cosa parlo?
Meglio spetezzare!
Vado pazzo-lucido
sgattaiolando
tra palazzi astrali
fissando con occhio di topo
nefritici poteri.
[Ottavo poema (di un) idiota – 1971]
—————-
Rabbia!
Mortiloquio!
E sia poesia di sangue
sublime caduta
di questo stato di cose!
Sia la poesia
guida sicura
di già stanchi colori!
Sappiamo cosa sia epoca spenta
e fuoco della nuova:
lo conosciamo tutti il sentimento!
Rabbia!
e già future invidie
con grida occhiute
sognano vendette,
e il poema è impazzito!
Sorge come un cuneo:
non è finita, silenzio!
Il poeta
sfascia la parola
con le trame dei versi.
Crisi del tuo linguaggio
il tuo calvario.
Invocazione a un Dio:
mistica
o pigrizia della storia?
Simulazione
tra schizzi, lampi, bagliori!
[Nono poema (di un) idiota] – 1971
————————————————-
antonio sagredo
"Mi piace""Mi piace"
NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA https://lombradelleparole.wordpress.com/2017/04/05/gino-rago-arte-dello-scrivere-due-frammentisti-vociani-a-confronto-clemente-rebora-aldo-palazzeschi-e-pier-paolo-pasolini-un-contributo-alla-rilettura-del-novecento-poetico-italiano-e-un-c/comment-page-1/#comment-19044
Grazie a Gino Rago per questo suo excursus critico sull”ars poetica” di autori che ritengo fortemente innovativi nel Novecento. L’accostamento che ne fa mi pare senz’altro appropriato: Clemente Rèbora, l’ “espressionista” Rèbora, annoverato tra i cosiddetti “vociani”, anche loro (come noi oggi) spinti verso la ricerca di un nuovo linguaggio (una Nuova Ontologia Estetica diremmo noi) dall’esigenza di abbandonare gli schemi tradizionali del secolo precedente; Aldo Palazzeschi, confluito nella rivista La Voce dopo l’esperienza futurista: uno scrittore e poeta controcorrente, nei cui versi Marinetti leggeva «un odio formidabile per tutti i sentieri battuti, e uno sforzo, talora riuscitissimo, per rivelare in un modo assolutamente nuovo un’anima indubbiamente nuova». Intellettuale fervido e lungimirante, mi pare giustamente accostabile a Pier Paolo Pasolini: «insoddisfatto del linguaggio e della forma-poesia del suo tempo – così analizza Gino Rago – già avvertiva in sé l’aspirazione di far muovere i suoi versi in un’area espressiva più vasta di quella fino ad allora esplorata e attraversata». Dopo di lui (e dopo il Montale di Satura), “la crisi nella poesia”, il “mondo in frantumi”, come scrive Giorgio Linguaglossa: quarto e ultimo autore citato, col quale Gino Rago ci conduce alla contemporaneità. La sua «febbrile ricerca poetica» lo pone senz’altro un passo in avanti, oltre la linea consunta di tanta poesia letta e riletta. È il passo in avanti richiesto dai tempi, dall’epoca in cui viviamo. Lo ripeto con le parole stesse di Giorgio Linguaglossa: «l’epoca in cui la crisi è in crisi, richiede dalla poesia risposte nuove, che si affranchino dalle risposte che sono già state date, pensare l’orizzonte della parola come un orizzonte del rimosso, una parola che anche quando la riusciamo a profferire, risulta in sé divisa in schisi, solcata dalla scissione…».
Per questo e per molto altro ancora, la nostra poesia deve procedere con i tempi verso una Nuova ontologia estetica: “Nuova” perché in grado di accogliere tutta la “frantumazione del frammento”, la “polverizzazione dell’«oggetto»”. Ancorché indebolirsi, di questo la poesia si fa forte: «questa è la sua forza, la forza percussiva delle sue icone semantiche ridotte ai minimi termini dell’azione semantica».
"Mi piace""Mi piace"
Complimenti a voi. Interessante relazione.
"Mi piace""Mi piace"
NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA https://lombradelleparole.wordpress.com/2017/04/05/gino-rago-arte-dello-scrivere-due-frammentisti-vociani-a-confronto-clemente-rebora-aldo-palazzeschi-e-pier-paolo-pasolini-un-contributo-alla-rilettura-del-novecento-poetico-italiano-e-un-c/comment-page-1/#comment-19048
…ma se confronto i poeti Rebora e gli stessi Palazzeschi e Marinetti (che si salvano in estremis) coi loro contemporanei europei (è ovvio anche i poeti russi)… beh, devo dire che il primo (nonostante spinto “verso la ricerca di un nuovo linguaggio”) ne esce definitivamente sconfitto… lo stile del Rebora è perdente poiché proprio a causa di questo non ne poteva mai scaturire fuori una nuova forma modernissima (?!)… intrisa come è di “pascolismi” e di “carduccinismi” ecc. — riguardo al secondo, superiore al primo per ironia formalistica e intenti più seri perfino anche del terzo, devo affermare che già possedeva quella forma disincantatamente frammentaria tipicamente appartenente alla poesia civile, (e non certo sanguinaria – metodo da deplorare – come quella del Marinetti), che l’avrebbe condotto ad una maturazione stilistica ben più valida del maturo Montale ( e che se il Nobel per assurdo ha una valore l’avrebbe meritato più dello scialbo e borghesuccio Eusebio). Pasolini resta la risposta più giustificata a chi voglia davvero cambiare le carte in tavola della Poesia, pure se aggravata dal persistente ideologismo…. ma già di questo ne sentiva il peso asfissiante se era così smanioso da voler desiderare un cambio di forma radicale come testimonia Franco Di Carlo. Resta per me Sanguineti coi suoi capricci stilistici forse l’unico capace di cambiare qualcosa anche se i suoi esperimenti linguistici facevano il verso alle già datate convulsioni formali dei poeti e critici russi dei primi 30 anni del secolo scorso. Ma è possibile che mi sbagli del tutto, come è possibile che tutto ciò non mi interessi per nulla, e che perciò erro, oppure affermo il contrario. Adieu!
"Mi piace""Mi piace"
NUOVA ONTOLOGIA = NUOVA POESIA
Il titolo della mia relazione tenuta il 30 marzo 2017 alla libreria L’Altracittà di Via Pavia (zona Piazza Bologna) nell’ambito delle meritorie iniziative
poetico-letterarie del Laboratorio Poesia Gratuito, voluto dalla Redazione de L’Ombra delle Parole con il magnifico coordinamento di Rita Mellace,
era: “Da Aldo Palazzeschi a Preghiera per un’ombra di Giorgio
Linguaglossa: verso lo “spazio espressivo integrale” passando per Rebora
e Pasolini. 3 poesie brevi di Rebora, Palazzeschi, Pasolini sull’ars poetica
come antefatti a “Preghiera per un’ombra”.
Nei 12 minuti a me concessi, senza sperpero di parole né arabeschi notturni, mi sono mosso in piena coerenza e pienezza di fedeltà con il tema
da me scelto e proposto alla Redazione e alla coordinatrice delle attività
del Laboratorio; e soltanto quando Giorgio Linguaglossa e Rita Mellace
lo hanno acquisito con il loro pieno consenso, l’ho fatto mio sviluppandolo
nella relazione proposta su questa pagina, con mio pieno appagamento.
Se considero che il “frammentismo vociano” si è proposto, si è sviluppato
e si è concluso nell’arco di meno di nove anni (1909 – 1916), navigando
dai versi di Rebora a quelli di Giorgio Linguaglossa abbiamo percorso insieme quasi un secolo di poesia italiana e dall’analisi dei testi proposti,
letti e commentati ho inteso direi “seppellire” definitivamente il tentativo
tanto diffuso quanto provocatoriamente agitato di confondere quella
stagione lirica del frammentismo, aggregato intorno alla “Voce Letteraria”
di Prezzolini-Soffici-De Robertis, con il verso frammentato della N.O.E.
Accanto ai nomi di Mario Gabriele, di Steven Grieco-Rathgeb, di Letizia
Leone, di (per talune prove poetiche) Antonio Sagredo da affiancare
al Giorgio Linguaglossa dello “Spazio Espressivo Integrale” già presenti
nella mia relazione, occore che citi, per la valenza estetica delle loro
recenti ricerche poetiche, sia Lucio Mayoor Tosi sia Angela Greco, senza
dimenticare la Costantina Donatella Giancaspero delle recentissime sue
composizioni pienamente rispondenti alla Nuova Ontologia Estetica.
Così come, a onor del vero, è buona cosa che ricordi che il vero, autentico
frammentista vociano è Clemente Rebora, essendo Aldo Palazzeschi
suggestionato da precedenti esperienze prima futuriste e poi crepuscolari con cui si spiegano certe sue inclinazioni iconoclaste.
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
SU ALCUNE QUESTIONI INTORNO ALL’ESSERE E AL NULLA, LA NUOVA ONTOLOGIA ESTETICA
Vorrei tornare ai miei spunti e appunti spersi su questa Rivista intorno alla questione del Nulla, del Vuoto e dell’Essere ai fini di una corretta impostazione metodologica della N.O.E. – Il tratto caratteristico e per me fondante, il tratto di distinguibilità io lo rinvengo nella percezione del Nulla, del concetto filosofico e scientifico che il termine Nulla ha. La N.O.E. recepisce questa gigantesca problematica di oggi, comune anche alla filosofia recentissima.
La questione del Nulla non è stata inventata dai redattori dell’Ombra, ma è da più di un secolo che la filosofia e la scienza pensano questa “Cosa”.
Si dice comunemente che «Il Nulla non è» e che «l’Essere è», ponendo il Nulla come originario e fondante l’essere; ebbene, questa impostazione ha il sapore di vecchia scolastica, oggi noi ipotizziamo l’indistinguibilità del Nulla e dell’Essere come dato di fatto filosoficamente inconcusso. Il Nulla significa e, in quanto positivamente significa è equiparabile alla significazione vuota del non-essere, il suo darsi è «vera e indeterminatissima negazione dell’essere»1] – È paradossale che la negatività assoluta, il Nulla, significhi anche qualcosa, proprio come l’Essere il quale significa anch’esso qualcosa. Ovvero, il positivo significare e il negativo significare sono su un piano di assoluta parità ontologica, nessuno dei due riveste un ruolo di priorità ontologica: «la positività del significato ‘albero’, non è assolutamente più originaria di quella predicabile dal nulla».2] Ovviamente, parlando di positività del nulla noi intendiamo la sua assoluta indeterminazione che non assume alcun ruolo prioritario nella individuazione di un qualunque essere dal punto di vista ontologico.
Questo «è» consiste nella SUA assoluta mancanza di determinazione e dunque costitutivamente connaturato con il Nulla. Così, Prima dell’Inizio, il nulla che è e l’essere che non è, si danno simultaneamente la mano.
Con le parole di Severino: «pensare “quando l’essere non è“, pensare cioè il tempo del suo non essere significa pensare il tempo in cui l’essere è il nulla, il tempo in cui si celebra la tresca notturna dell’essere e del nulla».3]
Lo stesso Severino afferma che il principium firmissimum riesce a strutturarsi «solo in relazione con il negativo, e l’incontrovertibilità può esser posta solo in quanto originariamente implicante una relazione con il nulla». Il Nulla di cui il filosofo italiano parla «non è il non-essere determinato ma il nulla in quanto «nihil absolutum», l’assolutamente altro dall’essere».
Ciò significa che anche l’Originario è auto contraddittorio, esso si dà quando non si dà, cioè quando non è Principio di alcunché: di qui la natura intimamente antinomica e paradossale dell’Originario. L’Originario non è un ente che si costituisce in ente ma è qualcosa connaturata al suo non-essere e, quindi alla sua stessa inconsistenza dal punto di vista dell’ente…
Da quanto precede, è ovvio che leggere la mia poesia Preghiera per un’ombra, presuppone il porsi nella dimensione esistenziale di accoglimento del Nulla e del non-essere (e quindi del tempo) sullo stesso piano ontologico di parità indistinta. La Nuova Ontologia Estetica non poteva sorgere che in questo nuovo orizzonte di pensiero filosofico. Questo mi sembra incontrovertibile.
Il problema in ambito estetico è percepire il nulla aleggiare nelle «cose» e intorno alle «cose», percepire il vibrare del nulla all’interno di una composizione poetica così piena di «cose» e di significati… per scoprire che tutte quelle «cose» e quei «significati» altro non erano che il riverbero del «nulla», il solido nulla del nostro nichilismo…
La positività del nulla è la sua stessa nullità, la sua nullificazione. Credo che questo sia chiaro a chi legga la poesia con la mente sgombra, facendo vuoto sul prima della poesia, leggerla come si respira o si guarda uno scricciolo che trilla, come un semplice accadimento che accade sull’orlo di qualcosa che noi non sappiamo… Ascoltare la progressiva nullificazione del vuoto che avanza e tutto sommerge nella sua progressiva forza nientificante. È questo appunto di cui tratta la Nuova Ontologia Estetica, prima ancora di parlare di metro, di parola e di musica… e quant’altro…
1]Massimo Donà, L’aporia del fondamento, Milano-Udine 2008 p. 183
2] Ivi, p.199
3] Emanuele Severino “Ritornare a Parmenide”, in Essenza del nichilismo, Milano 1982, p.22
4] Emanuele Severino, La struttura originaria, Milano 1981, pp.181-182 e p. 209
"Mi piace""Mi piace"
…. bisogna stringersi attorno alla Poesia fino a spezzarLe il collo!
Farla rinsavire, poiché prende o ha preso delle strade diverse da quelle dei Poeti, e a tutt’oggi non so chi abbia torto…. torto il collo di chi del Poeta o della Poesia, che poì infine sono due entità distinte, ma suvvia perdonatemi…
intanto stiamo perdendo un grande talento: Gaio Valerio Pedini (come se fosse il nome di un grande poeta latino! – un giorno mi disse piangendo al telefono: “Mi hanno rubato tutto fin dall’infanzia, e adesso mi vogliono rubare anche il momento del mio morire”. Di fronte a simile testimonianza ancora vivente, che significato hanno le nostre diatribe… avevano ragione Trakl e Majakovskij: sarebbero stati dei grandissimi compagni di strada, ma lo sono in virtù dei miei pensieri nei loro riguardi.
adieu!
"Mi piace""Mi piace"
Clemente Rebora a Boine:
“(…) Pensare ch’io ho raffreddato molte simpatie per me, con i miei versi! Tu, invece, mi sei rimasto, perché hai inteso la “poca importanza” che un’opera d’arte ha per chi vive senza perdono, come talvolta io feci. Oggi non mi è possibile scriverti perché sono nella “violenza” che ho fatta al mio destino da un mese, son tutto in questa nuova china dove forse mi romperò il capo, ma che io perseguo con piena adesione, a csto d’ogni svalutazione e d’ogni rovina” (29 luglio 1914)
Rebora stava ringraziando Boine per una delle sue “recensioni con gli umori” della rubrica Plausi e botte, leggi “Riviera ligure”. Recensione – ampia e particolareggiata – che attacca così:
“Quando in queste sere afose, improvvisa balena all’orizzonte, zitta e lontana, la nuvolaglia, la gente sul corso tira via queta per gli affari suoi. E qualcuno che si volta, dice: “Lampi di caldo” o “Ci sarà un temporale… di là dal mare”.
Questi frammenti sono usciti nel 13. Signori lettori scusatemi. – Ma la gente ha tirato via per i soliti affari di letteratura corrente e qualcuno che s’è voltato ha detto: “ci son baleni qua e là ed una pazzesca confusine di nuvoli”. Ha detot che ci fa buio. – Sissignori, c’è burrasca. Sissignori, c’è un meraviglioso divampare di elettrici sprazzi in un rotto cielo e convien passare il mare a vederlo perché tutti i giorni non capita. (…) Io ho detto: – qui c’è una fonte viva; qui c’è un’anima e un uomo.
(…) La febbre morale del secolo mio, codesto ansito di attivismo universalistico che è intorno, che è succeduto in Italia di botto agli estetismi dannunziani, agli smarrimenti fiacchi dell’Italia ufficiale, questa società filosofico-morale-incessantemente-operante, che è la filosofia della nuova generazione, mi dilacera, mi soffoca, è la mia tragedia ed io le canto all’incontro l’osanna ed io sono qiui, dinnanzi a lei, come la vittima sacrificata che lecca le mani al sacrificatore. – Quasi ogni verso qui è non sai se l’elegia o il peana della vita breve e dolorosa d’ogni giorno, la quale ti lascia in cuore lo sconforto e l’amaro ma è pregna dell’infinito, ma di cui il pensiero ti assicura ch’è il ritmo stesso dell’universo, ma in cui nella rinunzia del singolo, del gramo atto trovi l’esaltazione della divina pienezza. (…)
E poiché ho accennato di canzoni dantesche, dirò ch’io respiro in questa nuova poesia non so ch’è di vigorosamente antico nel sentire e nel ritmo, nello strappo, nel piglio maravigliosamente robusto della frase, nell’interiore leoninità della mossa; (in questo suo vittorioso tormento fra la tremenda vastità del cosmo ed il dolore dell’effimera umanità), dirò ch’io vi respiro qualcosa di nostro, di tradizionalmente, di virilmente e complessamente italiano (…). E ch’io, anche qui, non oserò mai, come i domineddio della critica si permetton di fare, o chiudere o aprire l’avvenire a nessuno, perché l’intimo degli uomini si strafotte delle previsioni dei critici e vivaddio di ogni previsione. (Perché, io dico con certezza: qui ciclopicamente vive, qui si dibatte, come un maglio, come un rosso ferro che strida e che suoni – che si lamenti tinnulo – in una fucina, un cuore, e non so affatto, non voglio sapere qual forma qual iridata incandescenza nuova sarà per pigliare all’ansito nuovo del nascosto mantice, quale ispirazione ispirerà il suo futuro canto); ma segno qui, mi vien voglia di segnar qui per parecchia di codesta poesia un anno durante inosservata, (per ciò che è e ciò che dentro quasi per echi, vi posso auscultare, trudire, intuire), mi vien voglia di segnar commosso qui la parola GRANDE.”
Boine, attento sempre che l’innovazione a tutti i costi non fosse deragliamento e deriva di microcosmi incomunicanti e incomunicabili tra loro, ci avverte (avverte anche noi che discutiamo di poesia cent’anni dopo) che vi è una linea imperscrutabile e sottile, che rischia spesso la lacerazione, in cui l’io fuoriuscendo tradisca se stesso e la sua poetica missione. E ci vien chiaro da dire che sì, agli inizi del ‘900 il rinnovamento profondo passò anche da qui (sopratutto da qui, per quel che mi riguarda), dal cuore e dal raccogliere e vibrare nella tradizione piena il Nuovo che avanzava (a briglia sciolta e frustate da chi ne aizzava ogni risoluzione in corsa) rischiando di spazzar via anche il vibrare concreto della poesia.
Così è bene cercare in modo diacronico, ciò che ciclicamente appare per essere risolto, spinto in avanti nei modi e con le istanze che ogni tempo richiede.
Gino Rago ha fatto un gran bell’intervento, limpido ricco, partendo dal quale (mi auguro) ad un prossimo Laboratorio si potrebbero sviluppare i discorsi qui accennati nei commenti.
"Mi piace""Mi piace"
Carissima Chiara, la tua citazione di Boine mi sembra ben introdotta e importante, a questo punto della discussione: quella linea che tu efficacemente chiami “imperscrutabile e sottile” purtroppo non è facile riconoscerla e, talvolta non oltrepassarla, perché è il limite sottile e misterioso che separa (e unisce) l’ “io”, l’essere personale, dall’ “Ego” che è la superfetazione patologica dell’ “io”, da cui siamo continuamente attratti e trascinati su percorsi aberranti o gratuiti. La difesa dell’ i”o” è fondamentale nella Poesia Ontologica perché ogni straripamento dell’ “Ego” si riflette sull’essere e impedisce quel misterioso passaggio di linfa poetica dall’ “essere” di ognuno di noi alla parola che dev’essere fecondata e radicalmente trasformata in modo non visibile ma percepibile tanto da rinascere, o risorgere emanando l’ “essere” (io profondo, essenza della persona) e comunicandolo (ricevendo) alle altre parole la linfa che ha ricevuto dall’io del poeta. Se l’ “Ego” prende il posto dell’ “io” la Poesia ontologica si trasforma in poesia “egologica” cioè autoreferenzaiale e gratuita. Sono d’accordo con te anche sulla necessità di lavorare in senso diacronico seguendo i cambiamenti del mondo culturale e sociale, ma sottolineo l’importanza di lavorare anche in sincronia con la maturazione dell’io e del suo approfondimento nell’ “essere” che, come il mondo, evolve e si trasforma. Propongo di fermarci più a lungo sui temi introdotti dai poeti dell’Ombra e di non introdurre immediatamente altri temi a scapito degli approfondimenti. La presentazione di nuovi poeti o la rivisitazione di quelli del passato può andare avanti senza interferire sui laboratori, come d’altra parte anche adesso avviene. Grazie per il tuo intervento chierificatore, Chiara!
"Mi piace""Mi piace"
“Gino Rago ha fatto un gran bell’intervento, limpido ricco, partendo dal quale (mi auguro) ad un prossimo Laboratorio si potrebbero sviluppare i discorsi qui accennati nei commenti”… e difatti è così, lontano da me il proposito di una critica negativa o d’attacco nei suoi confronti… ho scritto semplicemente altro e quel che pensavo, insomma quando scrivo di poeti o di poesia non posso non fare a meno di mettere a confronto questo poeta con altro, della stessa o d’altra letteratura o cultura come si dice… vado a strati, a scalette come se dovessi affrontare una salita o una discesa, e se qualche sassolino (piccolo poeta) o qualche sasso (un poeta) rovina giù, non me ne curo più di tanto e allora vado giù negli inferi o al contrario nelle sfere… e nei giudizi sono colmo di capricci e di varie giocolerie… non bisogna trovare simboli o poeti dappertutto….
"Mi piace""Mi piace"
Antonio infatti, stavo proseguendo il ragionamento: non era, quella frase, una risposta al tuo intervento, quanto un addentrarmici, portando quel che conosco dei nostri. Proprio l’intento di addentrarci – soffermarci, intendo – su alcuni interventi, dove si sviluppa, come qui, un bel confronto. Che poi a me interessa particolarmente, perché ogni volta voi risvoltate, mettete in luce, riscoprite. Insomma, dialogate: anche animatamente come è giusto.
Peraltro ciò che dici, che da Rebora non poteva scaturire una forma modernissima (cito), è sacrosanto. Mi interessa il punto di vista di Boine, non dando risposte ma aprendo altri quesiti a proposito: su come accada che il meccanismo s’inceppi, su come accada che ad un certo punto la poesia si manifesti libera negli intenti e pure nella forma…
"Mi piace""Mi piace"
L’ha ribloggato su gabriellacintie ha commentato:
Non so se si vedrà quanto scrivo, in quanto non pratica di blog dal punto di vista tecnologico ma vorrei aggiungere una voce di plauso a questo ardito compito di ” rifondamento” del fare poetico (letteralmente) . Certamente complesse sono le nuove direzioni da Lei e da Linguaglossa additate verso quello “spazio espressivo Integrale” tanto più difficile da esplorare perché espanso e vertiginosamente trasversale, almeno per ciò che ne intendo. Perché , al di là dei contenuti, mi sembra che il raggio esplorativo, in questa nuova ottica, si ampli in modo esponenziale, attraversando anche la concretezza della realtà per cortocircuitarla in un carotaggio assai più eversivo che il cosiddetto correlativo oggettivo. Ma in forma diversa, si ripropone quella tensione verso l’oltre, lo strumento principe della metafora che , se è veramente poetica, non può non essere ontologica. Cambiano le coordinate e il compito è ancora più arduo, illuminare l’abisso nelle schegge del quotidiano.
Tuttavia questo eroismo immette nuova linfa di freschezza nella poesia di oggi, quel lievito del divenire che mi sembra una conquista titanica e, al contempo, un imprescindibile afflato ispirativo.
"Mi piace""Mi piace"
NOI NON SIAMO SACERDOTI DELLA POESIA, SIAMO DEI POETI CHE VOGLIONO RICOMINCIARE A SCRIVERE POESIA. (LA NUOVA ONTOLOGIA ESTETICA).
Quanto scrive Gabriella Cinti mi conforta e mi spinge ad andare avanti nella riflessione sulla Nuova poesia, giacché la poesia deve rinnovarsi altrimenti rimane prigioniera e subalterna di impostazioni concettuali che appartengono ad altre stagioni spirituali e stilistiche.
Quello che tento e tentiamo di fare è costruire una base (anche) filosofica per la nuova poesia, dimostrare che c’è già in atto una nuova filosofia. Citare i filosofi contemporanei, quelli che si occupano dei problemi di cui, su un altro versante, si occupano i poeti di oggi, significa esplicitare che qualcosa di essenziale è cambiata rispetto alle impostazioni di cento anni fa, quelle reboriane e anche quella di Pasolini, il quale non ha potuto portare a compimento il suo progetto di riforma radicale del linguaggio poetico per intervenuta cessazione della sua vita ad opera di assassini di cui ancora oggi sconosciamo nomi e identità. E mi sia consentito dire una cosa molto semplice, anche Montale, con la poesia “Lettera a Malvolio” si è reso corresponsabile del linciaggio di Pasolini. Diciamolo con schiettezza: Montale non avrebbe mai dovuto scadere così in basso e additare l’equazione Pasolini=Malvolio. Era vero il contrario: Montale=Malvolio.
Lo dico e lo ripeto ancora una volta: Montale con Satura (1971) e poi con il Quaderno dei quattro anni del 1971 e del 1972 (1973), mette la poesia italiana in discesa, apre il rubinetto della falsa poesia in discesa, apre alla demagogia di una forma-poesia che si adatta e si arrende alla nuova barbarie mediatica. Si trattava di una resa intellettuale, di una smobilitazione generale, di un rompete le righe e di un si salvi chi può. Quella poesia era una poesia in minore, una pseudo poesia. E questo sia sempre detto con la massima chiarezza e sia ripetuto per i più giovani. Era una falsa sirena ammaliatrice perché Montale metteva in circolo i virus della disintegrazione della poesia a fronte della civiltà mediatica. Montale chiudeva la poesia non in una nicchia ma nel passato remoto. E questo atto di resa intellettuale risulta ormai chiarissimo a circa 50 anni di distanza da Satura.
Montale pubblica il Diario del ’71 e del ’72 due anni dopo Satura, mentre le raccolte precedenti avevano visto passare tredici-quattordici anni di pausa tra l’una e l’altra. Nel febbraio del 1971 Montale aveva dichiarato: “Non si tratta di intervalli programmati […]. Non credo sia possibile che appaia un mio quinto libro. Ciò dovrebbe avvenire nel 1985. Non è augurabile né a me né agli altri”[1].
Quanto dichiarato in questa auto intervista, all’uscita di Satura, non è un depistaggio perché in effetti l’autore, che spesso aveva espresso dubbi sulla prolificità della propria ispirazione, compose il Diario, tranne otto poesie, a partire dalla primavera del ’71 e già a fine luglio la prima metà della raccolta (45 poesie), l’intero Diario del ’71, era pronta, tanto che Scheiwiller la pubblicò in occasione del Natale dello stesso anno. Anche il Diario del ’72 ha una genesi breve, divisa in due tempi: il primo da gennaio a marzo; il secondo, dopo una malattia, da settembre a fine ottobre.
Nel Diario del ’71 e del ’72, Montale si allontana dal tono polemico che aveva trovato posto già nelle prose degli anni ’50 e ’60 per poi mostrarsi a pieno in Satura. I temi di cui si compone l’opera spaziano da riflessioni dell’autore sulla poesia stessa (A Leone Traverso, L’arte povera, La mia musa, Il poeta, Per una nona strofa, Le Figure, Asor, A caccia), alla polemica contro l’opportunismo dei suoi tempi, espressa nel genere della lettera in versi (dalle Botta e risposta di Satura a, soprattutto, la Lettera a Malvolio, uno dei componimenti fondamentali dell’opera, polemicamente indirizzato a Pier Paolo Pasolini), i testi che Montale popola di piccoli eventi quotidiani osservati dalla finestra del suo appartamento milanese e quelli di argomento metafisico-teologico. Esistono anche precisi luoghi del Diario che richiamano Satura e la restante produzione del poeta, come dimostra chiaramente soprattutto Annetta, per esempio con la citazione, tra le altre, de La casa dei doganieri.
«La mia voce di un tempo – si può sempre paragonare la poesia a una voce – era una voce, per quanto nessuno l’abbia detto, un po’ ancora ore rotundo diciamo così; anzi dissero che era addirittura molto prosastica, ma non è vero, riletta ora credo che non risulti tale. La nuova invece si arricchisce molto di armoniche e le distribuisce nel corpo della composizione. Questo è stato fatto in gran parte inconsciamente; poi, quando ho avuto alcuni esempi, diciamo, di me stesso, allora può darsi che io abbia seguìto degli insegnamenti che io mi ero dato. Ma all’inizio no, è stata veramente una cosa spontanea»[1].
Nelle prime tre raccolte Montale aveva utilizzato un linguaggio a volte criptico, con molte allusioni. A partire da Satura, le sue poesie diventano più facilmente comprensibili anche per un lettore che non conosca l’evento biografico che sta dietro il testo poetico.
Angelo Jacomuzzi ha parlato di “elogio della balbuzie”[2], in riferimento alla fase della poesia montaliana iniziata con Satura. Da allora tutta la restante poesia italiana ha parlato il linguaggio della balbuzie. Dobbiamo dirlo con franchezza: tutta la poesia posteriore a Satura parlerà un linguaggio dimidiato, balbuziente, affetto da impotenza. Non credo che c’entri nulla la questione della perdita di fiducia di Montale nei confronti della poesia, forse nessuno come noialtri della Nuova Ontologia Estetica ha più s-fiducia di Montale, io personalmente non ho alcuna fiducia nella poesia, molto meno di quella di Montale, ma la sfiducia, come anche la fiducia, sono atti di fede e io non sono un credente: non devo fare nessun atto di fede verso nessuna deità, tanto meno verso la Musa. Montale è ancora un poeta legato ad una cultura che vedeva nella poesia un luogo «sacro» in cui inginocchiarsi e pregare, io e i miei compagni di strada pensiamo che il «sacro» della poesia non ha nulla a che fare né con i miei (NOSTRI) atti di fede né con la fede purchessia. Io (NOI) non faccio (FACCIAMO) poesia perché sono (SIAMO) dei sacerdoti della poesia. Dio ce ne scampi e liberi dai sacerdoti della poesia! Questo era ancora il concetto che aveva Montale della poesia. Che non è il nostro. Noi non abbiamo alcuna fiducia verso alcuna cosa, tanto meno verso quella cosa chiamata poesia. Non scriviamo poesia per un atto di fiducia o di s-fiducia ma per un disegno intellettuale preciso.
Montale scrive: «Incespicare, incepparsi / è necessario / per destare la lingua / dal suo torpore. / Ma la balbuzie non basta / e se anche fa meno rumore / è guasta lei pure. Così / bisogna rassegnarsi / a un mezzo parlare»[3]
Montale scrive una «poesia del dormiveglia» come è stata battezzata ma con l’animus di chi ha perduto la fede nel suo dio:
La mia Musa è lontana: si direbbe
(è il pensiero dei più) che mai sia esistita.
Se pure una ne fu, indossa i panni dello spaventacchio
alzato a malapena su una scacchiera di viti.
Sventola come può; ha resistito a monsoni
restando ritta, solo un po’ ingobbita.
Se il vento cala sa agitarsi ancora
quasi a dirmi cammina non temere,
finché potrò vederti ti darò vita.
La mia Musa ha lasciato da tempo un ripostiglio
di sartoria teatrale; ed era d’alto bordo
chi di lei si vestiva. Un giorno fu riempita
di me e ne andò fiera. Ora ha ancora una manica
e con quella dirige un suo quartetto
di cannucce. È la sola musica che sopporto[5].
Io (NOI) invece scrivo (SCRIVIAMO) una «Preghiera per un’ombra», nella quale, e voglio dirlo, con un «pieno parlare» rimetto (RIMETTIAMO) in piedi la poesia italiana del dopo Satura. La Nuova Ontologia Estetica è questo: per chi non l’abbia ancora compreso: rimettere in piedi la poesia italiana, Noi non siamo i sacerdoti della sacra Musa, fare i sacerdoti non è il nostro mestiere, SIAMO DEI POETI CHE VOGLIONO RICOMINCIARE A SCRIVERE POESIA.
E su questo punto sarei curioso di conoscere i punti di vista degli interlocutori della rivista (Mario Gabriele, Steven Grieco-Rathgeb, Giuseppe Talia, Lucio Mayoor Tosi, Donatella Costantina Giancaspero, Gino Rago, Letizia Leone, etc.) e dei lettori tutti.
Grazie.
[1] Montale, Il secondo mestiere: arte, musica, società, p. 1699.
[2] a b c Jacomuzzi, La poesia di Montale. Dagli “Ossi” ai “Diari”, pp. 146-73.
[3] a b c d e f Montale, Diario del ’71 e del ’72, p. 194.
[4]. Montale, Satura. 1962-1970.
[5] Montale, Diario del ’71 e del ’72, pp. 75-6.
"Mi piace""Mi piace"
Caro Giorgio,
rispondo al tuo invito a esprimere un parere sulla N.O.E., ossia se ciò che stiamo facendo e realizzando, sia un evento utile alla poesia italiana, come ricambio estetico e formale, dopo il vuoto lasciato da Montale con Satura del 1971.
Da questa data in poi se si eccettuano i risultati della Neoavanguadia e gli esiti di Pasolini, non esistono cartografie poetiche in grado di stare nella bacheca storica come documenti innovativi e propositivi. Da che cosa nasce questo vuoto formativo di linguaggio poetico? Non sono pochi i fattori che l’hanno determinato. E mi rifarei soprattutto alla crisi mondiale che attanaglia la società e i popoli, la disoccupazione giovanile, la povertà della classi sociali martirizzate da una democratura che cerca di limitare i diritti dei cittadini pur di vivacchiare sul debito pubblico senza ridurlo, mentre in Siria, si usano armi micidiali contro i soggetti più deboli. Con questo clima non c’è posto per la poesia che è sinonimo di avanzamento culturale e sociale, ciò che manca ai cavernicoli della poesia tradizionale ostativi a qualsiasi forma di rinnovamento.. Ogni popolo interpreta differentemente la realtà in quanto conoscibile attraverso il filtro del linguaggio. Tutto il processo di significazione: espressione, referente e contenuti, risente dei condizionamenti culturali. Non esistono visioni della realtà corrette, ma ogni sua manifestazione ha significato e validità solo all’interno di un determinato contesto culturale.
Avrei i miei dubbi, qualora questo rinnovamento fosse Introdotto da un poeta, singolo e appartato. Ma dal momento che la N.O.E. è ormai diventato un soggetto plurale, che ha al suo seguito nomi importanti, allora non posso che essere favorevole alla tua battaglia culturale, che ci aiuta a non essere soli, e a superare momenti di solitudine di fronte alle menti, che così ostativamente alzano barriere inconciliabili con il nostro progetto. Il fatto è che stare a fronteggiare certi ritornelli di poeti a difesa dei loro papiri, si perde tempo, acqua e sapone. E qui, riprendo un vecchio assioma di Hume-Darwin che riscontrava la “pariteticità sostanziale dei processi mentali umani e animali” Su questo piano non avremo mai una linea di superamento in quanto la funzione della sinapsi per questi soggetti resta alla stato soporifero. Personalmente ho ritenuto che la poesia dovesse prendere tangenziali opposte alle vecchie gallerie, per esistere come “soggetto” come “idea” come “anima” .
E mi pare che ci stia riuscendo, lavorando onestamente su questo tema. Andare avanti è il passepartout contro ogni check-in dello status mentale arcaico.
"Mi piace""Mi piace"
NOI NON SIAMO SACERDOTI DELLA POESIA, QUEL CULTO LO LASCIAMO AGLI UOMINI DI FEDE CHE TANTI DISASTRI HANNO COMBINATO
Forse “Un’immortale bellezza/ Uscirà dalla nostra rovina”…
XIV
O pioggia dei cieli distrutti
Che per le strade e gli alberi e i cortili
Livida sciacqui uguale,
Tu sola intoni per tutti!
Intoni il gran funerale
Dei sogni e della luce
Nell’ora c’ha trattenuto il respiro:
Bùssano i timpani cupi,
Strìsciano i sistri lisci,
Mentre occupa l’accordo tutti i suoni;
Intoni il vario contrasto
Della carne e del cuore
Fra passi neri che han gocciole e fango:
Scivola il vortice umano,
Vibra chiuso il lavoro
Mentre s’incava respinta l’ebbrezza.
Ma tu, ragione, avanzi:
Onnipossente a scaltrire il destino,
Nell’inflessibil mistero
A boccheggiare ci lasci;
Ma voi, rapimento e saggezza
In apollinea gioia
In sublime quiete,
Al marcio del tempo le nari chiudete
O mitigando l’asprezza
Nella fiala soave dell’estro
O vagheggiando dall’alto
La vita, che qui di respiro in respiro
È con noi belva in gabbia chiusa!
Un’eletta dottrina,
Un’immortale bellezza
Uscirà dalla nostra rovina.
(Clemente Rèbora, Frammenti lirici, 1913)
"Mi piace""Mi piace"
DAL FRAMMENTISMO DEL 900 AL FRAMMENTO DELLA NUOVA ONTOLOGIA ESTETICA
Antefatti estetici a Laboratorio Poesia del 30. 3. 2017 che sono destinati a integrare la mia relazione e soprattutto a completare la mia nota di lettura di “Preghiera per un’ombra” di Giorgio Linguaglossa, antefatti
non proposti in Laboratorio per non sfondare i 12 minuti a me concessi dalla eccellente coordinatrice del Laboratorio Poesia Gratuito Rita Mellace,
Il poeta della N.O.E medita da anni sulla “Teoria estetica” di T. W. Adorno. Fa suo l’assioma adorniano secondo cui: “I segni dello sfacelo sono il sigillo di autenticità dell’arte moderna”. Per tale via maestra egli adotta la poetica del “frammento” come elemento costitutivo d’una sua personale ontologia estetica. La quale, partendo dalla “morte di Dio”, assume in sé la constatazione della fine della visione platonico-cristiana del mondo e della conseguente scomparsa del “centro dell’uomo nel mondo”. La sua ricerca d’arte ne prende atto e si muove nella persuasione della decadenza della “verità assoluta”, della impossibilità di ricondurre la frammentarietà ad una unità di senso. Entrando nella filosofia del frammentismo, il poeta della N. O. E. assume il “frammento” a cifra caratteristica della modernità poiché alla sua personalissima lettura il mondo moderno si pone sotto il segno della deflagrazione del “senso”, della dispersione, dell’astigmatismo scenografico, della moltiplicazione delle prospettive, della crisi e della inadeguatezza espressiva di un “unico”linguaggio. Nella teoria estetica dell’opera moderna il poeta della N. O. E. interpreta il prospettivismo di Nietzsche come una promozione della “frammentarietà” contro le tesi di quell’ordine metafisico incentrato sulla verità dogmatica, sulla verità indiscutibile.
La poetica del frammentismo tende a esiti estetici del tutto nuovi poiché la “filosofia del frammento” è in grado di restituire “dignità estetica” a quelle irriducibili singolarità che caratterizzano l’esperienza concreta di ciascuno perché il frammento è l’intervento della morte nell’opera d’arte. Rifondando l’opera, o distruggendola, la morte da essa elimina la macchia dell’apparenza. Ma ciò che conta è che per il poeta della Nuova Ontologia Estetica e dello Spazio Espressivo Integrale, il “frammentismo” va oltre il significato di “poetica”, va oltre le intenzioni d’arte. Il frammentismo in lui è una Weltanshauung. E’ uno stato d’animo. E’ il suo modo di sentire il mondo, di sentirsi egli stesso “frammento” di questo mondo poiché risiede in lui stesso l’unico punto di convergenza e di fusione di quella che Harold Bloom** ha definito “la cartografia psichica” dell’artista: l’agonismo perenne tra l’ “Io me stesso – l’anima – l’Io reale”.
Roma, 7 aprile 2017
** Harold Bloom, Il Canone Occidentale, BUR Rizzoli, 2016
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
Alfredo de Palchi, Helle Busacca, Angelo Maria Ripellino I NOSTRI POETI DIMENTICATI
Il Canzoniere di Petrarca, la cui prima edizione a stampa si ebbe nel 1470 a Venezia, porta il titolo meno conosciuto di Francisci Petrarchae laureati poetae Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti di componimenti in volgare di Francesco Petrarca, poeta coronato d’alloro). Tanta poesia è passata sotto i ponti da allora e i “frammenti” del canzoniere di Petrarca altro non sono che la diversità di componimenti, sonetti, madrigali, ballate, sestine, che lo compongono, tutti però legati a filo doppio attorno a un leitmotiv: l’autobiografia spirituale del poeta, o, come afferma Contini “una storia sacra di un amore profano.”
Simiglianze del Petrarca si possono trovare persino in Leopardi: “Ed in questo pensier l’alma respira” (canzone CXXIX) “ E il naufragar m’è dolce in questo mare” (L’Infinito).
Da allora, come ora, l’epigonismo petrarchesco ha trovato facile terreno. Tutt’ora vi sono poeti che emulano la perfezione strutturale del sonetto petrarchesco, dimenticando o disconoscendo l’evoluzione dello stesso in autori come Saba, Montale (che lo celava in altre forme) fino all’ipersonetto di Zanzotto, il quale lo reinventa attualizzandolo, e nello stesso tempo, recuperando tutta la tradizione letteraria maggiore della poesia italiana. Si veda, ad esempio, il sonetto “Di Sterpi e di Serpi” (contenuto nella silloge Galateo in Bosco ,1978, in cui le regole del galateo contrastano con il bosco, in un ossimoro polivalente), si noti come la siepe di leopardiana memoria si trasformi in Zanzotto in sterpo popolato di serpi.
Il frammentismo vociano, che ha radici pascoliane e post-d’annunziane, rappresenta nella poesia italiana dei primi del novecento, l’inizio della “forma costruita e oggettiva”. Soffici, Papini, Sbarbaro, Boine, inaugurarono una nuova forma poetica in cui l’oggettivo si muove tra discussione filosofica e interpretazione critica.
Della fatidica data del 1971 si è parlato a lungo. Il 1971 , nella poesia maggioritaria italiana si registra uno scompiglio, un rimescolamento, alcune rotture definitive e alcune ricostruzioni o restaurazioni che hanno ulteriormente frammentato stili e poetiche. Si è già detto, in un precedente commento, che tra i maggiori del tempo, Montale, Pasolini e Luzi, il 1971 rappresenta un giro di vite: Montale e Pasolini perdono la memoria storica e tradizionale (la sacrificano), Luzi, invece, la recupera, fuoriuscendo definitivamente dall’ermetismo.
Oggi, sappiamo che Pasolini aveva intenzione di riformare la poesia italiana, dopo l’uscita di Trasumanar e Organizzar, orientandosi nel recupero della tradizione dantesca del plot complesso, del plurilinguismo, della mescolanza di stili (vedasi vulgarium fragmenta di Petrarca ndr), che dopo la morte violenta del poeta non è certo possibile sapere degli sviluppi ulteriori che tale intuizione o intenzione avrebbe portato. Non si deve dimenticare, però, che autori singolari e di rilievo nel frattempo venivano fuori da quella fatidica data: Alfredo de Palchi, Helle Busacca, Angelo Maria Ripellino, il cui Autunnale Barocco del 1977 (la domanda di Linguaglossa su chi avrebbe meritato il Nobel in Italia dopo Montale trova in questi tre nomi statura statuaria fuori canone), lo consacra nell’itinerario del meraviglioso, della poesia-spettacolo (Sagredo è il degno continuatore della linea). Purtroppo l’indifferenza ha ammantato tutti e tre gli autori, relegandoli nella semi-ombra da una cecità consapevole e ideologica.
La Nuova Ontologia Estetica, nasce da una felice intuizione di Giorgio Linguaglossa, l’unico critico in Italia capace di censire, nel bene e nel male, l’andamento della poesia italiana, dando credito e voce ad autori che altrimenti non avrebbero avuto voce alcuna. La N.O.E nasce dalla “Belligeranza del Tramonto” di Linguaglossa (titolo alquanto predittivo). Chi ha modo di leggere il saggio di Giuseppe Pedota “La Nuova Poesia Ontologica di G. Linguaglossa, edito da LietoColle 2007 potrà capire la linea di demarcazione che traccia il cambio di paradigma verso “lo spazio espressivo integrale”, gradualmente e insistentemente portato avanti dall’Eclettico (leggasi sineddoche) fino alla più ampia realizzazione attraverso la realizzazione del mezzo di divulgazione di massa, L’Ombra delle Parole. (La poesia linguaglossiana dice ciò che dice ma intende altro).
Ad onor del reale, non tanto del vero, perché il reale è ciò che esiste, la prefazione de La Belligeranza del Tramonto è di Dante Maffìa, il quale scrive “La Belligeranza del Tramonto è un’opera che ha la potenza delle colonne doriche di un nuovo Partenone”. La diatriba tra i due autori potrebbe, forse, ascriversi nella letteraria tradizione di amore-odio che ha, per esempio, connotato il rapporto che intercorreva tra Quasimodo-Ungaretti-Montale? E’ una domanda che ci poniamo e poniamo a futura memoria.
Ad ogni modo, autori diversi compongono la rivista N.O.E., come nei “vulgarium fragmenta”, ma tutti accomunati da una determinata consapevolezza che la poesia italiana debba essere rifondata dalle fondamenta. E non è certo questione di abolire l’enjambement a discapito di una spezzatura del periodo frastico con punteggiature e correttezza ortografica quanto, piuttosto, di “interrogazione radicale”.
Io, personalmente, con i miei dardi a sei punte, tra celebrazione e critica totale cerco nel mio piccolo di muovermi verso l’interrogazione radicale, la quale, una volta posta, esige una risposta.
Della poesia Preghiera per un’Ombra, diremo più avanti, poesia di dialogo metafisico e di memoria.
"Mi piace""Mi piace"
Nella sua visione ravvicinata, circoscritta e lenticolare, il ricercatore-poeta spesso dimentica che la “deflagrazione del senso” andrebbe anche ricondotta alla decadenza del consumismo, così come narrata con grande anticipo da Antonioni in Zabriskie Point, nella famosa scena dell’esplosione. Nella realtà odierna, nelle periferie e nei piccoli paesi, chiunque può osservare l’impressionante sequenza di capannoni sfitti, la serie infinita di insegne “americane” abbandonate, attività messe in vendita che nessuno comprerà più, segno che quell’ “unico linguaggio”, quello commerciale ( non solo filosofico) si sta esaurendo in modo irreversibile. Non a caso la gran parte delle persone, la gente, oggi si sente disillusa e defraudata continuamente da quel mondo, ed è portata a credere che in quel mondo di finto benessere ci stia anche tanta arte e poesia.
Nel suo interessantissimo scritto, Gino Rago – grazie per averlo pubblicato – fa notare che ” Rifondando l’opera, o distruggendola, la morte da essa elimina la macchia dell’apparenza”. Di conseguenza i poeti tornano a farsi specchio, testimonianza di un’epoca in disfacimento e rapida evoluzione. Gino Rago fa giustamente notare che “Il frammentismo in lui (il poeta) è una Weltanshauung. E’ uno stato d’animo. E’ il suo modo di sentire il mondo, di sentirsi egli stesso “frammento”. Forse senza nemmeno averne piena coscienza, il poeta NOE ( preferisco scrivere NOE senza punti, alla maniera di Mario Gabriele) sta esprimendo il sentimento comune, ontologico, di buona parte dell’umanità. Saperlo ci aiuterebbe ad uscire dalla parrocchia delle belle lettere. Infatti Giorgio lo scrive con massima chiarezza e sincerità: “Noi non siamo i sacerdoti della sacra Musa, fare i sacerdoti non è il nostro mestiere, SIAMO DEI POETI CHE VOGLIONO RICOMINCIARE A SCRIVERE POESIA”.
"Mi piace""Mi piace"
https://lombradelleparole.wordpress.com/2017/04/05/gino-rago-arte-dello-scrivere-due-frammentisti-vociani-a-confronto-clemente-rebora-aldo-palazzeschi-e-pier-paolo-pasolini-un-contributo-alla-rilettura-del-novecento-poetico-italiano-e-un-c/comment-page-1/#comment-19099 Intenzioni encomiabili: riflettere la crisi in una struttura stilistica frammentaria che esprima il dissolvimento dell’unità spirituale e la paura della precarietà esistenziale, e sia capace di solidarietà con l’indigenza di chi non ha tempo da dedicare alla bellezza, sopraffatto com’è da problemi di sussistenza o di sopravvivenza. Tutto questo è ampiamente condivisibile. Il fatto è che trovo istanze alquanto diversificate: il gruppo di cui questi amici, a cui rivolgo la mia attenzione critica da diversi mesi, si sentono parte intende “ricominciare a scrivere poesia” dopo che dal 1971 nessuno, in pratica, è stato all’altezza di farlo, o in quanto naufragato nell’ego, evaporato in formalismi antiquati di stampo petrarchesco, o in quanto incapace di tradurre in forme espressive moderne una crisi di valori di cui l’arte deve essere il riflesso attuale e vivo. Per quanto si possa essere d’accordo, il problema di fondo, a mio avviso, non sono le intenzioni potenzialmente condivisibili, ma la consapevolezza di essere portatori di un’autenticità e di un’innovazione che non si vede altrove. Questo è a mio avviso molto discutibile. La ricerca poetica ispirata dalla scienza e dalla filosofia è una necessità, ne sono convinto, eppure il pensiero critico di chi vive il problema dell’evoluzione teorica, perlomeno scientifica-epistemologica, dall’interno viene dimenticato se non ignorato, in nome di generiche istanze progressiste che si ritengono prerogativa solo di una minoranza: chi non condivide una certa forma di poetica è fuori, ai margini del dialogo, portatore di valori superati. Eppure, credo, laddove si parla di poesia non si tratta di voler essere nuovi, ma di essere ricchi interiormente, quindi disposti a mettersi in crisi e a ripartire anche da zero. Mi vengono in mente due episodi. Il primo riguarda la mia teoria del tempo interno, in aperto conflitto con la teoria del tempo proprio relativistico. Ebbene, la rivista (Foundations of physics, diretta da Carlo Rovelli) che mi ha pubblicato lo scorso anno l’articolo “Physical time and thermal clocks” l’ha accolto in quanto conteneva un’analisi critica del concetto di tempo relativistico, laddove la stessa rivista qualche anno prima (con un diverso direttore) aveva rifiutato due miei articoli sullo stesso tema senza sottoporli nemmeno a peer review, in quanto riteneva (testualmente) che la teoria della relatività fosse indiscutibile, essendo ormai definitivamente provata sperimentalmente. Il secondo riguarda una mia recente visita a un museo di arte moderna, in cui alcuni quadri erano segni informi sulla tela e alcune sculture erano mucchi di mattonelle o accostamenti arbitrari di pietre: il tema dell’opera si riduceva, in pratica, al titolo. Di fronte alla mia perplessità mi è stato detto che gli artisti sono creature diverse e particolari, spesso incomprensibili per i loro contemporanei, portatori evidentemente di una spiritualità superiore. Ebbene, confesso il mio disorientamento profondo. Un’arte che non sappia parlare, trovare un’armonia tra artista e fruitore, è un prodotto schizofrenico, un frammento amorfo e senza necessità espressiva. L’arte nasce da un contatto profondo, da un dialogo implicito, anche quando l’artista sembra parlare una lingua morta. E’ la ricchezza interiore, la capacità di scavo e di trovare luce nella notte dell’esistenza, che splende come volontà di condivisione e, perché no, come un dono di bellezza e armonia a chi per contingenze dolorose non è in grado di produrle. Il problema, sono d’accordo, è il senso che possono avere la bellezza e l’armonia nel contesto di una crisi globale di valori e di spiritualità: su questo varrebbe la pena senz’altro discutere, senza pregiudizi di sorta. La crisi a cui si fa riferimento sul piano spirituale-filosofico è in atto da almeno 150 anni, per non dire di più, visto che il pensiero leopardiano contiene più di un germe del nichilismo di Nietzsche, laddove la crisi politica ed economica della società ha radici millenarie, in quanto da sempre ci sono oppressori e oppressi, popolazioni che vivono nel benessere e masse affamate e sofferenti, per non parare di deliri di onnipotenza e intolleranze religiose. Siamo d’accordo che dobbiamo aprire gli occhi sull’oggi, essere capaci di leggere nelle fibre problematiche dell’attualità: come si può non esserlo? Ma non convenite che un’evoluzione spirituale e poetica debba essere portata avanti nell’ottica di un confronto aperto con sensibilità e intelligenze diverse? Che la poesia non può chiudersi in gruppi minoritari di ricerca, ma arricchirsi nello scambio, nell’umiltà del confronto, nella fertile dimenticanza dell’ego che nella mente di qualcuno sta producendo inquietanti effetti di intolleranza, in nome addirittura del darwinismo, come ci fossero specie poeticamente elette e altre destinate alla sparizione in quanto inadatte alla sopravvivenza?
"Mi piace""Mi piace"
“Egregio Sig. Borghi, riporto qui di seguito quanto dice: “nella mente di qualcuno sta producendo inquietanti effetti di intolleranza, in nome addirittura del darwinismo, come ci fossero specie poeticamente elette e altre destinate alla sparizione in quanto inadatte alla sopravvivenza”. Ebbene, il suo richiamo si collega a ciò che ho inteso riportare su questa pagina a proposito del darwinismo. Il modo, velato e poco signorile,con cui ha voluto celare la mia presenza, non le fa onore, e per di più appartengono ad una prigionia culturale che non ammette avanzamenti propositivi, diversi dal suo fisiologico “sentire e vedere” la realtà, Per cui il mio richiamo a Darwin e Hume sul concetto di “pariteticità sostanziale dei processi mentali umani e animali”, da me riportati in questa pagina, e che lei ha trovato, come al solito, il modo di contraddire “Uno e Centomila” nella grazia di Dio e degli schemi metafisici e poetici, trova corrispondenza in quelle menti,(la sua) che da un lato si presentano come progressiste, ma che in effetti, sono il risultato di una dissociazione del divenire, che resta il vero viaggio naturale dell’uomo, e che nessun omino paleolitico può fermare o contestare.
"Mi piace""Mi piace"
Signore Gabriele, fino a prova contraria, se c’è una persona che sistematicamente giudica e spesso irride dall’alto di una presunzione di non si sa quale superiorità (culturale? generazionale?), questa è lei. Vada a rileggersi quello che mi ha scritto in repliche passate, sempre sopra le righe di fronte a un mio atteggiamento di totale pacata apertura e disponibilità al dialogo. Quindi non rovesci la frittata, giudicando me poco signorile, laddove lei, perlomeno nei miei confronti, la signorilità non sa nemmeno cosa sia. Un uomo della sua levatura culturale, apprezzato e stimato, non deve cedere all’impulso di esternazioni tanto gratuite quanto banali. Avere un interlocutore con cui confrontarsi è un privilegio, non un’occasione, come sistematicamente fa lei, per metterne in evidenza i presunti limiti, cosa che potrei fare benissimo anch’io con lei. Il rispetto è un valore che lei non conosce evidentemente, soprattutto laddove giudica cose e persone che conosce in minima parte.
"Mi piace""Mi piace"
Cari Claudio Borghi e Mario Gabriele,
cerchiamo di non personalizzare troppo il dibattito, cerchiamo di comunicare… ho fiducia nella comprensione e nel riconoscimento reciproco, penso ancora che un valore estetico non può essere disatteso da chi tratta normalmente valori estetici. Manteniamo un filo di dialogo, anche perché il dialogo c’è finché entrambi gli interlocutori vogliono accettare l’altro interlocutore del dialogo, altrimenti si finisce tutti imbalsamati nel monologo!
Ho scritto in altra occasione riferendomi ad alcune eccezioni sollevate da Claudio Borghi:
Il disorientamento
Comprendo molto bene il tuo «disorientamento» dinanzi alla nostra ricerca di una nuova ontologia estetica, io è dall’inizio degli anni Novanta del Novecento che tento di indagare la crisi della forma-interna della poesia, l’ho fatto con la rivista “Poiesis” che avevo fondato nel 1993 e tenuta in vita fino al 2005. Complessivamente ne sono usciti 34 numeri. Ma è accaduto che in questi ultimi 29 anni la crisi delle forme estetiche (e non solo) si è andata aggravando, la crisi ha impresso una accelerazione forsennata al crollo delle forme estetiche tradizionali, non è affatto colpa mia e dei miei compagni di strada se la crisi si è abbattuta come un maglio sulle forme estetiche che abbiamo conosciuto in poesia. Così, è avvenuto che quell’endecasillabo della tradizione che va da Bertolucci de La camera da letto al Bacchini degli ultimi libri, ormai non ha nulla da offrirci, è una forma estetica del passato e noi non possiamo restare fermi a dirci come erano belli i tempi nei quali scrivevamo e vivevamo come Attilio Bertolucci e Bacchini, con tutto il rispetto per quelle forme poetiche e la loro poesia.
Del resto, oggi, non vedo in giro in Italia ricerche alternative a questa che abbiamo messo in campo. Tenterò di spiegarmi. La «nuova ontologia estetica» è nata da una presa d’atto della crisi irreversibile della forma-poesia che abbiamo conosciuto nel secondo Novecento e in questi ultimi anni del nuovo secolo, è una risposta che è partita dai «fondamenti» della scrittura poetica, e, in particolare, da un nuovo concetto dei due elementi fondanti la forma-poesia: la «parola» e il «metro», entrambi visti non più come «contenitori» di grandezza fissa ma come entità a grandezza variabile; sia la «parola»che il «metro» sono entità elastiche, mutanti, noi percepiamo queste unità come enti dotati di tempo e di spazio «interni», non solo «esterni» come intendeva la poesia tradizionalmente novecentesca ed epigonica.
Che cosa voglio dire? Che spetta a ciascun poeta offrire una propria soluzione a questa crisi della forma-poesia e interpretazione a questi nuovi modi di intendere sia la «parola» che il «metro», e si tratta di quello che abbiamo denominato «tempo interno», che non è da intendere come un tempo interno fisso valido per tutti ma come una temporalità interna all’oggetto e al soggetto e una spazialità interna al soggetto e all’oggetto, per dire così.
"Mi piace""Mi piace"
Caro Claudio Borghi, non noi «chiudiamo», anzi, «apriamo» un orizzonte di idee «nuove».
Tu giustamente scrivi: «Che la poesia non può chiudersi in gruppi minoritari di ricerca, ma arricchirsi nello scambio, nell’umiltà del confronto».
E ti dico: Noi siamo aperti al confronto e al dialogo, forse come nessuno negli ultimi 50 anni di poesia italiana (non mi sembra che in altri blog e riviste ci sia un contraddittorio come quello presente ne L’Ombra). Presentiamo dei testi della NOE e li commentiamo. Commentiamo, Abbiamo riflettuto sul nodo Pasolini-Montale, abbiamo riflettuto sulla poesia di Helle Busacca, su quella di de Palchi, su quella di Ripellino, su quella di Ennio Flaiano, su quella di M.R. Madonna, su quella di Giorgia Stecher… abbiamo presentato e commentato anche moltissimi testi di moltissimi poeti di varia estrazione e provenienza geografica e culturale. Abbiamo parlato e discusso tantissimi poeti europei di rango elevato (come nessuno sa fare in Italia).
Tutto ciò, interessa a qualcuno? Mi sembra di no.
Ad esempio, parliamo della poesia postata qui da Gino Rago: «Preghiera per un’ombra» e delle altre poesie postate. Sono belle? Brutte? Difettose? E dove sono difettose?
Io ti rispondo: Noi presentiamo dei testi e dei commenti ai testi. Chi vuole può interloquire sui testi, entrare nelle argomentazioni critiche sui testi, altrimenti si finisce nel genericismo.
Torniamo ai testi.
"Mi piace""Mi piace"
Caro Giorgio,
dal giorno in cui ho proposto miei contributi, inizialmente scientifici, poi poetici e critici, alla rivista ho concepito i miei interventi come un’occasione di confronto, mai partendo dalla presunzione di possedere verità. Il mio è un atteggiamento scientifico, nasce dalla consapevolezza che una presunta verità di oggi può essere superata e diventare obsoleta domani. A maggior ragione in letteratura, in cui tutto è più sfumato, occorre un atteggiamento prudente e cauto, l’apertura verso l’altro è fondamentale, occorre non sottovalutare né i punti di vista né le forme di rappresentazione della realtà che vengono da fuori di noi. In questo senso, caro Gabriele, ho fortissimo il senso del divenire, le mie ricerche sul tempo muovono proprio dal desiderio di smascherare la finzione idealistica che si cela dietro la concezione einsteiniana: in questo consiste la mia ricerca intorno al tempo termico, quindi al tempo interno agli orologi, alle creature e alle cose. Questo non impedisce che, essendo una creatura, io viva il mio problema di ente precario e provvisorio e mi immerga nella ricerca spirituale. Non c’è conflitto tra scienza e spiritualità, questo ho cercato più volte di far capire, con interventi articolati e complessi, che il più delle volte sono rimasti pressoché lettera morta, fino alle assurde appendici del confronto con Gabriele, che a un certo punto ha deciso di bollare il mio sentire come un retrogrado statico spiritualismo, percependo i miei riferimenti al misticismo o alla metafisica come antimoderni e palesemente in conflitto con la linea guida della nuova ontologia, all’interno della quale in molti avete trovato o state trovando un orizzonte di ricerca. Io non ho niente in contrario alla vostra condivisione, per certi aspetti mi sembra stimolante, ma credo che il mio essere problematico, il mio cercare il possibile “anello che non tiene” (come ho ostinatamente fatto anche in fisica teorica, navigando quasi sempre da solo) sia un atteggiamento che alla lunga paga. Ovviamente nell’immediato pago lo scotto di non essere capito o di essere frainteso o rifiutato, ma le mie idee, se andate a rileggere i post in cui le ho proposte, possono essere utili all’evoluzione del “pensiero dominante” di cui vi sentire portatori. Ripeto: sentitemi come un inquisitore che sta pensando criticamente, non come uno che vuole ostinatamente mettere in discussione chicchessia o imporre il suo punto di vista. L’importante è la ricerca, la fluidità del pensiero, che tanto accomuna scienza e poesia. Vorrei, ho sperato che questo atteggiamento diventasse anche il vostro, senza imporre dall’alto giudizi in forma predicatoria o sentenziante, e chiaramente mi spiace se qualcuno mi ha percepito così.
"Mi piace""Mi piace"
Io assolutamente no…e a dire il vero non vedo la distanza cosmica che separa Borghi da Linguaglossa o Gabriele: il disorientamento è positivo quando si vive in una società”liquida”, nel caos delle più diverse interpretazioni della realtà e, quindi, anche del concetto di Letteratura e Poesia: secondo me bisogna stare invece attenti ai fraintendimenti tipici di una comunicazione virtuale. Credo che possiate trovare un accordo voi poeti, al di là dei limiti di una comunicazione incompleta e continuamente interrotta. Si tratta di buona volontà e credo che ognuno di voi ne abbia grandi riserve, ma che i fraintendimenti (anche nei confronti di se stessi) impediscano di riconoscerla.
"Mi piace""Mi piace"
La ringrazio, gentile Mariella, voci come la sua, discrete quanto profonde, sono aria fresca e quanto mai benvenute.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie a lei, Borghi, che è un serio e appassionato personaggio in lotta per la rinascita della poesia.Credo sia fondamentale, come ho detto a Chiara Catapano, a proposito della “poesia ontologica e di ogni tipo di crazione artistica, tenere ben separati nel proprio lavoro l’ “io” cioè l’essenza del nostro essere, dall’ “Ego”, che ne è la superfetazione: io sto lavorando a questo, a togliere il supefluo e a lasciare soltanto l’essenziale. CONDIVIDO CON LEI L’IMPORTANZA DELLA “RICERCA sia SCIENTIFICA che SPIRITUALE”, strettamente legata alla ricerca dell’ESSENZIALE nella dimensione dell’ESSERE. Spero che possiamo collaborare tutti serenamente per il buon esito dI questa grande impresa!.
"Mi piace""Mi piace"
al Linguaglossa e vari autori interventisti
l’idea di raggruppare e pubblicare i migliori interventi critici sotto la forma di una “antologia critica” o di una “critica antologica”, intendo magari col titolo del blog, non sarebbe affatto da scartare, così che a fianco delle poesie pubblicate dai vari poeti e poeti-critici vi sia anche una “nostra” antologia magari da anteporre a tant’altre di scarso egemonico potere…
"Mi piace""Mi piace"
Ho cercato di trovare un filo conduttore in questo dibattito interessante coinvolgente e, soprattutto, acceso e soltanto a più di una lettura sono arrivata a sintetizzare nella mia “dimensione culturale” un punto di vista che, in qualche modo, mi sembra convincente e stimolante: ed ecco le mie impressioni di nuova ma appassionata interprete della Nuova Poesia ontologica e Frammenti, che possono organicamente convivere nella libertà espressiva di chi scrive: la stimolante e creativa “ouverture” di Gino Rago ci ha immesso in una realtà poetica del passato ma ancora viva per gli irrinunciabili input che alimentano, grazie alle opere di chi ci ha preceduto, le nostre radici culturali, il suo commento alla”Preghiera per un’Ombra” di Giorgio Linguaglossa è servito a farci percorrere fulmineamente il tempo (interno e storico) che ci divide dai maestri del passato e ci ha gettato nella Nuova Poesia: per me è stato un’ occasione di sprofondamento nei percorsi ancora “liquidi” della Nuova Poesia e di ricerca personale sui versi di G. Linguaglossa. La lettura della “Preghiera per un’ombra, mediata dall’insostituibile commento di Gino Rago che mi ha lanciato in luoghi e tempi diversi (parlo sempre di itinerari interiori!) alla rincorsa del significato del linguaggio come “gioco degli dei” di eraclitea e platonica memoria. Per quanto riguarda il lungo dibattito, la mia impressione immediata è che ho avuto modo di imparare molte cose da tutti gli interventi…sono una persona che ama imparare dagli altri, pur avendo alle spalle un’intensa esperienza di insegnante (anzi proprio per questo) e perciò apprezzo i punti di vista che divergono, trovando negli uni e nei miei interlocutori alimento per crescere. Perciò credo chedobbiamo essere più che soddisfatti del disorientamento e del “caos” apparente o sostanziale, in cui a volte ci sembra di naufragare:un nuovo “ordine” nasce sempre dal “caos”, non dalla stasi pietrificata della tradizione che non vuole evolvere.
"Mi piace""Mi piace"
Riprendo qui il mio discorso, interrotto per non annoiare il presunto lettore. Come potremmo non essere nel “caos” vivendo in un mondo come quello in cui siamo costretti a vivere? E poi…altra cosa importante: non possiamo restare fermi al principio di “non contraddizione”!: dobbiamo lasciare agli altri la possibilità di contraddirci, ma soprattutto lasciare noi stessi liberi di entrare in contraddizione!
E’ uno stato che ci stimola ad uscire dalla contraddizione e, soprattutto dalla convinzione di essere nella verità…in poesia, poi, entrare in contraddizione è fondamentale…faccio un esempio in res: è stato interessante per me scoprire che, nella “Preghiera per un’ombra” di Linguaglossa, l’Ombra cade in contraddizione. Prima infatti dice: “Gli uomini non sanno di essere mortali, dimenticano / e vivono come e fossero immortali”…ed è vero!!! Nella seconda parte invece: “In fin dei conti, tutti gli uomini sono immortali,/ solo che essi non lo sanno”…ed è altrettanto vero!!! (a mio parere, s’intende!). In poesia è bello e perfino necessario contraddirsi! Dalla contraddizione nasce un nuovo nucleo di verità: un famoso filosofo dotato di una bella mente ha parlato, se non sbaglio, di “tesi-antitesi e sintesi”.
In ultimo: l’ironia ci salva dal pessimismo e dall’autocommiserazione. Vorrei che, anche nelle poesie del nuovo corso, come nei discorsi che facciamo e che fate, amici poeti, ci fosse più ironia e…autoironia! Comunque sono grata ai poeti e critici intervenuti e li ringrazio per la parte di vita e di entusiasmo che dedicano alla poesia e alla letteratura poetica, ma a invito tutti, me stessa compresa, ad essere più sereni.
Mi piacerebbe che qualcuno mi rispondesse.
"Mi piace""Mi piace"
Non si tratta di una contraddizione, alla Walt Whitman, per intenderci, ma di un “ribaltamento”, ed ha lo scopo di frantumare, capovolgere, rendere instabile e confutabile lo stesso pensiero. I testi di Giorgio Linguaglossa sono ricchi di figure retoriche, mai casuali, ma ben studiate come solo un artigiano sa fare. Inoltre, “Gli uomini non sanno di essere mortali” è una citazione di Eugène Ionesco (Gli animali e gli uomini politici non sanno di essere mortali).
"Mi piace""Mi piace"
Sono perfettamente d’accordo, Giuseppe Talia, chiamiamolo “ribaltamento” che Giorgio Linguaglossa opera , con lo scopo non soltanto di “frantumare, capovolgere, rendere instabile il suo stesso pensiero”, ma anche di affermare contemporaneamente due “realtà” (soltanto in apparenza) contraddittorie, rafforzando approfondendo l’idea-immagine che vuole esprimere, soprattutto per non congelarla in un significato univoco. Grazie per avermi ricordato la citazione tratta dal mio caro “amico” Eugène Jonesco: comunque il poeta se ne serve per lo scopo ben preciso a cui abbiamo accennato. Mi sarebbe piaciuta una risposta più articolata…sarà per un’altra volta! Grazie comunque, Talia.
"Mi piace""Mi piace"
Riporto qui una paginetta che ho scritto ieri su Gino Rago e Giorgio Linguaglossa:
Raramente ho trovato in un poeta e nel suo critico la sinergia e l’intensa integrazione che connota Giorgio Linguaglossa e Gino Rago: oltre alla grande cultura dei due nostri poeti e personaggi risalta l’amicizia che li lega e che si nutre delle profonde differenze dei percorsi poetici da loro compiuti trasformandoli in arricchimento reciproco delle idee e nella realizzazione del proprio itinerario di “rifondazione della Poesia” voluta da Giorgio Linguaglossa che, con grande chiarezza e competenza, Rago, in-relazione alla poesia-preghiera di Linguaglossa, riassume così:
Lo spazio espressivo integrale di Preghiera per un’ombra è il campo in cui “nomi”, “tempo”,“immagine”, “proposizione” vengono rifondati, ridefiniti, spingendo il nuovo fare poetico verso paradigmi fin qui esplorati da pochi poeti del nostro tempo…
Ma l’idea chiave che dà intensità e risalto estetico e comunicativo alla critica di Rago è l’ intuizione di mettere a confronto l’Ombra linguaglossiana con il mito platonico delle Ombre del “vero” che si proiettano sulle pareti della caverna, fornendo agli esseri prigionieri e incatenati soltanto l’oscura e vaga proiezione della conoscenza (doxa) che invece gli uomini liberi attingono direttamente alla luce incandescente del fuoco(aletheia). Gli uomini incatenati possono attingere soltanto alla verità che percepiscono attraverso i sensi. Quanto profondamente queste immagini colte al vivo dal mito siano evocatrici del nuovo mito linguaglossiano si comprende con un’attenta e partecipe lettura “ontologica” della preghiera-poesia dedicata dal poeta all’Ombra. Lettura dell’“essere”, che significa entrare, come ha fatto Gino Rago, nell’anima stessa del poeta tanto difficile da comprendere con una logica tradizionale quanto assimilabile con le facoltà superiori della mente e dello spirito. Per capire la poesia di Linguaglossa bisogna diventare Linguaglossa, annientando temporaneamente se stessi. Questo è riuscito a fare l’amico Rago allontanando da sé una volta per tutte qualunque sospetto di narcisismo e virtuosismo letterari: difficilmente ho letto un commento così aderente al testo e immune da vanitas ed esibizione della propria cultura.
Senza il commento di Gino Rago, non sarei arrivata al livello di comprensione della “Preghiera per un’ombra” raggiunto partendo dalla sua originale e immaginifica intuizione. Il lavoro di Gino mi ha anche riaperto molte strade d’investigazione sulla poesia del ‘900 e mi ha trascinato a riletture nutrite dalle osservazioni del nostro poeta-critico che vive di passione per la poesia degli altri al punto di trascurare la propria per mancanza di tempo. Io gli ho chiesto di scrivere ancora per la nostra gioia e per arricchire e nutrire la memoria che spesso viene attratta da tante notizie che non danno assolutamente nessun alimento all’anima. Anche l’anima, come il corpo, ha bisogno di pane, soprattutto di quello genuino cotto nel forno a legna.
"Mi piace""Mi piace"
Non era mia intenzione scrivere un commento sulla Rivista, ma dopo il “rimprovero” affettuoso di Rago non ho potuto esimermi, Ed ecco le parole di un vecchio brontolone che litiga con se stesso e con l’Altro.
Da:ragogino@libero.itAdd contact
Salvatore caro,
grazie per la tua e-mail. E’ un pezzo di critica letteraria nel quale “critica” viene ricondotto al suo etimo, troppo spesso dimenticato, di selezione e di giudizio. Ed è un peccato che tu lo releghi nel buio sordo d’una e-mail. Io, fossi stato in te, l’avrei pubblicato come valido commento e contributo culturale su L’Ombra delle Parole. Fai in tempo e arricchiresti
così molti frequentatori del blog.l’Ombra delle Parole. Fai in tempo e arricchiresti così molti frequentatori del blog.
Al prossimo incontro nel segno delle Muse.
Gino
—-Messaggio originale—-
Da: marsalora@tiscali.it
Data: 7-apr-2017 22.55
A: “Ragogino”
Carissimo Gino ti ringrazio per avermi omaggiato della poesia di Linguaglossa e del tuo relativo commento. Che dirti? Solo una mia confusa doxa, personalissima senza alcuna pretesa critica nè tantomeno di verbo. La tua analisi molto dotta mi ha profondamente colpito soprattutto nel ricordo di quel mito platonico sulla conoscenza, cardine sul quale si avvolge tanta della nostra cultura e non solo filosofica. L’altro riferimento al mio amatissimo Pessoa e ai suoi eteronimi in opposizione all’ortonimo. Qui non concordo pienamente : mi pare ci sia una differenza sostanziale. Mentre i personaggi di Linguaglossa rimangono sempre personaggi all’interno di quanto egli scrive gli eteronimi del poeta di Lisbona firmavano in prima persona i loro componimenti talvolta in dichiarata opposizione a Pessoa stesso. Ma lasciamo perdere. la poesia di Giorgio, e lo dico in una lettera strettamente personale, ma senza nessuna acrimonia, e presa di posizione aprioristica, non mi arriva e cerco di esternare qualche motivo. A parte l’indubbia abilità e la cultura che traspare chiaramente. Non c’è mistero, non cammino segreto da svelare, tutto è detto , raccontato in una sintassi tutt’altro che poetica, con alcune affermazioni apodittiche, vuoi mutuate testualmente da Empedocle,( sul fatto che gli uomini si credono immortali), vuoi traducendo Epicuro e il suo concetto sulla morte e l’incontro con essa.Tutto appare esplicativo, mai allusivo, come costruito intellettualmente a tavolino, . Invano cerchi una locuzione allusiva, ambivalente,impregnata di pathos. Nel discorso diretto in poesia appare a me superfluo ripetere il soggetto parlante. Non ho davanti il testo per accennare meglio a ciò che secondo me non va bene anche da un punto di vista strettamente tecnico. Ecco, è solamente una mia piccola opinione, il labor limae mi pare non sia stato così puntuale.
Rileggendo tra l’altro alcuni testi di passati volumi di Linguaglossa, da Paradiso a Belligeranza a quel titolo tedesco che mai imparerò ho trovato una profondità, un pathos, un legame col mondo infero, un vortice di eros, e un andamento misterioso, che mi appare perduto in queste ultime prove abilissime del Nostro.
Due ultime notazioni: a me non sembra di essere come poeta in una cerchia di rivolti al passato, e che non abbiano nulla da dire, come qualche tuo sodale afferma, e la cosa non mi scuce assolutamente nulla, vado per la mia strada, senza alcun cedimento…Tra l’altro ho ripreso a scrivere, malgrado avessi deciso di aver chiuso con la pubblicazione di Cinquantanni di poesia…ma il dàimon è stato di avviso diverso.
"Mi piace""Mi piace"
https://lombradelleparole.wordpress.com/2017/04/05/gino-rago-arte-dello-scrivere-due-frammentisti-vociani-a-confronto-clemente-rebora-aldo-palazzeschi-e-pier-paolo-pasolini-un-contributo-alla-rilettura-del-novecento-poetico-italiano-e-un-c/comment-page-1/#comment-19150 A parte il fatto che una “citazione”non può essere che apodittica, quando poi, come nel caso di “Preghiera per un’Ombra”, è utilizzata in un insieme di versi articolato nei suoi molteplici rimandi e collegamenti, non si può dire che sia “mutuata testualmente ( da Empedocle )”: la frase intera è: “Gli uomini non sanno di essere mortali, dimenticano / e vivono come se fossero immortali; / il pensiero più fugace obbedisce ad un geroglifico / imperscrutabile, / un fragile gioco di specchi inventato dagli dei.” Questa citazione, secondo me, è ben piazzata nel contesto …tanto più che, nella seconda parte della poesia, viene contraddetta e sottolineata dall’affermazione dell’esatto contrario ( “In fin dei conti, tutti gli uomini sono immortali, / solo che essi non lo sanno”): l’effetto è di sconcertamento per la mentalità comune (di più che bimillenaria matrice aristotelica), ma d’intenso approfondimento poetico del concetto di “mortalità” che non esclude, anzi rafforza il suo opposto, cioè “l’Immortalità”: e in tutti e due i casi, la doppia affermazione rende più intenso e completo il significato che il poeta ha voluto esprimere e,sempre in tutti i due casi, “gli uomini non lo sanno”.
Ho sottolineato questo argomento perché penso che le poesie vadano commentate considerando le parole, le immagini e tutte le figure retoriche introdotte dal poeta, non genericamente e teoricamente, come troppo spesso fanno i critici sovrapponendo le proprie idee e intuizioni a quelle degli autori. Comunque mi rendo conto di quanto sia inevitabile che questa sovrapposizione avvenga ed è anche bello che le opere “crescano” grazie alle idee e all’immaginazione dei lettori e dei critici.
"Mi piace""Mi piace"
IL PRINCIPIO DI IDENTITA DI ARISTOTELE E LA PAROLA PIENA DELLA POESIA
https://lombradelleparole.wordpress.com/2017/04/05/gino-rago-arte-dello-scrivere-due-frammentisti-vociani-a-confronto-clemente-rebora-aldo-palazzeschi-e-pier-paolo-pasolini-un-contributo-alla-rilettura-del-novecento-poetico-italiano-e-un-c/comment-page-1/#comment-19133 Nel Laboratorio di poesia del 30 marzo 2017 ho avuto modo di introdurre il discorso sul concetto di «parola» in poesia partendo dal concetto di parola «piena». Che cos’è la parola «piena»? – Risponderò citando il principio di identità di Aristotele il quale afferma A=A, che significa A è A. Ma l’esser A di A configura una dualità il che implica in modo sotteso una differenza di A dall’essere A. La conseguenza paradossale è che A è identica e diversa dalla A che avevamo postulato. Esito paradossale e auto contraddittorio.
Emanuele Severino coglie nel segno quando afferma che «ciò che è posto come identico è un non identico»,1] la conseguenza contraddittoria è lapalissiana. Severino continua così: «L’affermazione dell’identità come affermazione «della non identità», è lo stesso Aristotele a sostenerla».2]
La conclusione di Severino è l’accusa all’Occidente di aver posto un nesso inscindibile tra il principio di identità e quello di non-contraddizione. L’identico non riesce ad aver ragione sul «non-identico a sé». La conseguenza è il baratro del nichilismo «in quanto isolato dall’identità con se stesso (e cioè dal suo non esser l’altro da sé) l’essente non è se stesso […]. È un nulla.3] –
Il problema qui appena accennato è che il nichilismo contemporaneo pensa ad A nel momento stesso in cui ammette l’essere non-A insito in A. «In tal modo, A è in tutto e per tutto quello stesso non essere che nega A; non se ne può distinguere nella misura in cui deve costituirsi come un negare, e cioè non essere altro da sé. Insomma, dalla circolarità contraddittoria del negativo con cui il positivo è originariamente coincidente, non si può uscire».4]
Tutto questo reca con sé una sfiducia totale nelle capacità della «parola piena». Non c’è più una «parola piena» che possa salvare il mondo o che possa farci comunicare l’uno con l’altro con un minimo atto di fede nella parola; nella parola che noi pronunciamo c’è, appunto, il non-A che dice il contradittorio, il contraddittorio è profondamente innervato nel non-contraddittorio. Questa consapevolezza (o questa sfiducia per la parola piena, fate voi) è quella che caratterizza la «parola non-piena» degli autori della NOE dalla consapevolezza che avevano i poeti, diciamo genericamente, del Novecento (e qui intendo sia Bertolucci che Sanguineti, sia Pasolini che Montale). Noi abbiamo imparato, a nostre spese, che la parola non è più piena, non significa affatto un «è» se non con un intimissimo nesso con un «non-è». Ecco, questa è una certezza tra i poeti della NOE.
Dal punto di vista indicato sopra, è chiaro che una mia poesia risulti incomprensibile ad un poeta come Salvatore Martino e Bacchini i quali pensano e scrivono ancora in termini di «ambiguità», di «musica», di «armonia», di «dis-armonia», di «assonanza», di «dissonanza» e via cantando. la differenza è abissale e non c’è modo di colmarla perché implica un salto, una diversità del modo di concepire l’ontologia della parola poetica. Noi pensiamo che questo sia il punto centrale dal quale si diparte la NOE, tutto il resto può anche essere secondario – la consapevolezza della «debolezza della parola» e della parola poetica, la consapevolezza della sua infermità. È da qui che parte la nuova ontologia estetica. La questione del «frammento», del «tempo interno», del «metro a-metrico, della caduta dell’unità di misura del verso, tutto ciò è una conseguenza di quel nuovo modo di intendere il principio di identità e di non-identità della parola con se stessa.
La parola della Lingua di relazione e quella poetica abitano una medesima zona ontologica: non si dà una ontologia estetica che non sia fondata sulla ontologia della Lingua di relazione, sulla lingua viva dei parlanti.
Adesso apparirà chiaro che ciò che contraddistingue la NOE è la acuta consapevolezza da parte dei poeti della NOE di non poter fare a meno di utilizzare una «parola inferma», cioè colpita dal morbo della identità e della non-identità, una parola inutilizzabile ai fini veramente comunicativi. Questa amara consapevolezza porta con sédelle naturali conseguenze… la caducazione e la derubricazione di interi generi poetici…
Adesso apparirà più chiaro, spero, quello che scrivevo tempo fa a proposito della poesia di un Mario Gabriele.
“Mario Gabriele utilizza il «frammento» come una superficie riflettente, un «effetto di superficie», un «talismano magico», una immagine di caleidoscopio, un «cartellone pubblicitario»; impiega il «frammento» e la composizione in «frammenti» come principio guida della composizione poetica; ma non solo, è anche un perlustratore e un mistificatore del mistero superficiario contenuto nei «frammenti», ciascuno dei quali è portatore di un «mondo», ma solo come effetto di superficie, come specchio riflettente, surrogato di ciò che non è più presente, simulacro di un oggetto che non c’è, rivelandoci la condizione umana di vuoto permanente proprio della civiltà cibernetico-tecnologica. È una poetica del Vuoto, una poesia del Vuoto. E il Vuoto è un potentissimo detonatore che l’innesco dei «frammenti» fa esplodere. La sua poesia ha l’aspetto di un fuoco d’artificio che si compie in superficie; si ha l’impressione, leggendola, che si tratti di una diabolica macchinazione della simulazione e della dissimulazione, ci induce al sospetto che sia la nostra condizione umana attigua a quella della simulazione e della dissimulazione: non sappiamo più quando recitiamo o siamo, non riusciamo più a distinguere la maschera dalla «vera» faccia. La poesia diventa un gelido e algebrico gioco di simulacri, di simulazioni e di dissimulazioni, una scherma di sottilissime simulazioni, citazioni, reperti fossili, lacerti del contemporaneo utilizzati come se fossero del quaternario. È una poesia che ci rivela più cose circa la nostra contemporaneità, circa la nostra dis-autenticità di quante ne possa contenere la vetrina del telemarket dell’Amministrazione globale, ed è legata da analogia e da asimmetria al telemarket, danza apotropaica di scheletri semantici viventi…
Ricevo da Ubaldo de Robertis questa citazione di Mandel’stam sulla poesia. Credo che si attagli perfettamente alla poesia di Mario Gabriele e alla nostra sensibilità:
“Non chiedete alla poesia troppa concretezza, oggettività, materialità. Questa pretesa è ancora e sempre la fame rivoluzionaria: il dubbio di Tommaso. Perché voler toccare col dito? E soprattutto, perché identificare la parola con la cosa, con l’erba, con l’oggetto che indica? La cosa è forse padrona della parola? La parola è psiche. La parola viva non definisce un oggetto, ma sceglie liberamente, quasi a sua dimora, questo o quel significato oggettivo, un’esteriorità, un caro corpo. E intorno alla cosa la parola vaga liberamente come l’anima intorno al corpo abbandonato ma non dimenticato. […] I versi vivono di un’immagine interiore, di quel sonoro calco della forma che precede la poesia scritta. Non c’è ancora una sola parola, eppure i versi risuonano già. È l’immagine interiore che risuona, e l’udito del poeta la palpa. (Osip Mandel’stam, in La parola e la cultura)..
da L’’erba di Stonehenge
—————————–
E’ passato come l’albatros di Baudelaire
l’irrequieto Novecento.
A ritroso tornano alla memoria: La Maison Blanche
a Neuville Saint Vaast,
Guernica e Nagasaki, le ceneri di Gandhi e Irina,
la ragazza dell’Est che amava l’oiseau et son nid
di Georges Braque,
la scarlattina di Max e Joseph il giorno di Natale,
leggendo lunari e piccoli pamphlets,
e poi los ninos pobres de Rio,
i pochi versi di Cibulka nell’infamia del secolo:
“Nun kamen sie (e venivano coloro)
mitt denen ich gelebt, (coi quali avevo diviso la vita)
sie stürzten (precipitavano)
die Hänge des Monte Casino herab,
(giù per i pendii di Montecassino)
lauter Gefallene
(tutti caduti)
in sandbrauner Uniform, (in uniforme bruno-sabbia)”
con gli anni che credevamo non finissero mai
e che ora sono davanti a noi senza più redini e forza.
(da: Le finestre di Magritte, Bastogi,2000).
1] E. Severino, Tautotes, Milano 1995, p.98
2] Ibidem
3] Ibidem
4] Adalberto Coltelluccio in Anterem, n. 899 “L’autocontraddizione dell’Originario” dicembre, 2014 pp. 84.85
"Mi piace""Mi piace"
Tutto molto interessante, ma sorge in me una domanda: perché nessuno risponde ai miei lunghi interventi? E’ sempre così…ho l’impressione che il mio sia un monologo…oppure di parlare da sola, magari di fronte allo specchio per farmi compagnia. Capisco che i vostri argomenti sempre nuovi o polemici avanzino come tsunami trascinando via tutto. Però…ho il dubbio che quasi nessuno (salvo talvolta Giorgio Linguaglossa e, di sicuro almeno sempre fino ad oggi, Gino Rago,) legga i miei commenti. Eppure ho lanciato argomenti che dovrebbero interessare come la “vitalità della contraddizione” e l’importanza dell’ironia. Io metto tutto di me stessa in quello che scrivo…non vorrei che quel tutto sfumasse o si disintegrasse nel nulla perché, come ha detto Il sempre attuale Eugène Jonesco, “le parole cadono nelle orecchie dei…”. E ora taccio perchè voi tutti sapete in quali orecchie cadono le mie parole perché avrete letto “La lezione” di Jonesco, ne sono più che sicura! ( ironia che, spero, alleggerisca il mio intervento!)
"Mi piace""Mi piace"
Gentile Mariella Colonna, chiedo, innanzitutto, scusa per non essermi rivolto a Lei, in un precedente commento, citandoLa direttamente: la mia è stata una mancanza che vorrei qui colmare. I Suoi commenti sono veramente pertinenti, garbati, incisivi e portano, sicuramente, valore alle discussioni intorno alla “cosa” chiamata Poesia.
Non era mia intenzione contraddire i Suoi commenti, al contrario, aggiungere, per quanto io possa aggiungere, ulteriori valori e/o notizie a quanto Lei con grande rilievo ha sottolineato, in particolare sulla felicissima sinergia che intercorre tra Giorgio e Gino.
Giuseppe Talia.
"Mi piace""Mi piace"
Ma certo, gentile poeta! La ringrazio per avermi accontentatto con la sua risposta, che avevo invocata…quindi senza nessun retropensiero, ci mancherebbe! E poi una sottilissima ironia è come il sale nelle vivande… rinvigorisce il sapore delle parole che, una volta scritte da lontano, tendono a raggelarsi! Piacere di averla incontrata due volte in questo movimentato contesto!
"Mi piace""Mi piace"
Comunque, rileggendo l’intervento di Giorgio Linguaglossa, immediatamente precedente al mio, mi rendo conto che posso considerarlo un’ indiretta risposta ai miei appunti di prima e lo ringrazio vivamente. Però, in questa Rivista che io tanto apprezzo e che sento mia…perché io compaio come l’ “innominabile o innominata” di turno? Chissà…però questo sarebbe divertente se almeno si prendessero in considerazione gli argomenti che propongo…
"Mi piace""Mi piace"
https://lombradelleparole.wordpress.com/2017/04/05/gino-rago-arte-dello-scrivere-due-frammentisti-vociani-a-confronto-clemente-rebora-aldo-palazzeschi-e-pier-paolo-pasolini-un-contributo-alla-rilettura-del-novecento-poetico-italiano-e-un-c/comment-page-1/#comment-19140 Cara Mariella,
L’UTILITà E L’EFFICACIA DEI TUOI COMMENTI SONO UN DATO DI FATTO, E CHE NESSUNO LI CONTRADDICA NON SIGNIFICA CHE NESSUNO LI RACCOGLIE.
Giustamente tu accenni sulla utilità della contraddizione, infatti soltanto un pensiero che pensa l’identità rifugge dalla contraddizione quando invece nella mia poesia e nella poesia degli altri autori io non ricerco una verifica della identità che tutto riconduce alla identità, quanto una verifica della pluralità e della contraddizione… Jonesco, Borges, Mandel’stam e moltissimi altri poeti tutti insieme si trovano nella mia poesia in corpi di frammenti consapevoli e inconsapevoli… Questo tu lo hai messo in rilievo con grande precisione e te ne sono grato, come sono grato a Gino Rago e a Giuseppe Talia quando hanno delineato una differenza profondissima tra il frammentismo dei vociani e il frammento della nuova ontologia estetica, il «nuovo» frammento è una cosa ben diversa da quello di Rebora e dei vociani, se non altro sono passati cento anni, nel frattempo sono intervenute una grande quantità di cose…
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo Giorgio, so che tu prendi in considerazione i commenti e le parole non in base all’importanza e fama di chi le dice, ma soltanto perché ne condividi o meno il messaggio e i contenuti. Ho trovato in te una persona attenta all’ “altro”, chiunque fosse: scrittore affermato o neofita appassionato di poesia, E questo mi ha convinto a seguire il cammino che tu stai creando sia con le tue scoperte sul linguaggio poetico che con la tue opere: ho imparato anche a non dispiacermi, anzi ad essere grata quando mi hai fatto alcune giuste critiche e… a scrivere con libertà, a volte andando oltre il cammino indicato. Quanto alla tua poesia bisogna saperla leggere al di là dell’apparente freddezza delle immagini e delle parole (che poi non è una costante!): certo, chi scrive in modo diverso non riuscirà facilmente a spogliarsi di se stesso per prendere in carica la tua personalità di poeta semplice e complessa ad un tempo. Io ho trovato molti significati nascosti dietro la linearità dei tuoi versi, immagini di una forza straordinaria ma che non si pavoneggiano con esibizione di colori o straordinarie avventure dell’immaginazione. Quel tuo personaggio che ha perduto la lingua e inventa di nuovo un linguaggio è drammaticissimo e coinvolge totalmente il lettore, ci sono moltissimi tuoi versi in cui tu vivi nel cuore delle parole, con o senza analogie o metafore! Comunque la strada da percorrere non finisce mai, per fortuna. Andiamo avanti tutti insieme, ognuno nella sua diversità. Grazie per avermi risposto e ancora una volta chiamata per nome!
"Mi piace""Mi piace"
MA NON ERA LA POESIA ITALIANA LA MIGLIORE D’EUROPA? https://lombradelleparole.wordpress.com/2017/04/05/gino-rago-arte-dello-scrivere-due-frammentisti-vociani-a-confronto-clemente-rebora-aldo-palazzeschi-e-pier-paolo-pasolini-un-contributo-alla-rilettura-del-novecento-poetico-italiano-e-un-c/comment-page-1/#comment-19143
Caro Claudio Borghi
Cito dal libro di Alfonso Berardinelli Casi critici. Dal postmoderno alla mutazione (Quodlibet, 2007) a pag 37, c’è scritto:
«… la nostra poesia (con Montale, Luzi, Bertolucci, Caproni, Sereni, Penna, Zanzotto, Giudici, Amelia Rosselli) è stata fra le migliori in Europa; ma poi (salvo eccezioni) ha perso libertà e pubblico. – E commenta – un’arte senza lettori deperisce o si trasforma in una specie di pratica ascetica, con tutto il suo seguito di comiche devozioni e perversioni».
Berardinelli accenna al vero problema: Ma se la poesia italiana è stata fra le migliori d’Europa, come è accaduto che quest’arte ha perso pubblico e credito? –
C’è qualcosa che non va in questo ragionamento. Il ragionamento è rigorosamente logico: ma se era una delle migliori d’Europa la poesia italiana, come è avvenuto che ha perduto il suo pubblico?
Credo che bisogna cercare la risposta a questa domanda, e finché non abbiamo trovato la risposta azzeccata credo sia inutile continuare a scrivere poesie che nessuno leggerà.
È per cercare la risposta a questa domanda abbiamo messo in piedi questa nuova piattaforma: la NOE (la nuova ontologia estetica). Altre piattaforme in giro non le vedo…
1] Giorgio Linguaglossa Dopo il Novecento. Monitoraggio della poesia italiana contemporanea (2000-2013) 2013 Società Editrice Fiorentina, pp. 148 € 14.
"Mi piace""Mi piace"
https://lombradelleparole.wordpress.com/2017/04/05/gino-rago-arte-dello-scrivere-due-frammentisti-vociani-a-confronto-clemente-rebora-aldo-palazzeschi-e-pier-paolo-pasolini-un-contributo-alla-rilettura-del-novecento-poetico-italiano-e-un-c/comment-page-1/#comment-19144 Caro Giorgio,
il confronto tra te e Borghi sulla dialettica relativa alla NOE, considerato il tuo punto di vista chiarificatore ed esplicativo, e il suo pensiero diametralmente opposto, agganciato a zone perimetrali di ipotesi e teoremi, come principio di contraddittorio, mi porta alla Summa Contra Gentiles di Tommaso d’Aquino, che pur nella diversità tra Fede e Ragione, trova un giusto equilibrio fra le parti. “ I principi innati nella ragione”, secondo Tommaso, “si dimostrano verissimi al punto che è impossibile pensare che siano falsi”, pervenendo poi ad altre spinte conciliative con la Fede. Tommaso realizza il superamento delle consolidate filosofie, avvicinando il “lume della fede” (Borghi), al “lume naturale della ragione” (Linguaglossa). Ma con un interlocutore come Borghi, nessun accordo di vicinanza è possibile. Ora, rivestendo in questa sede i panni di un ipotetico giurista, porto a riferimento alcune contraddizioni di Borghi, (solo due, per fortuna), laddove con riferimento in data 8 aprile 2017, e altrove, egli testualizza la seguente frase: “la poesia non può chiudersi in gruppi minoritari di ricerca”, limitando, in questo modo, e restringendo il campo di azione del fare poetico,come un autentico torquemadista, aggiungendo e avvisando il lettore di considerarlo più come “ un inquisitore”, e qui il termine torquemadista, da me sopra citato, è perfettamente appropriato; quando il Borghi si autodefinisce, (bontà sua!) un “inquisitore che sta pensando criticamente, non come uno che vuole ostinatamente mettere in discussione chicchessia o imporre il suo punto di vista”. Tutto il contrario di ciò che ha espresso prima, quando riporta la frase “la poesia non può chiudersi ecc,) Qui non c’è dialogo, ma contraddizione, imperfezione di assunti, forse l’antica prosopopea di soggetti già canalizzati verso un istituto della poesia con i loro fondamenti metafisici e inoppugnabili del valore. Il problema sta tutto qui ed è ravvisabile nella non conciliabilità tra pensiero attivo e pensiero passivo.
"Mi piace""Mi piace"
Un confronto non dovrebbe mai essere condotto con le armi che usa lei, Gabriele, citando frasi fuori contesto con l’intento esplicito di liquidare l’interlocutore in modo sommario. Ammesso ci siano errori o contraddizioni nel mio ragionamento, il suo metodo “giuridico” è quanto mai prevenuto e fazioso. Lei evidentemente ha anche una bassa opinione dei lettori, visto che sembra volerli mettere dalla sua parte con mezzi che a me paiono palesemente poco corretti, dato che avevo espresso idee chiare che lei ora distorce a sua discrezione e a suo vantaggio, come ci fosse, poi, un vantaggio da ottenere.
Quanto all’emisfero destro o sinistro, ragione o fede, pensiero attivo o passivo, lei concepisce solo contrapposizioni e quel che è peggio è che parte prevenuto, quindi non fa nessuno sforzo per capire il pensiero altrui. Esistono tesi e antitesi, non ragione e torto separabili con un taglio netto, e il dialogo è necessariamente dialettico, la sintesi viene dal confronto, non è un a priori che lei sente sempre, immancabilmente dalla sua parte.
"Mi piace""Mi piace"
ALL’OMBRA DELLA POESIA QUALUNQUOIDE E BANALE DI OGGI
Caro Claudio Borghi,
mi rivolgo a te, che so interlocutore attento e sensibile, e a tutti coloro i quali guardano con sufficienza alla nostra piattaforma teorico-critica; vedi, al di là di tutto ciò che si potrà dire circa la bontà della nuova ontologia estetica, ci saranno sempre innumerevoli schiere di piccoli letterati che tenteranno di difendere la loro nicchia di visibilità e di presentabilità con tutti i mezzi e con tutte le armi, e con l’arma del silenzio… perciò io ti ringrazio per le questioni che poni, per le eccezioni che sollevi… io non mi pongo dal punto di vista se esse siano fondate o meno, è chiaro che le eccezioni che sollevi hanno un loro fondamento e una loro giustificazione psicologica, umana, e anche teorica, questo non lo nego… quello che noi stiamo facendo è un’altra cosa, una cosa che non può che essere fatta da una, come tu la chiami, «minoranza». Certo, tutti i movimenti che portano novità sono minoritari, questo è ovvio e comprensibile, ma minoritari non significa insignificanti, anzi, sono convinto che oggi in Italia l’unica piattaforma di prassi poetica e critica è quella della nuova ontologia estetica, in giro non ne vedo altre…… vedo in giro piccoli letterati che leggono soltanto se stessi e i poeti della loro nicchia, piccoli potentati di palazzo e di cortile che continuano a fare poesia stucchevole e noiosa, già finita cinquanta anni fa. E poi, noi ci limitiamo a seminare delle idee sperando che un giorno germoglieranno… se non germoglieranno vuol dire che quel terreno dove i semi sono caduti era secco, sterile, non poteva dare nuove piante, e che il seminato è andato perso irrimediabilmente.
Ecco cosa ho scritto per un poeta bulgaro che presenterò sull’Ombra delle Parole:
È ovvio, un discorso poetico implicito nasce perché non può essere reso esplicito, e non può essere esplicitato perché c’è un ostacolo che impedisce al discorso di divenire esplicito, chiaro, lampante. Oggi il linguaggio epifanico, mettiamo, di un Ungaretti è caduto in disuso perché quell’epifania è stata corrotta e defenestrata dalla pubblicità e dalla merceologia delle merci; e dove c’è pubblicità e merceologia e spot non vi può essere epifania. Credo che il nesso sia lampante. Interi generi poetici oggigiorno vengono «superati» e resi obsoleti non per questioni di stile o etiche o estetiche ma perché la storia li ha messi nello sgabuzzino del rigattiere a fare funghi. Ecco perché Ivo Hadzhiyski impiega solo e soltanto il discorso dell’implicito, perché là fuori il discorso dell’agorà è ingombro di masserizie del politico e del mediatico e del prossemico, ci sono parole chiare che aspettano il teleutente all’amo della propria chiarezza e politura poliziesca. Ecco perché la poesia di un poeta moderno non può che impiegare, se vuole difendersi dalle aggressioni della poesia qualunquoide e telematica, il discorso eterodiretto, ovvero, il discorso dell’implicito.
"Mi piace""Mi piace"
Certo, Giorgio, minoritari non significa insignificanti, tutt’altro, questo mi sembra chiaro, io rispetto la ricerca di chiunque. L’importante è, credo tu ne convenga, il rispetto e l’attenzione reciproci e questi vengono se c’è volontà autentica di ascolto e di confronto.
"Mi piace""Mi piace"
è NOE
"Mi piace""Mi piace"
UNA NUOVA EDILIZIA POETICA AVVERSO L’USUCAPIONE DI COLORO CHE IN PIAZZA AGITANO CARTELLINI DI PROPRIETA
Alle baraccopoli poetiche di cui sono affittuari i vari soggetti che ne rivendicano l’usucapione e che in piazza agitano cartellini di proprietà, noi rivendichiamo una nuova edilizia poetica nella quale possono coabitare tutti coloro che hanno cultura, esperienza, dimestichezza con la poesia nazionale e straniera, con una una visione del mondo esterno con i suoi conflitti, ignorati dai vari aedi sassofonisti di armonie, che conoscono soltanto i loro assoli, ignorando che ci sono anche altri suoni dodecafonici e linguistici, che pure hanno fatto storia,dimostrando come il fare poesia non è raccontare storie private, accanto a curriculum di premi che non servono a nulla: tutto un repertorio di shilly-shally e underground che ha falsificato e imperializzato una poesia privandola di altre prerogative, dove il carattere criminogeno è da ricercare nell’omicidio di una lingua nuova, che grazie alla riforma del soggetto poetico rimette, in gioco verità incontrovertibili, come potremo leggere nel nuovo lavoro critico di Linguaglossa, dove chi merita è considerato giustamente e chi solfeggia ariette pseudoestetiche e astoriche, viene inquadrato nella sua giusta dimensione.
"Mi piace""Mi piace"
lo so Mario. Ne sono consapevole. Io continuo a ricercare.
"Mi piace""Mi piace"
Caro Grabriele,
sono in perfetto accordo con la parte propositiva del tuo ultimo intervento; mi piace quello che dici: “noi rivendichiamo una nuova edilizia poetica nella quale possono coabitare tutti coloro che hanno cultura, esperienza, dimestichezza con la poesia nazionale e straniera, con una una visione del mondo esterno con i suoi conflitti, ignorati dai vari aedi sassofonisti di armonie, che conoscono soltanto i loro assoli, ignorando che ci sono anche altri suoni dodecafonici e linguistici, che pure hanno fatto storia,dimostrando come il fare poesia non è raccontare storie private, accanto a curriculum di premi che non servono a nulla…”, mi dispiace, invece, che tu, come d’altra parte Borghi, non sia più sereno restando nella convinzione profonda delle tue idee, suffragata dalla modernità di “ontologia estetica + frammenti” che leggo nelle tue poesie dove le realtà concrete e l’essenza “invisibile”, misteriosa di cose personaggi eventi convivono in perfetta armonia in una nuova dimensione con e senza tempo: dimensione che definirei “musicale” per quello che la musica ha di più umano e immerso nel mistero dell’essere. E’ giusto anche dibattere e sostenere le proprie idee: quello che preferirei non sentire è il “ri-sentimento” nei confronti di chi esprime, magari troppo vivacemente, idee che non concordano con le proprie: è accaduto sia a te che a Borghi. Dico questo perchè io avevo fatto amicizia con un una poetessa molto intelligente, autrice di opere poetiche di grande livello…e l’ho perduta per la sua suscettibilità…non ha accettato una piccola critica e si è chiusa in se stessa. A me piace essere o diventare amica dei poeti della NOE a cui credo di appartenere anche io. Perciò auspico in tutti un apertura reciproca in nome della comune passione per la Poesia!
"Mi piace""Mi piace"
“I combattimenti cessano al calare delle ombre.
Per l’intero giorno Ettore dà battaglia al ferro greco.
Gonfi di baldanza i troiani accendono i falò.
Riempiono di fuochi la campagna. Disperdono la notte.
Achille in preda all’ira si chiude nella tenda.
Favorita delle tenebre Ettore teme che la flotta greca salpi.
Ordina che da Troia arrivino cibo e vino in abbondanza
e poi, secco: « Si accendano i fuochi per arrostir le carni».
Volge il suo sguardo verso l’attendente. A bassa voce
quasi come un fiato gli sussurra:« Reca il poeta a me.
Immortali con i versi il sereno plenilunio
su questi fuochi accesi come stelle». Giunge il poeta.
Tende le corde lente. Tra i bagliori alza il suo canto.
Gli occhi del poeta sono senza luce. Eppure in sé indovina
l’incanto dell’intero firmamento:«Siccome quando in ciel
tersa è la luna e tremule e vezzose
a lei dintorno sfavillano le stelle, allor che l’aria è senza vento
ed allo sguardo si scoprono le torri e le foreste
e le cime dei monti, immenso e puro l’etra si espande,
gli astri tutto il volto rivelano ridenti
e in cor ne gode l’attonito pastore…»
Ettore tace. Trattiene a fatica l’umido caldo agli occhi.
Nessun troiano spezza il brillar muto delle ninfe eterne…”
E’ la maniera da me scelta per dire grazie a Mariella Colonna, per i suoi commenti incentrati
sulla mia relazione e non su altro, commenti pertinenti (altri, pur importanti, di fronte a quelli di
Mariella Colonna appaiono al contrario im-pertinenti) e ricchi di saggezza e di sapienza. E grazie
anche a Lucio Mayoor Tosi, a Chiara Catapano, a Donatella Costantina Giancaspero, a Francesca Dono
(pur laconica, ma sincera), a Gabriella Cinti, a Salvatore Martino per avermi nominato
nei loro commenti pieni di dottrina.
Grazie anche a coloro, davvero numerosi, che hanno scelto la via silente della e-mail
per esprimere parole vive di apprezzamento sul mio lavoro. Un grazie grande a Giorgio Linguaglossa,
per tutto.
(Rimbomberà a lungo dentro di me la constatazione, da fedele compagna di viaggio, quale si è
pienamente fin qui mostrata, di Mariella Colonna secondo cui – facendo centro – mi sento così
al servizio della Poesia da giungere a trascurare la mia ricerca poetica per occuparmi degli altrui versi.
Fino ad ora è stato così…)
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
caro Gino, essere laconica fa parte della mia natura. Voi , comunque, siete dei grandi maestri. Dalle vostre opere così come dai vostri commenti traggo gli insegnamenti più profondi. Buona giornata.
"Mi piace""Mi piace"
Brava Francesca! Penso anche io la stessa cosa: imparare e assimilare nell’essere è importante quanto insegnare, soprattutto con la testimonianza delle proprie opere.. E in silenzio si impara tantissimo: anche io come te sono stata a lungo in silenzio per capire e assimilare le parole sagge e profonde degli interlocutori dell’Ombra: e mi è giovato moltissimo! Tu scrivi con uno stie molto personale e vorremmo sentire il tuo pensiero sugli argomenti che ci stanno a cuore! Allora coraggio…alla prossima!
"Mi piace""Mi piace"
cara Mariella, spero di riuscire a scardinare questo limite che mi perseguita dalla nascita. Grazie comunque per le tue parole. Un caro saluto.
"Mi piace""Mi piace"
Cara Donafrancesca, il tempo della scrittura in poesia non è questo. Qui lo sanno tutti.
"Mi piace""Mi piace"
Non ho capito Lucio Mayoor Tosi. Scusami.
"Mi piace""Mi piace"
Era per non dire stai serena.
"Mi piace""Mi piace"
ahhhh… allora che fò? Quasi quasi ci dormo o non ci dormo? Opto per la prima perchè io e il sonno non siamo molto in sintonia.. Ovvio scherzo…mica tanto!
"Mi piace""Mi piace"
Caro Gino, proprio oggi che mi sono un po’ lamentata per la mancanza di risposte ne ho avute tante gentili e interessanti…ma la tua è davvero lo specchio della tua anima generosa! Lo specchio in senso linguaglossiano, gioco inventato dagli dei anche (dico io su ispirazione popolare) per la sua presunta capacità di imprigionare l’anima. La mia anima è libera, ma tu hai catturato un simpatico e invisibile essere alato poetico e svolazzante che per magia le corrisponde: io lo chiamo “folletto della poesia”. Il mio “folletto ti fa un inchino e ti ringrazia per averci offerto la stupenda descrizione dell’ antico Poeta, che, pur essendo cieco, “indovina l’incanto dell’intero firmamento”. Non soltanto “tersa è la luna e…intorno a lei sfavillano le stelle,” ma tace il vento e anche il le torri le foreste e le cime dei monti si rivelano scutoreI nell’ombra luminosa, sullo sfondo degli astri scintillanti. Riviviamo questo momento di assoluta purezza contemplativa con immensa gratitudine verso il poeta che ci ha ricordato quanta poesia c’è nel passato quando ritorna miracolosamente in un mondo che sembra averlo dimenticato per sempre.Non basta dirti grazie,Gino Rago… mi farò venire un’idea poetica. La Poesia ci aiuta a ricordare la Bellezza del mondo. Lo salverà?…Dipende anche da noi.
"Mi piace""Mi piace"
Francesca, mia cara, la laconicità, anche in poesia, è per il mio gusto una grande, preziosa qualità. Tu la possiedi con l’altra non meno importante
qualità: la sincerità. E io te le riconosco entrambe.
"Mi piace""Mi piace"
grazie caro Gino. A presto.
"Mi piace""Mi piace"
Il più grande pericolo del pensiero è – il pensiero. L’onnifagia del pensiero. Là più pericolosa, dove si cela
…a partire da quel pensiero di Heidegger che si legge nell’Introduzione di Sein und Zeit: Höher als die Wirklichkeit steht die Möglichkeit, che lessi come il rovesciamento del Grundsatz, del principio fondamentale di Aristotele: próteron enérgheia dynámeos. Non l’atto è prima della potenza, non l’essere è prima del possibile, ma questo – il possibile, il possibile non la potenza – è prima del mondo, della vita, dell’essere. “La possibilità più in alto della realtà” mette in giuoco tutto…
Il più grande pericolo del pensiero è – il pensiero. L’onnifagia del pensiero. Là più pericolosa, dove si cela.
il linguaggio di Celan sorge quando il linguaggio di Heidegger muore, volendo dire che il linguaggio della poesia – della ‘nuova’ poesia – può sorgere soltanto con il morire del linguaggio tradizionale che la
filosofia ha fatto suo, o – forse – che si è impadronito della filosofia
(Vincenzo Vitiello)
"Mi piace""Mi piace"
cara Mariella,
ti rispondo per interposta persona:
Ognuno di noi continua a parlare un linguaggio
che lui stesso non intende,
ma che ogni tanto, viene inteso.
Il che ci permette di esistere e di essere perciò quanto meno fraintesi.
Se esistesse un linguaggio in grado di essere inteso, disse Saurau,
non ci sarebbe bisogno di nient’altro.
(Thomas Bernhard – Perturbamento)
"Mi piace""Mi piace"
Caro Giorgio,
la tua saggezza ha raggiunto un alto livello di umanità che ti permette, a quanto sembra, di non essere turbato dai fraintendimenti: spesso si è fraintesi perché il lettore non è in grado di aprirsi e far entrare, oltre le altissime e munite torri del proprio “io” (o meglio ego), quello che generosamente gli viene offerto da altri “io” meno difesi e più desiderosi di dare quello che hanno avuto la gioia (a volte la sofferenza) di scoprire vivendo leggendo e scrivendo.
Risponderei a Saurau: c’è un linguaggio in grado di essere inteso ed è quello dell’amore nella sua connotazione di fondo:l’apertura verso l’ ‘Altro’ che richiede umiltà , generosità e sacrificio di sé. Mi rendo conto di quanto sia difficile relazionarsi con il prossimo in questo modo…ma è possibile! (e tu hai sottolineato l’importanza del “possibile”, anche se in un diverso contesto). Grazie per l’interessante citazione! (amo le citazioni)
"Mi piace""Mi piace"
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER – ALLA RICERCA DI UNA LINGU
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER – ALLA RICERCA DI UNA LINGU
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER – ALLA RICERCA DI UNA LINGU
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER – ALLA RICERCA DI UNA LINGU
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER – ALLA RICERCA DI UNA LINGU
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER – ALLA RICERCA DI UNA LINGU
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER – ALLA RICERCA DI UNA LINGU
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER – ALLA RICERCA DI UNA LINGU
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER – ALLA RICERCA DI UNA LINGU
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER – ALLA RICERCA DI UNA LINGU
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER – ALLA RICERCA DI UNA LINGU
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER | L'Ombra delle Parole Rivis
Pingback: DIBATTITO A PIÙ VOCI: NON LA POESIA È IN CRISI MA LA CRISI È IN POESIA – ALCUNE QUESTIONI DI ONTOLOGIA ESTETICA – LA QUESTIONE MONTALE-PASOLINI – ALLA RICERCA DI UNA LINGUA POETICA: TOMAS TRANSTRÖMER | L'Ombra delle Parole Rivis