
Ho scritto questo romanzo ispirandomi, in parte, alla struttura di La notte della cometa dell’amico Sebastiano Vassalli, e in parte all’autobiografia (Son of Italy) di Pascal D’Angelo, da lui scritta in inglese e pubblicata nel 1924 a New York. Nato a Introdacqua (L’Aquila) nel 1894, Pascal emigrò in America nel 1910 e morì a Brooklyn, in estrema solitudine e indigenza, nel 1932. I fatti narrati nella prima parte sono realmente avvenuti, come realmente esistiti sono alcuni personaggi di questa storia, compaesani di Pascal che condivisero la sua vicenda di emigrato. Vari altri episodi descritti nel romanzo sono puramente immaginati sulla base della documentazione biografica da me raccolta e sulla base della temperie socio-storica della New York degli anni Venti.
In Italia, tra i pochissimi che si sono occupati di D’Angelo, occorre, di fatto, menzionare proprio Vassalli, il quale richiamò l’attenzione su questo sventurato quanto visionario “poeta italiano che volle essere americano” (paragonandolo a Dino Campana), in uno dei suoi Improvvisi sul “Corriere della Sera” (21 novembre 2001), in occasione dell’uscita di Canti di luce, un libriccino di poesie di D’Angelo da me curato per un coraggioso editore salernitano (Ed. Il Grappolo), lo stesso che due anni prima aveva pubblicato, per la prima volta in Italia, Son of Italy.
La lettera di D’Angelo, riportata in italiano nel penultimo capitolo, è la traduzione letterale di quella che lui scrisse effettivamente il 2 gennaio 1922 a Carl Van Doren, l’allora direttore di The Nation, il cui archivio presso l’università di Princeto conserva i fogli originali che usò Pascal nel batterla a macchina.
(Luigi Fontanella)
 scheda del romanzo
scheda del romanzo
New York 1910: Pasquale D’Angelo, un giovane sedicenne di origine abruzzese, sbarca a Ellis Island insieme con il padre e un gruppo di suoi compaesani in cerca di fortuna. L’impatto con il “nuovo mondo” è durissimo, fra i più traumatici tramandati dai nostri emigrati, e allo stesso tempo, per Pasquale – divenuto ben presto “Pascal” –, magnetico ed elettrizzante. A differenza dei suoi compagni, la cui principale aspirazione è di migliorare le proprie condizioni di vita e fornire un aiuto ai familiari rimasti in Italia, Pascal matura l’ideale di diventare scrittore e poeta americano. Per questo ideale studierà accanitamente l’inglese notte e giorno, approfittando di ogni frammento di tempo libero che gli concede il suo massacrante lavoro di spaccapietre, di manovale, di pick and shovel man. Con perseveranza titanica, e una fede incrollabile nella poesia, Pascal percorrerà fino in fondo il tunnel del suo calvario. Il giovane si sentirà man mano investito come di una missione suprema, palingenetica, con il dovere di obbedire alla sua voce interna, a dispetto delle tremende difficoltà ambientali, degli innumerevoli sacrifici ai limiti dell’umano, di una lingua nova imparata con l’aiuto di un Webster sempre più sbrindellato, e l’insegnamento di maestri sublimi come Keats e Shelley; maestri che illuminano il suo cammino accidentato e gli danno la forza necessaria a resistere. Sarà una lotta prometeica, gravata da un’assediante indigenza, che porterà il giovane spaccapietre ad abbandonare i suoi compagni dopo una logorante e lunga esperienza di manovalanza, e a ritirarsi infine in una misera topaia di Brooklyn per lanciare da lì la sua sfida alla città di New York e al Dio “spietato” che la governa.
Luigi Fontanella, saggista e poeta fra i più significativi della sua generazione, ha raccolto documenti e materiali di vario genere su questa vicenda vissuta cento anni fa da un nostro connazionale in America, traendone un romanzo “storico” avvincente e commovente, seguendone tutta la traiettoria, dal suo inizio sconvolgente fino al tragico e glorioso epilogo.
Luigi Fontanella vive tra New York e Firenze. Ordinario di Letteratura Italiana e direttore del Dipartimento di Lingue e Letterature Europee presso la State University di New York, ha pubblicato libri di poesia, narrativa e saggistica. Tra i titoli più recenti Pasolini rilegge Pasolini (Archinto, 2005, tradotto in più lingue); L’angelo della neve (Mondadori, 2009); Bertgang (Moretti & Vitali, 2012, Premio Prata, Premio I Murazzi); Migrating Words. Italian Writers in the United States (Bordighera Press, 2012); Disunita ombra (Archinto, 2013, Premio Frascati alla Carriera); L’adolescenza e la notte (Passigli, 2015, Premio Pascoli, Premio Giuria-Viareggio, uscito anche in francese: L’adolescence et la nuit, tr. by P. Démeron, Éditions RAZ, 2017); Lo scialle rosso. Poemetti e racconti in versi (Moretti & Vitali, 2017) . Per la narrativa ha pubblicato i romanzi Hot Dog (Bulzoni, 1986, tradotto anche in inglese e pubblicato da Soleil nel 1998) e Controfigura (Marsilio, 2009). Dirige per la casa editrice Olschki la rivista internazionale di poesia e poetologia italiana “Gradiva”, ed è critico letterario di “America Oggi”.
Prologo
New York, 31 dicembre 1921
Un uomo sta dirigendosi verso Times Square dopo aver trascorso l’intera giornata nella sala di lettura della New York Public Library.
Arrivato al botteghino della metropolitana, infila meccanicamente una mano nella tasca del logoro cappotto ma non trova i pochi spiccioli che gli servono per il biglietto. Di colpo si rende conto che qualcuno glieli ha rubati in biblioteca approfittando di una sua momentanea assenza dalla sala di lettura.
C’è un momento d’imbarazzo da parte di quest’uomo (un giovanottone di quasi 28 anni, ma già segnato da una vita piena di stenti e ristrettezze) di fronte all’impassibile bigliettaia, la quale, di fronte al suo smarrimento, svogliatamente si limita a dirgli che la BRT (Brooklyn Rapid Transit) non fa opere di beneficenza. L’uomo accenna a un mezzo sorriso; senza dire una parola risale le scale e si riporta sulla strada. Sono le otto di sera. Dà un’occhiata al cielo senza stelle come a interrogarlo sul tempo. In fondo – pensa – che fretta c’è a rientrare a casa, in quel minuscolo, gelido tugurio dove vivo tutto solo?
Si raccoglie nel suo cappotto e si avvia verso la Quinta Avenue, improvvisamente schiaffeggiata da furiose folate di vento. È una rigida sera del 31 dicembre 1921.
Va avanti per più di un’ora, senza fermarsi, fino ad arrivare nei pressi di Union Square. Ancora poche traverse, ed eccolo immettersi su Broadway. Ma proprio qui si scatena il finimondo: un misto di neve, grandine e pioggia ghiacciata lo investono da tutte le parti, senza dargli scampo.
Indeciso sul da farsi, l’uomo ripara sotto il cornicione di un palazzo. Ma è solo per una manciata di secondi. Riprende la sua marcia e arriva a Canal Street. Sa che, da Canal, potrà imboccare molto presto Forsyth Street e da lì c’è il Manhattan Bridge che collega la City a Brooklyn, dove si trova la sua abitazione.
Arrivato di fronte al ponte, violenti fiocchi di neve gli sferzano la faccia. In pochi istanti il soprabito si copre di un luccichio diffuso, ma l’uomo non si ferma anche perché oramai ha di fronte a sé soltanto questo ponte e non c’è un posto ove ripararsi dalla furia degli elementi.
Attraversa come un automa il Manhattan Bridge, lungo due chilometri, mentre neve e pioggia ghiacciata gli stanno inzuppando i vestiti fino alle ossa. Sbircia incurante sotto di sé l’East River, le cui acque scure schiumano impetuose.
Arrivato infine alla stazione di Flatbush, l’uomo sosta per un po’ dentro la saletta d’ingresso per riprendere fiato dopo oltre due ore di marcia. Dalla grande vetrata guarda, paralizzato dal freddo, stanco e affamato, la neve che continua a scendere implacabile. Socchiude gli occhi e come trasognato pensa al tozzo di pane raffermo che ha lasciato sotto il suo letto. In questo momento la sua fatiscente stanzetta, un tempo usata come sgabuzzino per la legna, gli sembra di gran lunga migliore di questo androne dove non c’è un’anima viva.
Si fa coraggio, e rasentando i muri di sporadiche costruzioni, palazzi fatiscenti, catapecchie e umili magazzini, prosegue il suo cammino lungo l’interminabile Flatbush Avenue, che agli inizi degli anni Venti era un semplice rettilineo della periferia newyorchese.
Eccolo arrivare finalmente alla quarta Avenue. Un tempo era l’estremo sobborgo di Brooklyn. Per lui, divenuto poco più di un’ombra, ci sono ancora da percorrere un paio di chilometri nel buio della notte. Quindicesima strada, sedicesima strada, Prospect Avenue, diciassettesima, diciottesima, diciannovesima…, l’uomo arriva infine alla ventesima, dove al numero civico 210 è situata la sua abitazione.
È quasi mezzanotte.
Per entrare nella sua stanzetta deve passare attraverso un gabinetto, usato da altre famiglie che vivono in quel caseggiato. Da questa latrina in comune spesso ci sono perdite d’acqua sporca e lordure di ogni genere che s’infiltrano sotto la porta del suo alloggio. Questa notte, per la pioggia e la neve, oltre che per le frequenti perdite d’acqua, si sono formate alcune chiazze semighiacciate.
L’uomo apre la porta del suo tugurio e, nel buio, affonda i piedi in una pozzanghera. La finestra è spalancata e la neve è penetrata a folate, e continua a penetrarvi in un turbinio feroce. Una parte del letto è bagnata e ugualmente allagato è il pavimento su cui sono impiastricciati fogli di carta, i suoi pochi libri, qualche umile suppellettile. Tutto bagnato o inzaccherato. Insudiciati anche un paio di pantaloni e alcuni panni di ricambio che lui generalmente tiene sotto la branda. Il pane, intriso d’acqua e di sporco, emana un tale fetore che lo rende immangiabile.
Infreddolito, tremante, stanco morto per l’immane fatica, l’uomo chiude la finestra, si rannicchia nella parte del letto ancora asciutta e si avvoltola nel cappotto che gli fa anche da coperta. Chiude gli occhi e va col pensiero ai suoi anni infantili, quando abitava con la sua famiglia in uno sperduto paesino dell’Abruzzo.
Quest’uomo si chiama Pascal D’Angelo. Mio nonno, finché visse, gli fu amico fraterno, e io oggi voglio raccontarne la storia, così come lui me la raccontò in modo tanto appassionato, e così come io ho potuto ricostruirla grazie alle mie ricerche.
PRIMA PARTE
Introdacqua, Abruzzo, 1910
1
Poco più di cento anni fa Introdacqua era, e in buona misura lo è ancora oggi, una piccola contrada arroccata sull’Appennino abruzzese fra due giogaie di monti, nella parte meridionale di quella che è chiamata la Conca Peligna. Situata a pochi chilometri da Sulmona, il suo singolare nome allude al fatto che il paese fu costruito tra le acque (inter aquarum cursus). Il Gonfalone del Comune, che riprende l’originale disegno a inchiostro eseguito nel 1751 da Giuseppe Lafolla, raffigura tre torri merlate e, sotto di loro, lo scorrere delle acque.
L’idea della sua costruzione in alto, tra due valloni sulle pendici di Colle Rotondo, fu certamente suggerita dalla necessità di difendersi, nei secoli scorsi, in caso di attacchi durante le guerre.
La montagna che domina tutta l’area è il Genzana, alto più di duemila metri, così denominato perché vi abbonda la genziana, bellissimo fiore dalle azzurre corolle a imbuto. Secondo quanto afferma Plinio il Vecchio, a scoprire le proprietà curative di questa pianta fu Genzio, re dell’Illiria (180-168 a.C.).
Dalla cima di questo monte, che da Introdacqua si può raggiungere in circa quattro ore di cammino, si gode un panorama di spettacolare bellezza; si scorgono nitidamente in lontananza il Gran Sasso, la Maiella, il Morrone, il Colle Mitra, l’alveo del Fucino e, scendendo con lo sguardo in basso, l’intera Conca Peligna. Quasi tutte queste montagne sono coperte da una lussureggiante distesa di serre e di boschi, essenzialmente costituiti di faggi, cerri, pini e abeti. Sulle radure di queste giogaie e venivano, e ancora oggi vengono – sebbene in misura minore -, i pastori delle varie vallate a ridosso di Introdacqua per condurvi e farvi stazionare le proprie pecore durante la primavera e l’estate; radure ricercate per la qualità e l’abbondanza delle erbe e delle acque, in quanto tutta la zona è ricca di fonti sorgive. Ugualmente numerose le grotte e cavità naturali sui fianchi dei monti, create dalla continua azione delle acque di infiltrazione.
Un tempo per raggiungere Introdacqua bisognava, da Sulmona, percorrere un sentiero di pochi chilometri, che si incuneava tra boschi e mulattiere. Questo viottolo divenne una strada carrozzabile nel 1874, esattamente vent’anni prima che nascesse Pascal D’Angelo.
10 Ottobre 2010.
Sono in macchina e sto percorrendo, dopo aver lasciato Sulmona, la stradale 479 che porta, appunto, a Introdacqua. È la seconda volta che mi reco in questo paesino. La prima volta ci capitai quasi per caso dieci anni fa, anche se mentalmente avevo desiderato venirvi da tempo, ossia fin da quando di Pascal mi aveva parlato mio nonno che l’aveva conosciuto di persona negli anni Venti a New York.
Oltre ai racconti di mio nonno, ad accrescere la mia curiosità verso Pascal aveva decisamente contribuito la lettura che avevo fatto anni prima della sua autobiografia, pubblicata nel 1924 da un’importante casa editrice americana. Quella mia prima visita, tuttavia, era stata brevissima e del tutto casuale. Ero diretto a Pescara per incontrarmi con un amico, e da lì, seguendo la A25, sarei andato a Termoli dove mi sarei imbarcato per le isole Tremiti per una breve vacanza. A causa di una serie di imprevisti non riuscii a vedere quest’amico. Ecco che inaspettatamente avevo davanti a me un’intera giornata a mia disposizione. Perché allora, mi dissi, non fare una deviazione e inserire nel mio viaggio verso le Tremiti una breve visita al paesino di mio nonno?
Ben altro lo spirito con cui oggi sto andando a Introdacqua. Voglio cercare di rivedere la casa natale di Pascal, visitare con calma e attenzione i luoghi della sua infanzia e adolescenza, raccoglierne notizie e possibilmente qualche documento. In particolare, vorrei incontrarmi con Rino Panza, un anziano e affabile signore che ebbi modo di conoscere in occasione della mia prima visita, del quale divenni subito amico. Questi mi parlò con entusiasmo di Pascal; gli sembrava un fatto straordinario che qualcuno venuto apposta da New York si occupasse di lui.
Mi portò a vedere il suo luogo di nascita: una minuscola contrada, fuori del paese, denominata Cauze, e costituita essenzialmente da una piazzola sulla quale si affacciavano poche modeste casette. In una di queste casupole aveva abitato la famiglia D’Angelo. Mi parlò inoltre, con competenza e passione, della tematica dell’emigrazione del proprio paese, sulla quale aveva scritto vari articoli e raccolto materiali preziosi. Oggi mi piacerebbe poter consultare questo suo archivio per ricavarne utili informazioni. Vado col pensiero al nostro primo incontro, avvenuto sulla piazza principale del paese.
Persona gioviale ed estrosa, spirito poliedrico, poeta, saggista e musicista, Rino a quel tempo stava lavorando a uno studio aggiornato sulla tormentata vicenda biografica di Pascal D’Angelo. Ma oltre che di Pascal mi parlò con fervore, e a lungo, anche di un altro suo illustre concittadino: Francesco Ventresca, il quale una volta sbarcato negli Stati Uniti nel 1891, a 19 anni, spese subito i suoi pochi denari a disposizione per acquistare una grammatica inglese. Due anni dopo intraprese a Western Springs, Illinois, il suo lungo iter scolastico a cominciare dalle elementari fino all’università e, al contempo, facendo i più umili mestieri: sterratore, manovale, spaccapietre, muratore, operario delle ferrovie – tutti mestieri che pochi anni dopo avrebbero fatto anche Pascal e mio nonno – e dedicando le nottate allo studio e all’apprendimento della lingua e della cultura inglese. Infine, laureatosi e specializzatosi come interprete e traduttore, divenne un professionista al servizio del Dipartimento della Marina e della Guerra degli Stati Uniti.
Arrivo a un incrocio: a sinistra c’è il cartello che indica Introdacqua, distante un chilometro; alla destra una strada di campagna: Via Torre San Pietro. Giro dunque a sinistra e davanti a me si apre un lungo viale alberato in salita.
Poco prima di entrare nel paese chiedo a un tale che sta caricando dei sacchi su un furgone se sa dove abita Rino Panza. Mi dice che devo ritornare indietro, oltrepassare l’incrocio e prendere Via Torre che porta a un minuscolo rione denominato, se ben capisco, “Case del Medico”. Lì ci sono alcune villette, in una di esse c’è quella dove abita il mio uomo.
2
Mi viene incontro verso il cancelletto chiuso una signora molto avanti negli anni. Mi scruta, attraverso le sbarre, con perplessità più che curiosità. Mi scuso per la mia venuta senza alcun preavviso; le dico, un po’ precipitosamente, che vengo da New York, che sono lì per visitare Introdacqua, il paese di origine di mio nonno Giorgio Vanno e che… desidererei vedere Rino Panza (mentalmente presumo sia suo marito) per avere notizie e informazioni su Pascal D’Angelo.
Sul volto della donna si disegna come una piccola smorfia di dolore mista a diffidenza o titubanza: ma è solo un momento, ed è possibile che io interpreti la sua reticenza in modo errato.
Aggiungo, il più premurosamente possibile: “ Mi scuso di nuovo per il disturbo… è che terrei veramente a rivedere Rino ” (sottolineo con la mia voce quel “rivedere” e uso di proposito soltanto il suo nome per farle intendere una certa “familiarità” che mi legherebbe da tempo a quest’uomo). “Sa, ci siamo conosciuti dieci anni fa proprio qui a Introdacqua. Suo marito…, Rino è suo marito, vero?, mi parlò di un libro che stava scrivendo su Pascal D’Angelo e sulla tematica dell’emigrazione. Io in questo periodo sto facendo alcune ricerche sulla sua permanenza qui a Introdacqua prima che emigrasse in America insieme con suo padre. Anche mio nonno emigrò in America insieme con Pascal e suo padre.”
“Mio marito è malato, molto malato… non può parlare, non riesce a parlare bene”, taglia corto la donna, ma lo fa con grazia e pazienza antica.
Non aggiunge altro. Forse s’aspetta che io me ne vada o che le esprima qualche segno di comprensione. Poi, soprappensiero, quasi parlando a se stessa, mormora sottovoce: “ È a letto… ha avuto un ictus.”
Mi dice queste ultime parole guardandomi negli occhi, facendo un lieve gesto con la mano, come se volesse togliersi qualcosa dai capelli, tutti bianchi, raccolti in una crocchia dietro la nuca.
“Mi dispiace tantissimo… non lo sapevo, ne sono veramente addolorato”, non so cos’altro aggiungere.
La donna mi dà un’occhiata che a me sembra umilmente benevola.
“Vabbene, venga… venga” sussurra di nuovo a bassa voce, e, come tirando un sospiro di sollievo, mi apre gentilmente il cancello.
Attraversiamo un piccolo giardino mentre io provo un vago senso di vergogna per la mia intrusione. Per un istante penso di fermarmi, scusarmi con la donna e ritornare in macchina.
Tutt’intorno un silenzio astrale, interrotto solo dal calpestio dei nostri passi sulla ghiaia del sentiero che dal cancelletto conduce fino alla porta di casa.
Entriamo in una minuscola anticamera che dà su un corridoio. Mi colpisce immediatamente la densa penombra che avvolge tutto lo spazio. Alla mia destra: un ampio soggiorno, a sinistra la cucina. Poi il corridoio continua più avanti dove scorgo altre camere e, proprio in fondo, una vetrata che dà su un giardino con, in mezzo, un bel pergolato.
Seguo la signora nel soggiorno. Al centro, una lunga tavola fratina con le sedie e, su un lato, il salotto con un divano, un tavolinetto basso e due poltrone di fronte a un caminetto in pietra. In un angolo della sala troneggia una vetrina la cui base è formata da uno scrittoio di legno massiccio. Alcuni vecchi quadri raffiguranti, perlopiù nature morte, completano l’arredamento.
Tutto lo spazio è immerso in una profonda oscurità, le due finestre laterali sono chiuse e le persiane quasi del tutto abbassate. Filtra da alcune stecche una pallida luce pomeridiana.
“Si accomodi” dice la donna, “vado di là ad avvisare Rino. Come si chiama lei?”
Un po’ imbarazzato le rispondo: “Mi scusi, non mi sono ancora presentato. Sono Giorgio Vanno… porto lo stesso nome di mio nonno che era di Introdacqua. Forse suo marito ha conosciuto qualche membro della mia famiglia, anche se oggi qui non c’è rimasto più nessuno della mia parentela. Tutti i miei familiari vivono da anni in America.”
La donna scompare risucchiata dal corridoio. Mi guardo attorno. Nell’aria si avverte distintamente l’acre odore di caminetto mescolato ad alcuni effluvi provenienti dalla cucina che intravedo benissimo da questa sala. Odori di legna bruciata, misti con altri che sembrano, di primo acchito, come di funghi e pomodori secchi, castagne, aglio e origano. Mi giungono intanto brevi spezzoni di frasi pronunciate in dialetto dalla donna, alle quali fanno riscontro solo brevi suoni gutturali dell’uomo. Una radiolina accesa in cucina a basso volume.
“Venga… Rino desidera vederla”, la voce sottotono della donna mi sorprende alle spalle mentre sto dando un’occhiata alla vetrina, che invece di contenere le solite suppellettili, come tazze, bicchieri e altri arredi usuali, raccoglie perlopiù, in maniera un po’ caotica, libri, mucchi di carte, schede e ritagli, cataste di opuscoli e riviste di vario genere.
Entriamo in una stanzetta umilmente arredata: un letto, un comodino e un piccolo armadio. Odori penetranti di canfora, alcol, orina, medicinali e muffa dominano l’aria. Disteso, immobile sul letto, c’è un uomo dallo sguardo stralunato, i pochi capelli bianchi schiacciati sulla testa calva, la bocca semiaperta con una smorfia fissa e tremante allo stesso tempo.
Gli tendo inutilmente la mano e mi presento ricordandogli il nostro precedente incontro. Il vecchio ha un lampo negli occhi. Forse cerca di dirmi qualcosa per me del tutto incomprensibile, mentre io gli spiego succintamente le ragioni della mia visita. È una situazione irreale, accentuata dalla sua totale inerzia. Un fascio di luce vividissima, rettangolare, proveniente dall’unica, piccola finestra della stanza, investe a metà il letto su cui è disteso quest’uomo.
A un certo punto tra lui e la moglie avviene una specie di dialogo essenzialmente costituito da uno scambio di segni visuali e mozziconi di parole in dialetto. La donna sembra di capire ciò che suo marito intende comunicarle; mi fa cenno di seguirla di nuovo nel soggiorno. Qui tira su la serranda di una delle due finestre. Apre la vetrina. Vi estrae due libri e me li porge in silenzio. Non capisco se me li sta consegnando affinché io li possa consultare o se me li stia semplicemente regalando. Leggo di sfuggita sulla copertina di uno dei due il nome dell’autore (Rino Panza) e il titolo: Il mondo di Pascal D’Angelo. Si tratta, molto presumibilmente, del volume che lui mi aveva annunciato nel corso del nostro primo incontro.
“La ringrazio”, dico un po’ impacciato, “posso… potrei consultarli?”
“Li tenga pure”, risponde prontamente ma con estrema gentilezza la donna, “Rino mi ha detto di regalarglieli, mi dispiace che per lui non sia possibile fare altro. È semiparalizzato… ha visto lei stesso…, ha un’enorme difficoltà a parlare, ma credo che l’abbia riconosciuta.”
Non mi resta che congedarmi da questa donna, da questa casa, da quest’uomo: l’unica persona di Introdacqua con la quale mi sarebbe piaciuto discorrere di ciò che mi sta a cuore; l’unica e forse ultima persona che avrebbe potuto fornirmi notizie e informazioni sul mio Pascal.
Giunti alla porta d’ingresso, ringrazio la donna e le esprimo, come posso, il mio conforto. Risalgo in macchina mentre sento il cancello chiudersi alle mie spalle.

da dx Luigi Fontanella, Paolo Valesio, Adriano Spatola N.Y. anni settanta
3
Non si sa quando e da chi sia stato costruito il Castello (in realtà si tratta di una Torre di controllo) che svetta a 739 metri di altezza e a 109 metri dal fondo valle (Piazza di Contra), nella parte più alta di Introdacqua, tra due valloni che un tempo delimitavano il paese a nord e a sud. Una posizione più strategica non poteva immaginarsi per scoprire da lontano eventuali nemici e abbracciare con lo sguardo tutto il territorio del Feudo, dalla Rupe di S. Nicolò alle falde del Tassito Piccolo.
La tesi più accreditata vuole che a erigere la Torre siano stati i Conti Di Sangro, i quali, alleati dei Normanni, riuscirono a fondare una dinastia feudale fra le più potenti e durature d’Abruzzo. Di questa dinastia si distinse in particolare Simone I Di Sangro, che nel 1173 estese il suo dominio non soltanto su Introdacqua ma su tutta la cosiddetta Conca Peligna. Fu lui, verosimilmente, il costruttore della Torre, non perché servisse di dimora per sé e per la sua famiglia, ma solo come ultimo asilo e luogo di difesa dei suoi guerrieri in caso di pericolo. In seguito, fu usata come prigione e come tale è descritta nel catasto onciario dell’Università della Terra di Introdaqua (“Castello alla sommità della Terra per uso di prigione”).
Era costume dei Feudatari minori (valvassori e valvassini), in effetti, non di organizzare giostre o indire tornei, ma semplicemente di realizzare guadagni, abbandonandosi ad atti di rapina, di vero e proprio brigantaggio nei territori dei Feudi vicini, spogliando senza scrupoli mercanti, sacerdoti, donne e persone più o meno facoltose di passaggio per il loro Feudo, le quali – catturate e rinchiuse nei sotterranei del castello – dovevano sottostare a un prezzo o tassa di riscatto se volevano essere liberate. Unica eccezione: i mendicanti, perché poveri, e i musicanti, che però dovevano attraversare il Feudo sonando.
Ricavo queste notizie da uno dei due libri regalatimi da Rino Panza: un pesante volume di quasi 600 pagine e 43 tavole fuori testo (Introdacqua nella storia e nella tradizione), pubblicato da Gaetano Susi nel 1994, come ristampa di quello del 1970. Questo librone campeggia sul tavolo della mia camera d’albergo (situato a due passi dalla Torre) insieme con altri libri, carte, documenti e appunti che ho portato con me da New York.
L’albergo si trova nel cuore del borgo antico, una zona che gli abitanti del paese chiamano genericamente “il Castello”. Più che un albergo è una locanda che ha delle camere da letto al piano superiore. La mia è l’ultima di una breve serie di stanze che s’affacciano su squarci di panorami selvaggi di assoluta bellezza.
 4
4
Sono le sei di sera e me ne sto nella mia cameretta riordinando e ripassando cronologicamente carte e libri in mio possesso: innanzi tutto la fotocopia della prima edizione dell’autobiografia pubblicata da Pascal nel 1924 (Son of Italy), che sono riuscito a reperire presso la New York Public Library; un taccuino su cui scrissi alcuni appunti da me presi in quella gloriosa Biblioteca; un libretto del 1989 pubblicato (si fa per dire) dall’Università degli Studi di Sassari a cura di Francesco Mulas (Le poesie di Pascal D’Angelo); fotocopie di alcune recensioni uscite nell’anno di pubblicazione dell’autobiografia e alcuni materiali bibliografici, fra cui, per me molto preziose, le fotocopie delle lettere scritte da Pascal a Carl Van Doren, conservate preso la Firenstone Library della Princeton University.
A questi materiali vanno aggiunti i due libri donatimi da Panza (il suo studio Il mondo di Pascal D’Angelo) e il ponderoso volume di Gaetano Susi. Ho, inoltre, tutta una serie di fogli stampati da Google, nonché tre opuscoli di scarso rilievo che mi sono stati dati dalla Pro Loco di Introdacqua. Il primo, del 1997, contiene delle poesie dialettali, e le musiche relative, composte da Rino Panza (Lu file de la vite); il secondo, genericamente intitolato Introdacqua Duemila, è privo della numerazione delle pagine e senza la data di stampa, ma probabilmente è del 2000, visto che sull’ultima pagina compare, appunto, il calendario dell’anno Duemila. Quest’opuscolo raccoglie brevi testimonianze e immagini su Introdacqua a cura di Antonio Giammarco. Un gruppo di queste testimonianze sono su San Feliciano, il santo protettore di Introdacqua.
Affascinante la leggenda legata a questo santo martire, rievocata, in questa pubblicazione, da Berardino Ferri. Ecco la sua vivace testimonianza.
“Il popolo di Introdacqua voleva le reliquie di un santo da venerare in paese. Quando il vescovo di Sulmona nel 1755 autorizzò finalmente il parroco di Introdacqua a inviare una delegazione a Roma per riportare il corpo santo di un martire della Chiesa, grande fu l’emozione tra i popolani credenti. La voce corse di casa in casa, volò fino alle ultime case del Castello e, veloce come il suono di una campana, giunse a tutte le case di campagna. In tutte le messe della domenica ci fu conferma ufficiale della notizia.
Si costituì immediatamente un comitato per accogliere degnamente l’arrivo delle reliquie e preparare i festeggiamenti per questo evento tanto atteso.
Si formò un gruppo di sei uomini, tutti giovani e robusti, che si sarebbero recati a Roma, per prendere in consegna il santo e si raccolsero fondi per le spese di viaggio e l’acquisto di un’urna.
Il corpo del martire era sepolto nelle catacombe; era stato un guerriero romano, che aveva rifiutato di bruciare l’incenso dinanzi alla statua dell’imperatore, perché per un cristiano tale atto di devozione era riservato solo a Dio.
Questo giovane romano era stato pagano fino a vent’anni, ma poi aveva conosciuto la nuova religione e si era fatto cristiano. Con quel rifiuto sapeva a che cosa sarebbe andato incontro, ma volle dare una testimonianza della sua fede e patì il martirio. Si chiamava Feliciano e questo nome fu subito di buon auspicio per tutta la cittadinanza; col suo arrivo ci sarebbe stata nel paese tanta felicità e serenità.
Da allora tanti neonati furono battezzati col nome di Feliciano, Felice, Felicetta, Felicia. Anna Felicia, in segno di devozione e di omaggio verso il nuovo protettore del paese.
Il gruppo dei giovani introdacquesi partì per Roma col salvacondotto del Vescovo e l’indirizzo preciso dove recarsi. Quando attraversarono la frontiera dello Stato Pontificio non ebbero problemi e il viaggio si svolse con i migliori auspici.
Molti di essi conoscevano la strada perché più di una volta erano andati a lavorare nella campagna romana. Questa volta però non andavano a piedi; avevano il corredo di tre mule e, forse per questo, la strada sembrò più breve.
Roma era allora una città piccola; al massimo duecentomila abitanti, tutta raccolta entro le vecchie mura.
Questi pellegrini trovarono presto la Chiesa, dove giaceva il corpo del martire e, nel giro di poche ore, ricevettero in consegna la sacra reliquia, proveniente dalle catacombe di S. Callisto.
Che emozione per quei giovani montanari! Avevano ora con loro il corpo di un santo, il corpo di un uomo, che aveva testimoniato il suo credo e aveva pagato per questo atto con la vita.
Le sante reliquie furono lavate, asciugate accuratamente, deposte in una grande cassa sopra una coperta di raso.
Con questa nobile compagnia, ripartirono tappa tappa per il paese. Quando giunsero sopra Tagliacozzo, quei giovanotti erano molto stanchi e si misero a dormire per terra sotto un gruppo di alberi di faggio. Accanto a loro avevano deposto la cassa contenente l’urna tra i sassi e il falasco.
Probabilmente la cassa fu appoggiata male, perché improvvisamente scivolò giù per il pendio verso Roccacerro.
Gli abitanti di questo paesino, quando seppero dell’accaduto e vennero a conoscenza della presenza della preziosa reliquia, pensarono che fosse un segno del destino e che il santo aveva manifestato l’intenzione di fermarsi lì, per restare con loro. Era difficile convincerli che si era trattato di un incidente, che l’erba bagnata aveva facilitato lo spostamento della cassa e la sua precipitosa caduta.
Mentre gli abitanti del villaggio insistevano perché i viandanti lasciassero lì San Feliciano, improvvisamente si sentì salire dall’urna una voce possente che disse:
I’ nen so’ né de Rome né de Bare,
nen so’ de Tévule né de Roccacerre;
i’ so’ Feliciane de ‘Ntredacque,
quile è lu mio paese e loche adienca i’.
Ci fu sconcerto tra tutti i presenti. Gli abitanti di Roccacerro si misero in ginocchio e pregarono a lungo il santo. Poi rifornirono quei giovani di ogni ben di Dio e li accompagnarono in processione fino alle ultime case del paese. E da lì paesino dopo paesino, contrada dopo contrada arrivarono fino a Introdacqua.”
Così il racconto di Berardino Ferri.
 5
5
Pasquale D’Angelo nasce a Introdacqua il 20 gennaio 1894, da genitori poverissimi. Il padre, Angelo D’Angelo, nato il 18 novembre 1859, fa il contadino; possiede sei pecore quattro capre e un minuscolo pezzo di terra. Morirà il 24 novembre 1935. Dalla gente del paese veniva chiamato ze’ ‘Ngelélelle (“zio Angelino”), secondo una consuetudine locale che indicava un certo rispetto verso le persone più anziane. Nel registro delle nascite del Comune, ove vengono annotati i natali di Pasquale, compare la sua firma. Il che non significa che egli sapesse leggere e scrivere, nel senso pieno in cui intendiamo. Negli ultimi decenni dell’Ottocento l’analfabetismo in Italia si aggirava, mediamente, intorno al 60 per cento. In alcune regioni come l’Abruzzo e la Puglia toccava circa l’ottanta per cento. La maggior parte degli abitanti non andava al di là della propria firma.
La madre di Pascal, Anna Felicia, nasce il primo marzo 1864 e muore il 6 dicembre 1932. In dialetto veniva chiamata ze’ ‘Naflice (“zia Anna Felicia”) per le stesse ragioni su indicate.
Pascal ha un fratello minore, menzionato ogni tanto nel corso della prima parte della sua autobiografia. I quattro conducono una vita grama, quella dei braccianti, “la classe più miserabile esistente in Italia alla fine dell’Ottocento.” Così Vincenzo Padula, in un suo studio. E, ancora il Padula: “ Fino a otto anni il fanciullo va dietro all’asino, alla pecora e alla scrofa; a nove anni il padre gli pone in mano la zappa e la pala, in spalla la cesta di vimini, lo conduce seco al lavoro e lo mette in condizione di guadagnarsi 42 centesimi al giorno. A quindici il suo salario cresce, e ne ha 67; a venti non tratta più con la zappettina, ma la grossa zappa, e rompendosi l’arco della schiena da mane a sera ha 85 centesimi e la minestra, o 125 senza minestra. Allora si sente di esser vero bracciante, e per scemare o raddoppiare la sua miseria, prende moglie.” (Cito dal volume curato da Denis Mack Smith, Storia d’Italia 1861-1969, I, Laterza, p. 176).
L’alternativa a questa misera esistenza è emigrare altrove. È ciò che faranno padre e figlio nel 1910 insieme con altri compaesani, ed è ciò che farà mio nonno Giorgio. Ma dopo sei anni di manovalanza durissima, un calvario vissuto in condizioni di lavoro disumano girovagando da una parte all’altra nel nordest degli Stati Uniti (New York, New Jersey, Maryland, Connecticut, Massachusettes, Vermont e Virginia), il gruppo si sfalda: due di loro muoiono maciullati sul posto di lavoro; il padre di Pasquale (in America divenuto subito “Pascal”), sfinito e avvilito, decide di ritornare in patria. Suo figlio, invece, resta a New York. È ormai fermamente intenzionato ad abbandonare il suo lavoro di pick and showel man (manovale con piccone e badile) e a intraprendere la carriera di scrittore, malgrado le obiettive quanto feroci difficoltà esistenziali che dovrà affrontare. Un’esperienza che, per un povero contadinello italiano, emigrato in America un secolo fa, ha dell’eroico o del sublime.
 Seconda parte
Seconda parte
2
Scintillano gli occhi del nostro Pascal di fronte allo spettacolo – per lui straordinario e convulso – di macchine taxi autobus e fiumi di gente frettolosa per le strade della Lower Manhattan.
È una tarda mattinata di aprile. I nostri introdacquesi sono ormai nella Grande Mela. I loro occhi vanno soprattutto verso le sopraelevate, sulle quali scorrono senza sosta, proprio sopra le loro teste, con enorme fracasso di ferraglie, i vagoni della metropolitana (New York City Subway).
Si trattava, e si tratta tuttora, del maggiore sistema di trasporto pubblico esistente al mondo, i cui primi tratti, nella città di New York e dintorni, cominciarono a funzionare fin dal 1869.
Pascal è soprattutto sbalordito dalla lingua (le lingue) che sente circolare fra la gente, mentre sfrecciano velocemente automobili e vari mezzi di trasporto della City.
Ovviamente a prevalere è l’inglese, una lingua che il giovane ha già sentito a Ellis Island dai solerti impiegati della dogana, e che ora si rimescola prodigiosamente con il dialetto abruzzese dei suoi compagni e di Mario Lancia, il compaesano caposquadra che è venuto puntualmente a prelevare il nostro gruppetto al Battery Park.
Ma non c’è molto tempo per assaporare o rendersi pienamente conto di queste “meraviglie”. La loro guida, si muove con scatti precisi e sa ben districarsi in mezzo al traffico di Manhattan. Controllando nervosamente l’orologio, Lancia scambia sbrigativamente qualche parola con loro, mentre li porta immediatamente alla Penn Station e da lì, in mezzo al marasma generale, subito in treno alla volta di Hillsdale nel New Jersey.
Questa è l’America, la prima America, che si fece incontro a Pascal il 20 aprile del 1910.
*

New York di notte
Terza parte
New York e dintorni
1917-1922
1
Pascal ora è a New York veramente solo. Sta camminando lungo l’interminabile Broadway, e prova una sensazione di ebbrezza, mista a una strana eccitazione nervosa. Mille pensieri occupano la sua mente mentre con la propria valigetta si districa abbastanza bene in mezzo al traffico. I mesi in cui è stato fuori gli sembrano un’eternità. Ora sa che qualunque cosa che vorrà o potrà fare dovrà affrontarla da solo, senza consultarsi con nessuno. Non ci sarà nessun Asso di Cuori a guidarlo, né Giorgio, né il possente e ben istruito Andrea Lenta a difenderlo – e magari insegnargli ancora tante cose. Prova improvvisamente una stretta al cuore al pensiero, in particolare, di Andrea; di colpo gli balza vivida nella mente l’atroce smorfia di dolore mentre sta agonizzando stritolato sotto quel maledetto argano della Cumberland Valley.
Non ci sarà suo padre, che in questo momento è a Introdacqua e presumibilmente sta ancora maledicendo la sua esperienza americana, ma anche godendo l’affetto di sua moglie e dell’altro figliolo Felicino, ora divenuto un baldo giovanotto di diciannove anni sul quale può contare per sostenere la propria famiglia. Pascal pensa per un istante al suo fratellino minore… gli sembra impossibile che Felicino, da lui lasciato quando era solo un bambino, ora abbia diciannove anni. Ma il pensiero più affettuoso lo rivolge a Giorgio, dal quale si è appena congedato, e che di tutto il gruppo introdacquese, è l’unico che sia riuscito a far fortuna.
Nella valigia di Pascal, oltre a qualche sommario capo di vestiario, ci sono il nuovo inseparabile Webster, alcuni libri, fra cui il volume della letteratura inglese, e soprattutto due quadernoni, nuovi di zecca, uno dalla copertina rossa, l’altro dalla copertina azzurra. Li ha acquistati a New Haven in un negozietto di College Street, a due passi dalla Yale University; se ne è subito innamorato appena li ha visti in vetrina. Su questi quaderni fantastica di scrivere chissà che cosa. Al centro della copertina di ognuno di essi, in alto, campeggia una targhetta sulla quale compare la scritta COMPOSITIONS. Sotto questo titolo a caratteri cubitali ci sono tre righe. All’inizio della prima c’è scritto Name; all’inizio della seconda: School; all’inizio della terza: Grade.
Pascal non è studente di Yale, l’antica, prestigiosa Università del Connecticut, né su questi quaderni dovrà scrivere alcun paper, sul quale ricevere un voto (grade) dal suo prof. Li ha acquistati semplicemente perché gli piacciono. Non ha mai visto in vita sua quaderni di questo genere, ma qualcosa l’ha spinto a comprarli. Qualcosa, ancora un po’ vago ma imperioso, gli ha suggerito di farlo.
Pascal continua a camminare euforico per le strade di Manhattan, finché i suoi passi non lo portano meccanicamente verso Little Italy, il quartiere di New York City che conosce meglio di qualunque altro. Prende in affitto – pagando giornalmente – una cameretta in Bayard Street, e trascorre i primi giorni newyorchesi bighellonando per le strade di downtown e midtown.
Una mattina – è il dieci settembre del 1917 – Pascal sta camminando sulla Fifth Avenue, all’altezza della quarantaduesima strada. A un certo punto, si trova inaspettatamente di fronte alla maestosa New York Public Library. Pascal si ferma di fronte alla facciata della Biblioteca; ne guarda, stupito ed estasiato, le imponenti fattezze architettoniche, in particolare le solenni colonne dell’entrata. Sale i primi scalini e osserva a lungo i due grandiosi leoni, posti uno a destra l’altro a sinistra. Non ha mai visto, in tutta la sua vita, nulla di simile. In alto, lungo il cornicione che sovrasta il colonnato, fanno bella mostra di sé sei statue. Il giovane si chiede chi o cosa possano rappresentare. Solo qualche tempo dopo scoprirà che quelle da lui più ammirate, al centro del sottotetto – sono opera dello scultore Paul Wyland Bartlett – e che rappresentano, l’una, la Poesia (quella a sinistra) e l’altra (a destra) il Teatro, più propriamente la Tragedia. Sono e ancor più lo saranno di lì a poco, le due forme d’arte da lui più amate, quelle che sente a lui più congeniali e che aspira fortissimamente d’imparare a scrivere.
Il giovane è gradualmente come invaso da una specie di vertigine ed esita prima di salire gli ultimi scalini che lo conducono nel monumentale vestibolo della Biblioteca. In cuor suo, teme che qualcuno possa improvvisamente fermarlo e perfino vietargli l’ingresso.
16
“Con chi vorrebbe parlare, lei?”, gli fa l’usciere, guardandolo sbrigativamente dall’alto in basso.
“ Vorrei parlare con il direttore… il Cavaliere Barsotti”, gli risponde con non minore sfrontatezza Pascal e, ammiccando ai fogli che ha in mano, subito aggiunge: “ Ho da proporgli alcuni miei scritti.”
“Il direttore oggi non c’è”, taglia corto il portiere. “Torni domani.”
“Vabbene” gli risponde pronto Pascal, “mi faccia parlare con il caporedattore Adolfo Rossi.” Il giovane ha debitamente memorizzato i nomi del direttore e del caporedattore.
L’usciere, leggermente sorpreso che Pascal conosca i nomi dei maggiori responsabili del quotidiano, si alza svogliatamente dalla sua seggiola, e gli replica: “ OK, aspetti qui un momento, vediamo se può essere ricevuto…”, e scompare dietro la sua guardiola.
Poco dopo Pascal è in una stanza, sobriamente arredata; dietro una scrivania c’è un signore con piccoli e appuntiti baffetti che lo guarda perplesso, ma anche vagamente incuriosito.
“Buongiorno” fa Pascal tendendogli la mano. “Lei è Adolfo Rossi?”
“No, non sono Adolfo Rossi… non è ancora arrivato. Si accomodi. Piacere, Alfonso Buttafuoco”, gli risponde un po’ cerimoniosamente il tale. Mi dica… cosa posso fare per lei?”
“Ecco, avrei da proporre al vostro giornale queste poesie…”. Pascal porge a Buttafuoco i fogli che ha in mano.
“Poesie? Poesie… scritte da chi? Da lei?”, risponde con sussiego il redattore, che prende a scorrerle svogliatamente. Ma dopo pochi secondi smette di farlo, e aggiunge: “Guardi che il nostro giornale pubblica solo opere di autori noti… Non possiamo fare nulla per lei.”
“Ascolti”, incalza senza demordere Pascal, “ ci sono riviste e giornali americani che pagano dai cinque ai dieci dollari… Io mi accontento di qualunque compenso… quello che ritenete giusto… scrivo anche in inglese.”
Buttafuoco sobbalza dalla sedia: “ Dieci dollari!? Ma neanche dieci centesimi” gli fa di colpo con brutale arroganza. “Mi dispiace. Non siamo interessati. Provi con qualche giornale americano.”
[…]
Siamo a una settimana prima di Natale. New York sembra paralizzata da un freddo polare, ma, al contempo, anche invasa da una folla di passanti in preda ai frenetici acquisti. In mezzo ad essa c’è il nostro Pascal che si sta dirigendo verso l’ennesima Redazione di un importante giornale di fama internazionale. Dopo aver parlottato con l’usciere, gli ha consegnato alcuni fogli dei suoi dattiloscritti, e ora è afflosciato, chiuso nei suoi pensieri, su una sedia della sala d’aspetto, in attesa che qualcuno venga a riferirgli che le sue poesie sono state rifiutate. A un certo punto passa davanti a lui un giovanotto dall’aria baldanzosa, il quale, adocchiato Pascal, si ferma di colpo davanti a lui, sbalordito dal suo aspetto malandato. Pascal s’alza dalla sedia e lo osserva a sua volta con aria interrogativa e, allo stesso tempo, vagamente speranzosa.
“Posso fare qualcosa per lei? Non sta bene, è forse malato?”, gli fa il tale ipocritamente premuroso.
“ Io sto benino”, gli replica Pascal con un lieve sorriso, “ è la mia poesia a essere inferma… e non riesce a trovare un riconoscimento.”
Al solo udire la parola “poesia”, il giovinastro ridacchia e il suo viso raggrinza in una piccola smorfia mentre volge gli occhi in alto, come inseguendo un punto invisibile. Poi congedandosi bruscamente da Pascal, gli dice: “ Credo che lei, amico mio, sia capitato nell’ospedale sbagliato.”
Poco dopo l’usciere, a cui aveva consegnato i suoi fogli, ricompare nella sala d’aspetto e fa entrare Pascal in un ufficio interno. Qui lo accoglie un signore dall’aria calma e rassicurante, come quella di certi medici di famiglia. Questi guarda Pascal a lungo, in silenzio, quasi benevolmente; poi con voce pacata ma ferma, gli dice, proprio come forse farebbe un medico dopo aver esaminato lo stato di salute di un suo paziente: “Sono molto spiacente, signore, ma temo di non poterla aiutare. La prassi del nostro giornale non prevede… insomma, non ci autorizza a pubblicare testi scritti da estranei al nostro gruppo editoriale. Le auguro buona fortuna.”
È una scena che Pascal ha già visto e vissuto, con poche varianti, nei mesi precedenti. Ma un simile trattamento, pur ripetuto più volte nelle sue modalità, non riesce a scoraggiare il nostro giovane scrittore. Nella sua mente c’è sempre in serbo un pensiero fisso che lo sprona a non arrendersi. Se anche novantanove redazioni – pensa – rifiutano le mie poesie, c’è sempre la possibilità che la centesima potrà accettarle.
Quella sera Pascal, rientrando nel suo gelido stanzino, l’unico conforto che riesca a trovare nella sua mente è l’incoraggiante consapevolezza che restano ancora svariati editori a New York da contattare.

Mark Baum (American, 1903–1997). Seventh Avenue and 16th Street, New York, 1932. The Metropolitan Museum of Art, New York
19
[…] La mattina del 23 dicembre Pascal è intento a leggere riviste e giornali nella New York Public Library. Sfogliando The Nation, scopre l’annuncio di un concorso letterario sponsorizzato da questo quotidiano.
2 gennaio 1922
Egregio Direttore di “The Nation”,
ho inviato tre poesie per il Premio indetto dal Vostro giornale, e pur avendo rispettato i termini della presentazione, come descritti dal bando, non ho ricevuto alcuna notifica dalla Vostra Redazione. Vi sarei dunque estremamente grato se poteste informarmi in merito alla questione.
Io spero che nel leggere quelle mie poesie voi terrete conto della mano che le ha scritte; è la mano di uno spaccapietre ignorante che l’inglese non l’ha mai studiato a scuola. Se non contengono troppi sbagli lo devo solo agli amici cari e tanto gentili che mi hanno segnalato gli errori grammaticali. Io sono un uomo che arranca con fatica per emergere dal buio dell’ignoranza e portare il suo messaggio di fronte a un pubblico, di fronte a Voi. Voi la cui missione è di difendere l’immensa causa degli oppressi.
Questa lettera è il grido di un’anima che si è arenata su lidi tenebrosi lungo il suo disperato viaggio verso la luce, verso un faro che le indichi la via per trovare un giusto riconoscimento, affinché io possa vivere della mia arte. Non sto tentando di spezzare le catene di qualche lavoro forzato per rifugiarmi nel mondo della letteratura. No! No! Io voglio solo denunciare le piaghe di quelle catene. Un rifugio? NO! Io sono un manovale, uno spaccapietre, voglio soltanto un’opportunità per esprimere ciò che so dire oltre che fare. Sì, per esprimere le pene di chi piega il capo sotto lo schiacciante peso del giogo di un ingiusto destino.
Non esistono parole in grado di descrivere i miei stenti. Ogni immagine resta muta e incapace di dipingere un simile quadro. Io soffro per un ideale, per la libertà, per la verità da molti taciuta, ma non da chi come Voi ha il dovere di essere umano. Poiché ieri, primo giorno dell’anno, io possedevo solo cinque centesimi, che bastavano appena per un pasto a base di banane marce e un pane secco. E tutto per amore di un ideale. (…) Vi prego di considerare la mia situazione e la qualità delle poesie che ho inviato. (…) Voi potete, sì!, potete fare qualcosa per me. Nonostante la miseria in cui vivo, io non Vi chiedo denaro. Io non vi chiedo pietà. Non c’è scrittore che sopravvivrebbe in un simile stato di abiezione. Fate allora che il premio scavi una breccia in questo muro di indifferenza e che lasci entrare la speranza di un mondo nuovo! Liberatemi dalle mie catene! Datemi un’opportunità prima che il freddo, la pioggia, la grandine e altre infinite sofferenze finiscano di annientare la mia salute fisica e mentale, facendo di me un mostro. Datemi un’opportunità prima che sia troppo tardi. Vi prego di ascoltare il mio grido! Io non ho amici in grado di spianarmi la strada che porta alla letteratura. Sono un misero bracciante, una manovale, ma anche un paladino della libertà. Vivo con poco. Con cento dollari posso tirare avanti cinque mesi. Fatemi emergere da questo ignobile grigiore e aiutatemi a salire su un pulpito splendente da dove io possa, anch’io, far parlare lo scrittore che c’è in me.
Pascal D’Angelo
210 – 20th Street, Brooklyn, New York
È mezzogiorno. Pascal è appena uscito dall’imponente Ufficio Postale della Grand Central Station, che sorge a pochi isolati dalla Biblioteca. Ha appena spedito la lettera a Carl Van Doren, direttore di The Nation.
È una fredda ma trasparente mattina del 2 gennaio. Il giovane fende la folla come in uno stato di ebbrezza aerea. Poco dopo, improvvisamente, sente vicino a lui un uomo che lo guarda benevolmente, gli stringe la mano, gli sorride. Lo aiuta ad alzarsi dal marciapiedi ghiacciato su cui è scivolato…
Pascal trascorre due giorni come in uno stato di catalessi, senza uscire mai dal suo buco; è sprofondato in uno stato di disperazione calma, senza sofferenza e senza pensieri; un vuoto nel quale egli è assopito serenamente, anche perché non ha più voglia di nulla. Passa quasi tutto il tempo a letto, dormendo o sonnecchiando, finché una mattina viene scosso da un continuo, brutale battito alla porta, tonfi che diventano sempre più furiosi. Il giovane si trascina fino all’ingresso del suo tugurio. Fuori c’è Gordon che lo squadra imbestialito ma anche con aria perplessa. Schifato, gli consegna una lettera, special delivery. Pascal con gli occhi socchiusi sbircia sulla busta l’intestazione del quotidiano The Nation. È Carl Van Doren, il direttore in persona, che gli ha scritto: lo invita a venire nel suo ufficio, con tanto di data e ora specifica.
Due ore dopo, Pascal, smunto, tremante, scheletrico, la testa fra le nuvole, è nell’ufficio di Carl Van Doren. Malgrado il suo grave deperimento, sul volto spettrale del giovane compare un lieve sorriso. Van Doren, in effetti, lo sta accogliendo con benevolenza; ordina immediatamente caffè caldo e donuts che arrivano in un baleno. Al giovane che lo guarda smarrito, dice: “ I was touched by your letter…”, al contempo, gli stringe più volte le mani e gli annuncia che è lui il vincitore del Premio di Poesia!
Pascal quasi non l’ascolta, si guarda attorno incredulo. Dalla grande vetrata della finestra filtra un raggio di sole che illumina diagonalmente tutto l’ufficio e gradualmente fa luce anche nella sua mente. Van Doren continua a parlargli con tono affabile, lo interroga, lo incoraggia, lo rincuora, gli consiglia infine di raccontare la sua storia di emigrato in un libro di cui si farà mentore lui in persona. Pascal lo ringrazia, ancora alquanto frastornato. Poi, quasi di colpo, lo attraversa un pensiero: non dovrò più andare a suonare alla porta di un Grande Giornale; mai più masticare del lurido pane raffermo; mai più picconare, sterrare, scavare, patire offese e soprusi.
Sì, ora potrò scrivere, pensa, come e quanto voglio, e ciò che voglio. È Van Doren stesso, rimugina, che me lo sta dicendo e ripetendo. Nulla più ostacolerà il mio cammino di scrittore.
Pascal lo sa benissimo, mentre poche ore dopo, con la sua valigetta sgangherata, nella quale ha raccattato le sue carte e gli striminziti effetti personali, sta per uscire dalla sua topaia. Gli è ritornato come per magia il coraggio di un tempo e ora si sente pronto a percorrere la sua esistenza, giorno per giorno, come rinato a nuova vita.
“Addio Mister Gordon” mormora a bassa voce mentre passa davanti a lui che dal cancelletto d’ingresso lo sta osservando con aria interrogativa.
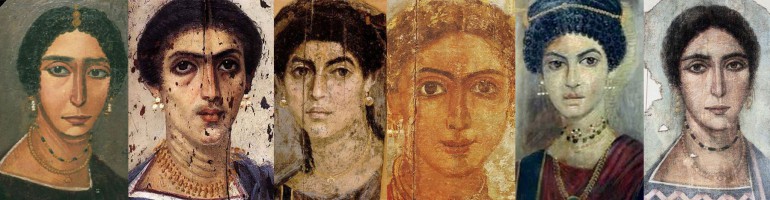










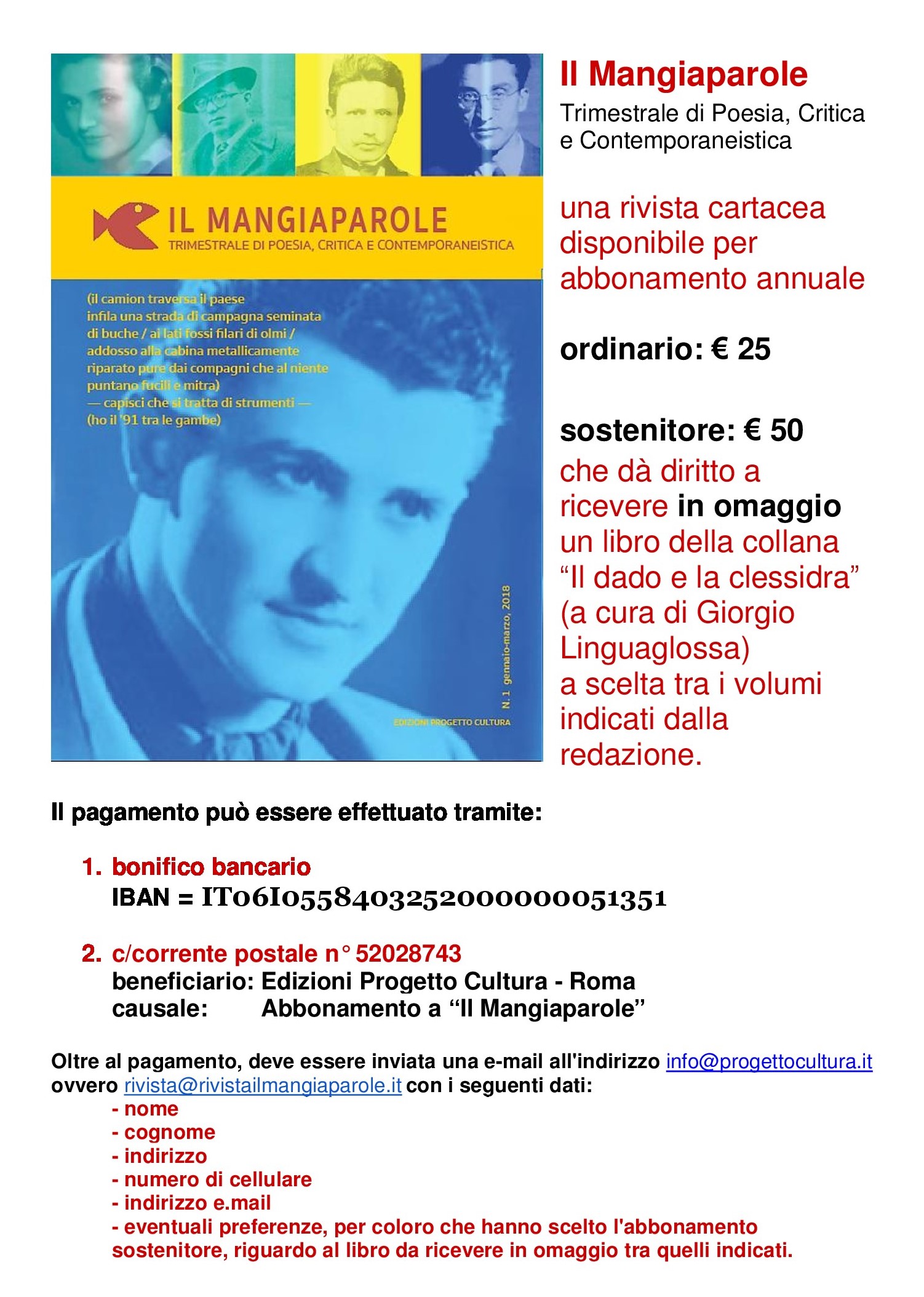
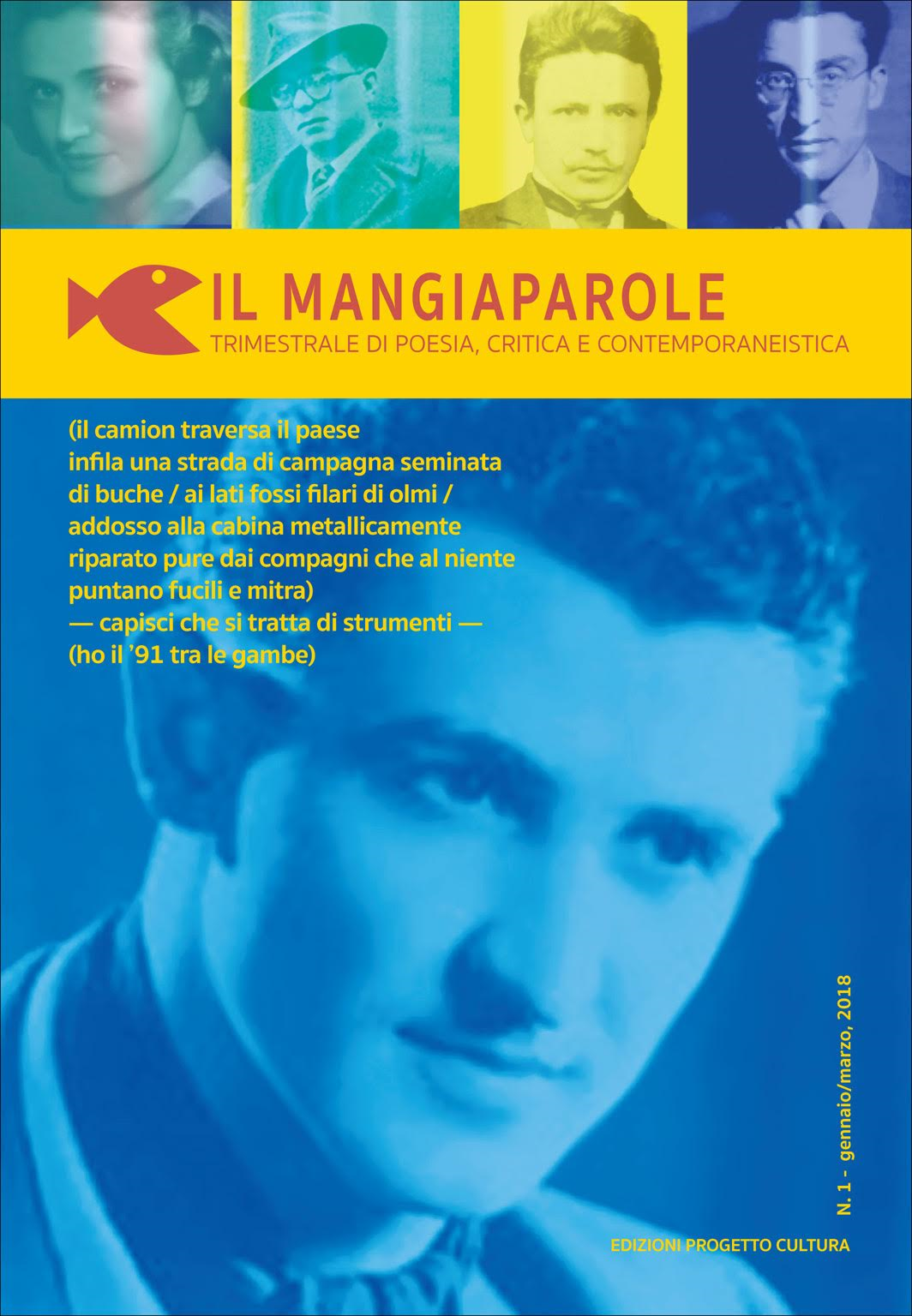

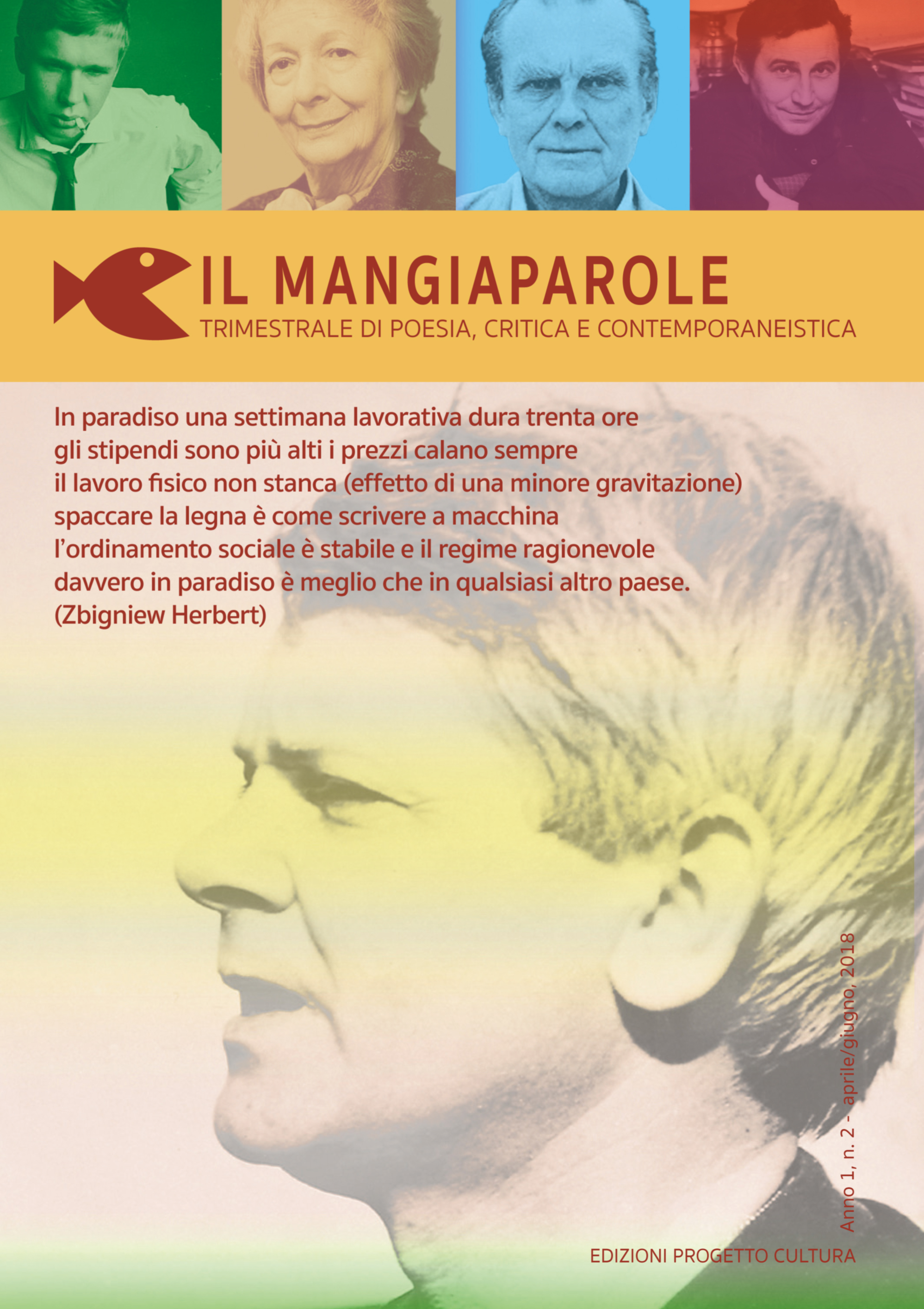



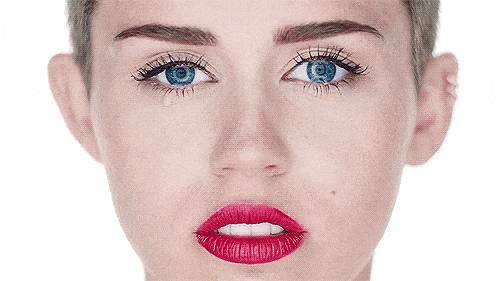
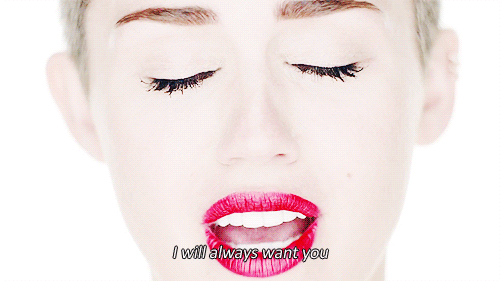
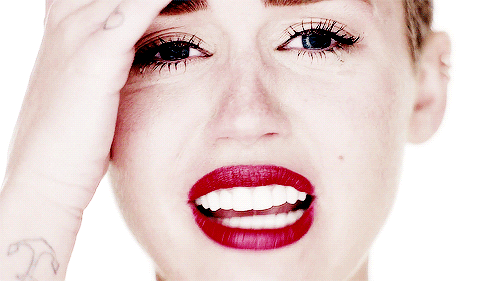
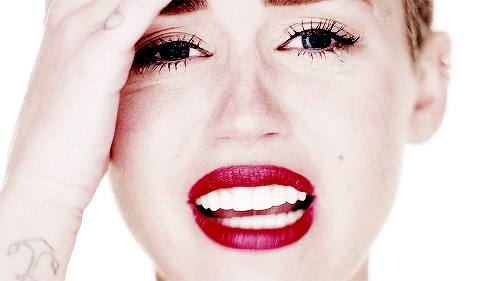
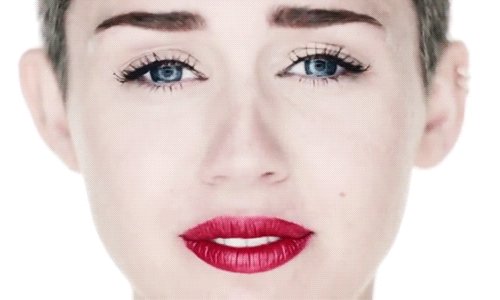



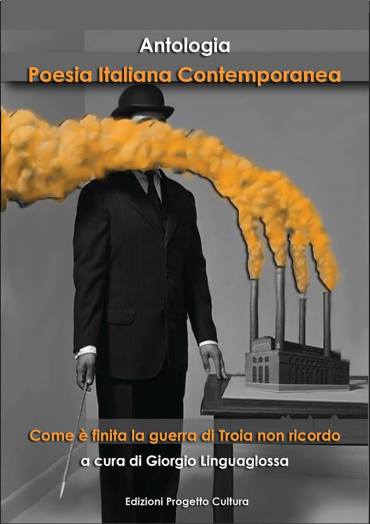




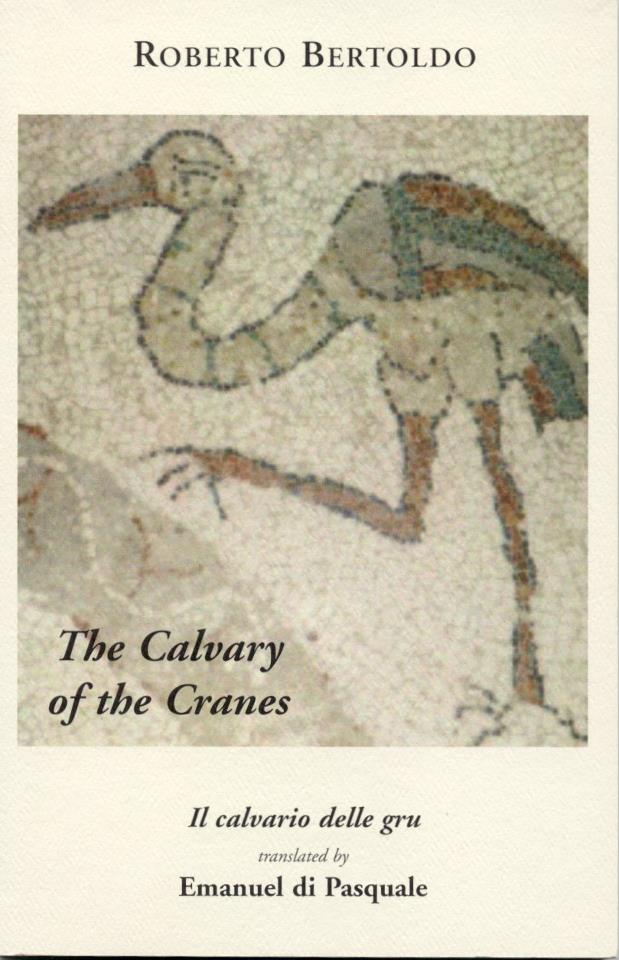
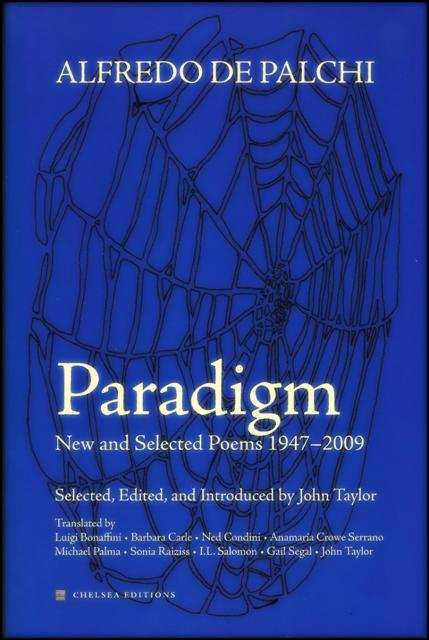


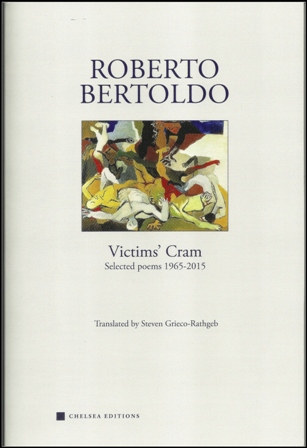





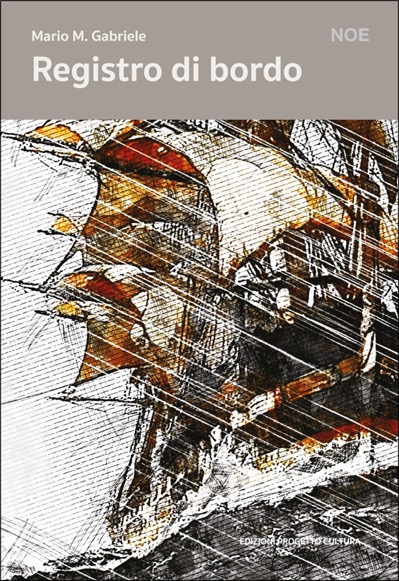

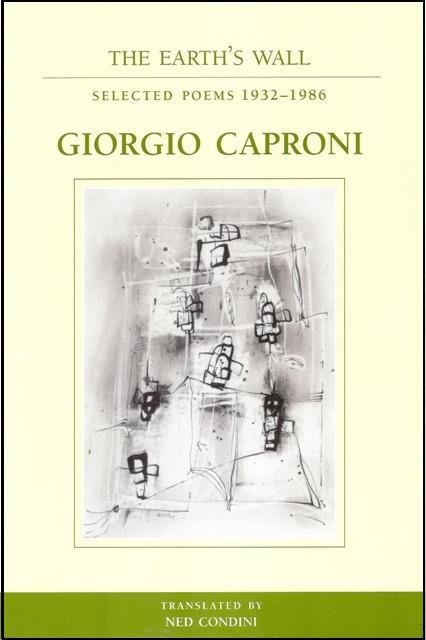
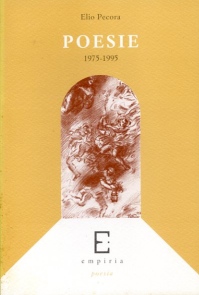

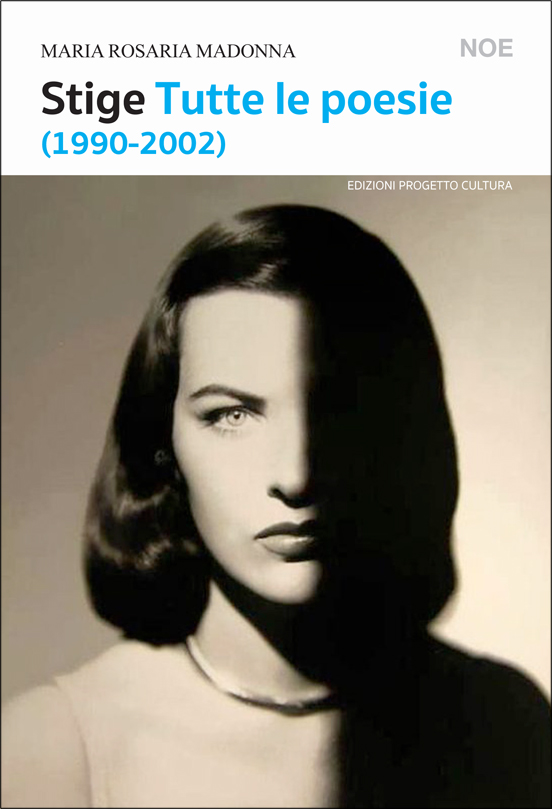

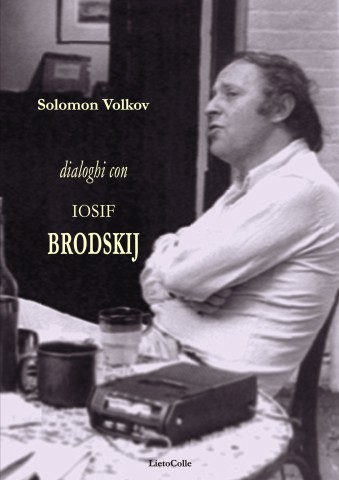




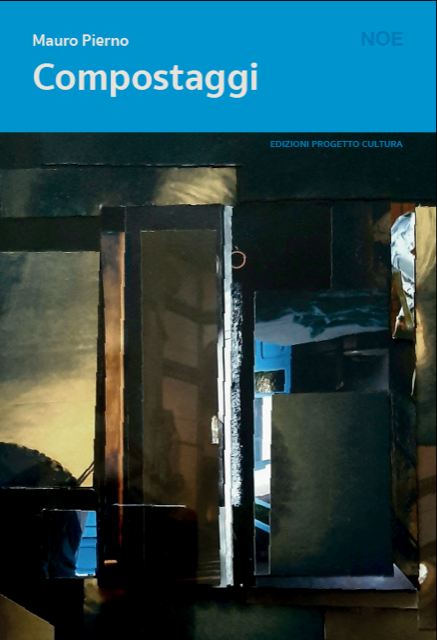
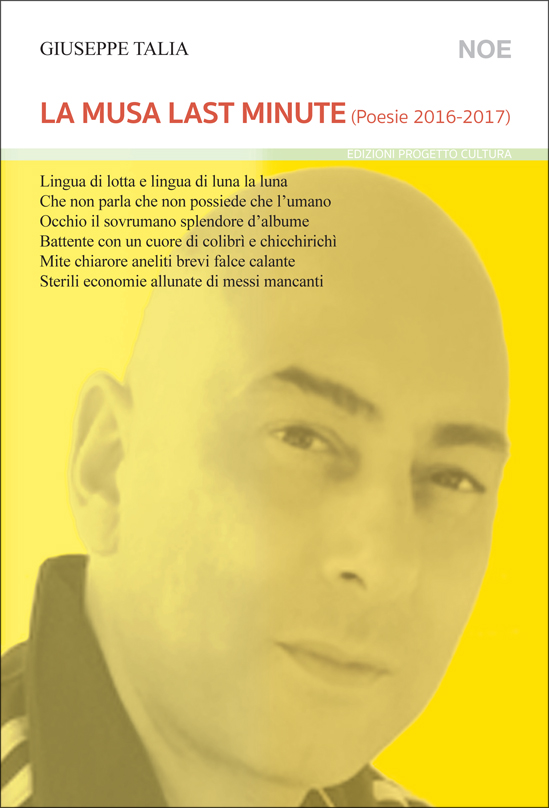


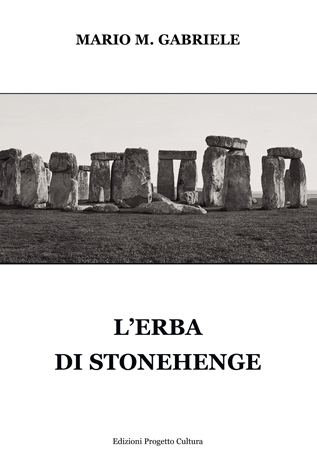
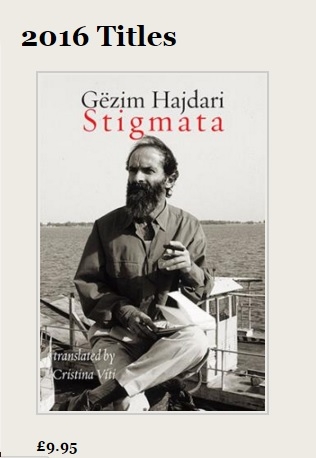
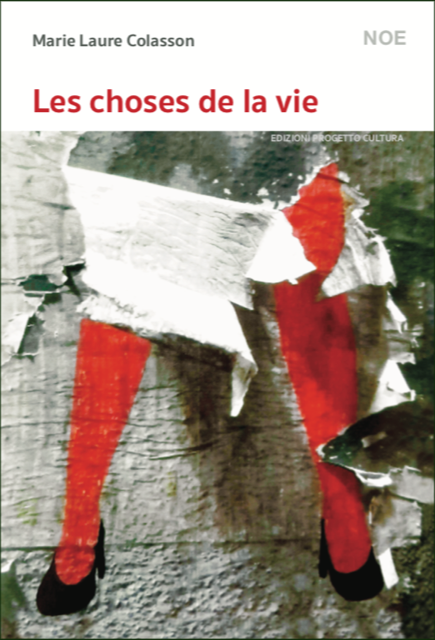




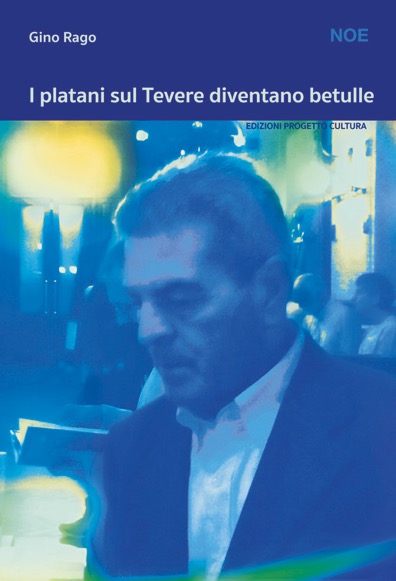
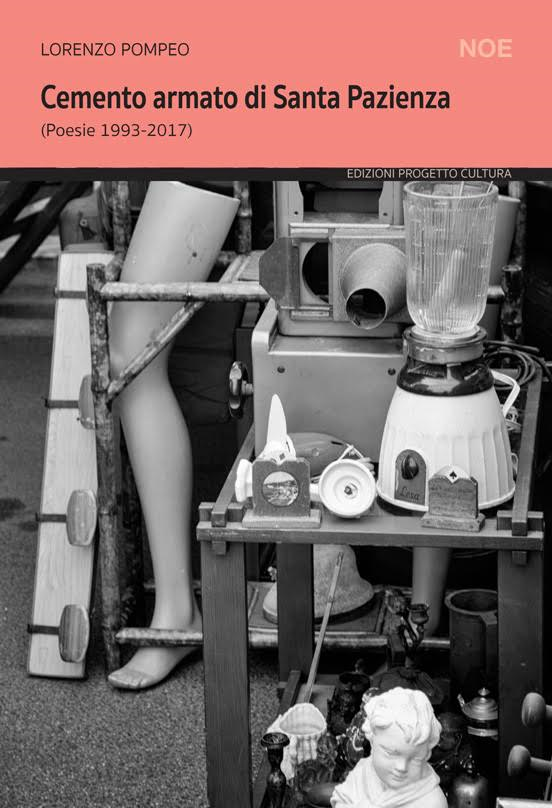
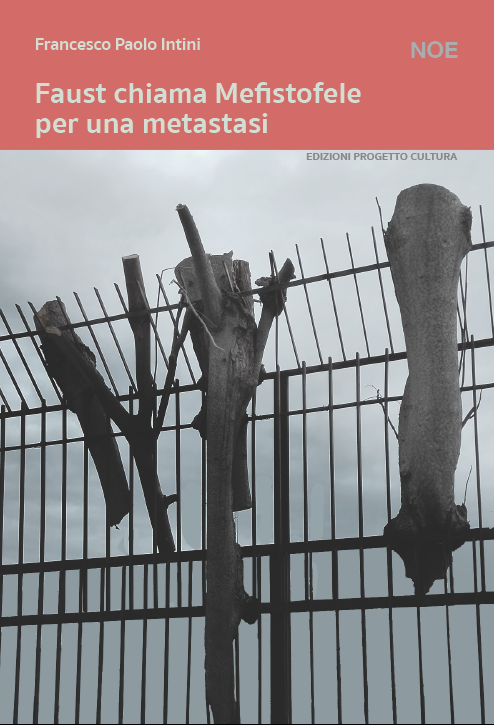

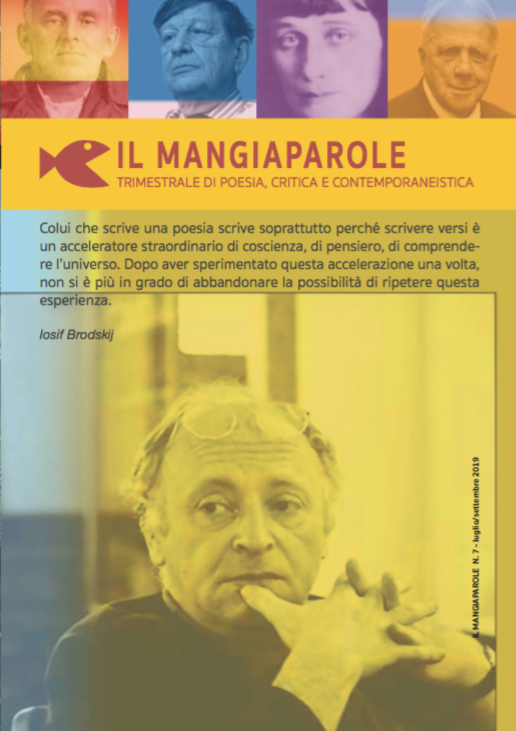




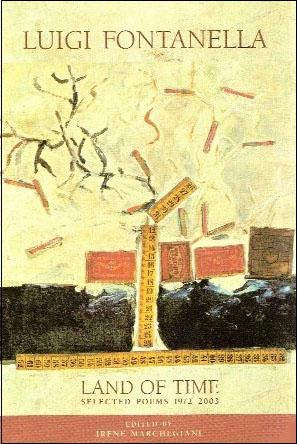








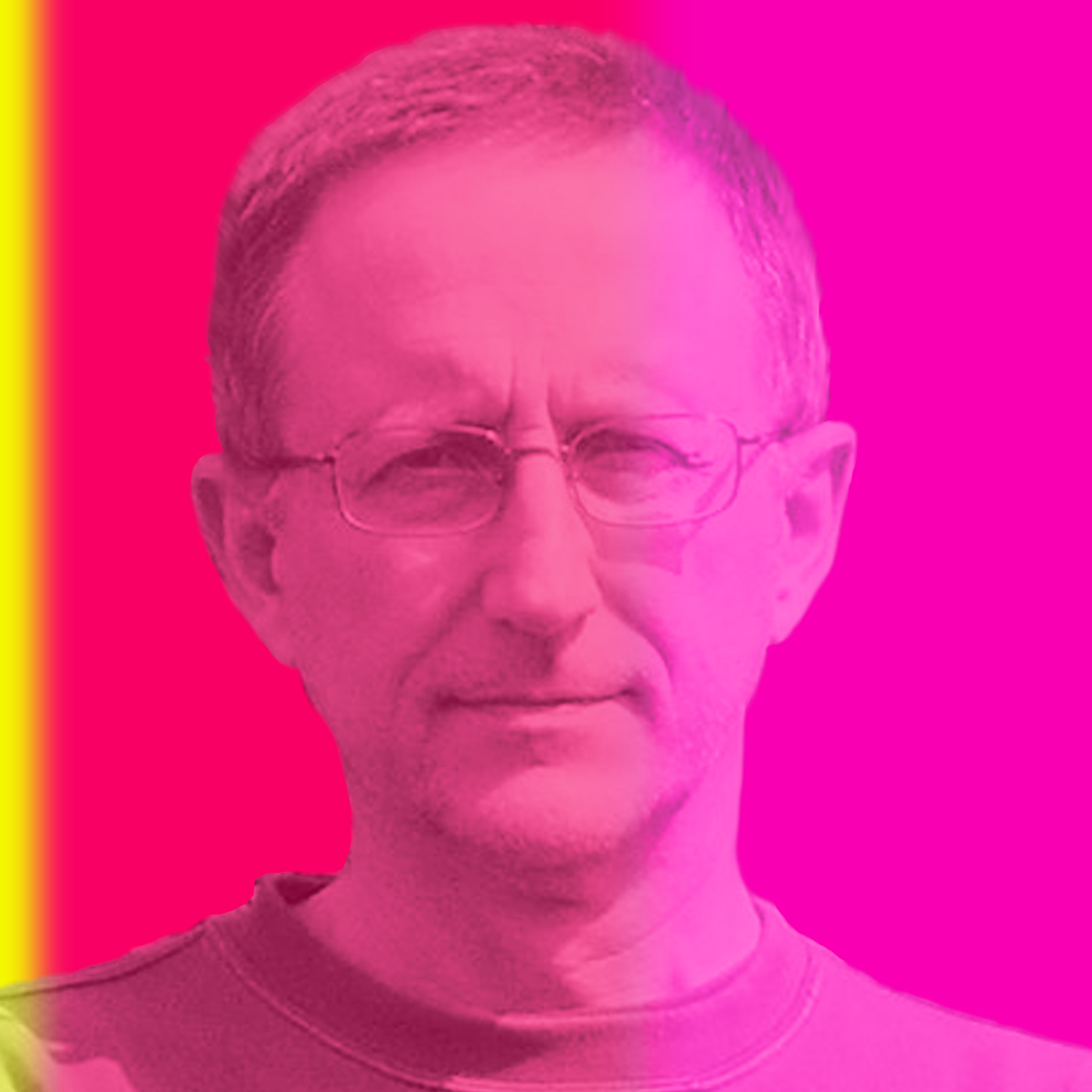







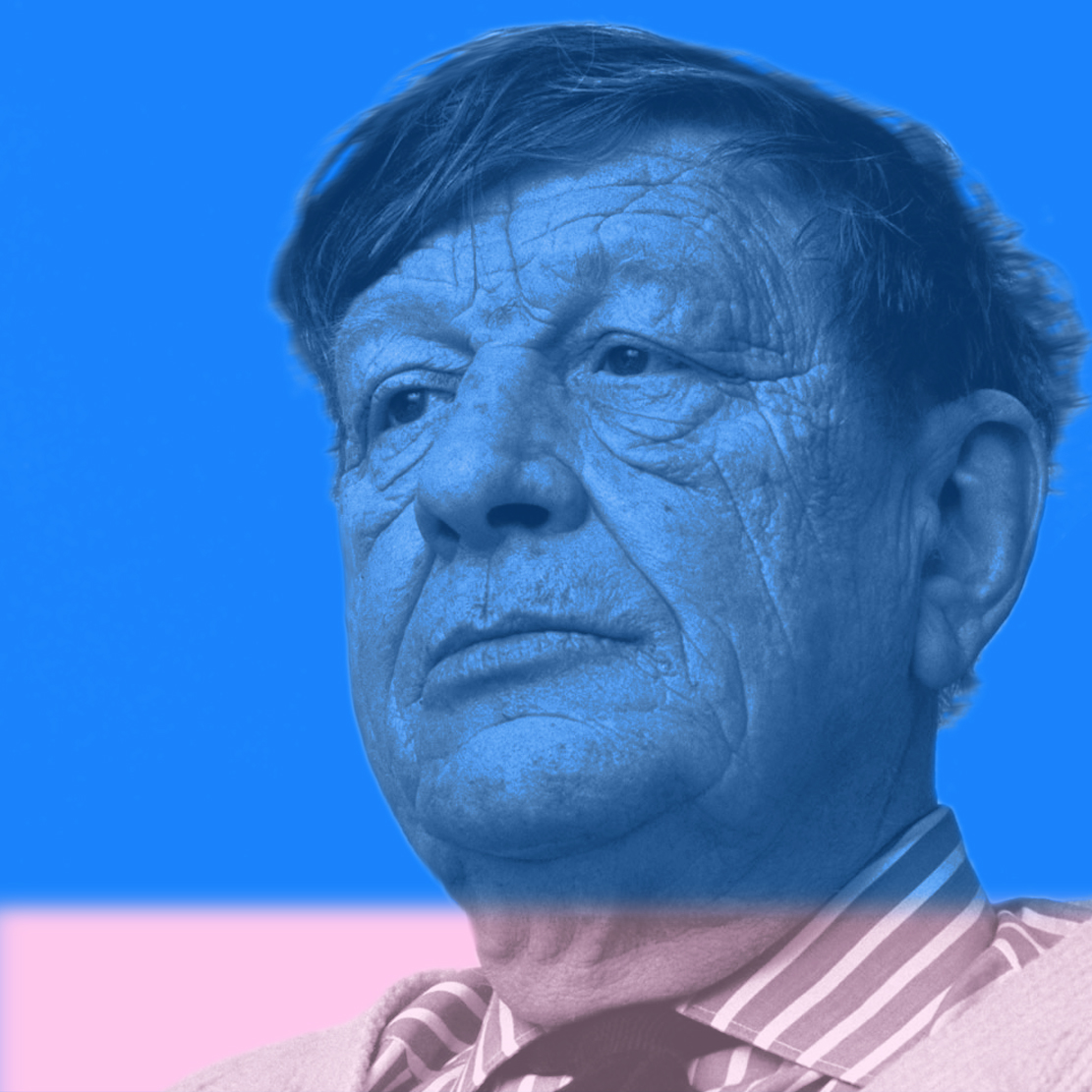



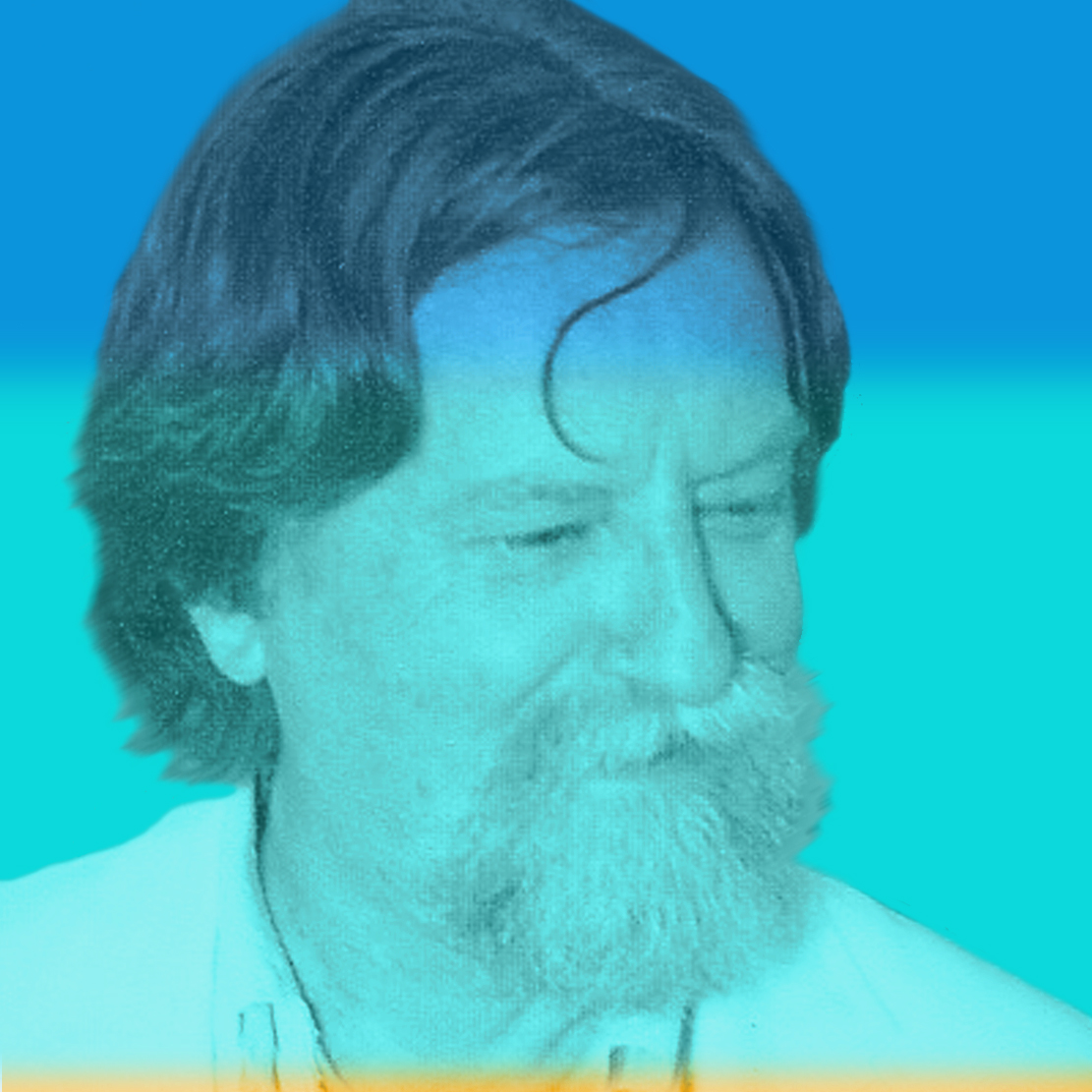
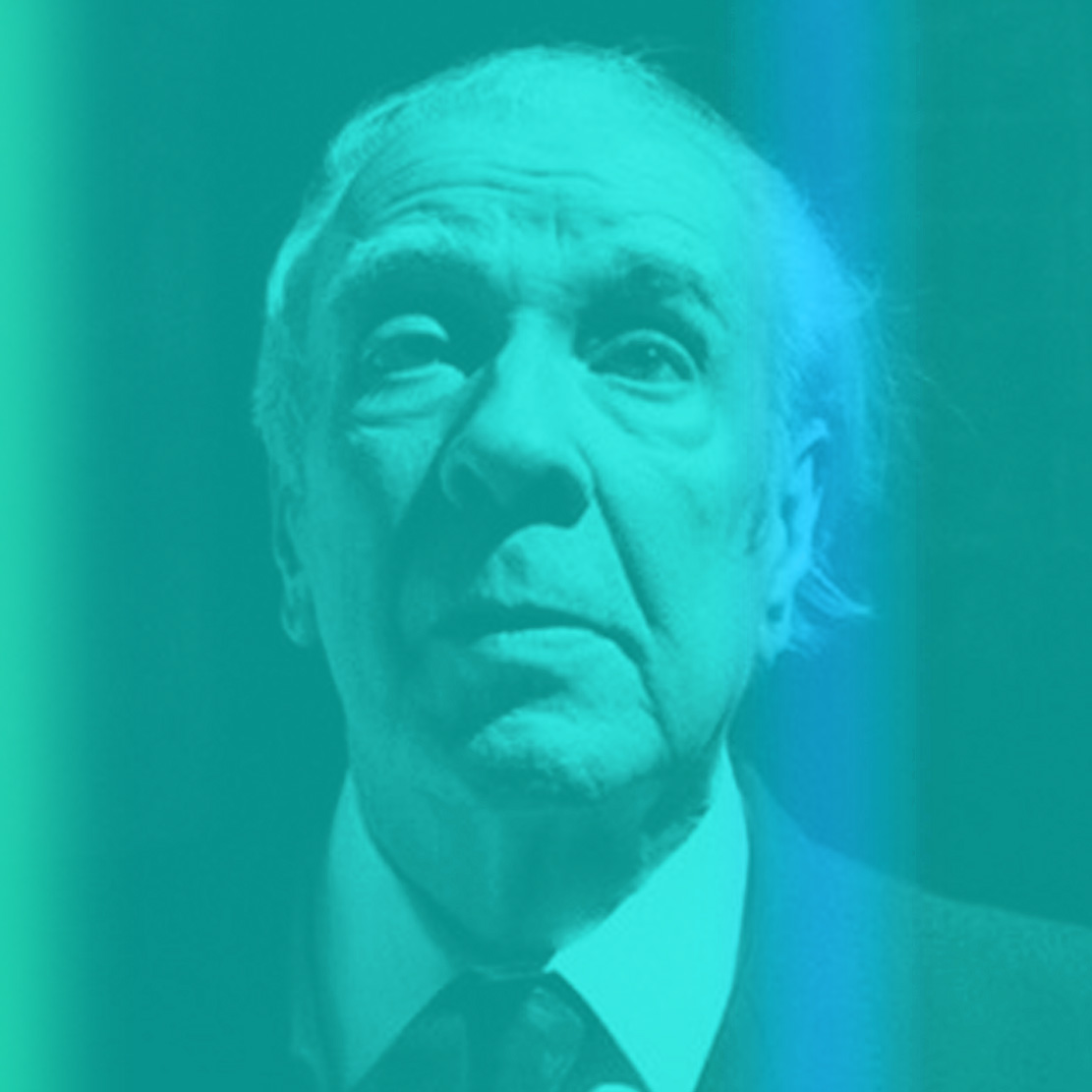




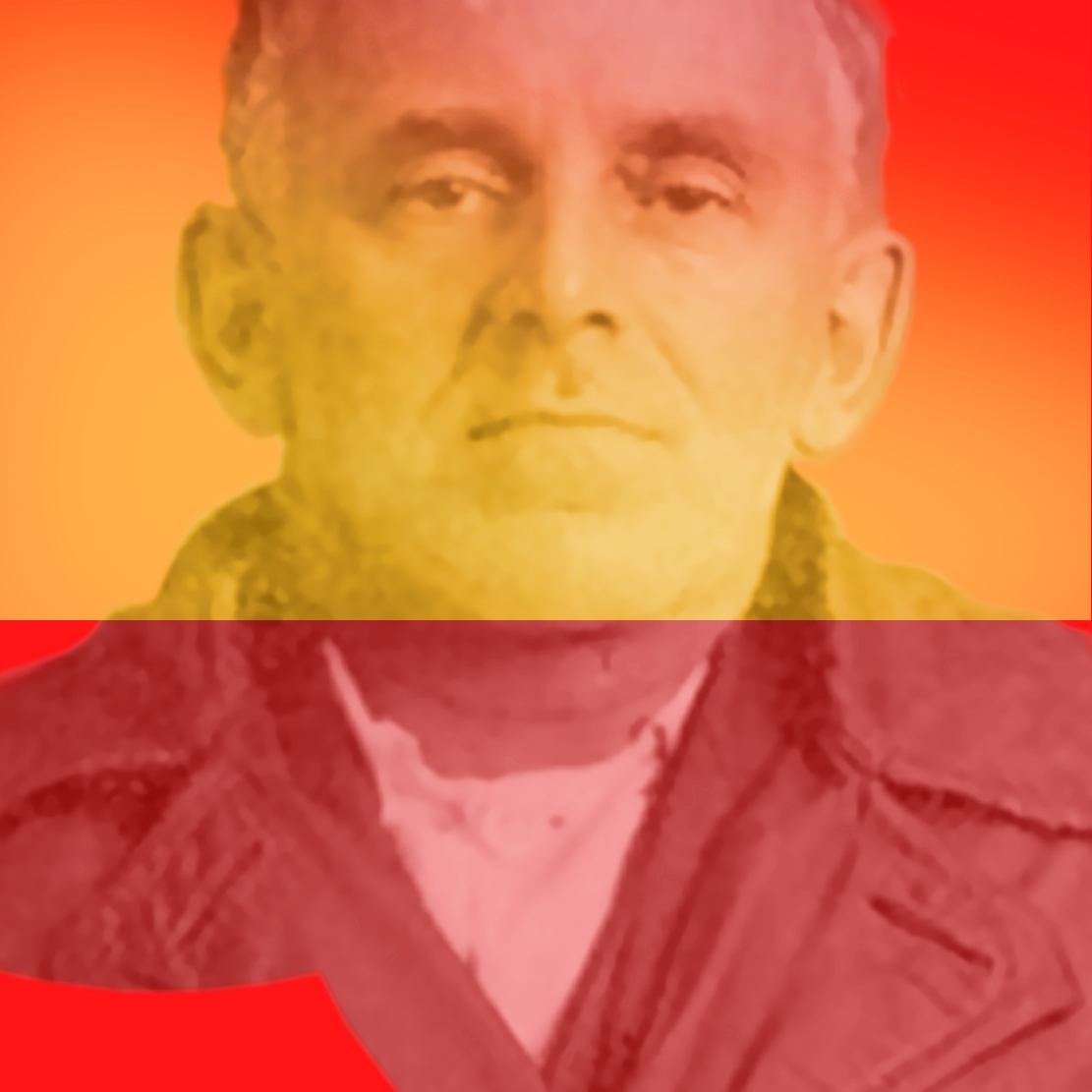






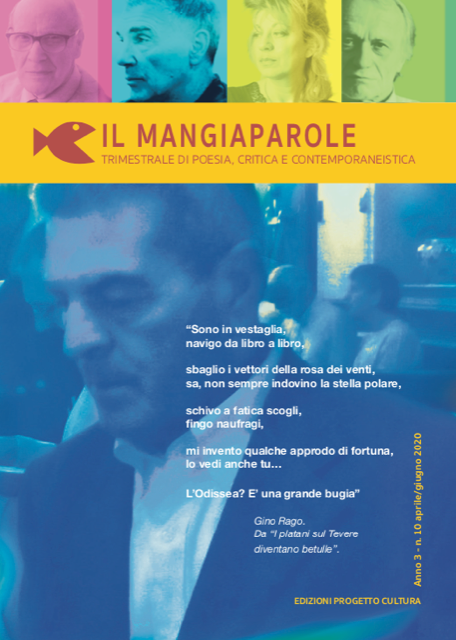




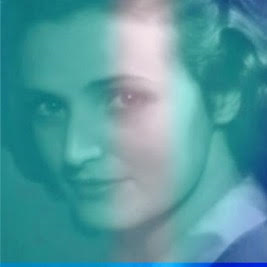
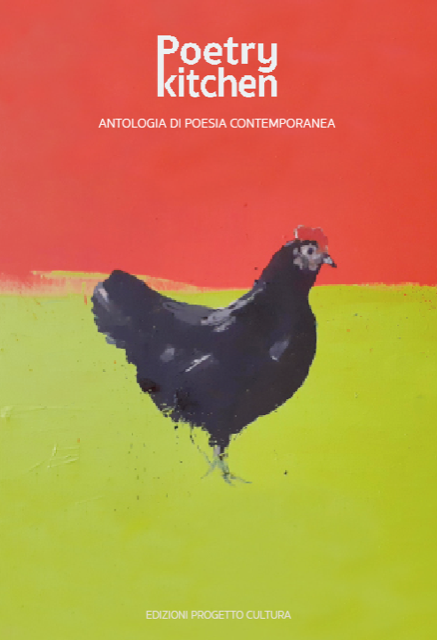



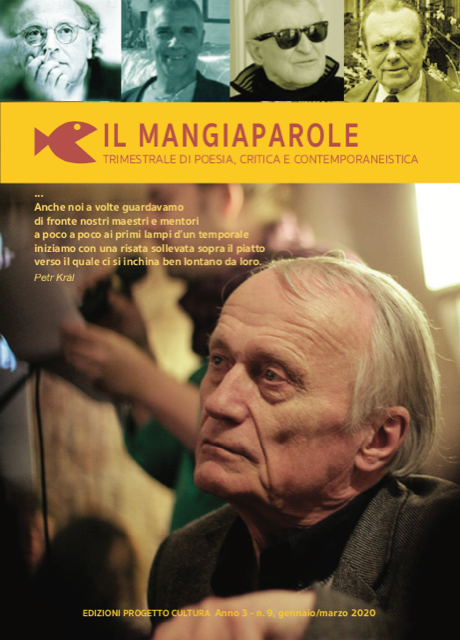











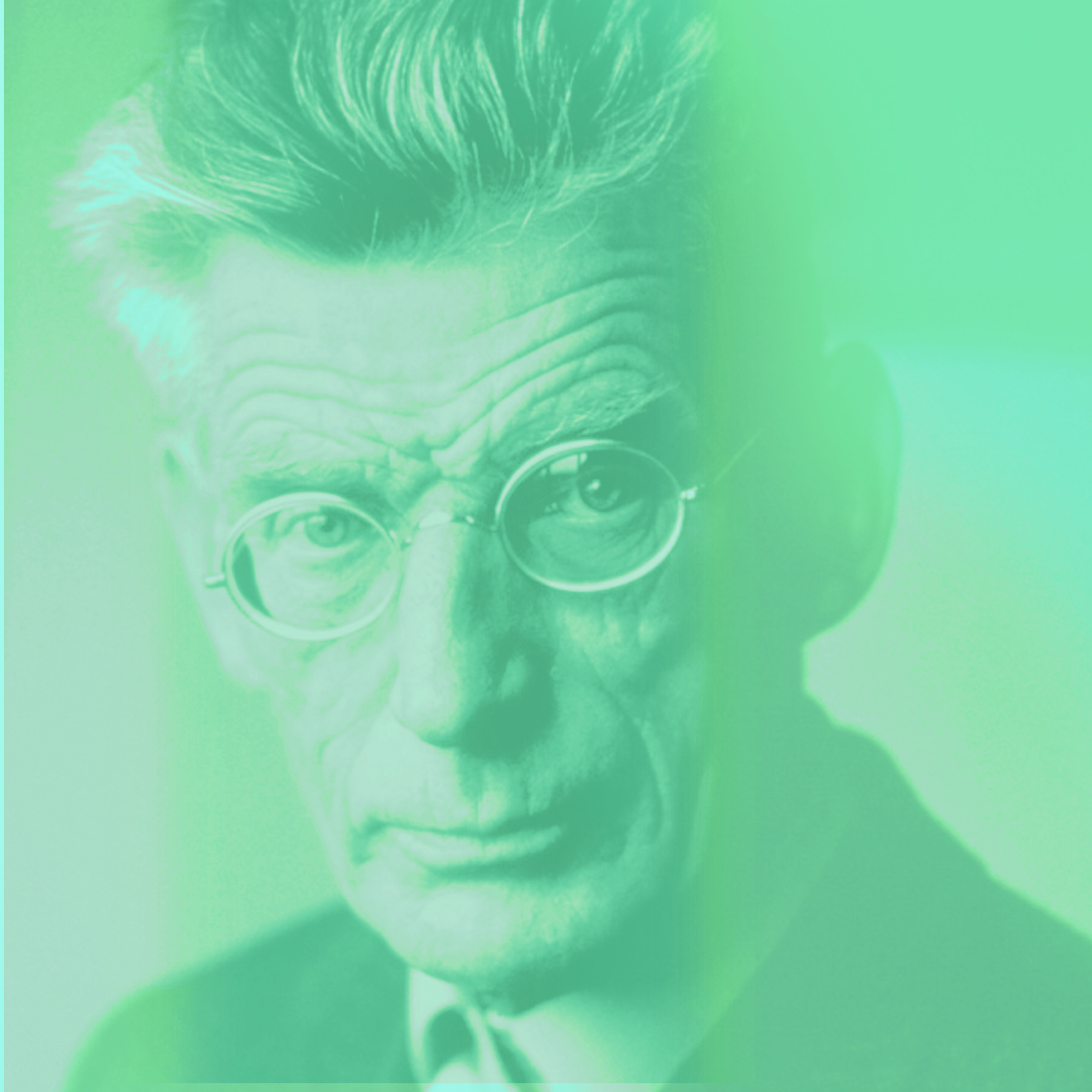
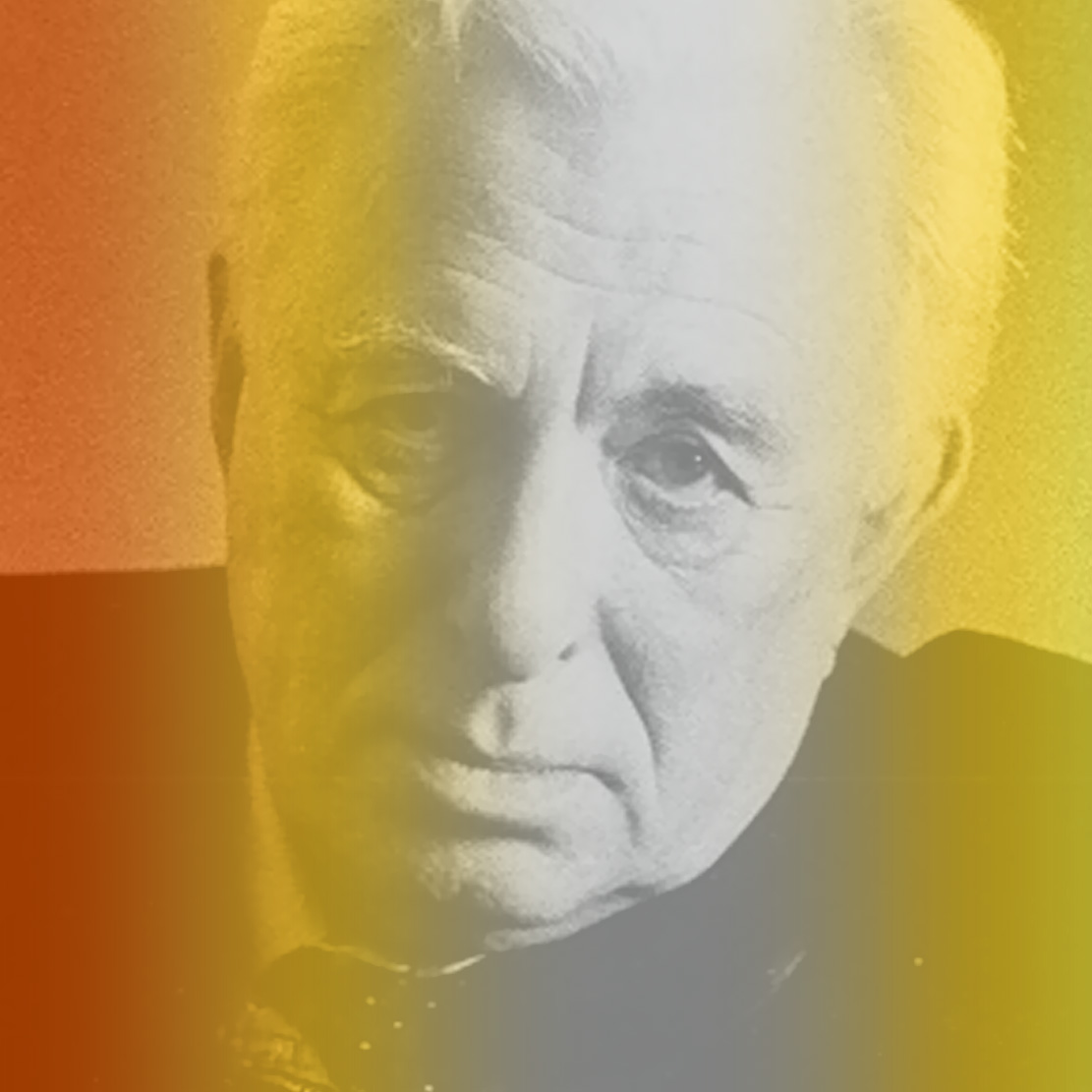









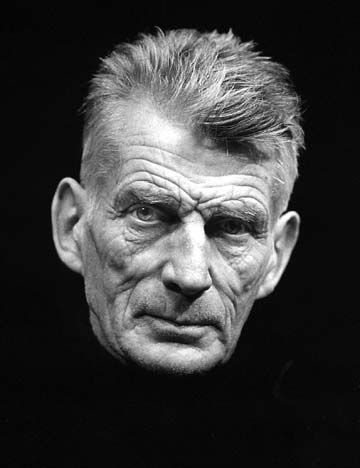


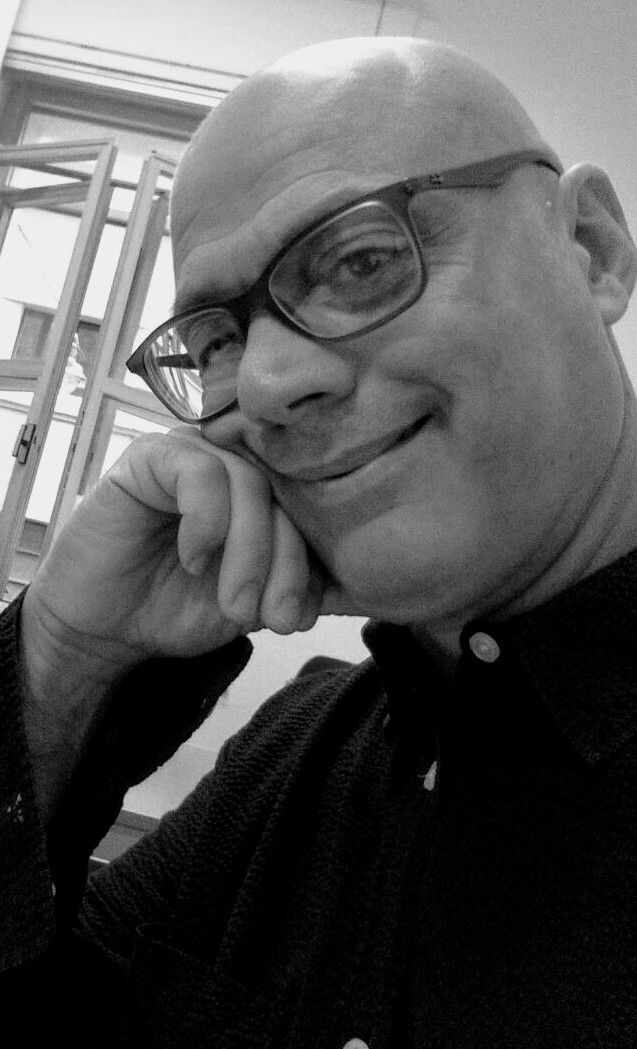
Voglio ringraziarti, Giorgio, per avermi permesso di scoprire Pascal D’Angelo con questo post meraviglioso, e soprattutto Luigi Fontanella per aver dedicato tanto del suo lavoro e questo libro splendido a quello che è davvero un poeta-santo.
Leggendo il suo racconto, la commozione è stata così intensa che ho pianto. Quanto amore per la poesia, per la scrittura, nati in un ragazzo cui la vita aveva tolto tutto. Perfino la patria. Ed è interessante che dalla nuova patria che lo aveva – pur duramente accolto – abbia tratto la lingua con cui poteva esprimere quello che aveva dentro.
So la durezza delle condizioni degli emigranti abruzzesi. Molti emigrarono dai paesini abruzzesi dei miei nonni e non a tutti andò bene.
Grazie davvero, ancora. Leggerò questo libro.
"Mi piace""Mi piace"
Considerando come D’Angelo sia morto – un’appendicite curata male da un medico di un’ospedale di New York – mi viene da pensare alla sorte analoga che ebbe Dylan Thomas, lui pure colto da peritonite e ricoverato in un ospedale di New York e lì ammazzato da un medico insipiente.
"Mi piace""Mi piace"
Sì, mi sono commosso anch’io per questo omaggio ad un poeta abruzzese che scriveva in inglese, che ha fatto i lavori più umili e massacranti a New York come Pascal D’Angelo. Disperato e solo, che aveva soltanto la poesia come sua compagna di vita. Una vita miserabile e una poesia sublime. Ecco, l’essere miserabili non vuol dire non essere un sublime poeta. Pascal D’Angelo nella sua breve vita ha vissuto tutte le esperienze più degradanti. Da qui è nata la sua poesia, da questo colmo di miseria e di umiliazione.
Un grazie a Luigi Fontanella per questo romanzo biografico.
"Mi piace""Mi piace"