
.
Simone Zafferani, nato a Terni nel 1972, vive a Roma. Ha pubblicato i libri di poesia Questo transito d’anni (Casta Diva, 2004), vincitore del premio Lorenzo Montano 2006, Da un mare incontenibile interno (Ladolfi Editore, 2011), finalista ai premi Sulle orme di Ada Negri 2012 e Laurentum 2012, L’imprevisto mondo (La Vita Felice, 2015). Ha inoltre scritto insieme a Paolo Camilli il testo teatrale Per colpa di un coniglio, rappresentato a Roma nel maggio 2017. Sue poesie sono uscite in riviste, antologie, plaquette ed edizioni d’arte. E’ autore del blog imprevistoverso.it
*
L’unica sfera in cui si dà Senso è nel luogo dell’Altro, nell’ordine simbolico.
Allora, si può dire, lacanianamente, che «il simbolo uccide la “Cosa”».
Il problema della “Cosa” è che di essa non sappiamo nulla,
ma almeno adesso sappiamo che c’è,
e con essa c’è anche il “Vuoto” che incombe sulla “Cosa” risucchiandola
nel non essere dell’essere.
È questa la ragione che ci impedisce di poetare alla maniera del Petrarca e dei classici,
perché adesso sappiamo che c’è la “Cosa”, e con essa c’è il “Vuoto” che incombe minaccioso e tutto inghiotte.
È stato possibile parlare di Nuova Ontologia Estetica,
solo una volta che la strada della vecchia ontologia estetica si è compiuta,
solo una volta estrodotto il soggetto linguistico
che ha il tratto puntiforme di un Ego in cui convergono,
cartesianamente, Essere e Pensiero,
quello che Descartes inaugura e che chiama «cogito».
(Giorgio Linguaglossa)
 Commento impolitico di Giorgio Linguaglossa
Commento impolitico di Giorgio Linguaglossa
Simone Zafferani ha un senso spiccato nel cogliere la dimensione illusoria degli «oggetti»; ecco due suoi tipici versi:
è perfetta la quiete degli oggetti
nel punto preciso del dolore il dolore finisce
che descrivono con precisione lo stato di «quiete» degli «oggetti», quella loro sonnolenza «domenicale» mentre riposano nella «penombra sul fianco delle cose», nel punto in cui inizia e finisce il «dolore» degli «oggetti». Questo è il punto decisivo della poesia di Zafferani, non a caso si tratta della poesia che apre la raccolta, come a prefigurare la sua nuova poetica degli «oggetti» e delle «cose», categorie sulle quali la nuova ontologia estetica ha da tempo appuntato la propria riflessione.
È significativo che nel frattempo anche la poesia di Zafferani già da tre lustri si muovesse in questa direzione di ricerca; il tempo è un testimone affidabile e non smentibile, è la nostra ancora di salvezza; i nuovi orizzonti di ricerca sono parte integrante dello Zeitgeist, sono qui, nell’aria che respiriamo, nelle parole che a volte affiorano dal profondo. Un altro elemento che mi induce in riflessione è la percussiva attenzione alla presenza dei «morti», alla «rovina purgatoriale» nella quale sono immerse le poesie di Zafferani.
Il verso è lungo, spezzato, irregolare, un verso che non dà tregue al lettore, che lo incalza con la propria aritmia, con la propria irregolarità metrica. Anche il titolo rimanda al concetto di «transito d’anni», al tempo che fluisce in rigagnoli, estraneo alla nostra interiorità più intima. Le poesie di Zafferani si rivolgono ad un «tu», un interlocutore lontano e inaccessibile al quale l’autore chiede di pronunciare il «nome nevralgico»; lo ripete più di una volta, il «nome nevralgico», l’utopia di un «nome» dotato di proprietà demiurgiche.
Ed invece alla poesia di oggi è concessa soltanto una nominazione «debole», sbiadita e corrosa dal tempo. È forse per questo motivo che oggi la poesia contemporanea pensa il proprio «oggetto» nei termini di una «poesia statica» attraversata da micromovimenti e contro movimenti tellurici. Un aiuto ci può giungere dalla riflessione del Wittgenstein maturo: nelle Ricerche filosofiche è all’opera un tentativo di de-psicologizzazione del linguaggio psicologico, vale a dire un’indagine grammaticale relativa al modo in cui parliamo delle nostre esperienze «interne». Centrale, in quest’ultimo tratto del percorso wittgensteiniano, è il termine «atmosfera» (Atmosphäre); il filosofo si muove attraverso una critica di tale concetto, si analizza il nostro modo di parlare dei processi psicologici e, in particolare, della comprensione linguistica, intesa come esperienza mentale «privata».
Contro l’idea che il significato accompagni la parola come una sorta di alone di senso, come un sentimento o una tonalità emotiva (Stimmung), Wittgenstein valorizza l’aspetto comunitario e già da sempre condiviso dell’accordo (Übereinstimmung) tra i parlanti. Il richiamo al modello musicale dell’accordo armonico tra le voci consente così di recuperare la dimensione «atmosferica» dell’esperienza linguistica, in cui si assiste a una «sintonizzazione» tra i parlanti coinvolti in un comune sentire.
Mi sembra che anche Zafferani si muova in questo ordine di idee: tracciare una «atmosfera» degli «oggetti» per poterli comunicare meglio.
Poesie di Simone Zafferani
Poesie da Questo transito d’anni (2004)
è perfetta la quiete degli oggetti
in questa disposizione
nell’uso domenicale di riflettere
la penombra sul fianco delle cose
(un volgersi minimo, estenuato trasalimento).
Nulla ferisce più le cose in questa
usura periferica del loro
vivere
– non conta alcun perché, è un lieve sfarsi
un ossidarsi continuo.
*
avvicinate i morti gli uni agli altri.
Scostateli dai muri. Fatene un cerchio
che prema i confini al silenzio ostile,
contro l’oblio. Salvacondotto della gloria
feritoia dei martiri. Visti in processione mormorano
parole come mollica di pane al passaggio.
Questa gerusalemme irreale
questa rovina purgatoriale. Fate grumi d’ossa e
macerie. Un cerchio che ritroveranno tra secoli.
Il segno del passaggio, dai pozzi del cuore
all’inferno delle viscere.
Macchiate di sangue la strada, come
avventori appestati untori. Anche questa
ennesima fine va celebrata.
(qui manca una spina, un dorso)
*
sei ad ovest del cuore dove
non puoi che tramontare. Questa
inconvenienza breve ti sta addosso come
un peso di cui liberarti.
Liberati, adesso, mentre sei ancora
Intermittente.
L’improvvisa ombra sul tuo deserto
non dovrebbe intimorirti. Ma
eventualmente circumnavighi il cuore.
*
scrivilo tu per me il mio nome nevralgico.
(la pena non dura oltre l’istante in cui la pensi.
Parlandone la spegni)
Adesso nel nitore del mezzogiorno puoi donarmi
la tua latitanza assoluta tra gli sterpi.
Adesso che non c’è ombra che ci protegga, che l’estate accoglie
tutte le estati passate e tutte quelle a venire
dimmi
quale sole può esplodere la sua belligeranza
quale rogo attende
le parole in rivolta – tu ammutolisci la pronuncia
chiedi stanotte al capanno la tregua del buio.
Domani al sole fermenteranno le ore.
Ci sarà teso l’agguato del tempo
quale mai l’abbiamo atteso.
Tu scrivi, te ne prego, il mio nome nevralgico
sfiora la mia vena tesa allo spasmo, il cataclisma che temiamo.
La successiva stagione cancellerà le tracce
di questa canicola
di questa chiarezza disperata per caso.
È un momento di desolato splendore.
Una periferia improvvisa del senso.
*
nel punto preciso del dolore il dolore finisce.
Nell’equinozio della calma e dello smarrimento
L’incontro presagisce il suo abbandono.
Nel centro del trifoglio esiste
la possibilità del quadrifoglio.
Nel sogno si rovescia il tentativo in resa
si disfa la trama della corda
avanza la più cedevole acqua
a barricare il mondo.
Nella betulla dorme la neve fatta goccia.
In un impensabile suono di flauto
resiste la forza degli anni;
sorveglia un diesis ostinato le procedure e le consuetudini
e le addolcisce.
Dove non sono arrivato io non dovevo arrivare
Se mi sono assiepato percepivo lo strappo.
Se ero fermo in un punto, da quel punto pensavo la traiettoria
per disciplinarla.
Nella dispensa più vuota germoglia il bisogno del pane.
*
quasi niente, questi ritorni questi sestanti
il sole radente di Roma una franta allegria.
Uscire è come divagare e molto si deve camminare
fino a un ponte dove il pensiero torna a sé
– l’incrocio esatto della memoria e della cura
con l’attenzione ostinata del tempo.
Io sono caparbio e mobile. Tu aspettami
non spaventarti
portami verso una curva più lieve del cuore
dove il fiume possa specchiarsi e sentire
che il viaggio riparte, che i platani continueranno,
che il sussulto lieve dell’acqua colmerà le distanze ed i mesi
le provvigioni del ricordo.
Cercami ancora in una piazza tra volti che indovini,
scaturigini di tenerezza, fughe impensate.
Cercami e non chiedere.
*
la cosa più difficile per la madreperla
è affiorare. Esita perché deve
tornare a somigliarsi e per fare questo deve assottigliarsi
– dirompere in eccesso non le è dato, né comporsi
nell’argine della brezza presto costretta all’esalazione.
Certo preferirebbe divagare, scoprire lentamente
come fare a rilucere in potenza, dimezzare.
Ecco allora che fluttua,
fluttua, si tiene lontana dall’estensione e dall’abbraccio,
compone internamente un mosaico di ragioni, trame vegetali
utili a rimandare, affabulare, misurare
l’esatto tempo necessario al sole per riscaldare
la superficie accessibile del miraggio.
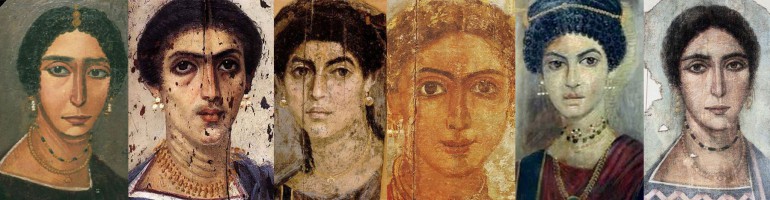


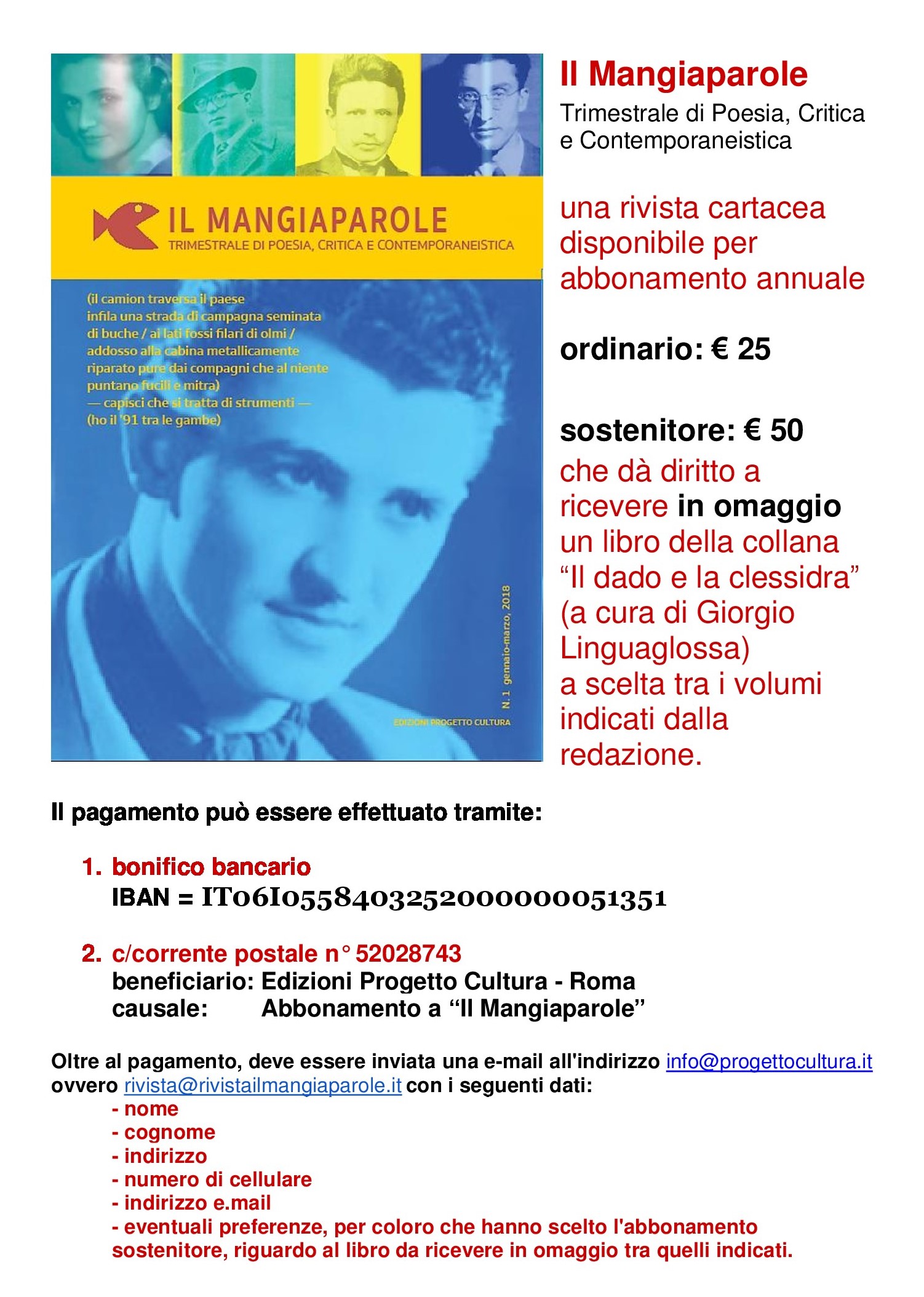
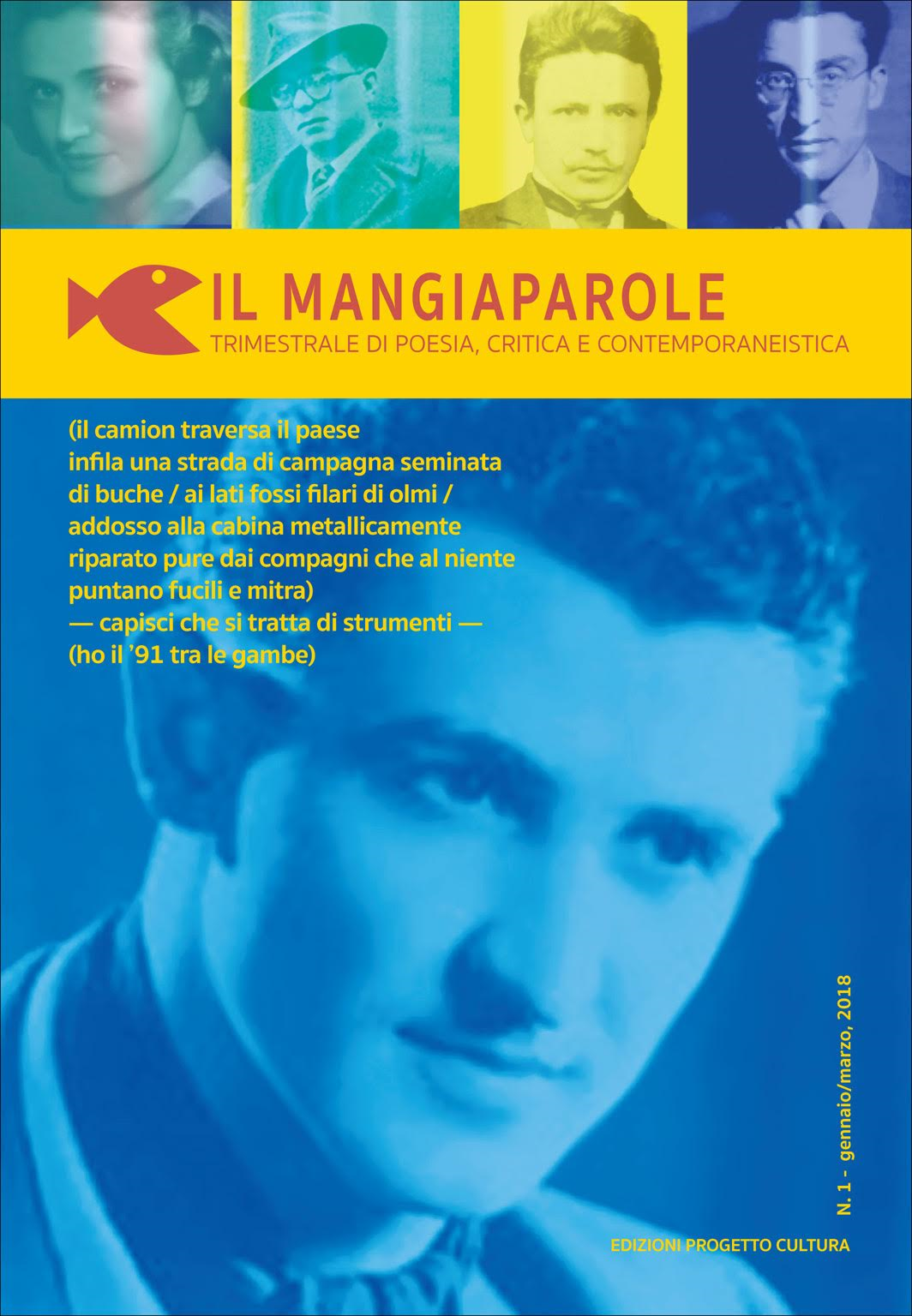

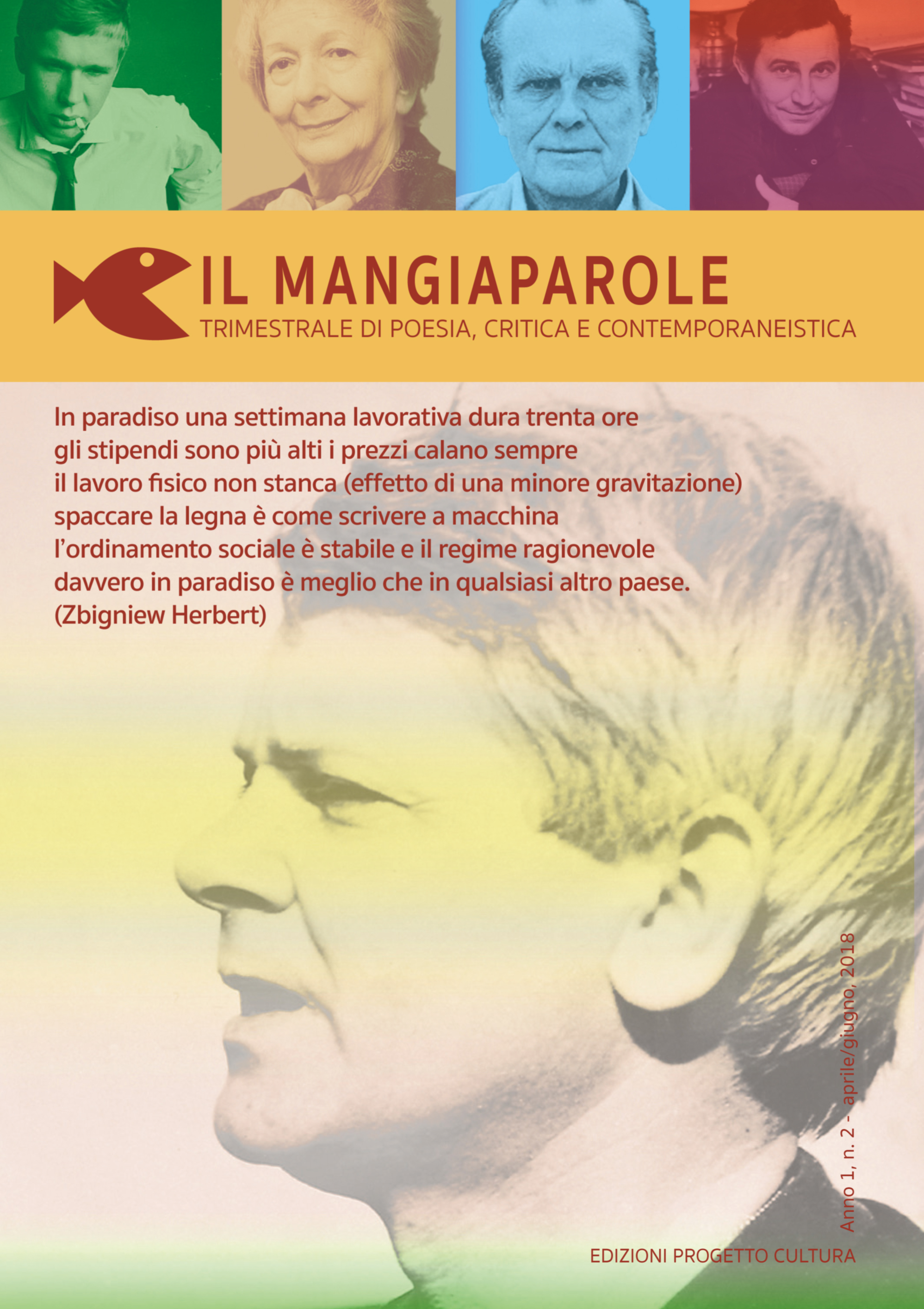



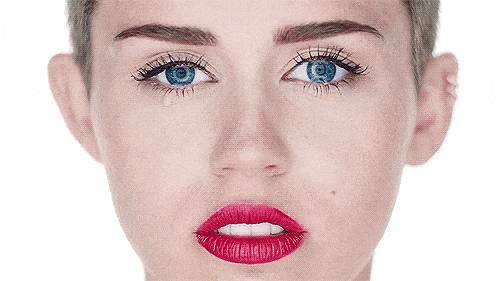
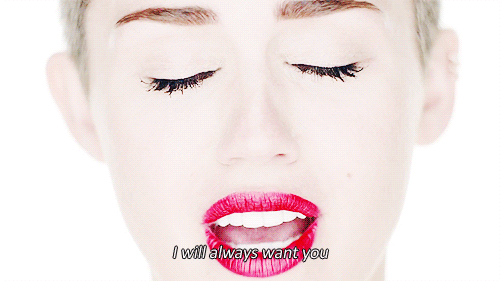
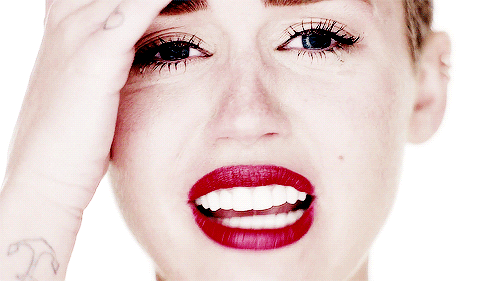
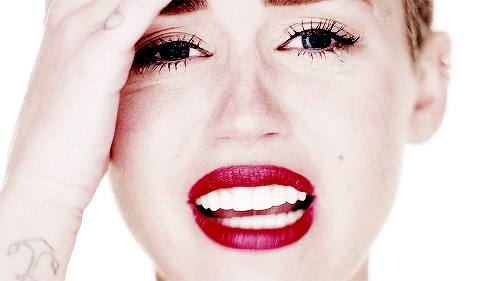
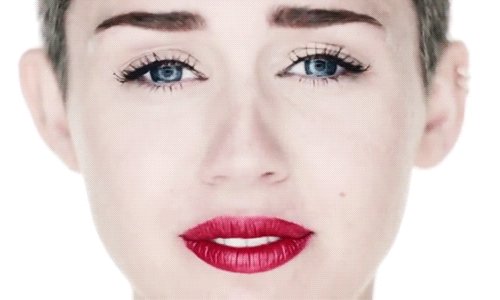



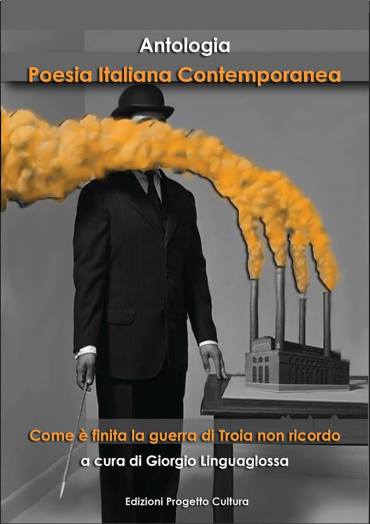




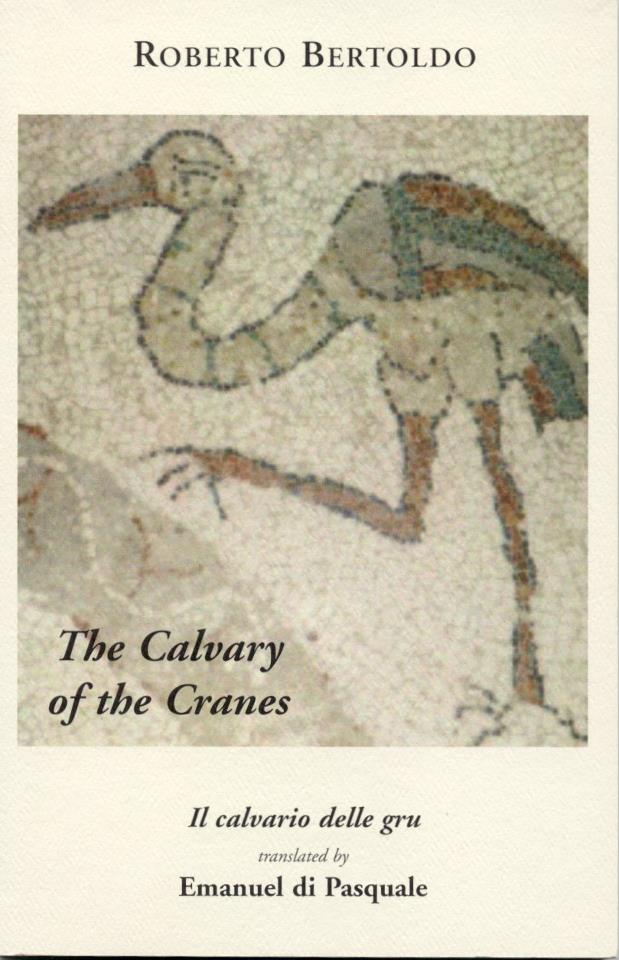
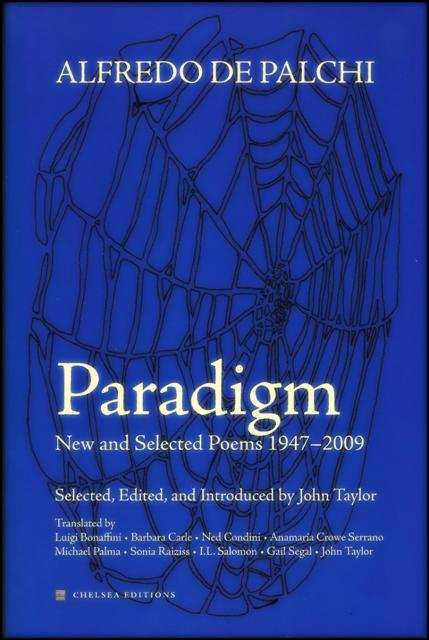


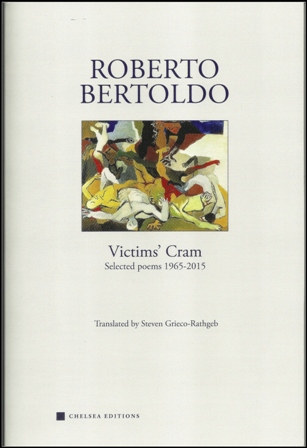





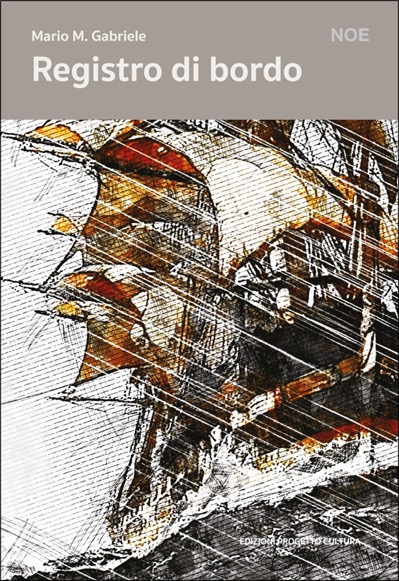

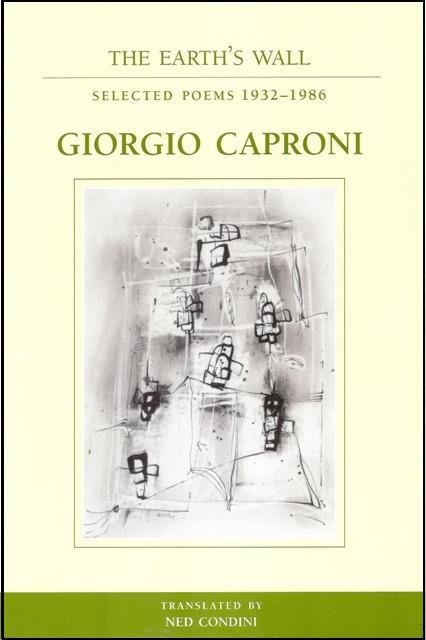
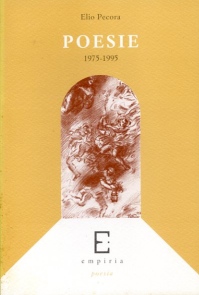

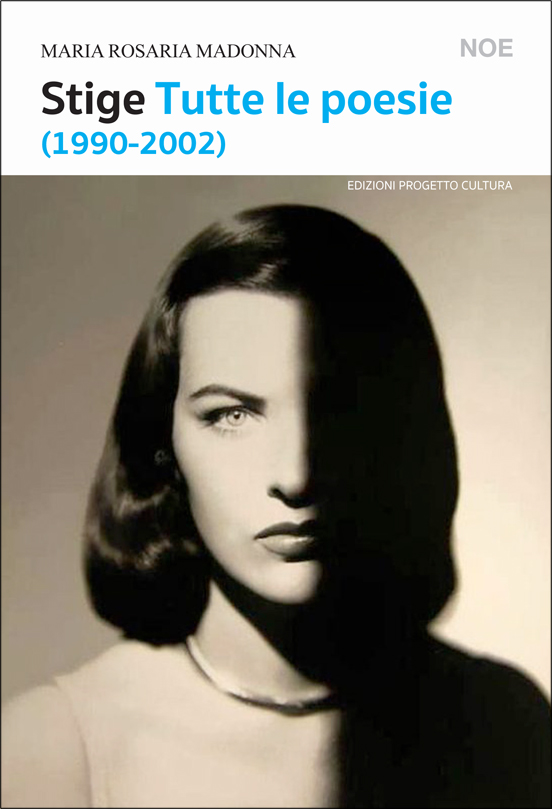

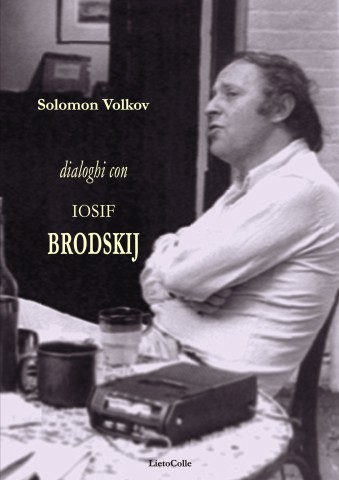




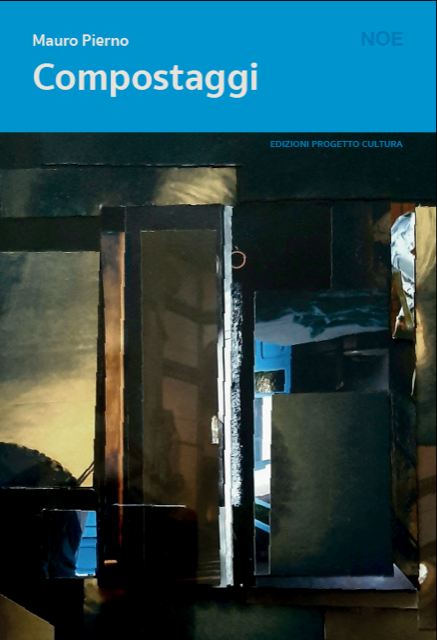
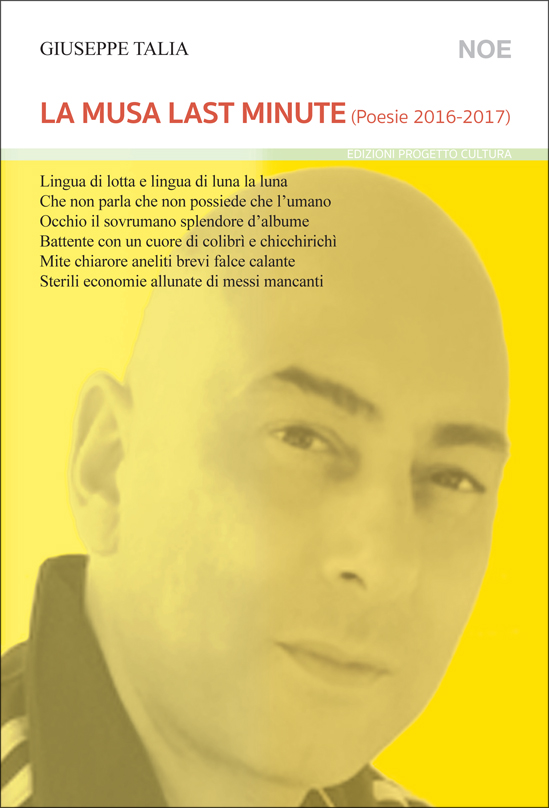


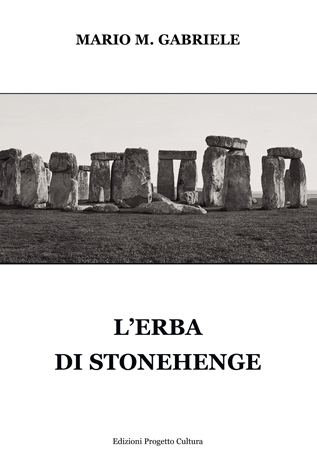
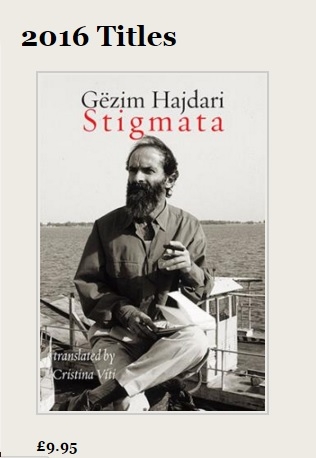
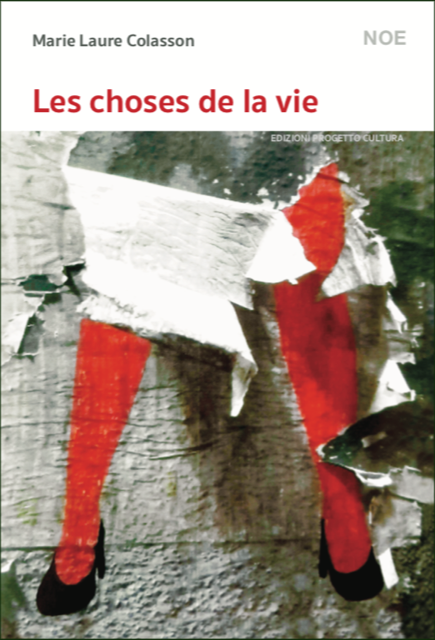




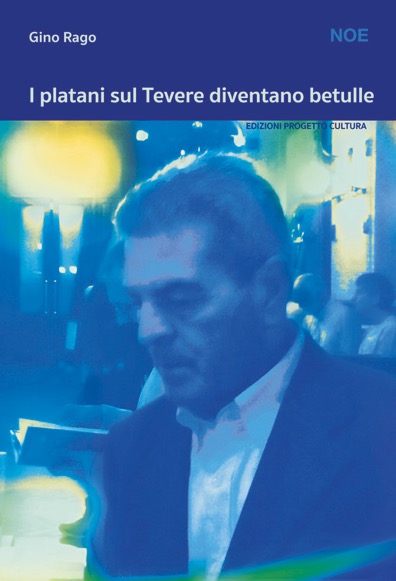
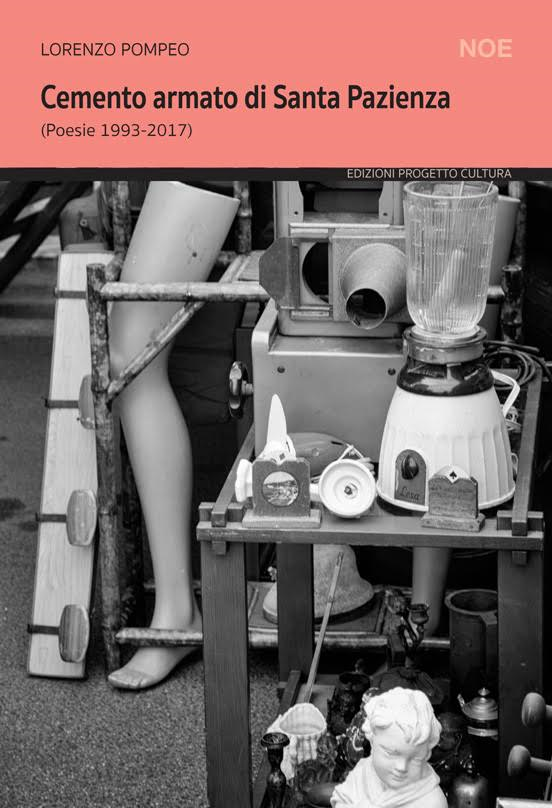
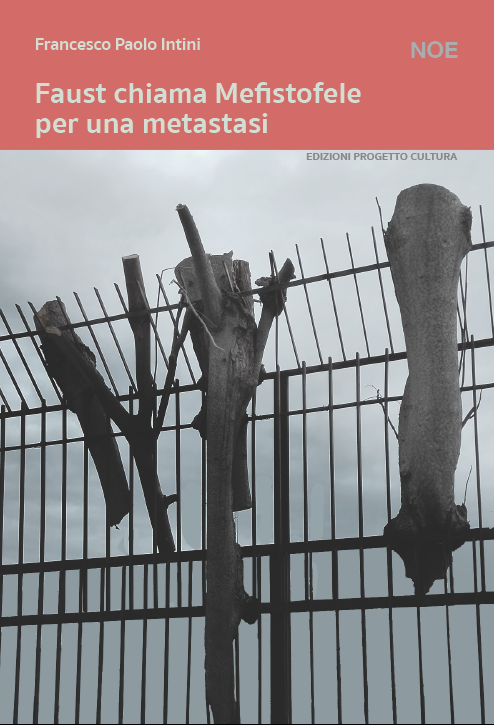

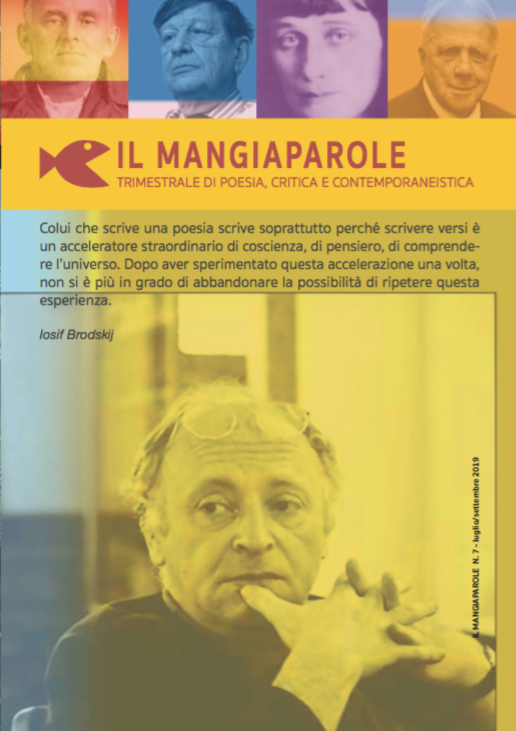




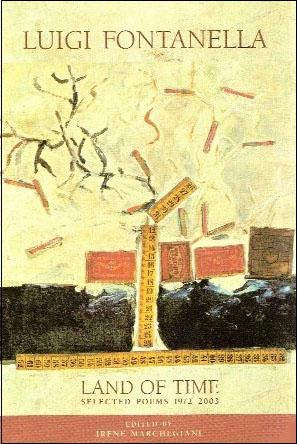








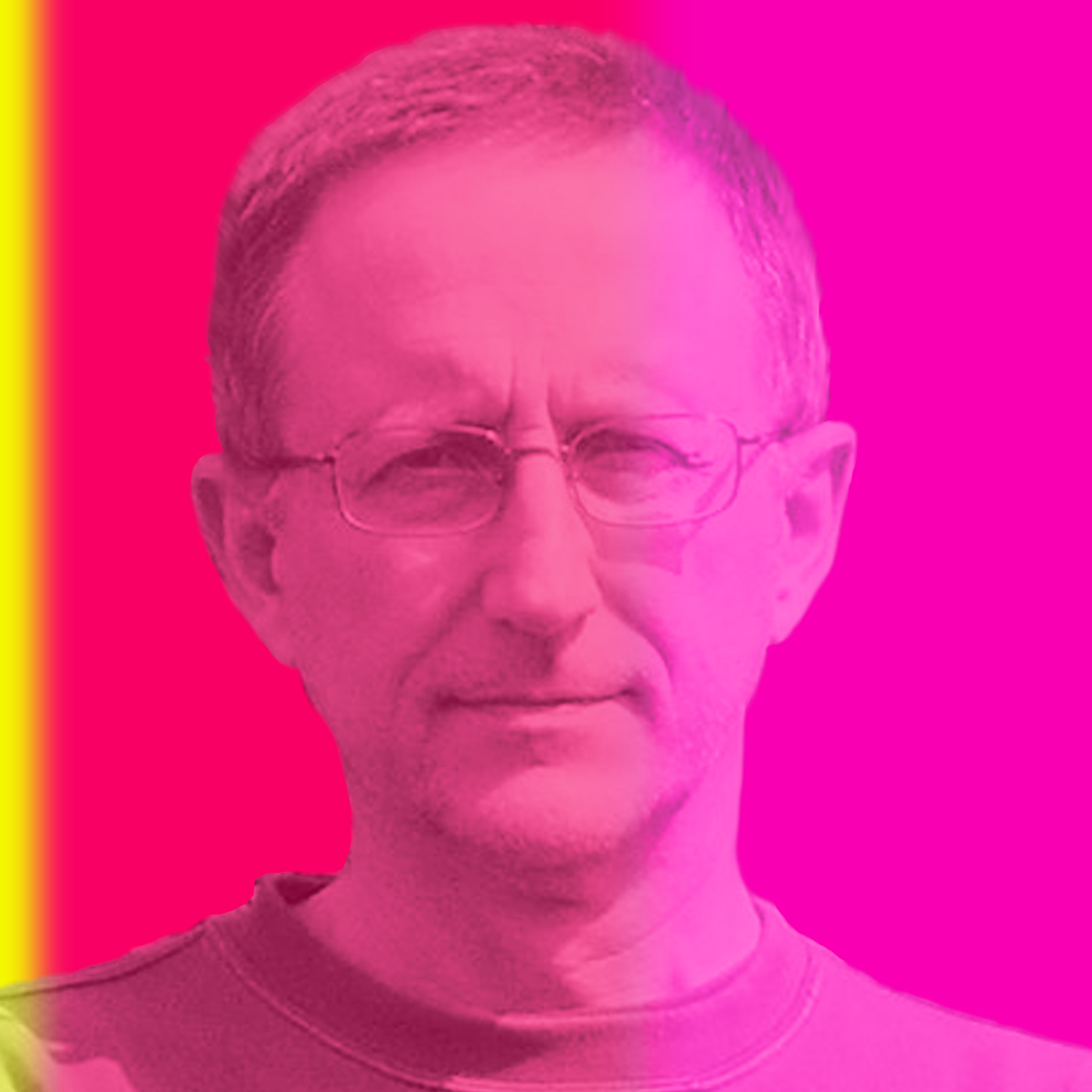







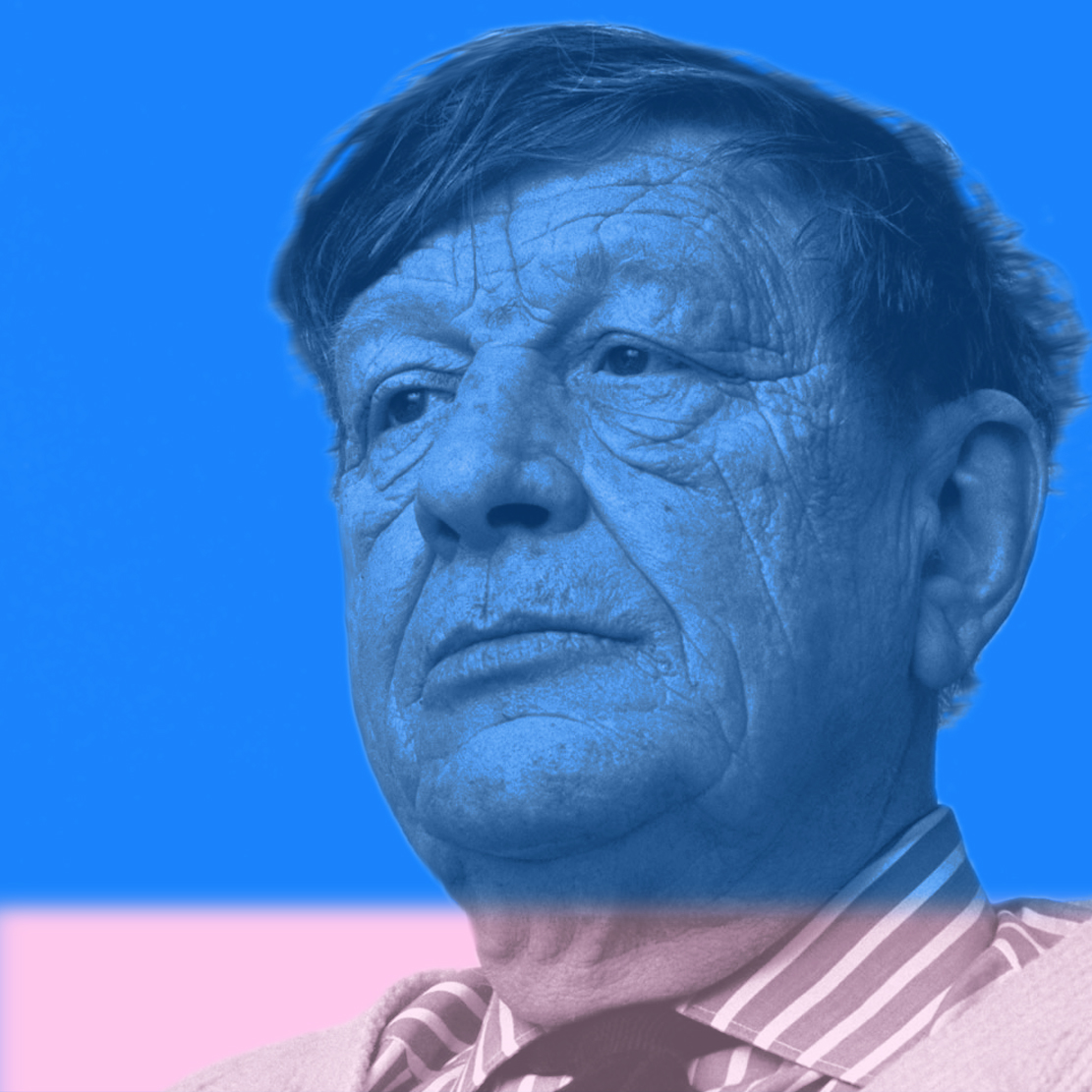



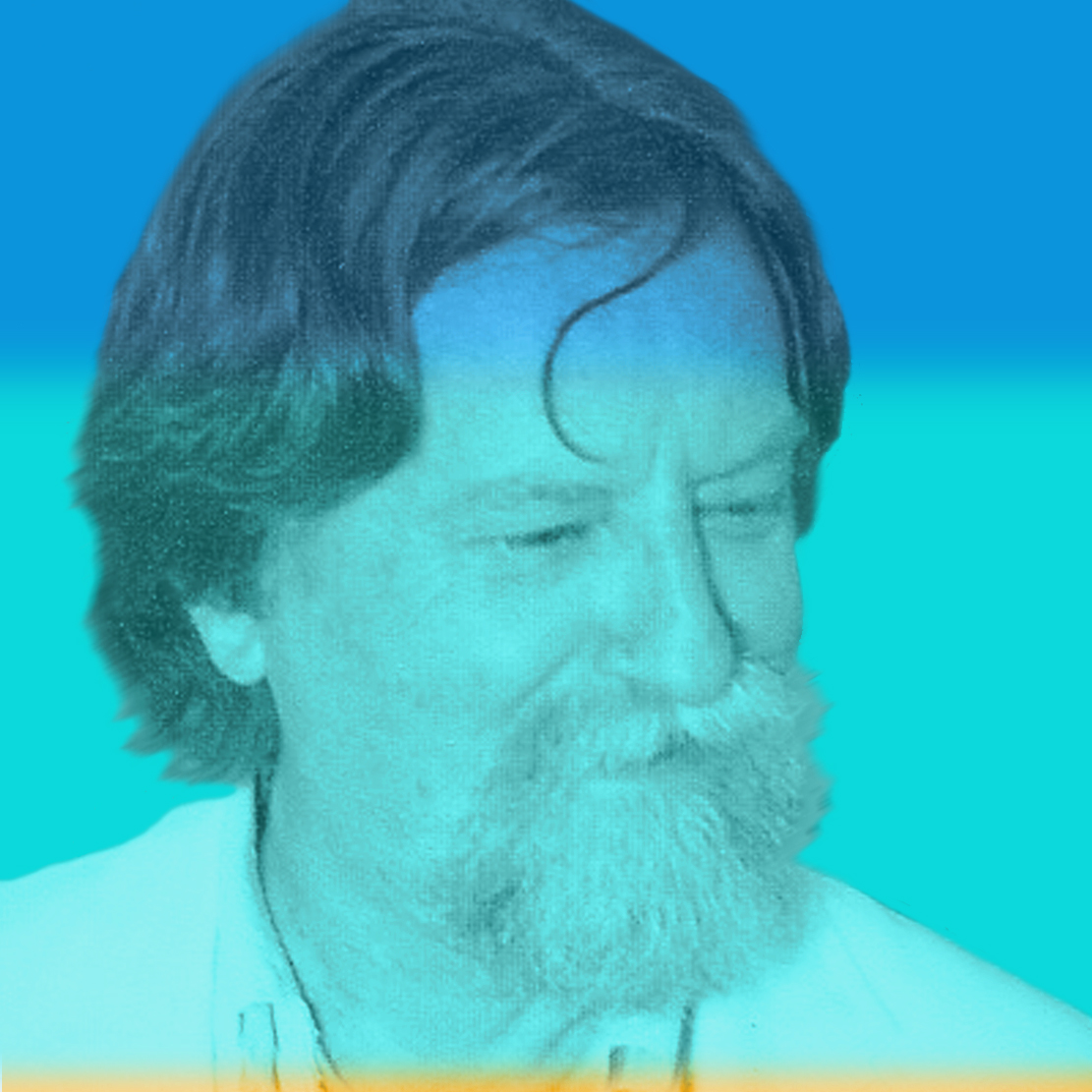
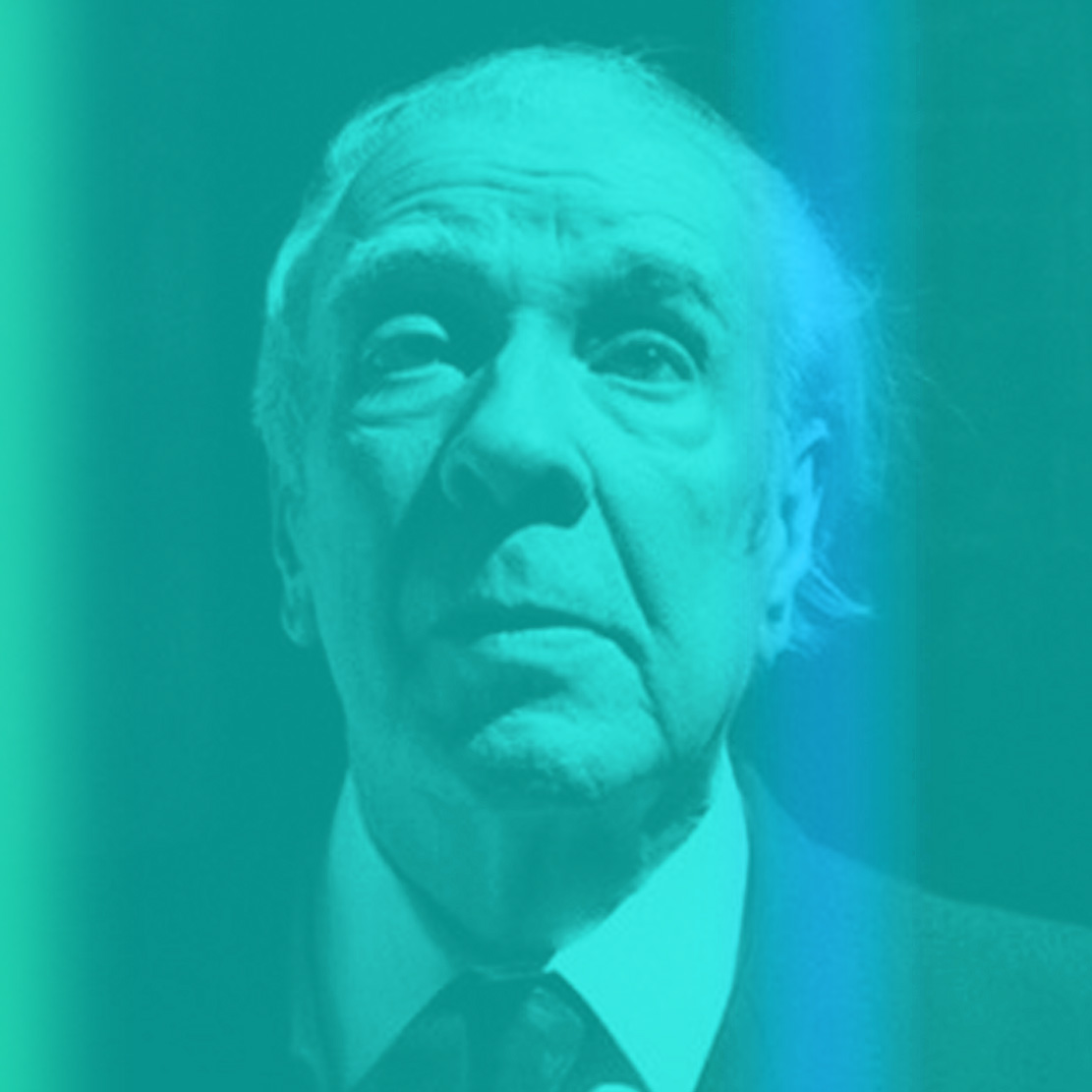




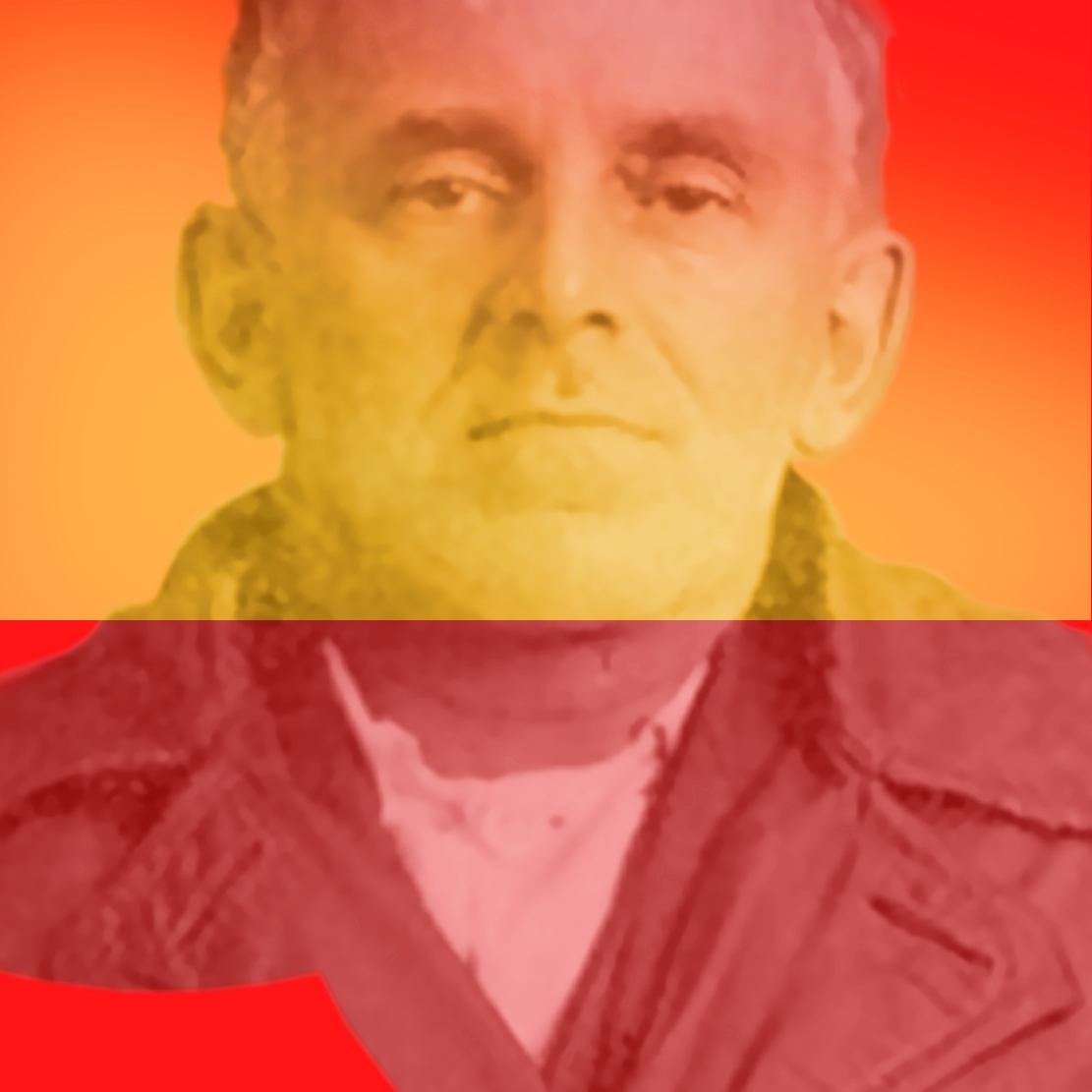






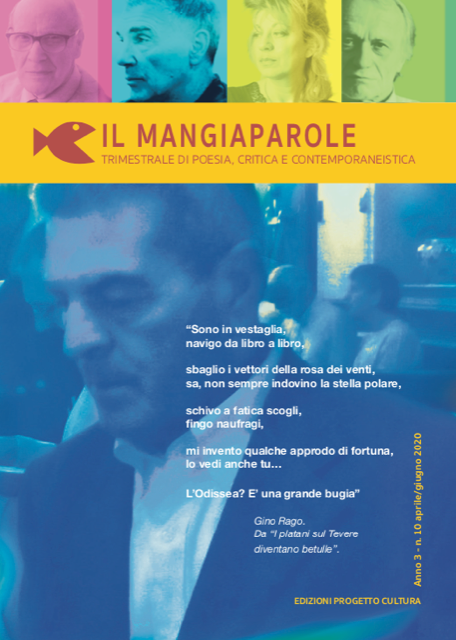




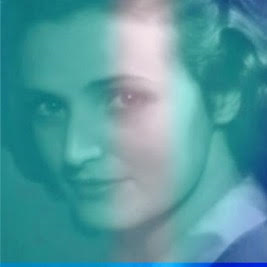
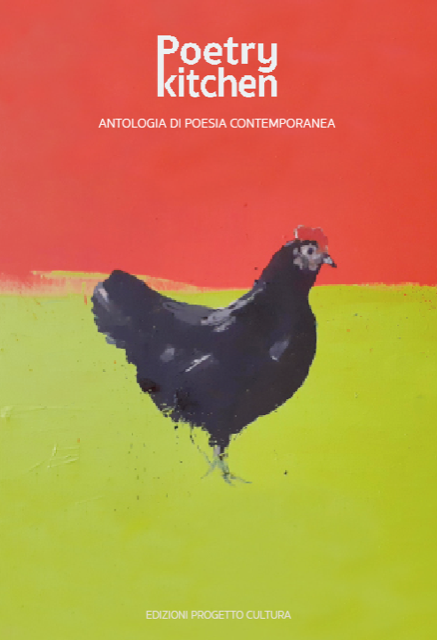



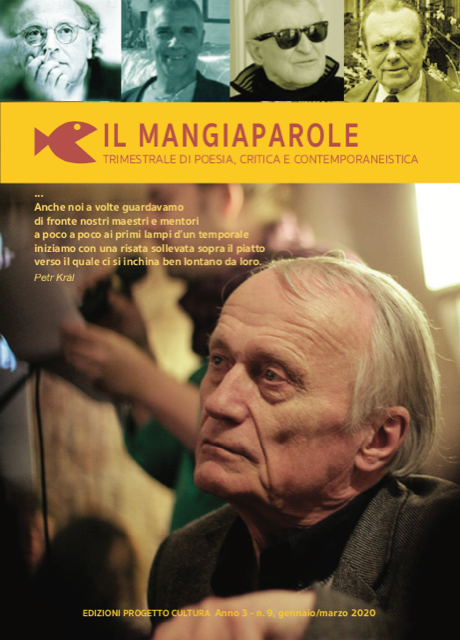











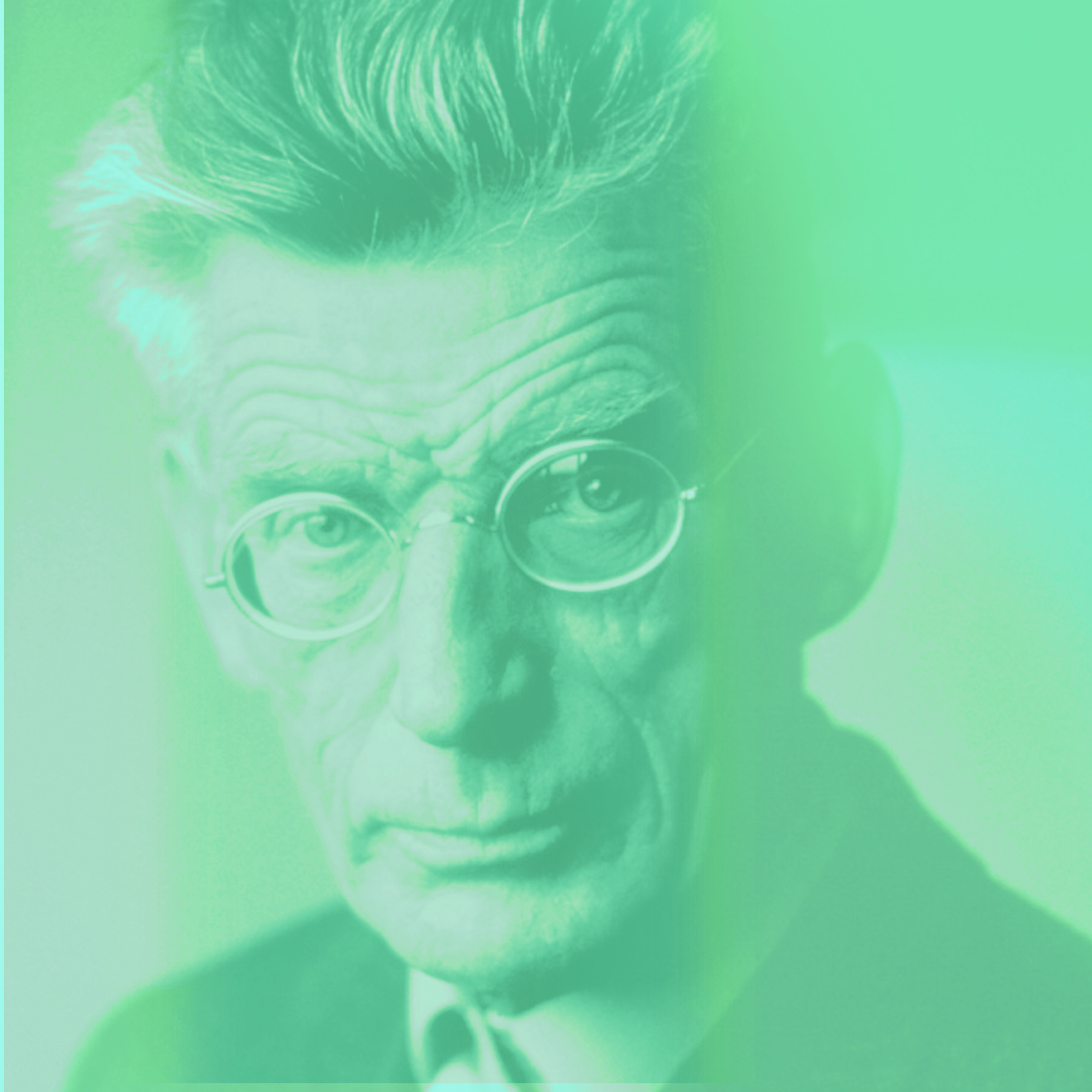
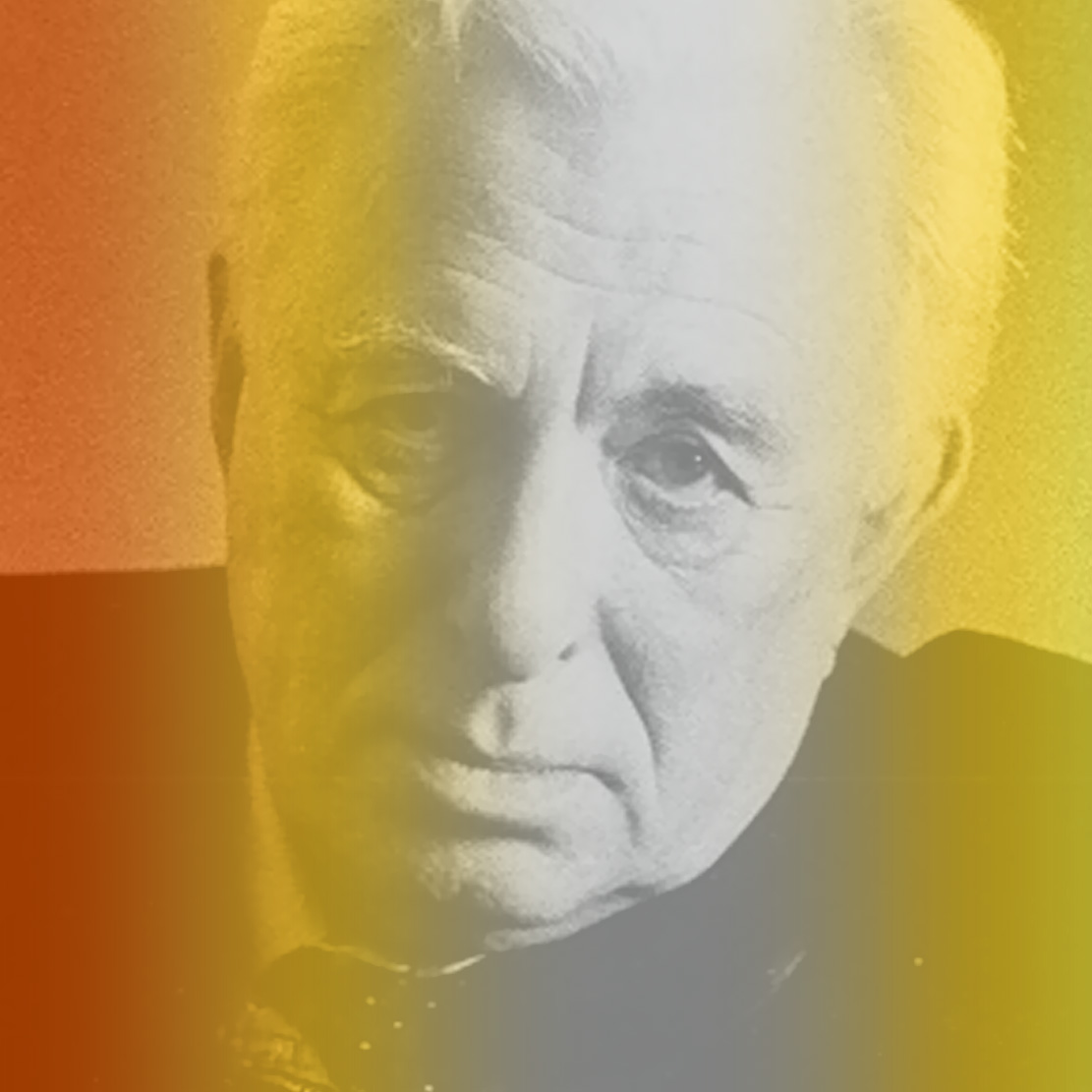









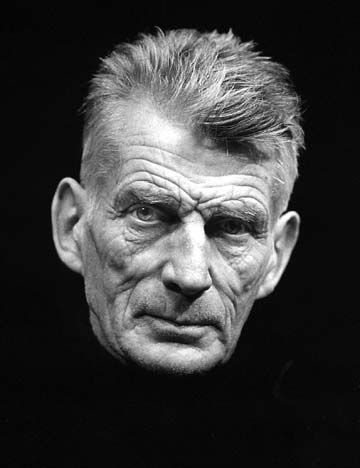


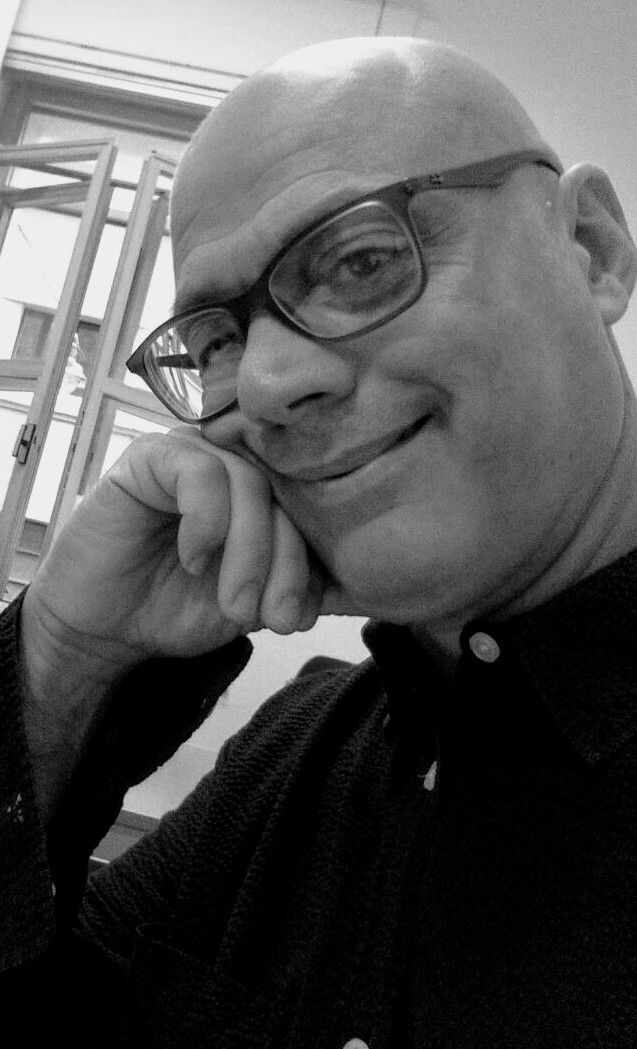
L’ha ribloggato su SESTOSENSOPOESIA feliceserino's blog.
"Mi piace""Mi piace"
Apprezzo la poesia di Simone Zafferani:è la ricerca di un centro, di una matrice da cui scaturiscono la poesia e la bellezza.Mi piace perchè ripropone, coraggiosamente, un modello di scrittura che sarebbe potuto essere di Carlo Levi o di Sinisgalli,quando si parlava col cuore, per essere capiti .
"Mi piace""Mi piace"
La riflessione sugli oggetti ha accompagnato la cultura del Novecento, capaci come sono di veicolare idee, immagini, comportamenti, quasi nel tentativo di vedere in essi la sopravvivenza dell’ordine simbolico e tradizionale. Ma il pensiero postmoderno ci dà arresi alle copie di copie, ai simulacri senza originale.
Tuttavia, cosa accade agli ‘oggetti’ quando vengono percepiti come ‘cose’ e come tali sembrano possedere la capacità di stabilire relazioni?
Nei miei versi de ‘I platani sul Tevere…’ (dedicati a Giorgio Linguaglossa e a Donata De Bartolomeo e da me letti la sera del 21 giugno scorso all’Isola
Tiberina, nell’ambito della rassegna poetica “L’Isola dei poeti” di Roberto Piperno e Francesca Farina) mi sono rifatto a una meditazione ad hoc di Remo Bodei, ( meditazione che mi ripropongo di riprendere in altre occasioni).
In questa occasione, invece,, dico che il mio commento è subito scaturito dalla lettura dei primi quattro/cinque versi di Simone Zafferani nei quali questo interessante poeta parla prima di “oggetti” e dopo un pò di “cose”, nello stesso componimento,
oggetti, come felicemente suggerisce Giorgio Linguaglossa in prefazione,
immaginati in una “quiete domenicale”… con un loro tempo interno.
Condivisibile la riflessione di Anna Ventura.
.
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
“Nella betulla dorme la neve fatta goccia”….
UN BEL VERSO FINO A NEVE…
POI LA ROVINA CON QUEL CHE SEGUE
"Mi piace""Mi piace"
Mi riallaccio alla considerazione di Gino Rago per dire che
la struttura del discorso poetico è, in quanto struttura significante, qualcosa di analogo a una struttura desiderante e, in quanto tale tende ad uscire fuori di se stessa, tende a fagocitare gli «oggetti», a incorporarli e a espellerli. Questo fenomeno si può rilevare chiaramente nella poesia moderna. In sostanza, gli «oggetti» in poesia diventano sempre oggetti fantasmatici. Non bisogna confondere gli oggetti del mondo esterno con quelli che sono presenti in una poesia, questa è una questione che le estetiche ingenue hanno sempre trascurato, ma è una distinzione essenziale, senza di essa non capiamo nulla della poesia moderna.
Possiamo dire che gli oggetti fantasmatici annunciano una sorta di schibboleth del linguaggio, la scena in cui la rappresentazione scenica della poesia viene a rendere manifesta la «mancanza» degli «oggetti», la loro inconsistenza materiale, la loro presenza unicamente simbolica, quella sorta di «beanza aperta dall’effetto dei significanti», dice Lacan.1] È così che il «fantasma» rende manifesto nel discorso filosofico la questione dell’inconsistenza del soggetto parlante, annuncia che parlare è un venir meno, un sottrarsi del linguaggio rispetto agli «oggetti», un «mancare». Ecco la ragione per cui nella poesia moderna non troviamo mai gli «oggetti» ma le «cose», in quanto le «cose» si sono liberate della presenza al di fuori del linguaggio e dimorano soltanto nel linguaggio.
Invece di chiedersi, come fa la filosofia, «Che cosa è pensare?», «Che cosa è l’essere?»; la poesia moderna si domanda insistentemente: «Che cosa è parlare?»; “Chi parla? ”.
.
1] J. Lacan, La direzione della cura, in Scritti, Einaudi, 2 volumi, 2002., p. 624.
"Mi piace""Mi piace"
“La poesia è l’amore realizzato / del desiderio rimasto desiderio” ( Rene’ Char). Le manifestazioni lessicali piu’ qualificate – come quella di Simone Zafferano – rendono quasi tangibile questa istanza ad una verticalizzazione inafferrabile ed inesperibile, da cui promana un sentore d’esilio, una nostalgica temperie di oblio e dissesti emotivi, una profusione di retropensieri annichiliti in un orizzonte di specchi vuoti.
Il soggetto esperisce e testimonia la trascendenza del pensiero sul linguaggio, come afferma Vigoskj, ma anche la reclusione e subordinazione di ogni atto cognitivo e gnoseologico alle strutture linguistiche, come intuisce Wittgenstein nelle Ricerche, la relazione e il dominio sulla realta’ è illusorio, non esiste verita’ estrinseca alle regole del linguaggio.
L’illusione di un isomorfismo fra logica e ontologia rende arduo l’auspicio di un nuovo sapere olistico ( tanto vagheggiato da Claudio Borghi e anche da me ) che accresca fecondita’ e valore epistemico a scienza, filosofia e poesia. Purtroppo non siamo piu’ al tempo di Aristotele, per cui la metafisica era l’ultimo capitolo della fisica, Kant ha dimostrato in modo inconfutabile che la metafisica non puo’ essere una scienza, il linguaggio analitico vi si addentra senza nulla su cui far presa, come un uccello che tenta di volare nel vuoto, senza l’attrito dell’aria.
La frammentazione di saperi e linguaggi è la conseguenza di quell’inedia spirituale rappresentata da Kafka nell’immagine dell’uomo che attende il messaggio dell’imperatore, consapevole dell’impossibilita’ che avvenga; ma l’uomo aspetta ogni sera, seduto presso la finestra. Ora ci siamo accorti che il vetro della finestra è uno specchio, in cui vediamo pensieri fatti di parole da noi stessi inventate. In un gesto di disperazione abbiamo infranto quello specchio, rinunciato alla verita’.
Resta il dolore dell’esilio, ma forse anche la speranza che un Dio venga a salvarci…
Un testo che vorrei dedicare a Simone Zafferano, con sincera stima.
Nel sottoscala del Paradiso, una sera qualunque, una morte festosa dipinge l’interminabile incesto azzurro e oro, con la mia vita in fondo…
La tristezza del cielo è così vicina da lasciare nell’anima una ferita di rose false e orologi guasti.
In fondo al grande ripostiglio celeste trovo preghiere spezzate, la sottoveste della passione, un guanto dell’Enigma, un silenzio duro e prezioso come il diamante.
La madrina degli Dei, sepolta nel vento dell’est, mi chiama da una vecchia canzone.
Ferito, nel cuore dell’uragano, denudo le belle frontiere impossibili.
Lo sconfinato altare celeste è una vertigine di flauti.
Le grandi macchine spirituali avanzano in lunghe file,
l’ultima ha una ferita da cui cadono donne scarlatte.
"Mi piace""Mi piace"
Vigoskj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Lev Semënovič Vygotskij (1896-1934)
"Mi piace""Mi piace"