
gif dal film Nosferatu
Sull’Espressionismo
I termini temporali entro cui si svolse l’espressionismo sono alquanto complessi e discutibili. Il grande germanista Ladislao Mittner fa parecchia fatica nei volumi della sua straordinaria “Storia della letteratura tedesca” a mettere dei paletti non solo cronologici, ma pure nel labirinto di tematiche e problematiche che si svolsero (meglio: sconvolsero) tra gli anni 1907-1926. Questo intervallo di tempo è un tempo allargato definito dallo studioso F. Martini, rispetto all’intervallo 1910-24 (il così detto “dodicennio nero”, in definitiva il “falso splendore di un decennio d’oro”) o al 1919-33 (”i 14 anni di obbrobrio” come avrebbe detto lo stesso Hitler). Il germanista Paolo Chiarini pone la data di nascita dell’espressionismo negli anni 1905-06.
Nel 1907 vi furono due eventi: l’esposizione di van Gogh a Monaco e la retrospettiva di Cezanne nel Salon d’Automne. È R-M. Rilke, su suggerimento della scultrice preespressionista Paola Beker-Modersohn, a cui dovette l’ammirazione per Cezanne, a dare una delle definizioni più azzeccate dell’arte nuova figurativa definendo le “mele” del pittore come “inafferrabili o anche “incomprensibili”, e cioè non più mele di una arte culinaria, ma di una “arte dell’assoluta discrepanza fra l’io e la realtà, per effetto della quale la realtà si presenta all’io come angosciante nella sua incomprensibilità. Questo si riflette nella “nuova musica” specie nel secondo quartetto (1907) di Schönberg già “consapevole di un addio al passato e primo tentativo di una nuova musica cosmica”.1]
E allora in Germania si parlò “degli anni ’20 come degli anni (amari) , anni dello stordimento di una generazione che si gettò nel piacere con la disperazione di un suicida… anni in cui vissero sconosciuti o appena conosciuti o isolati Musil, Brecht, Berg, Wittgenstein, Bloch, Kästner e Tucholsky””, tutti speranzosi di voler creare un tedesco umano e nuovo, e invece… 2].
Arte figurativa, arte letteraria, arte musicale e arte teatrale sono i quattro principali snodi del movimento espressionista, la cui definizione resta sospesa: “non è facile dire che cosa propriamente significhi”; essa secondo il Mittner è una sorta di “comoda approssimazione”, un minimo comune multiplo che ci permette di collegare fra loro determinati fatti artistici appartenenti ad una determinata età.” Insomma uno degli aspetti più originali e validi dell’espressionismo è la tentata e talora realizzata sintesi artistica nella tendenza cosmico-lirica e di quella politica-morale”.3] Una linea adottata da tutti gli autori, ognuno secondo il suo stile e la sua disciplina; p.e. visibilissima nella poesia di G. Benn. E per finire sulla sostanza espressionista lo studioso A. La Penna vede “nell’espressionismo «l’esasperazione violenta dell’espressione», mentre il barocco suscita il sospetto che l’esasperazione sia un giuoco futile, esagerazione vana più che esasperazione vera” (rivista , 1963, p.181).
Kandinskij, che fu anche poeta, da par suo nei suoi saggi cerca di dare varie definizioni dell’espressionismo già dal 1912, ma “non riesce, né tenta infine di definirlo in alcun modo” e pure dice “cose notevolissime sui rapporti fra le forme ed i colori, ma trascura di esaminare partitamente quelli fra i colori ed i suoni” . Quest’ultimo rapporto (mi) sorprende, poiché il suo maestro il pittore lituano Čurljonis compose la musica in/coi colori, specie le note di Beethoven.
Insomma, e per finire, l’intervallo tradizionalmente accettato dell’espressionismo sono gli anni 1910-24, ma suscettibili di essere ampliati certamente, diciamo 1905-1933, secondo quanto scritto più su. Quasi parallelamente all’espressionismo si muove il futurismo, ma con una vita un po’ più breve, ma con la stessa intenzione di abbattere il vecchio mondo, cioè il mondo di ieri decadente-naturalistico.
Sempre il Mittner mette a fuoco nel paragrafo §393 (La musica atonale e dodecafonica) l’arte della musica con le altre due arti: la pittura e la letteraria, facendo spiccare le personalità più evidenti: Schönberg (che fu anche pittore), Berg e Webern.
Alban Berg è con il Wozzeck, del 1921, più che con l’opera Lulu del 1928 che al confronto appare più debole almeno in apparenza, che raggiunge risultati positivi, e cioè rivela “insospettate possibilità insite nel procedimento atonale” e p.e. “il bel concerto di Berg per violino dice chiaramente che se la dissonanza è infelicità, la consonanza è felice riconciliazione”; il punto fondamentale è ancora chiarito dal Mittner (§393, p. 1202) quando scrive che Berg “accetta il principio dello Sprechgesang che rompe la cristallizzazione della vocalità melodrammatica che wagneriana, eppure recupera le forme del bel canto e del recitativo drammatico, aprendole a nuove e più sensibili possibilità espressive”
Questo aspetto a dir la verità è più evidente in Lulu, dove il recitativo é predominante; e non credo affatto che sia limitativo.
Dunque l’espressionismo si rivela il solo movimento capace di coinvolgere tutte le arti possibili: nella musica il tono diviene atonale; la pittura (si) disgrega e (si) ricompone distruggendo con l’urlo dei colori; la cinematografia col montaggio cinetico rivela possibilità oltre la semplice trama; l’architettura distrugge i fronzoli floreali e altro e bada all’essenziale geometrico sviluppando con nuovi materiali costruttivi prospettive impensabili; il teatro, p.e. con Pirandello viene frazionato con la psiche fino all’esaurimento della stessa; il romanzo con Joyce non è più lo stesso.
L’espressionismo coinvolge tutte le culture europee; in Boemia, p.e. Kubin “disegna situazioni terrificanti che sono assolutamente irrazionali eppure hanno tutta l’aria di poter essere narrate anche in chiari termini razionali”; in suo romanzo Die andere Seite (L’altro lato) anticipa, secondo il Mittner, i procedimenti sinestetici e geometrici di Kandinskij (Mittner, § 394, p.1205).

Otto Dix, I mutilati di guerra, 1920
Da Kubin al “Golem” di Meyring, e da questi a Kafka
Si innesta a questo punto la poesia ceca del ‘900 che con František Halas ha il suo poeta forse più rappresentativo dell’espressionismo poetico, che nel barocco boemo del ‘600 trova il suo fondamento naturale. Secondo il maggior critico ceco F. X. Šalda, “Halas è il poeta della sconnessione del mondo, dei nodi, dei groppi, delle intermittenze, degli abissi, degli iati nella struttura del cosmo.” (A.M. Ripellino, F. Halas, Imagena, Einaudi 1971, p. 18)… continua lo slavista:” Per molti critici Halas era in concetto di uno dei più accaniti accòlti boemi dell’espressionismo. E in effetti i suoi temi di morte e marasma, il piglio brutale, la forza esplosiva, le contorsioni, gli sfinimenti lo apparentano agli espressionisti, anche se la < la volontà di cristallizzazione astratta>, per usare parole di Šalda, la tettonica a strati, a fratture, a sovrapposizioni derivano dal cubismo”.
Amò, Halas, la poesia di Trakl tanto da essere accusato dal poeta “poetista” V. Nezval di “traklismo”. “Comunque fu la lettura di Trakl interpretato da B. Reynek (poeta e incisore cattolico) a immettere i germi dell’espressionismo nelle tessiture di Halas”, specie nei versi della raccolta “Il gallo spaventa la morte”; ma Trakl influì su tanti scrittori e poeti cechi di primo piano; perfino su Vladimir Holan. Anche il giovanissimo e sfortunato Jiří Orten fu grande ammiratore del poeta austriaco. Insomma un filo diretto c’è tra la poesia ceca e i poeti espressionisti tedeschi-austriaci.
1] Ladislao Mittner, Storia della letteratura tedesca, §391 – L’Espressionismo – pp.1190-1191, Einaudi 1982
2] ] L. Mittner, ibidem, § 261, p.858
3] L. Mittner, ibidem, §391, p.1189

František Halas
(da Sepie, 1927, Seppia)
La poesia
Migliaia di raggiri e imposture
trappola tesa nel buio
arte dello spionaggio
a cui ti abbandoni da solo
seguendo le tue tracce e condannandoti
per i segreti svelati
punito soprattutto da te stesso
le tue liriche libro di lagnanze
Hai agonizzare la poesia per una parola andata a traverso
non morirà mai tuttavia
un giorno troverai le tue parole come il terno di una lotteria
e l’avrai vinta
Stretta è la rosa centifoglia dei poeti
ami soltanto quelli con la lingua serpentina
di cui metà è querimònia di angeli
e metà assalto
Ultima Tule dove ti allontani
con dolcezza infinita per le cose che hai conosciuto
con voce tutta falsa congedandoti
dalla soave malsanía che ti ha perduto
(trad. A. M. Ripellino, 1971)
*
Scarmigliato dal fascino audace in una corazza di nebbie
Beve sino al fondo l’alcool delle rose
Il volto pieno di giorni impiastricciati
Intriso di sangue rugginoso l’abito pende fra i rovi
Il relitto del giorno cola a picco col suo equipaggio di ombre
Lo strazio della terra si placa nel buio smanceroso
Corre nudo da una pratolina la moneta orfanile dell’aurora
stringendo nel palmo
dall’angoscia pigola un uccello nel raro fogliame al risveglio
nelle sorgenti si sciolgono le rusalche
Mestizia antica offusca i suoi occhi afflitti
Il sole imperatore negro incoronato
Sorge pian piano da guazzi melmosi
Cade la noce imputridita della bella testa
nella sua cavità qualcosa insieme sboccia e marcisce
con le orbite vuote una cerbiatta vaga nel bosco e geme
Un pipistrello il patto con l’inferno sulle membrane delle ali
dorme nel cantuccio di una grotta
(trad. A. M. Ripellino, 1971)
*
Paesaggio velenoso
Nelle àgate oleose di acque funeste
un fiore più làido di un morbo si allarga
e gelatina di rospo abominevoli
La strada maneggio di spettri striscia scabbiosa
solo un ronzío velenoso di mosche carnarie
l’erbaio gialleggia impuro come calunnia
Della propria laidezza si consola con l’arte
qui il sole incendiando dovunque la desolazione
e gioielli di coleotteri martella dalle carogne
Il contagio maligno si estende sino alle nuvole
gelosamente conservando la loro pioggia
e nel tramonto livido si uccidono gli scorpioni
(trad. A. M. Ripellino, 1971)
*

Jiří Orten
Jiří Orten
Fu un dicembre generoso. Sulla radura innevata
c’era qualcuno con la tavolozza in mano.
Nevicava, nevicava nel suo dipingere.
Era inconsapevole, dipingeva
questo nudo inverno, le sue compatte ossa,
la valle della nostra origine, profonda, più che non volesse,
e l’altezza dei seni nella ripida ebbrezza.
Sul modello nevicava.
Dio mio, qui ha svolazzato il corvo, cosa vuole,
da dove viene?
Fu un dicembre generoso. Sulla tavolozza nevicava
e la tavolozza era vuota.
Questa terribile impotenza a impossessarsi del dipingere,
che cade sulle tele,
come neve bianca, che non sa, non sa nemmeno
perché deve cadere!
Questa terribile impotenza a trattenere ciò che fugge!
Si è indebolita la tua mano,
hai la lingua impedita, e non sa dire
a quello, cosa si scioglie:
o eterna metamorfosi, si scioglie tutto ciò che è nascosto,
o eterna metamorfosi, dove sarà la mia anima,
finché mi sciolgo in neve, dove sarà, in quale donna
e in quali nevai?
Fu un dicembre generoso. Sulla radura innevata
c’era qualcuno con la tavolozza in mano.
Nevicava, nevicava nel suo dipingere.
Lui era inconsapevole, dipingeva.
.
1939
(trad. Antonio Sagredo – Katerina Zoufalová, 2006)
*
Eternamente
Si piega sulle ginocchia la notte,
si piega e non lo crede.
Nulla più mi trattiene alla vita,
di scatto taccio,
mentre le madri dei morti
sono pronte ad un’altra volta.
Pietà si deve avere
di tutti noi superstiti.
Sbagliare eternamente, fino ad essere puri.
Eternamente.
Si piega sulle ginocchia la notte.
Pregherai stasera, Desdemona?
.
1940
(trad. di G. Giudici e V. Mikeš, 1969)
*
Deviazione
Nubi di polvere si alzano dietro la carretta.
Commosso il boia si volta inorridito.
Tra poco la testa chiomata rintronerà a terra.
Voi fatevi più avanti, spettatori!
Era già condannato da sempre. A lungo nella cella maturò.
Aveva tempo. E spesso di tra le sbarre un bagliore
C’era, forse di sangue. Non pensa all’accusatore.
Vuol giustiziare se stesso.
Vuole? Non sa. In un languente sogno si perde,
fino all’ultimo vuole sognare la nuvola, un giovane seno,
compatire i carnefici, andare diritto al patibolo
e cantare, cantare fino all’estremo!
1941 (trad. di G. Giudici e V. Mikeš, 1969)
.

Vladimir Holan
Vladimir Holan
Non sai
Non sai più se hai mentito
a tal punto che oggi il rimpianto s’è contraddetto
dilatando la colpa che fuggendo con te
ti rivuole indietro
a colori ravvicinati.
Non sai più se per le percosse
ci scordammo l’offesa
che le accompagnava.
Non sai… ma la brughiera era sferzata da una bufera di neve!
Ma quella voce… “Non vi perdonerò mai”.
*
Quante volte
Quante volte, scrutando con gli occhi,
passeggiavi presso un orologio o sotto una vecchia acacia,
ma le loro sembianze si deformano facilmente.
Per la fatalità nei sensi e per l’anima negli echi
hai conosciuto la paura della morte,
questa è l’attesa… Soltanto dopo
gli spettri sono concreti… Ma la gelosia
nessuno la difenderebbe…
(trad. Antonio Sagredo, 1983)
http://riviste.unimi.it/index.php/itinera/index – Sabrina Orivelli, Kirchner e Murnau: ricorrenze iconiche, tematiche e semantiche dalle arti figurative al cinema
German Expressionism has had from the beginning a multidisciplinary character and the works of the painters, pertaining to that current, have strongly influenced the filmmakers of the subsequent decade. More specifically, it is possible to find in some sequences of Nosferatu by Friedrich Wilhelm Murnau several formal features that have characterized the production of expressionist Ernst Ludwig Kirchner, as well as the direct quotation of some works of him, including The Red Tower in Halle, Two Women in the Street and Five Women in the Street. The reproduction in the frames of specific works of art, the image distortion, even the make-up of actors resume then aesthetic elements first developed by Murnau and are intended to convey to the viewer a sense of anxiety compared to the reality, to the contemporary society, to the city life, even manifesting an inner struggle, that has united Kirchner and Murnau itself.

Quattro poesie inedite di Antonio Sagredo
Il libro… oggi
Il libro aprì le mie mani per segnarmi come un monatto irriverente,
nella mia mente avvilita i misteri della metonimia antica,
e quella malattia che traverso il nome si chiama, se volete, Poesia.
Sorrise il lucido dorsale per mostrarmi la sua identità cartacea.
E mi sfogliò le epoche come uno stregone distilla il suo veleno cortigiano.
Mi accecò come un bardo la parola per cantare la mia corteccia irrazionale.
Il furore dell’infanzia esondò come la bellezza di Rosalia!
Come la beatitudine di Smeralda inquisì lo spasimo della materia!
Per coprire d’oscurità i triviali segreti celebrò le distinzioni delle pagine
con le affilate misture di Salafia, e gli spettri delle sue formule
per vincere d’immortalità i suoi sembianti. Per il trionfo della maschera
il trucco di una pelle si ritirò sdegnoso dietro la propria inconsistenza.
Il libro… oggi, è un cavaliere insopportabile e vincente.
La macchina non ha piedi, né cammini tracciati dai sentieri,
e passi tardi e lenti per stampare i tempi e gli ignobili pensieri.
Come un geniale attore che alle scene assegna gli atti, i gesti, e i fallimenti.
Roma, 5/12 novembre 2011
*
Il cielo si scurì per neri ombrelli
Dai confessionali cinguettava una condanna ambigua senz’appello,
sinistro era il calvo battito di un giudice in gramaglie nere.
Non avevo più i conforti estremi di un’anima eretica, la carne arsa
e quella fede irregolare che un celeste trono nega a malincuore.
Mi tallonava l’inutile urlo della croce e la sua smorfia stercoraria
che dal capezzale mi pianse la perdita di astragali e aliossi.
Come uno stendardo si levò la beffa simile a una profezia teatrale!
E io vidi, non so, patiboli in stiffelius e quinte martoriate come golgotha
e coi reggicalze ben in vista alati putti e sacerdoti celebrare beati,
sotto i portici del granchio, sanguinanti spine, lombi e glutei!
Ah, Dante, non avevi più urina e saliva, ma la tua lingua era ancora toscana,
cordigliera e velenosa… perfino gli uccelli scansano questa croce! – gridò.
Il cielo si scurì per neri ombrelli… tuniche codarde e orbite di livide veroniche
oltraggiarono i tramonti – chiodato dai suoi miracoli l’Incarnato pulsava
per un coito dismesso a malincuore – per un altro sesso, come un velo mestruato,
depose il divino Verbo nel postribolo – fu l’inizio della nostra croce, e la sua gloria!
I giorni che trascorsi nello specchio gelano epoche e finte apocalissi.
Promise al suo sosia e gemello le meraviglie della Terra e degli Universi
tutti, ma quel bosco fu avvelenato dalle bacche del tasso: miserie del martirio!
finzioni! resurrezione dei vivi! fede dei misteri!… compassione, per loro… ecc… ecc….
Roma, 29 settembre 2011
*
Camera
Forse tu, domani, stupita vedrai il mio trionfo calpestare l’ardesia,
le consolari ammutolite e il riflesso ostinato di un Kaos nelle cisterne
vuote… il clamore del mio volto fu sorpreso da un cratere attico
e umiliato l’incarnato in una gabbia dalla mia storia scellerata.
Nei laboratori dei presagi ho scovato non so quale fattura inquisita,
la promessa di una risurrezione mi stordiva… mi svelava una fede
il negromante a squarciagola: ecco, questi sono gli altari,
dove ancora nei secoli si canterà la favola di un qualsiasi Cristo!
Era inverno. Come un latino antico carezzava la soglia di codici miniati
e sul leggio la potenza di un centrale impero. Raggirava la città zebrata
con Keplero, e tra insegne, bettole e vino nero, respiravano l’ansia,
la carta e l’inchiostro – e con lo sguardo la neve, la polvere della decadenza.
Lastricate d’attese e geometrie le nuove leggi simulavano la memoria.
Raffiche di gelo salmodiavano le nostre ossa, i numeri cedevano il segreto
al secolo più virtuoso, straziata la nemesi e sformata la pietra angolare.
Gli occhi e le dita computavano nuove orbite e principi matematici.
Maldestro è il tradimento! Come il trono è una maschera inabile,
capriccio e parvenza di se stesso! E mi vaneggia lo specchio di incubi,
eventi e sembianti… e come si trastulla nel giardino, e in questa
stanza mia, che è Tutto per me – per fortuna – ma non è la Storia!
.
Vermicino, 16-20 maggio 2008
*
Non ho mai incrociato una fede umana o divina con un pianto di legno nella Casa,
– sul pianerottolo una marionetta gioca con la testa di Maria Stuarda.
Ha di gelatina gli occhi e non lacrime vomita, ma trucioli e colla di coniglio!
Il lutto non s’addice ai Cesari e alle stelle… Gesti, gesti a me! Soccorrete le mie mani!
Ma io che faccio qui o altrove se il boia non ha un nobile rancore sulla lingua
e mescolare non sa con l’accetta dell’attesa e dell’accidia un colore di Turner.
Il Nulla azzera i giudizi sui patiboli, e il resto di un delirio è nello specchio.
E dov’era vissuto il mio corpo quando offriva sangue alla sua ombra?
Sono rose nere queste quotidianità, ma non sono le mie rose!
E come posso rifiutare un destino che ad ogni sua domanda mi risveglia?
Io sono esente per grazia umana, e nella mia parola non c’è risposta!
E non ho l’acrimonia del vivere, solo voglio esserci quando accadrà.
Svegliatemi dopo la mia immortalità! La pantomima è piena
di vento nelle apocalissi, negli incendi e nelle distruzioni! – i tre profeti
farfugliano : Scusi – lei – sente – molto – la – nostra – differenza?
La confessione è un’arma terrificante… il Poeta: io me ne fotto!
Roma, 29 ottobre 2011
Il libro… oggi
Il libro aprì le mie mani per segnarmi come un monatto irriverente,
nella mia mente avvilita i misteri della metonimia antica,
e quella malattia che traverso il nome si chiama, se volete, Poesia.
Sorrise il lucido dorsale per mostrarmi la sua identità cartacea.
E mi sfogliò le epoche come uno stregone distilla il suo veleno cortigiano.
Mi accecò come un bardo la parola per cantare la mia corteccia irrazionale.
Il furore dell’infanzia esondò come la bellezza di Rosalia!
Come la beatitudine di Smeralda inquisì lo spasimo della materia!
Per coprire d’oscurità i triviali segreti celebrò le distinzioni delle pagine
con le affilate misture di Salafia, e gli spettri delle sue formule
per vincere d’immortalità i suoi sembianti. Per il trionfo della maschera
il trucco di una pelle si ritirò sdegnoso dietro la propria inconsistenza.
Il libro… oggi, è un cavaliere insopportabile e vincente.
La macchina non ha piedi, né cammini tracciati dai sentieri,
e passi tardi e lenti per stampare i tempi e gli ignobili pensieri.
Come un geniale attore che alle scene assegna gli atti, i gesti, e i fallimenti.
Roma, 5/12 novembre 2011

Antonio Sagredo, grafica di Lucio Mayoor Tosi
Antonio Sagredo (pseudonimo Alberto Di Paola), è nato a Brindisi nel novembre del 1945; vissuto a Lecce, e dal 1968 a Roma dove risiede. Ha pubblicato le sue poesie in Spagna: Testuggini (Tortugas) Lola editorial 1992, Zaragoza; e Poemas, Lola editorial 2001, Zaragoza; e inoltre in diverse riviste: «Malvis» (n.1) e «Turia» (n.17), 1995, Zaragoza. La Prima Legione (da Legioni, 1989) in Gradiva, ed.Yale Italia Poetry, USA, 2002; e in Il Teatro delle idee, Roma, 2008, la poesia Omaggio al pittore Turi Sottile. Ha pubblicato dieci poesie nella antologia a cura di Giorgio Linguaglossa Come è finita la guerra di troia non ricordo (Roma, Progetto Cultura, 2016) e la sua prima silloge in italiano, Capricci. Articoli e saggi in La Zagaglia: Recensione critica ad un poeta salentino, 1968, Lecce (A. Di Paola); in Rivista di Psicologia Analitica, 1984, (pseud. Baio della Porta): Leone Tolstoj – le memorie di un folle. (una provocazione ai benpensanti di allora, russi e non); in «Il caffè illustrato», n. 11, marzo-aprile 2003: A. M. Ripellino e il Teatro degli Skomorochi, 1971-74. (A. Di Paola) (una carrellata di quella stupenda stagione teatrale).
Ho curato (con diversi pseudonimi) traduzioni di poesie e poemi di poeti slavi: Il poema :Tumuli di Josef Kostohryz , pubblicato in «L’ozio», ed. Amadeus, 1990; trad. A. Di Paola e Kateřina Zoufalová; i poemi: Edison (in L’ozio,…., 1987, trad. A. Di Paola), e Il becchino assoluto (in «L’ozio», 1988) di Vitězlav Nezval; (trad. A. Di Paola e K. Zoufalová).
Traduzioni di poesie scelte di Katerina Rudčenkova, di Zbyněk Hejda, Ladislav Novák, di Jiří Kolař, e altri in varie riviste italiane e ceche. Nella rivista «Poesia» (settembre 2013, n. 285), per la prima volta in Italia a un vasto pubblico di lettori: Otokar Březina- La vittoriosa solitudine del canto (lettera di Ot. Brezina a Antonio Sagredo), trad. A. Di Paola e K. Zoufalová. È in uscita, per Chelsea Editions di New York, Poems Selected poems di Antonio Sagredo.
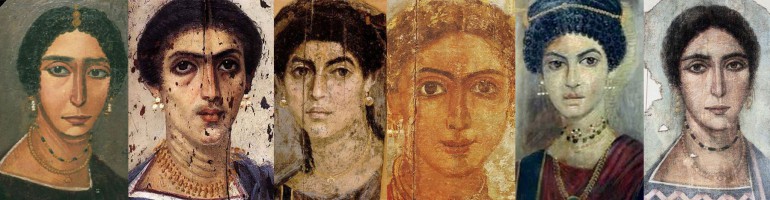
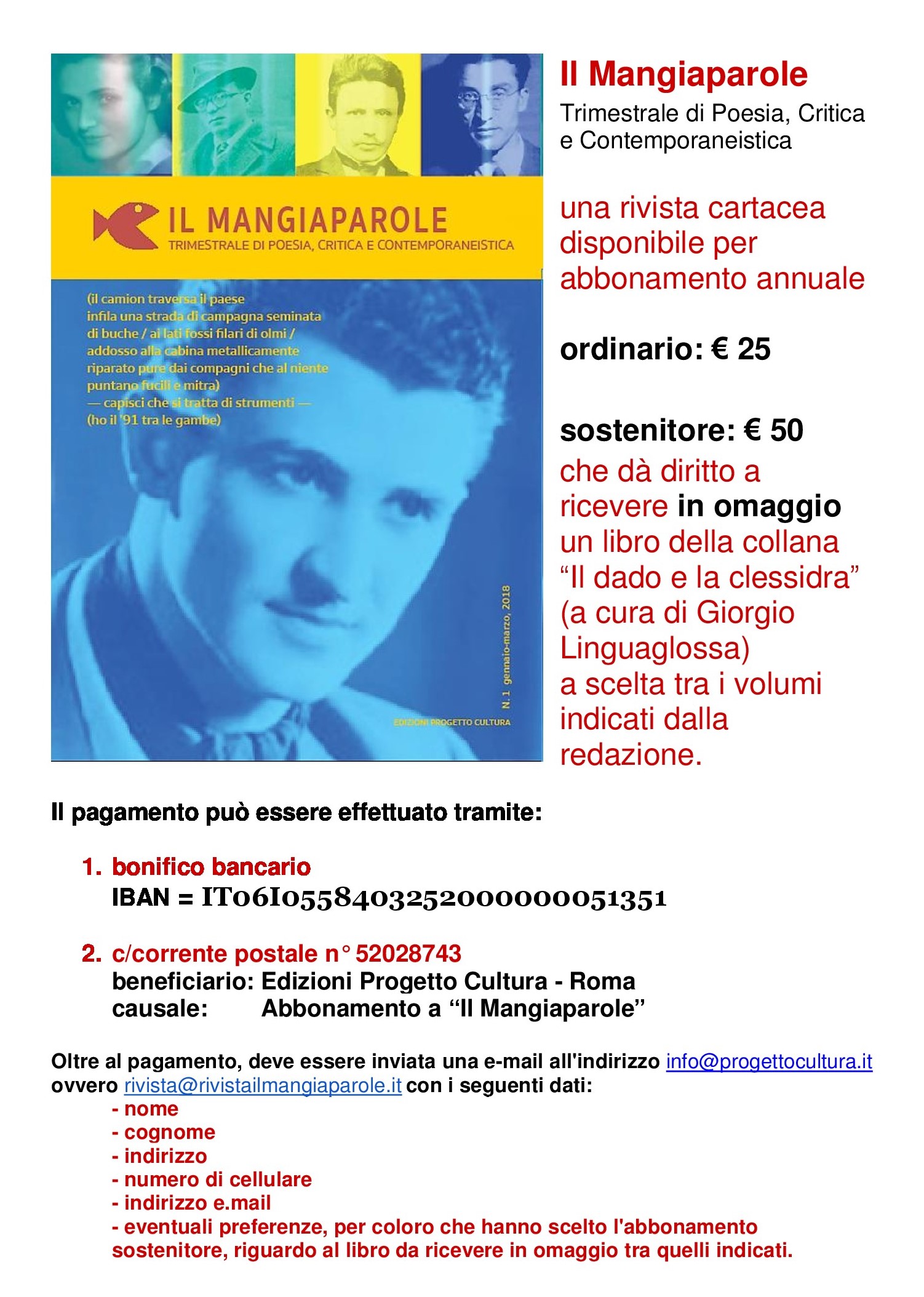
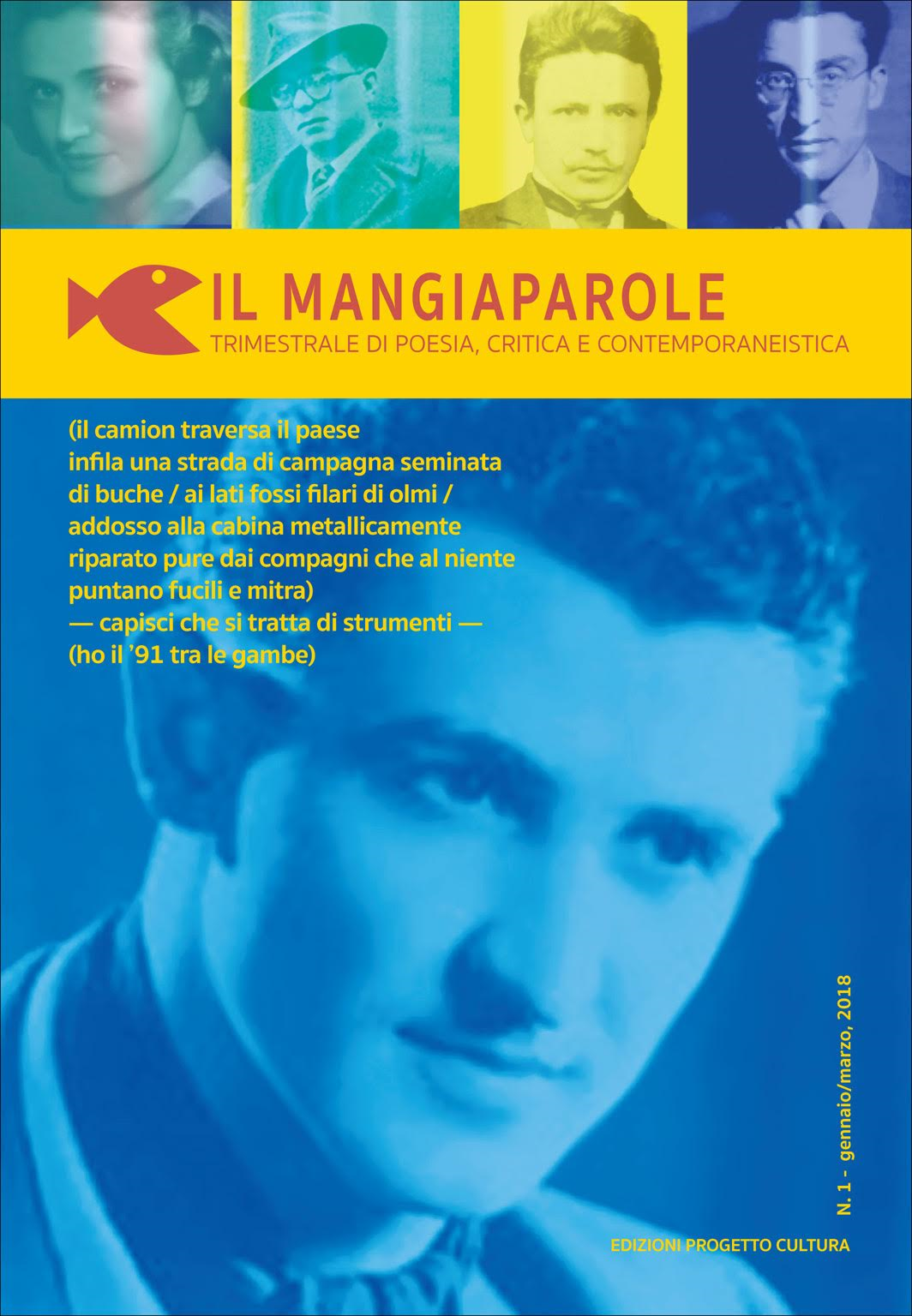

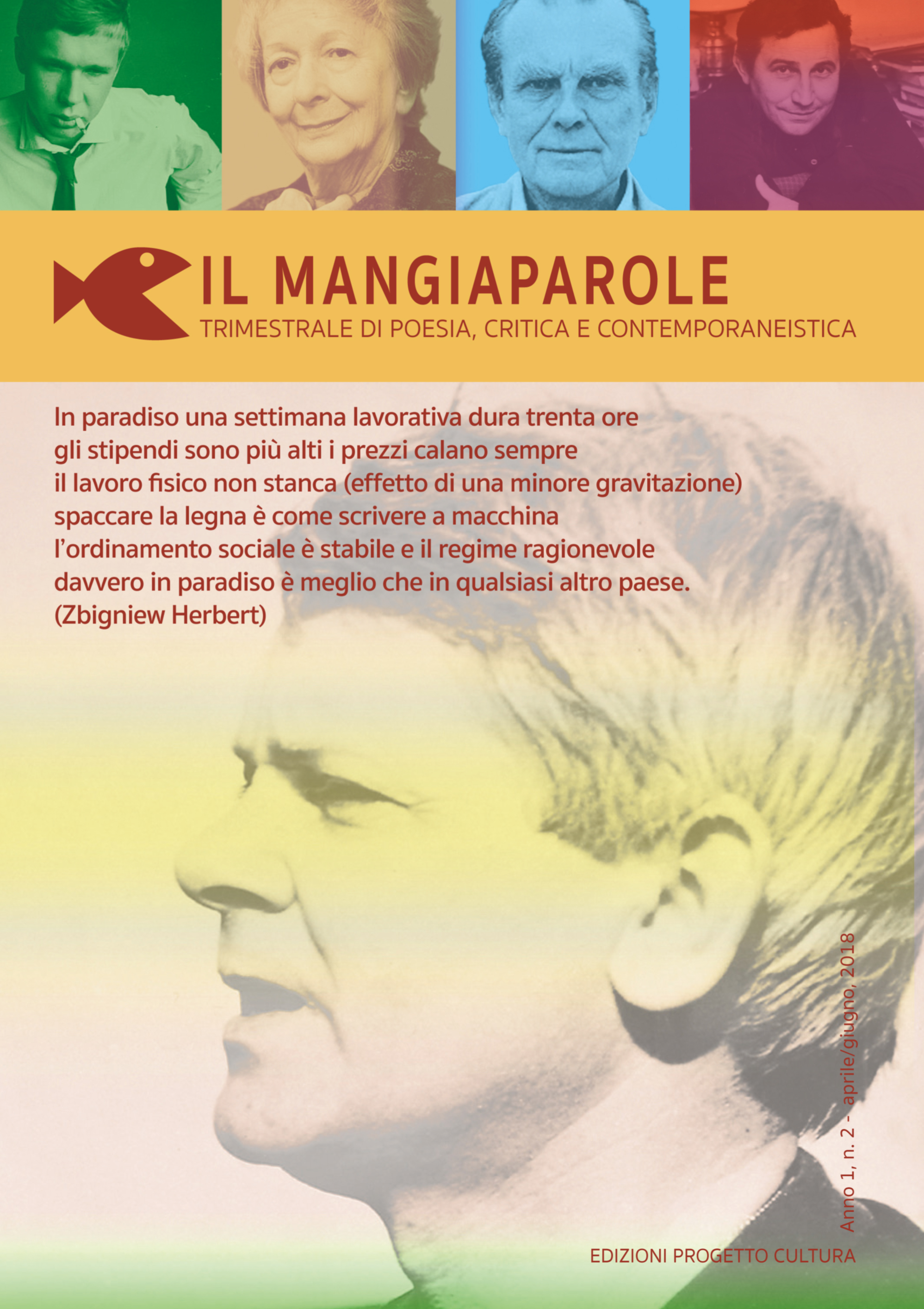



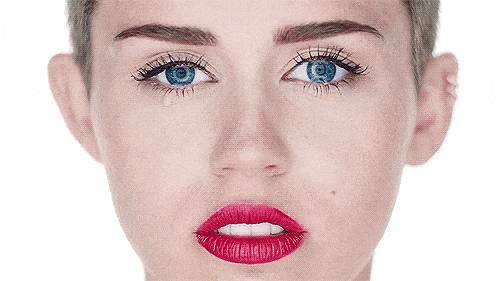
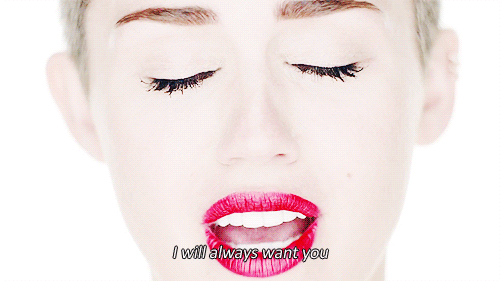
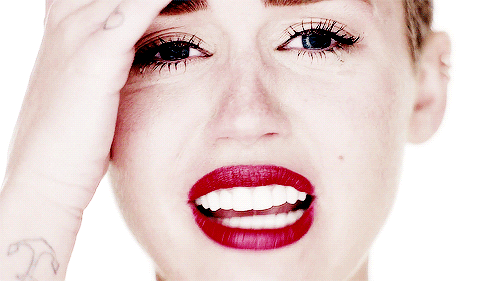
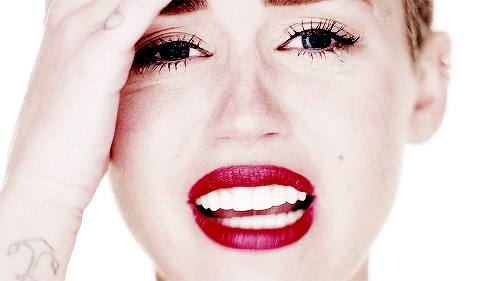
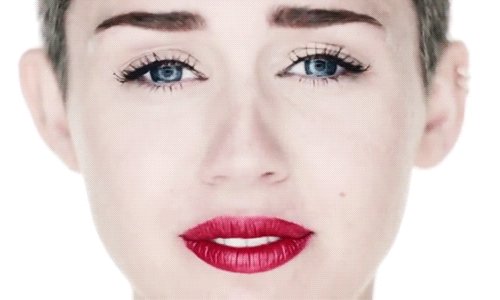



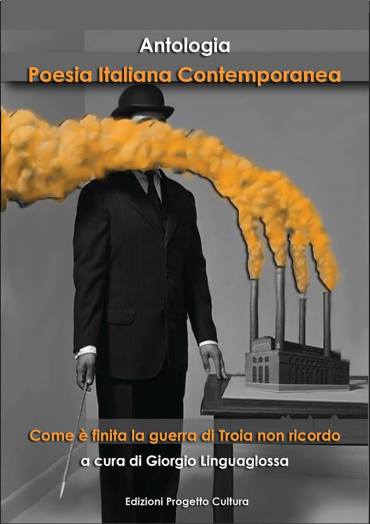




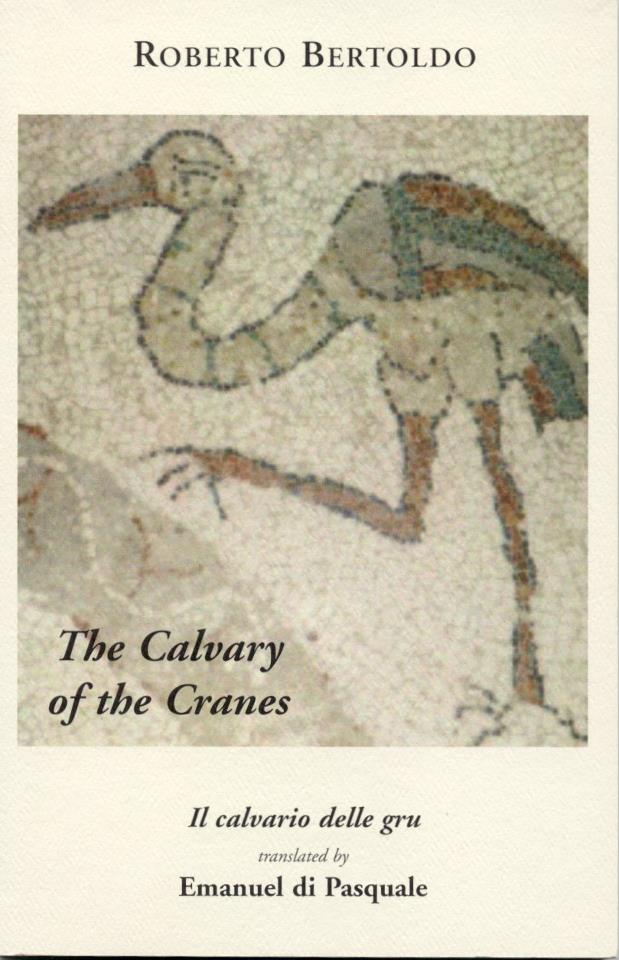
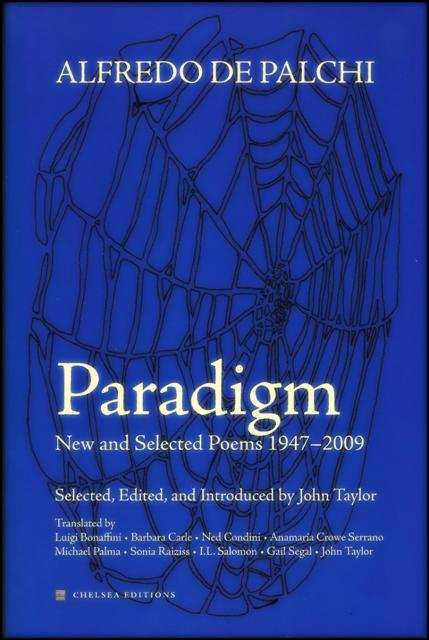


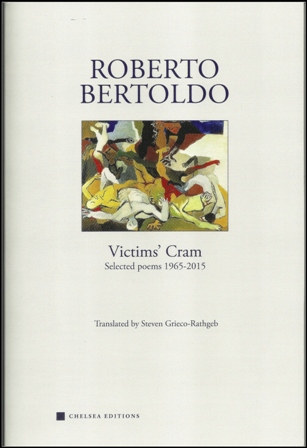





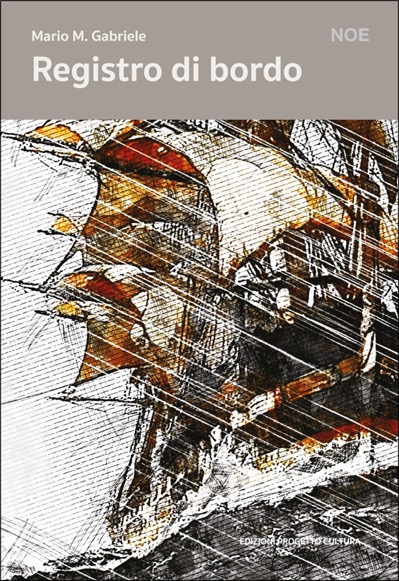

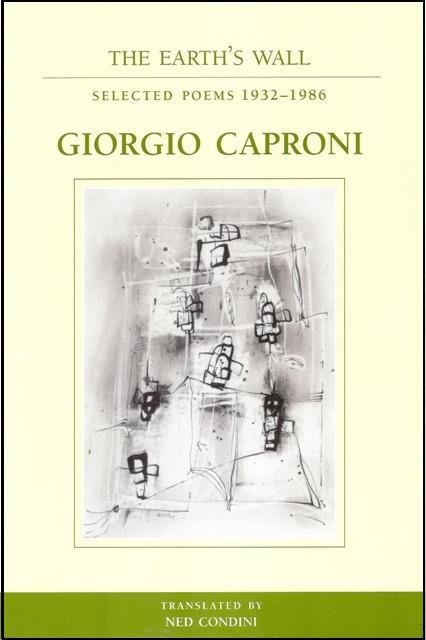
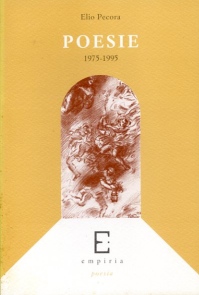

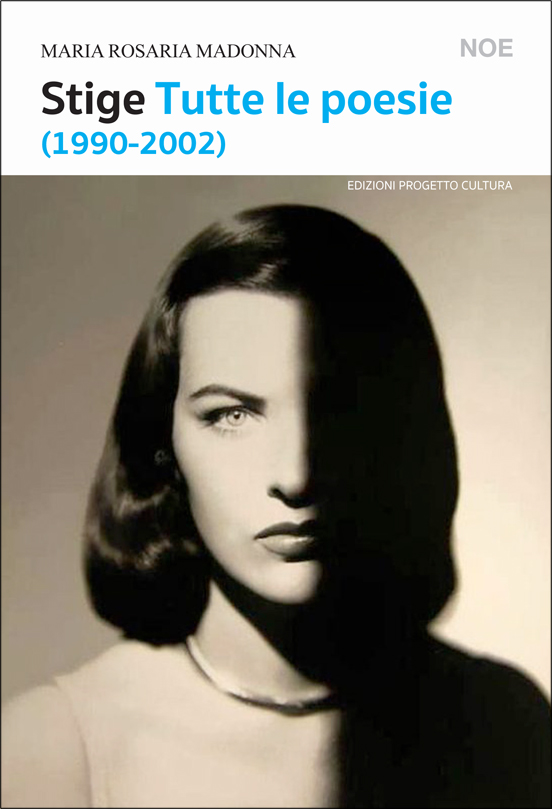

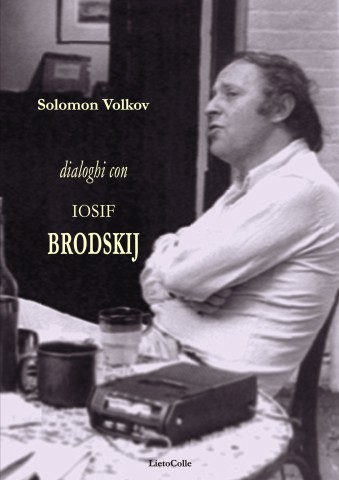




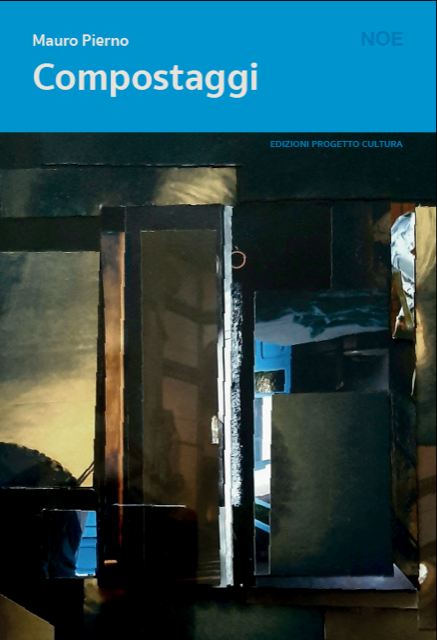
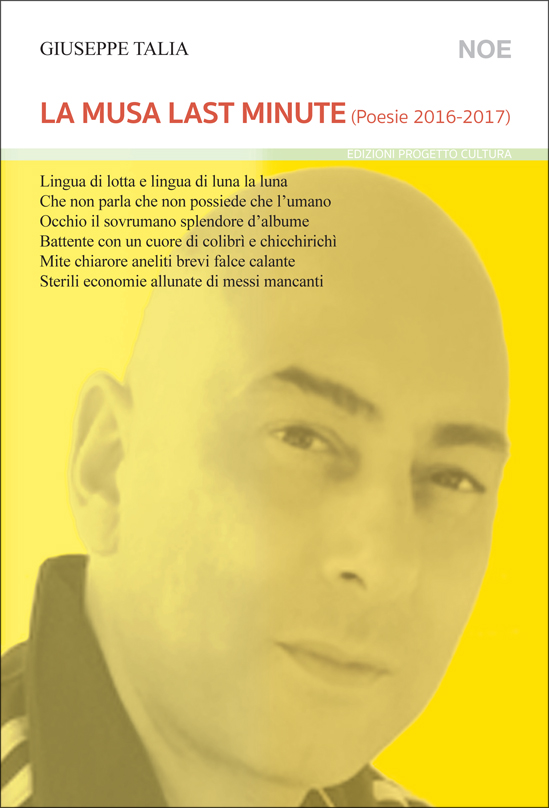


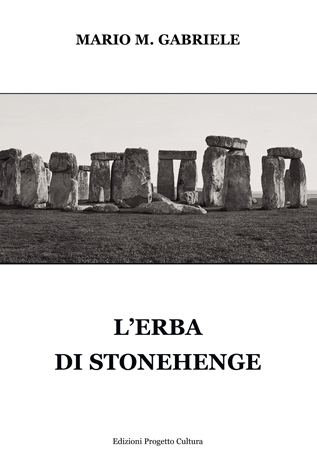
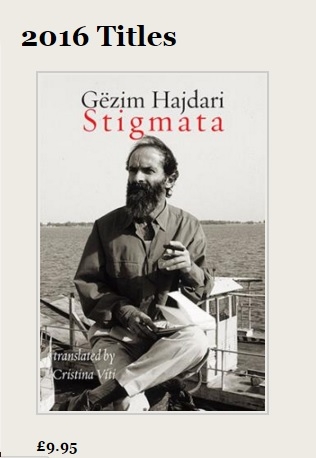
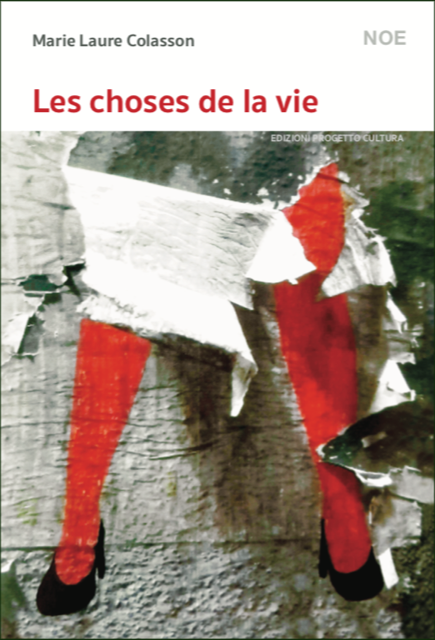




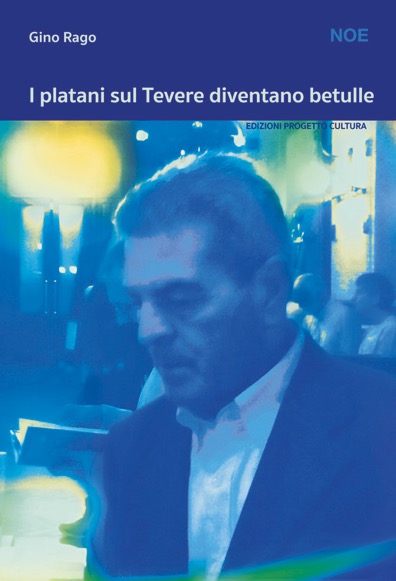
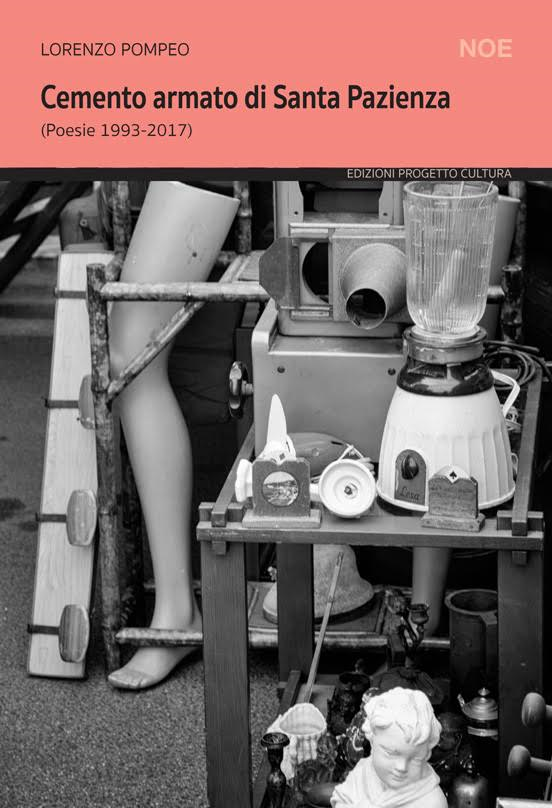
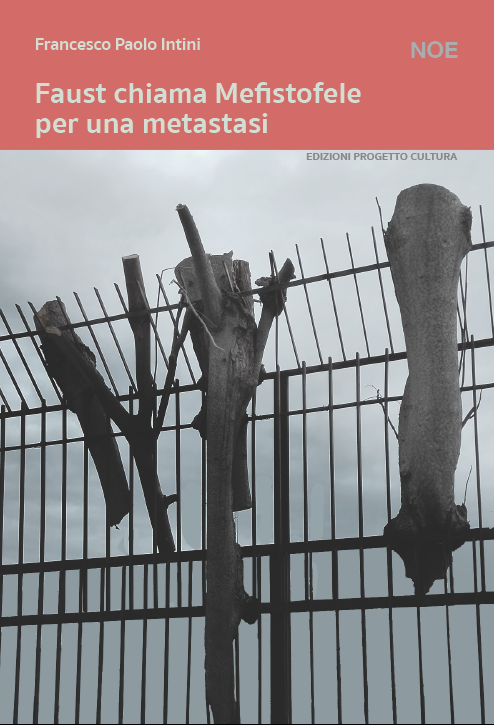

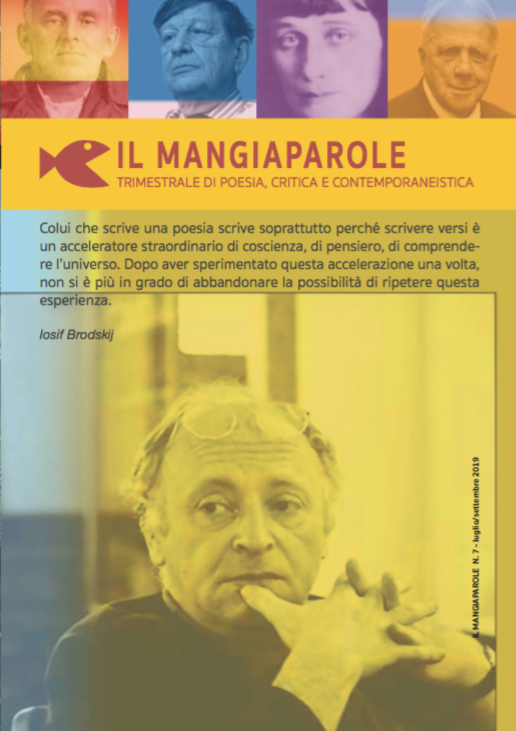




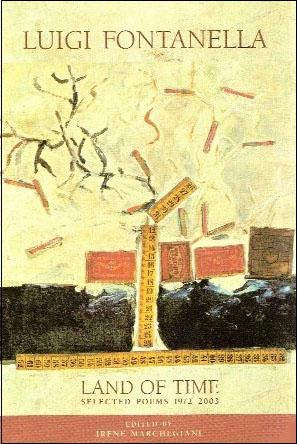








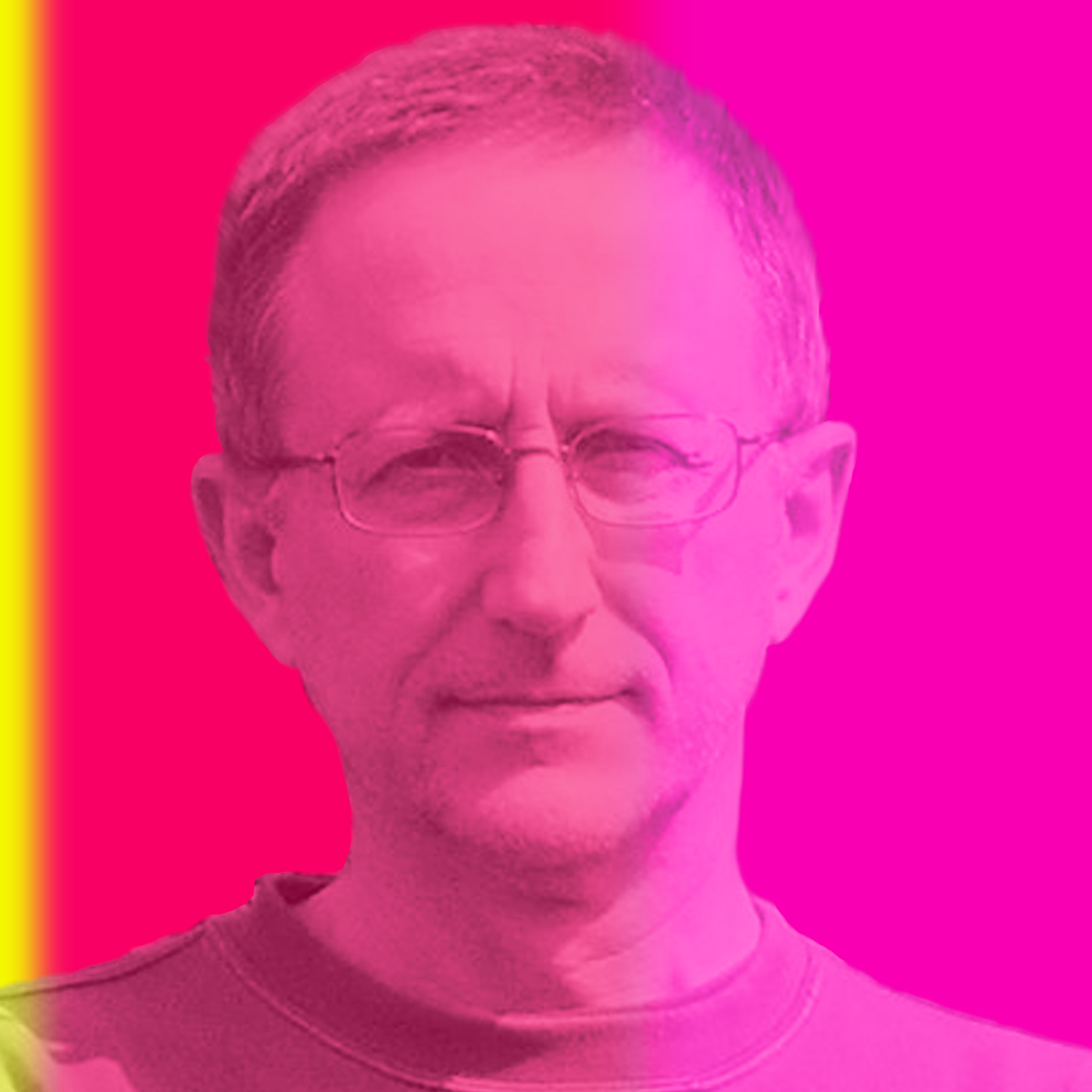







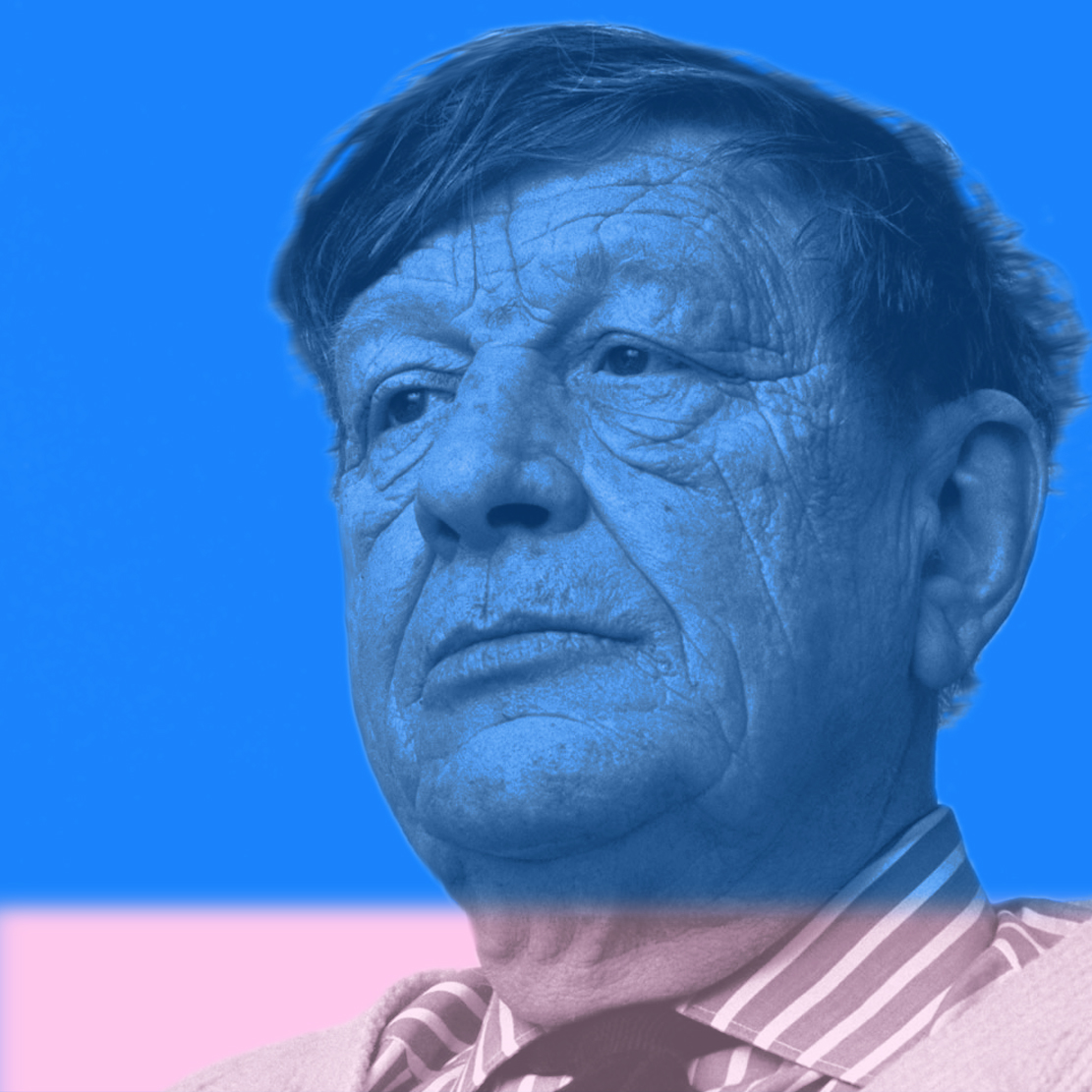



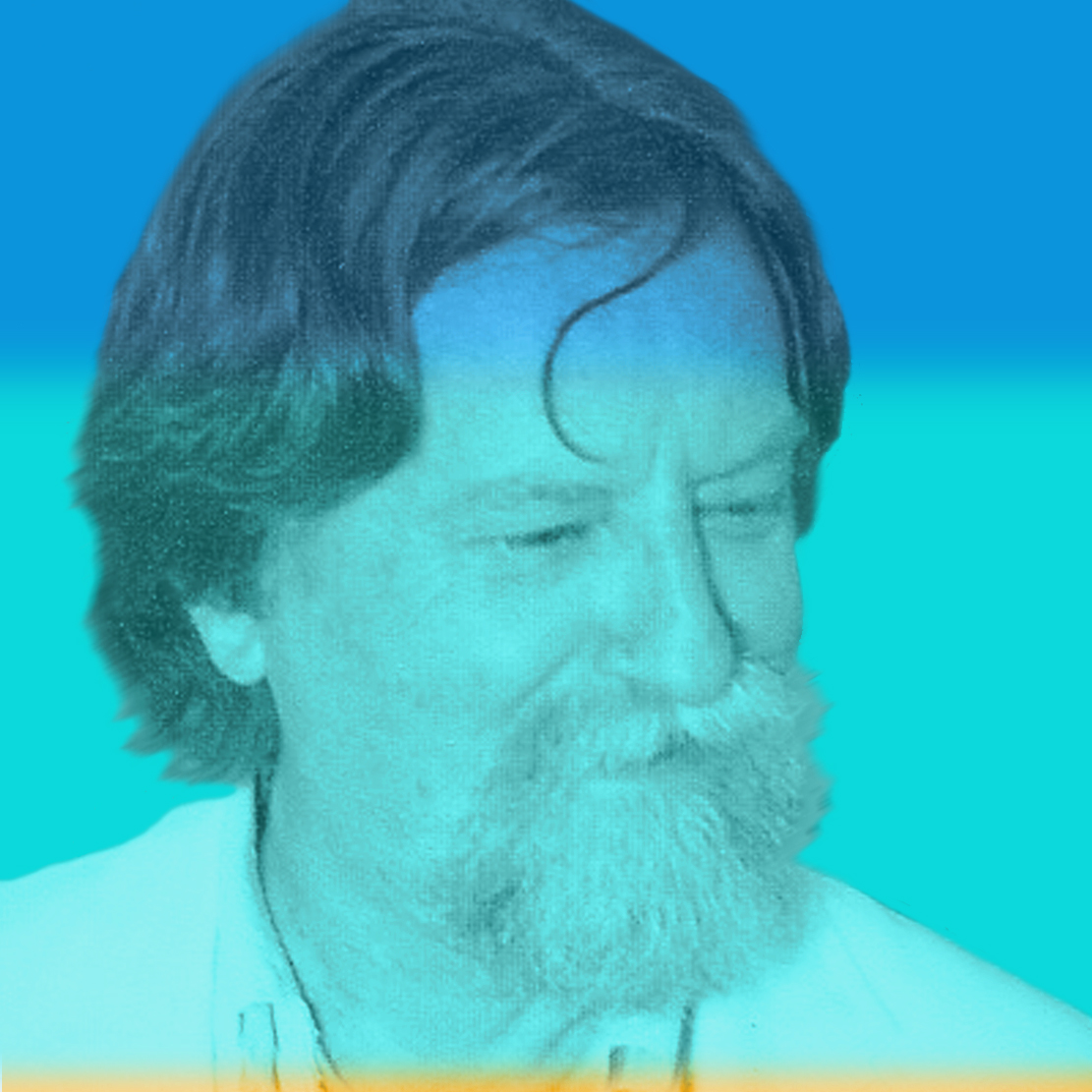
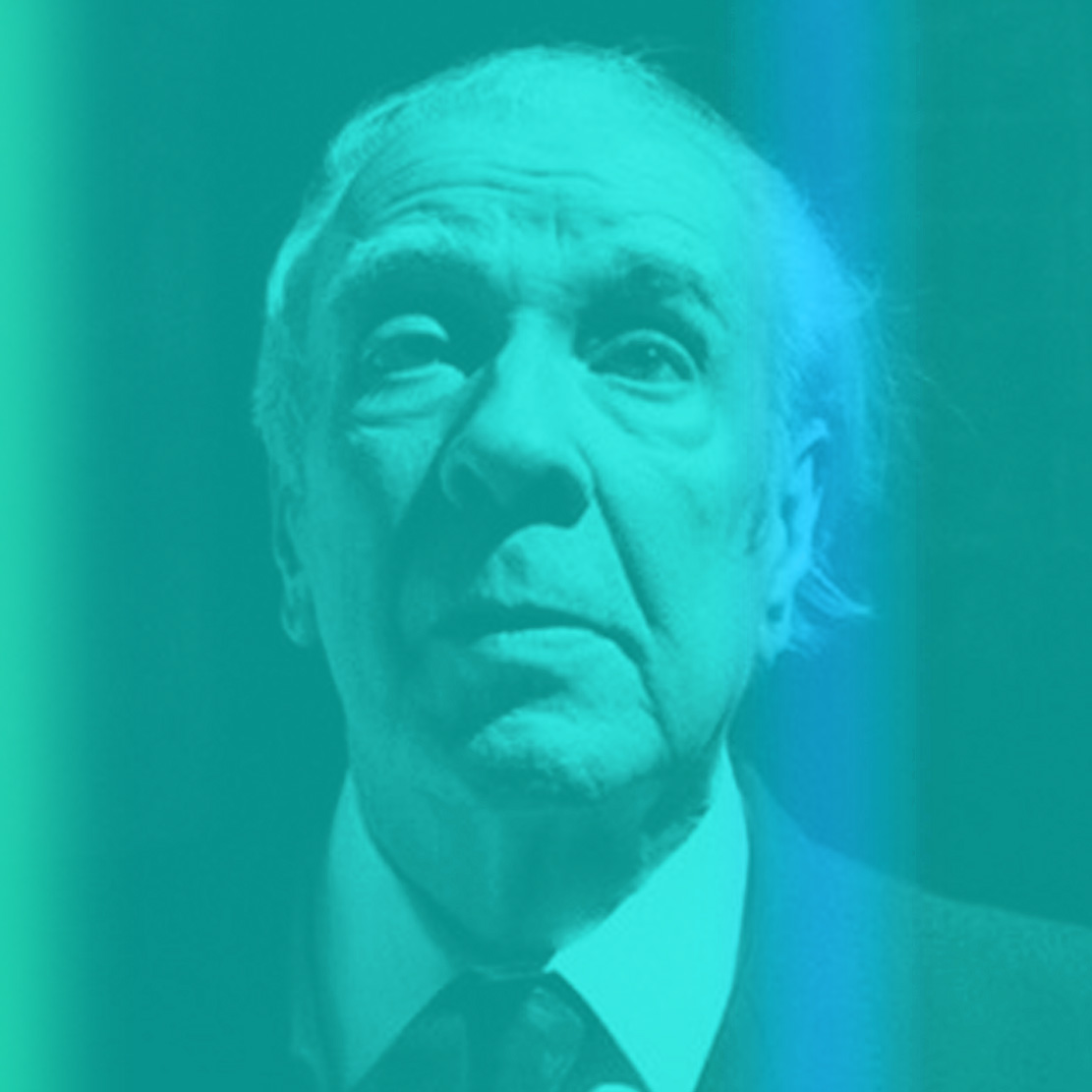




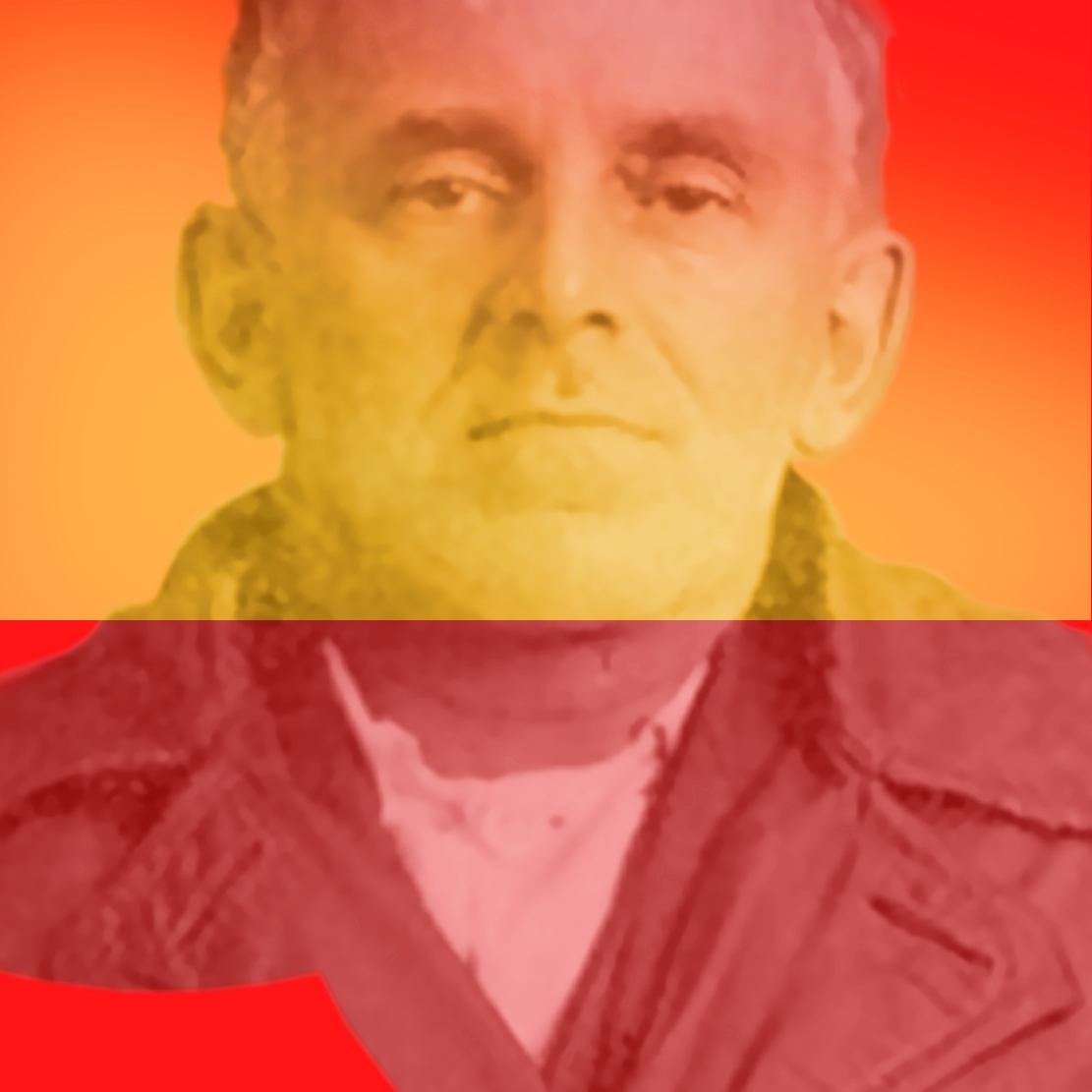






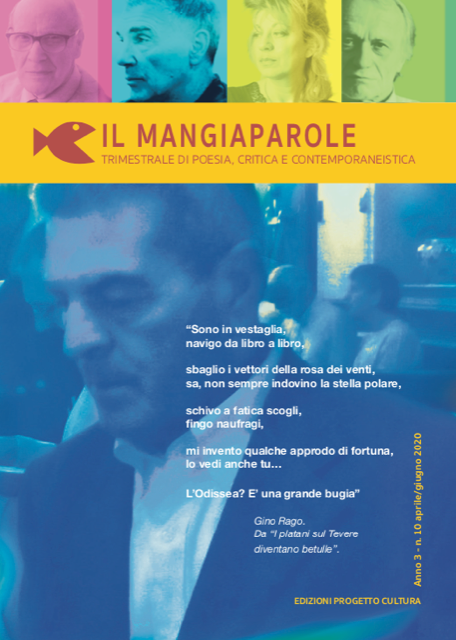




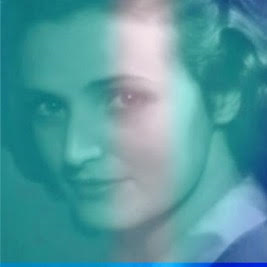
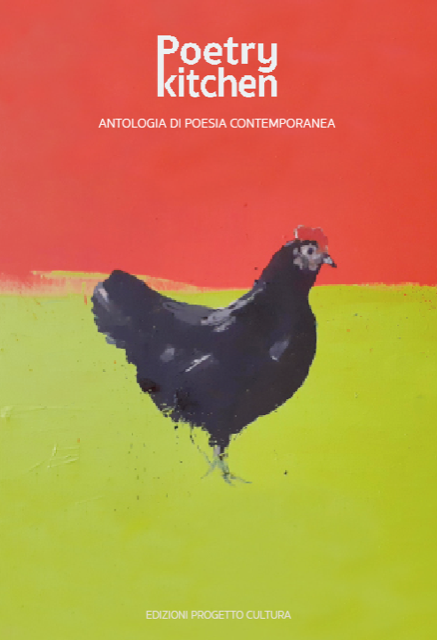



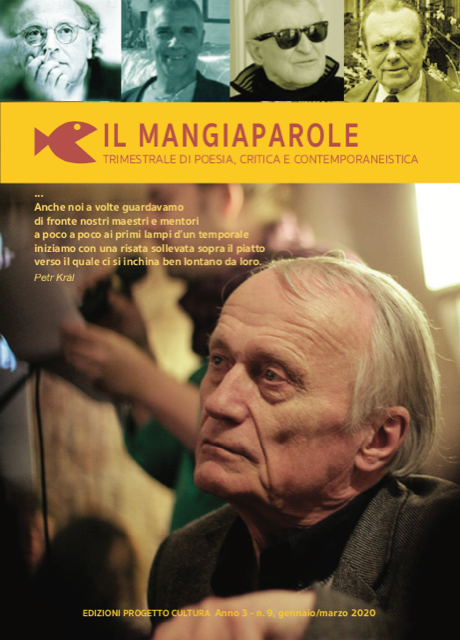











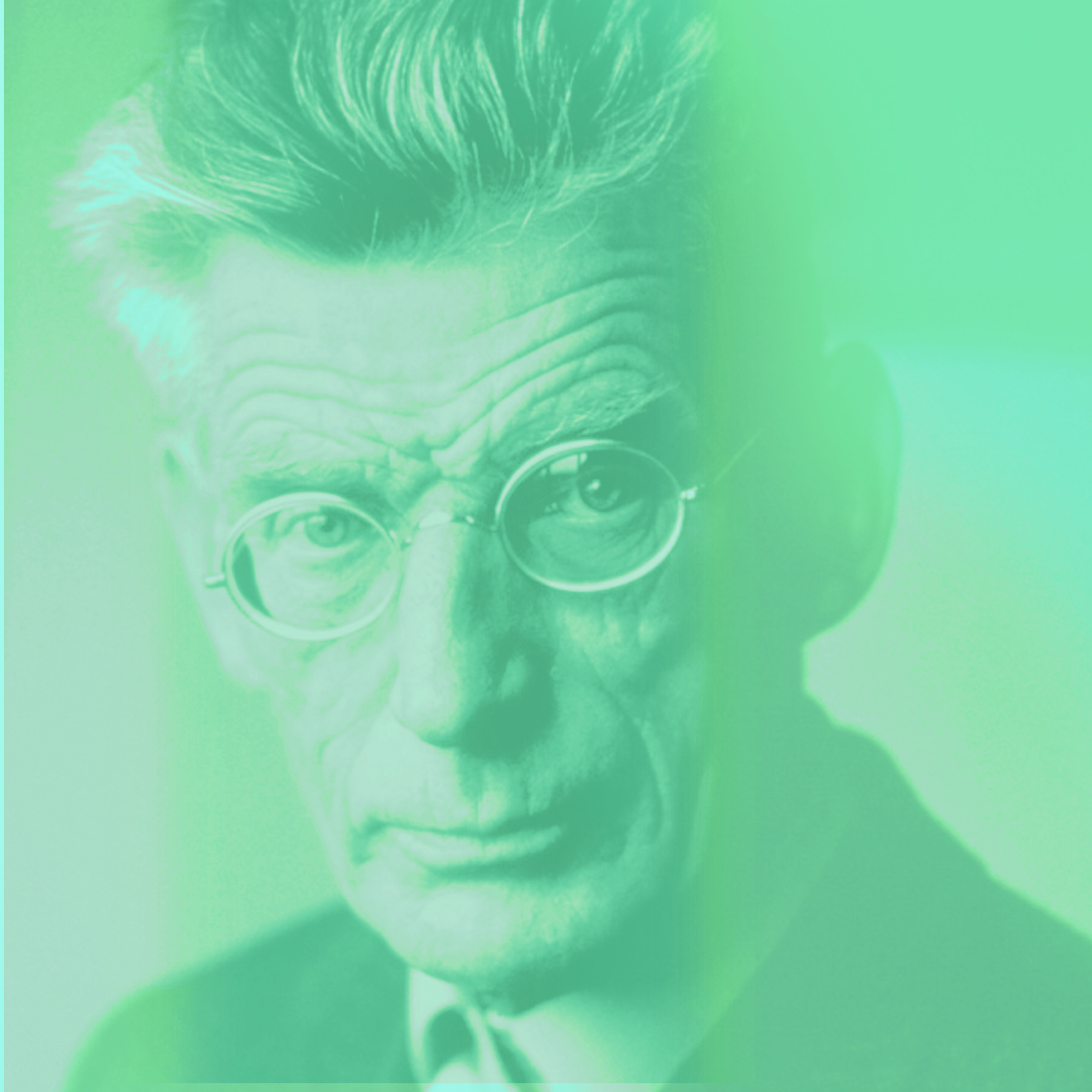
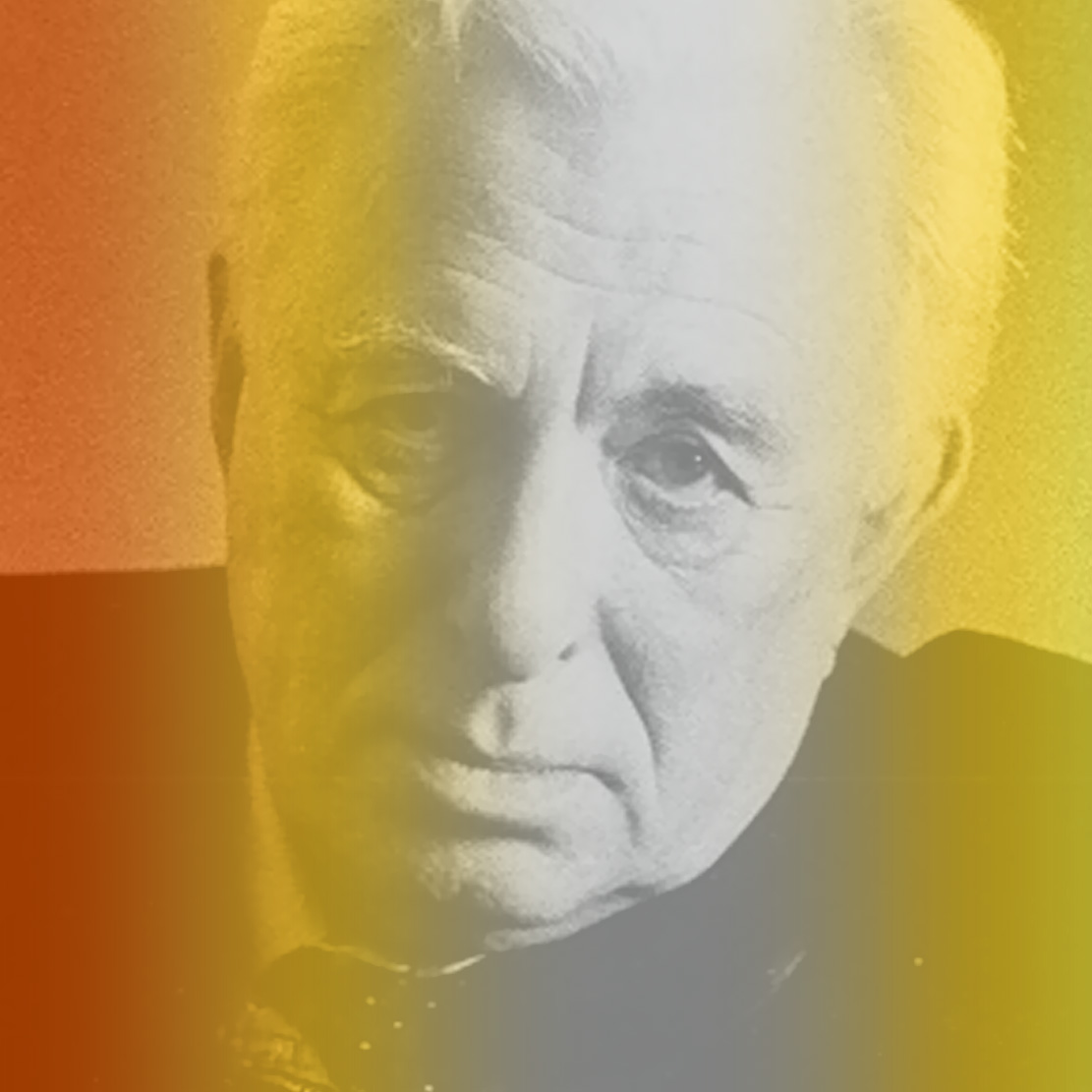









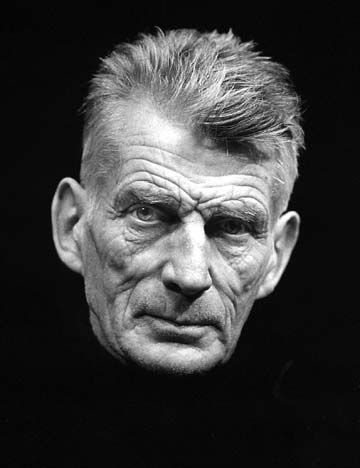


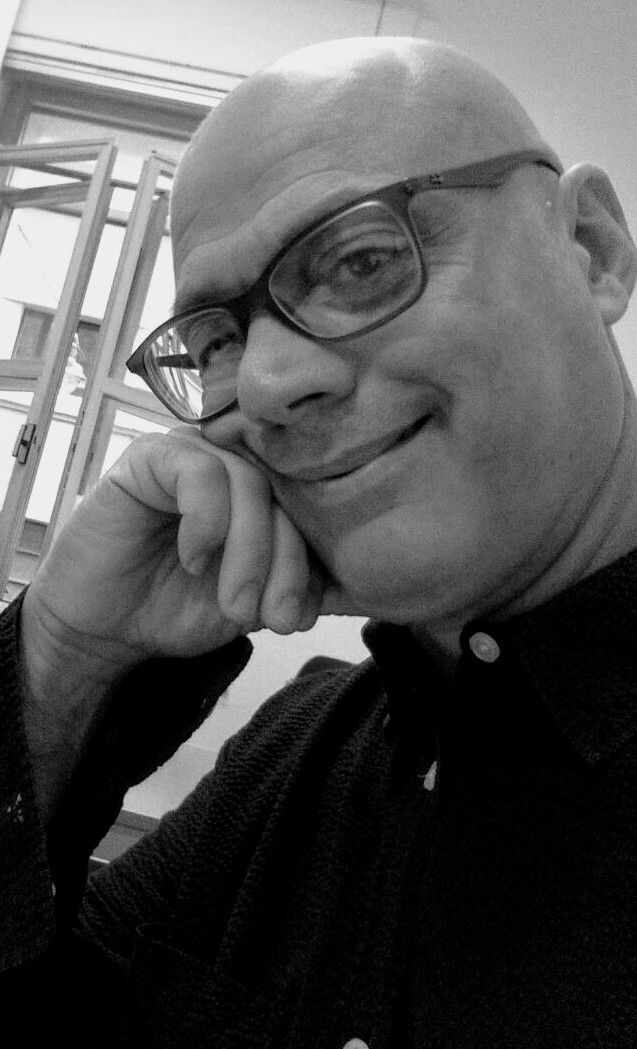
Invidio a Sagredo la sua profonda conoscenza del mondo slavo,al quale ho tentato di avvicinarmi, umilmente, molte volte,sempre con scarsi risultati; resta sempre qualcosa che sfugge alla mia conoscenza ,quasi un tabù,di cui non individuo la vera ragione,se non in una formazione culturale che oscilla tra Studio Fiorentino e Illuminismo,suggerita dall’insegnamento di Alessandro Ronconi e di Eugenio Garin,che mi hanno lasciato il segno.
"Mi piace""Mi piace"
Ho fatto una sorpresa ad Antonio Sagredo, ho inserito, a sua insaputa, in coda al suo articolo sull’Espressionismo ceco e i poeti cechi, anche 4 sue poesie inedite che egli aveva imbucato nello spazio Commenti nei giorni scorsi.
Su Antonio Sagredo ho scritto molte volte, ma questa volta ritengo di non dire nulla, queste poesie di per sé lo pongono come uno dei poeti più interessanti che io abbia letto negli ultimi 20 anni, e vi assicuro che ne ho letti a migliaia… volevo precisare: uno dei migliori poeti in ambito europeo…
"Mi piace""Mi piace"
ho condiviso sul mio profilo. Grazie .
"Mi piace""Mi piace"
Il tempo, categoria centrale della Nuova Ontologia Estetica:
"Mi piace""Mi piace"
Certo è che il signor Linguaglossa ha coraggio da vendere proclamando Antonio Sagredo “uno dei migliori poeti in ambito europeo…”.
Insomma rischia molto sulla sua reputazione futura come critico letterario. Ma devo dire che poi, tutto sommato, non si discosta molto da una “critica verità”, perché a ben vedere i versi “possenti” (G. B. Squarotti) di Sagredo sono come perle scaramazze di cui i poeti italiani sono privi assolutamente.
Invidia e gelosia accompagneranno (per) sempre la figura di questo straordinario poeta, che può contare soltanto sui suoi versi che all’occasione si muteranno in armi terribili contro la mediocrità che ci circonda e sempre ci circonderà.
Si mettano l’anima in pace i poeti più famosi… sono stati superati e distanziati, anzi non si vedono più, sono spariti, invano scriveranno altri versi – non nobili di certo – ma puramente ignobili.
a. c.
"Mi piace""Mi piace"
da Frantisek-Halas-Jiri-Orten-Vladimir-Holan ad Antonio Sagredo, la via espressionistica alla nuova ontologia estetica
Nelle tre poesie di Jiří Orten ho ritrovato una che non leggevo da tempo, una parola che davo per scomparsa: inconsapevole. E versi di saggezza come: “Sbagliare eternamente, fino ad essere puri.” Di Holan sappiamo, e gli è anche superiore perché riporta veri accadimenti, o come lo fossero stati. Di Antonio Sagredo, il quale giustamente s’aggrega nell’espressionismo, aspetto la sua uscita di scena: dell’IO, perché in successione lo si trova sempre; ma è così, dev’essergli necessario per la visione prospettica. Solo che dietro l’IO, non dico dentro e nemmeno oltre, che si trova? Vedo un muro disadorno, qualcuno appoggiato mentre guarda le stelle. Suoi personaggi e costumi, come le parole. Alla fine incanta per forza.
"Mi piace""Mi piace"
ANTONIO SAGREDO, UN POETA DELLA NUOVA ONTOLOGIA ESTETICA
Sagredo finalmente ci consegna un suo articolo, atteso da tempo. Dal pertugio aperto anni addietro sulla poesia russa, pertugio attraverso il quale la memoria di studi non accademici sguscia fino qui, ringrazio per l’approfondimento.
Per quel che riguarda le poesia “sagrediane”: sono battenti che il vento apre e chiude a volte con delicatezza, altre con quasi violenza; quella della natura verso una struttura chiusa, una separazione dal dentro al fuori e viceversa. In me trova sempre una lettrice appassionata, sopratutto in queste poesie che vedono un superarsi nei limiti (quelli che ogni poeta, artista, ha come pungolo a migliorarsi, a non chiudersi mai in se stesso).
"Mi piace""Mi piace"
DALLA DODECAFONIA ALLA NUOVA OGGETTIVITà E ALLA NUOVA ONTOLOGIA ESTETICA, LA VIA PIU LUNGA AL RINNOVAMENTO DELLA POESIA ITALIANA
Complimentandomi con Antonio Sagredo per il suo excursus letterario e artistico sull’Espressionismo, vorrei intervenire a proposito di Alban Berg, sul quale ho avuto il piacere di scrivere alcuni giorni fa, dopo la rappresentazione della “Lulu” al Teatro Costanzi.
Proprio riguardo a quest’opera, mi sento di poter affermare che non trovo in essa elementi di debolezza rispetto al “Wozzeck”, ma di continuità e sviluppo. Perciò, il fatto che Alban Berg, nel “Wozzeck”, riveli “insospettate possibilità insite nel procedimento atonale” (Mittner) è un dato logico e acquisito, che non toglie nulla alla scrittura della “Lulu”. Inoltre, va sottolineato che il “Wozzeck” non è dodecafonico (per ovvi motivi cronologici) e nemmeno del tutto atonale, poiché in esso appaiono intere scene tonali. Ma, in quei numerosi passaggi dove prevale la dissonanza, notiamo come Berg vi lavori in maniera talmente estrema, da toccare tutti i dodici suoni, sebbene non ancora ordinati secondo gli schemi dodecafonici, come poi, a partire dal 1921, verrà teorizzato dal maestro, Schönberg.
Il “Wozzeck” è tutto improntato sul contrasto tonalità-atonalità, consonanza-dissonanza (la stessa opposizione si realizza nell’impiego del timbro). Da questo contrasto fondamentale deriva all’opera, non solo la violenza espressionistica, ma un’intima coerenza, che va a ricomporre i due estremi del linguaggio.
Viceversa, “Lulu” è opera dodecafonica a tutti gli effetti (essendo Berg già approdato alla “musica nuova” nel 1926, con la “Suite lirica” per quartetto d’archi). E il soggetto, ancora più espressionistico che nel “Wozzeck”, è trattato con molte analogie rispetto al precedente lavoro. Invece, come già detto, l’originalità assoluta di “Lulu” è nell’impiego della tecnica dodecafonica, il cui merito principale è quello di negare alla musica il ruolo illustrativo del testo. Ma, a mio modesto parere, ciò che fa di “Lulu” un capolavoro assoluto, oltre alla scelta del soggetto e al suo significato intrinseco, è la grande libertà della scrittura: dal rigore estremo della dissonanza, al più banale impiego della tonalità, con citazioni di canzonette, riferimenti al “cabaret” e altro ancora.
In definitiva, nonostante la dodecafonia, Berg rimase un musicista autonomo, con una propria delineata personalità, accogliendo la nuova prospettiva compositiva solo come arricchimento del proprio linguaggio espressivo. Difatti, in seguito, poco o niente gli sarebbero interessate le polemiche sulla dodecafonia (che pure imperversavano negli anni precedenti alla seconda guerra mondiale)… La dodecafonia resta estrema conseguenza di quell’espressionismo spiritualista, che aveva necessariamente rivoluzionato l’arte (tedesca) nei primi decenni del Novecento (una sorta di “nuova ontologia estetica”), e che, in breve, proprio a seguito di tante polemiche, avrebbe incontrato il suo grande oppositore: la Nuova Oggettività… (ma questa è un’altra storia)…
"Mi piace""Mi piace"
"Mi piace""Mi piace"
Interessante, ben organizzata questa breve esegesi di Sagredo sulla poesia ceca dell’espressionismo. Un’altra dimensione da quella poetica che conosciamo bene, Una dimostrazione dell’accurato suo accostamento alla cultura slavofona. Da parte mia intuisco certi valori nel suddetto tracciato poetico, capisco che possa persino entusiasmare molti lettori, ma io rimango totalmente infreddolito dalla visitazione di codesti versi, che non arrivano a toccarmi nel profondo. Ma certamente è una mia mancanza.Per quanto riguarda le poesie di Sagredo qui presentate, pur conoscendo profondamente e ammirando i testi dell’autore, ne ho persino parlato pubblicamente, faccio fatica a decifrarli, dovrò tornarci sopra, senza farmi vincere dal primo sospetto, fallace, di incomprensibilità, che spesso produce la sua poesia. A prima vista mi appaiono meno sanguigni e barocchi, e violenti di altre composizioni. Ma non ci giurerei. Comunque se Linguaglossa lo benedice come uno dei maggiori poeti europei bisogna credergli.
"Mi piace""Mi piace"
Ringrazio Donatella Costantina Giancaspero per gli approfondimenti “espressionistici”: se ne potrebbe parlare a iosa, ma col pericolo mio di capirci poco non essendo musicista (maledizione a me!), pur capace di comprendere le musiche delle parole con le loro ombre e luci. Ma è strano come non capendo io nulla di note senti la musica, cioè una musica che mi viene chi sa di dove e non so dove se ne va lasciandomi più volte interdetto. Ma quale musica? Io non so definirla affatto! : essa potrebbe comprendere tutte le musiche o non comprendere nemmeno una.
In alcuni versi del passato scrissi questi versi, dicendo di cose strane che giungevano alle mie orecchia.
———————————————————
Quando nella notte il silenzio è assoluto
cosa sono questi segnali nell’orecchio?
Sono forse in contatto con un mondo perduto
o è la materia che scricchiola nel mio cervello?
Duemila anni di grida…
ma negli spazi a che serve gridare?
Deve cessare d’esistere l’umano terrore!
Al mattino si scuote la notte
dell’orrida materia,
come illustre e antico ritornello.
L’inno alla vita si squama,
come pagliuzze nelle torbide acque.
a.s.
Roma, 7 settembre 1970
"Mi piace""Mi piace"
Sono felicissimo di questa carrellata offertaci da Giorgio su tre poeti ed un periodo della storia letteraria e della storia tout-court cui sono molto legato per aver avuto modo di approfondirli nella traiettoria dei miei interessi culturali legati all’est europeo come Halas, Orten ed Holan; personalmente ho una particolare predilezione per Orten per la vividezza che risalta dalle immagini che contrassegnano le sue composizioni, le stesse che ritrovo in ambito prosastico un altro grande suo contemporaneo, conterraneo e co-esponente della stessa corrente, come Vladislav Vancura. Si tratta ad ogni modo di valutazioni prettamente soggettive e relative, poiché si tratta comunque di figure tutte di altissimo ed assoluto valore poetico e che soprattutto evidenziano ancora una volta gli straordinari punti di contatto tra la tensione rivolta alla destrutturazione della costruzione poetica tradizionale (in particolare per ciò che concerne la rappresentazione dell’Io rispetto nella realtà circostante) che accompagnarono le avanguardie (utilizzo il termine in questo contesto in senso puramente aggettivale) dell’epoca ed un percorso palingenetico nei confronti dei canoni espressivi della poesia, come quello intrapreso e condotto dalla Noe. Per ciò che riguarda le poesie di Sagredo qui presentate, emerge ancora una volta la sua grandezza come poeta totalmente a sua volta “de-strutturante” rispetto alle comode certezze di cui si è nutrita la poesia italiana di questi ultimi cinquant’anni, con la sua poetica icasticamente ricca, ma indiscutibilmente dura, corrosiva nella nudità dei concetti e dei contenuti propostici e che trovo essere assolutamente assonante (pur forse con un ulteriore maggior asperità di linguaggio) con la i testi dei tre autori cechi presentati. Mi congratulo tra l’altro con il mio conterraneo Sagredo per la sua notevole conoscenza della poesia di area slava e mitteleuropea
"Mi piace""Mi piace"
Un tratto accomuna questi testi: la parola non si ferma alla superficie degli oggetti, ma ne scavalca l’inconsistenza di simulacri per estrarne la forza di rivelazione che essi spalancano. Un paesaggio contiene un enigma da sviscerare, un mito concentrato che dischiude una parabola sull’uomo e sul suo drammatico rapporto con l’esistente; una landa che la nevicata incessante seppellisce, e intanto una presenza umana, minuscola e tenace, che si ostina a continuare a dipingere, senza ragionare sull’utilità o sugli esiti della sua operazione, opponendo la vitalità dei colori a un universo condannato a essere progressivamente inghiottito dal bianco: io ci vedo lo sforzo tragico del poeta che afferma la propria volontà di resistenza anche mentre tutto il resto scivola verso la sparizione. Quell’inverno vittorioso è emblema dello svuotamento di senso del mondo, che il linguaggio poetico riscatta semplicemente testimoniandolo. E quanto più il mondo si fa povero di senso, tanto più la parola, caricando di senso tutto ciò che nomina, sembra farsi baluardo dell’umano tentativo di non soccombere al nichilismo, della nostra impresa di non lasciarci risucchiare dal buio crescente che divora i cieli e così i nostri occhi;
"Mi piace""Mi piace"
poi credo che molti lettori italiani potrebbero confondere per mancanza di rigore l’esuberanza tellurica, la furia ctonia che sconvolge le immagini e le mulina alla velocità dei venti degli uragani di Giove; ma forse una tale eccedenza formale è inevitabile, quando si prova a strappare alla terra e alle piante il palpito che risuona anche nello scorrere delle vene, per cui gli aggettivi a cascata e l’efflorescenza di attributi che rimpolpano la rappresentazione naturale sono stilisticamente giustificabili, perché servono a promuovere il dato sensibile su un orizzonte visionario (teste decapitate che rotolano, sole che assume una maestà di imperatore negro o che affonda tra le nubi come un relitto che naufraga), a farci percepire il sentore di elettricità vivente che irrora ogni particella del mondo abbracciata dalla prensile ragnatela del linguaggio
"Mi piace""Mi piace"