
Stefanie Golisch, scrittrice e traduttrice è nata nel 1961 in Germania e vive dal 1988 in Italia. Ultime pubblicazioni in Italia: Luoghi incerti, 2010. Terrence Des Pres: Il sopravvivente. Anatomia della vita nei campi di morte. A cura di Adelmina Albini e Stefanie Golisch, 2013. Ferite. Storie di Berlino, 2014.
Commento impolitico di Giorgio Linguaglossa
Origine (Ursprung) e spaesatezza (Heimatlosigkeit) si danno la mano amichevolmente. Se manca l’Origine, c’è la spaesatezza. E siamo tutti deiettati nel mondo senza più una patria (Heimat). Ed ecco l’Estraneo che si avvicina. E all’approssimarsi dell’Estraneo (Unheimlich) le nottole del tramonto singhiozzano.
L’espressione è il volto codificato del dolore.
Ad un lettore italiano la poesia di Stefanie Golisch suona come un oboe sommerso, con un tono cupo, monocorde, attutito. Del resto, i titoli di queste poesie e della raccolta inedita sono esplicativi: Summerguests (Ospiti d’estate) e Fly and fall (Volo e caduta), sono eloquenti. Si tratta della tematica dell’estraneo e della tematica del volo e della successiva caduta. Tematiche ad un tempo della metafisica e della vita quotidiana, tanto per smentire le tesi di coloro i quali intendono la metafisica come cosa diversa e a parte dalla vita quotidiana. E invece per Stefanie Golisch è il medesimo tema che ritorna in tutte le sue poesie, come anche nella sua narrativa fatta di brevi prose fulminanti, prose legate ai luoghi e alla loro storia. Ma da come viene posizionato il verso italiano, dalle atmosfere plumbee, dagli improvvisi incisi e dai susseguenti strappi, si capisce subito che abbiamo a che fare con un poeta di madrelingua allotria. Ed è un arricchimento questo per la lingua poetica italiana di insospettabile valore. Il fatto è che il linguaggio poetico italiano ne viene come strattonato, reso plumbeo, ammaestrato alla scuola dell’espressionismo tedesco; e ne sortisce fuori come fortificato, solidificato, preciso, tagliente. Un solo esempio: «Corvi che gridano al cielo vuoto l’insensatezza del rimorso», verso che sembrerebbe uscito dalla penna di un autore che sta tra Georg Trakl e Gottfried Benn. Certo, in Italia non abbiamo avuto un equivalente del movimento poetico dell’espressionismo tedesco, e questa lacuna stilistica non è stata indolore; la poesia italiana del Novecento è stata così costretta dentro la asfittica forbice: lirica – antilirica, con il prosieguo di post-lirica e di anti-lirica di marca tardo novecentesca e sperimentale, con tutta una serie di equivoci che si sono moltiplicati a dismisura. Da noi i pochissimi poeti a tendenza espressionista non hanno goduto il favore della critica. Tipico è il caso dei Canti orfici (1914) di Dino Campana, opera etichettata da Pier Vincenzo Mengaldo sotto l’egida dell’inno, da porre come contraltare all’elegia di Montale. Ma le questioni non sono così semplici e non si possono ridurre a formule antogonistiche e, dunque, riduttive. Ma ecco qui che viene la Stefanie Golisch ad immettere linfa espressionistica nel nostro armamentario stilistico e nel lessico poetico italiano. Ed è un dono di non poco significato.
Quello che colpisce nelle poesie della Golisch è la sua capacità di inserire la molteplicità del mondo nella struttura monologante della sua lirica, cosa non facile né scontata, non si giunge a questo grado di rappresentazione senza una profonda meditazione su ciò che è la «cosa» chiamata poesia e su ciò che essa deve contenere; e soprattutto, la poesia qui non è un mero contenitore di «cose» ma una «cornice» dove ci sta di tutto: l’infanzia, la vita erotica, le passioni, la conoscenza, l’oblio, la percezione del limite, il mistero che dà alla poesia un significato omogeneo e unitario. Il significato di una poesia è sempre fuori di essa, mai dentro, come credono gli ermeneuti ingenui, la poesia non si risolve in un amalgama di significanti e di significati, come purtroppo una vulgata durata decenni ci ha voluto dare ad intendere. La poesia è, al pari del romanzo, molteplicità, totalità finita che allude all’infinito delle possibilità inespresse.
Quello che colpisce in queste poesie è l’impiego sapiente delle immagini, certe poesie sono costruite con i mattoni delle immagini alternate:
.
Il matto, lo chiamano lupo mannaro.
Corvi che gridano al cielo vuoto l’insensatezza del rimorso.
La copia della copia del santo bevitore.
Uomo in canottiera gialla alla finestra della cucina, fumando.
La vecchia che attende il suo giorno, ripetendo tra sé e sé
una storia della sua vita…
.
Le immagini chiudono e aprono, sono una serratura che permette al lettore di entrare all’interno della poesia. E il lettore entra come un ladro che ruba le sensazioni, gli attimi di cui sono fatte le parole. Il lettore diventa un ladro di parole. Come del resto lo è anche l’autore: un ladro di parole. Nei suoi momenti di punta l’espressionismo della Golisch ci apre delle porte verso l’aldilà, un luogo ultroneo, verso il mistero dell’esistenza di questo ente chiamato uomo.
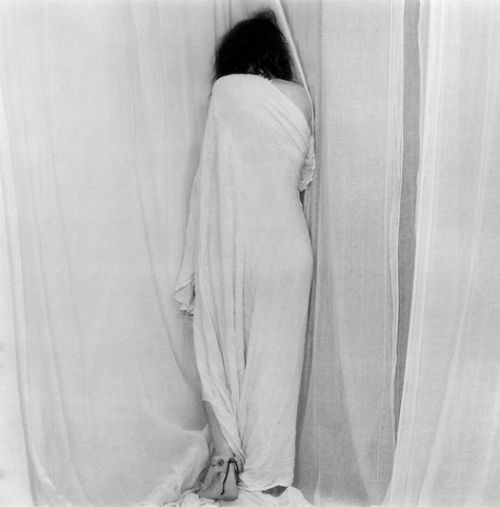 Summerguests
Summerguests
Una donna con la barba bianca, gonna a grandi fiori
impressionisti, mi ferma per strada. Chiede del pane,
ma non ha fame. Dice che non è di qui e con un cenno
di mano appena, si congeda da me casuale. Passeggia
lungo questa giornata d’estate lenta e senza scopo
preciso come una nuvola indecisa, una etimologia poco
chiara, un amore moribondo per colpa di nessuno
*
Dice che non riesce più a baciarla dopo averla intravista
per sbaglio in camicia da notte a fiorellini azzurri, una
vecchia che pure un tempo è stata la sua amante
d’occasione. Lei chiude gli occhi mentre lui serra le
labbra. Ecco, il bacio più goffo del mondo, sbrigato
in un rifugio di montagna, raggiunto faticosamente in
una domenica di giugno generoso
*
Lo vede il cane dalla finestra della cucina, il ragazzo che
passeggia per le vie del centro deserto in una camicia da
vecchio, collo chiuso, cappello contro il sole sul capo. Un
giorno sì, uno no, con un cono di gelato alla crema, sempre
guardando avanti diritto come se avesse in mente una meta
precisa. Appare alle tre del pomeriggio e si dissolve verso
le cinque in una nuvola di magliette colorate e hot pants.
L’estate è ugualmente per e contro tutti

Stefanie Golisch
Stefanie Golisch Fly and fall – Inedito
Poesie tratte dalla raccolta inedita Fly and fall
.
Un io e la sua bestia
.
Copri con il tuo grigio pelo
il pallore della mia pelle,
il mio tremolante desiderio.
Dentro le mie calde viscere
sento il tuo ansimare secolare
mischiarsi alla mia linfa.
I tuoi morsi mi risvegliano reale,
custode del mio segreto animale.
Nel nostro silenzio
gorgoglia vita indistinta
Proteggi questo troppo lieve io
dalla tristezza degli uomini
.
Corpo di madre sulla terra
.
When will we three meet again?
In thunder, lightning or in rain?
When the hurlyburly’s done,
When the battle’s lost and won.
(Shakespeare, Macbeth)
Stesa sull’asfalto,
avvolta nella mia pelle pallida,
il corpo di mia madre
è una ferita
Sulla breve via verso il freddo,
la sua carne avara
prega la mia,
calda per coprire la nostra sconfitta
La battaglia è finita.
Tra cavalli e guerrieri morti
con bocche spalancate,
ti canto, madre, la ninnananna
alla rovescia
.
Kartoffelfeuer
.
Nella quiete di primo autunno,
un improvviso grido di corvo,
il profumo di mele mature
e di involtini primavera dal ristorante cinese
al pian terreno
C’è in questa natura morta
una ansia di risposte a fine estate,
un cupo giorno di settembre
in cui la mia infanzia bruciò
in un Kartoffelfeuer.
Dopo quel giorno, non c’era più
Nello specchio una ragazza sorride seducente
al mondo appena nato, come per dire,
eccomi,
prendimi,
sono tua
.
* Il Kartoffelfeuer è il fuoco con il quale, nelle campagne, i contadini bruciano le piante di
patate dopo il raccolto.
.
La mia inviolabilità
.
Luz è il nome dell’osso
dalla cui improbabilità risorgerò
dopo che la grande onda mi avrà trascinato via,
mia madre mi avrà chiamato a casa
Non dimenticare
la mia gobba antica,
non dimenticare
il vuoto nell’ora degli uccelli morti,
quando le domande,
una a una, svaniscono
senza risposta,
Raccogli quell’io pietra
nel mistero della sua
imperfezione
*Nella religione ebraica luz è il nome di un osso minuscolo che non può essere distrutto e dal quale, alla fine dei tempi, l’uomo sarà ricreato.

Quando una vecchia suora si prepara per la notte
.
Quando una vecchia suora si prepara per la notte, innanzitutto si toglie
le pesanti scarpe marroni,
poi il velo, chiuso dietro la nuca con una striscia di velcro.
Aprendo la lunga cerniera sulla schiena, lascia cadere la tonaca
a terra.
Nella sua veste ingiallita sta davanti a nessuno specchio.
Invece della propria immagine, le sorride seducente
un giovane uomo dai lunghi riccioli biondi che dice:
non aver paura, sei o non sei la mia sposa diletta?
Fiduciosa, sfila i collant color pelle,
il reggiseno color pelle e le mutande color pelle.
Nella luce diffusa di una fredda notte d’autunno,
eccola, nuda davanti al suo Signore.
Tremando, indossa una camicia da notte rosa,
e si fa scivolare sotto le coperte.
Persa come una goccia di pioggia in un cielo senza nuvole,
fa sparire le dita stanche
nell’antro sacro tra le gambe,
dove si nasconde la vita
umida, oscura, muta
.
Il motel più economico
.
Questa è la stanza dei vecchi amanti,
così disperatamente devoti all’idea dell’amore
che potrebbero uccidere,
diciamo un cane,
se questo fosse il prezzo da pagare
per una prima volta nuova di zecca.
Ma non c’è alcun cane intorno,
soltanto due paia di scarpe consunte
sotto un unico letto
per tutti gli amanti.
Venite, uccidetemi, direbbe
il cane, se ci fosse un cane,
ma, ahimè, non c’è.
Tutto qui: non c’è
.
Fly and Fall
.
Piano il giorno apre gli occhi
per salutare la mattina di fine agosto.
Ecco ciò che sta per accadere oggi:
Un uomo troverà l’amore e un altro lo perderà.
Qualcuno arriverà alla stazione giusto in tempo,
mentre un altro attenderà invano.
Un merlo sussurra nell’orecchio di un altro, che bello volare e cadere.
Qualcuno inaugurerà il giorno con una bottiglia di birra,
e un altro ascolterà a lungo l’eco dei sogni complessi.
Qualcuno scriverà una lettera scarlatta,
mentre nel cuore ferito del suo vicino non è rimasta una sola parola.
Una bambina si sveglierà dai suoi sogni notturni
stringendo il suo orsacchiotto, e una donna si sveglierà
soltanto per morire a metà mattina poiché il giorno
richiede tutto questo. Lottando scivolerà via davanti agli occhi
dei vivi nello stesso momento in cui
un pittore finalmente trova il suo blu.
Oggi sarà il mio giorno pensa il giovane,
mentre si allena, impaziente di gettarsi nella mischia.
Nella cantina di una casa abbandonata,
una gatta tigre gioca con un topo soltanto
per intrattenere la piccola cosa
Quel che il pittore non sa
è che quel blu non esiste,
ma soltanto una voce lontana,
quasi non udibile nel brusio di tutto questo fare all’amore,
morire, chiacchierare con gli amici, mangiare, bere,
spaventarsi e gioire,
impaziente di placare l’insaziabile
oggi
.
La vita è tutto questo
.
You are marvellous. The gods want to delight in you.
Charles Bukowski
.
Il matto, lo chiamano lupo mannaro.
Corvi che gridano al cielo vuoto l’insensatezza del rimorso.
La copia della copia del santo bevitore.
Uomo in canottiera gialla alla finestra della cucina, fumando.
La vecchia che attende il suo giorno, ripetendo tra sé e sé
una storia della sua vita.
La ragazza finta bionda con i jeans economici,
la maglietta economica e i suoi sogni inimmaginabili.
La coppia di nani al loro primo bacio, ansiosi
di fare bella figura.
Sole di Novembre, tempo di resa,
tempo di rinascita, perdono e oblio.
Un verso di Hölderlin che recita:
più l’uomo è felice, più alto è il rischio che si rovini.
Il mistero di ogni nuovo giorno
e i sette significati nascosti di una antica fiaba.
Oscure selve germaniche e luminosa bellezza mediterranea.
La speranza che una calza rotta può essere rammendata,
che le ferite possono guarire,
e che la nostra voce può migliorare con il tempo,
perdendosi
in tutte le voci
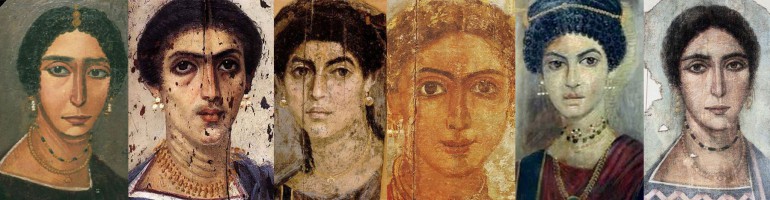
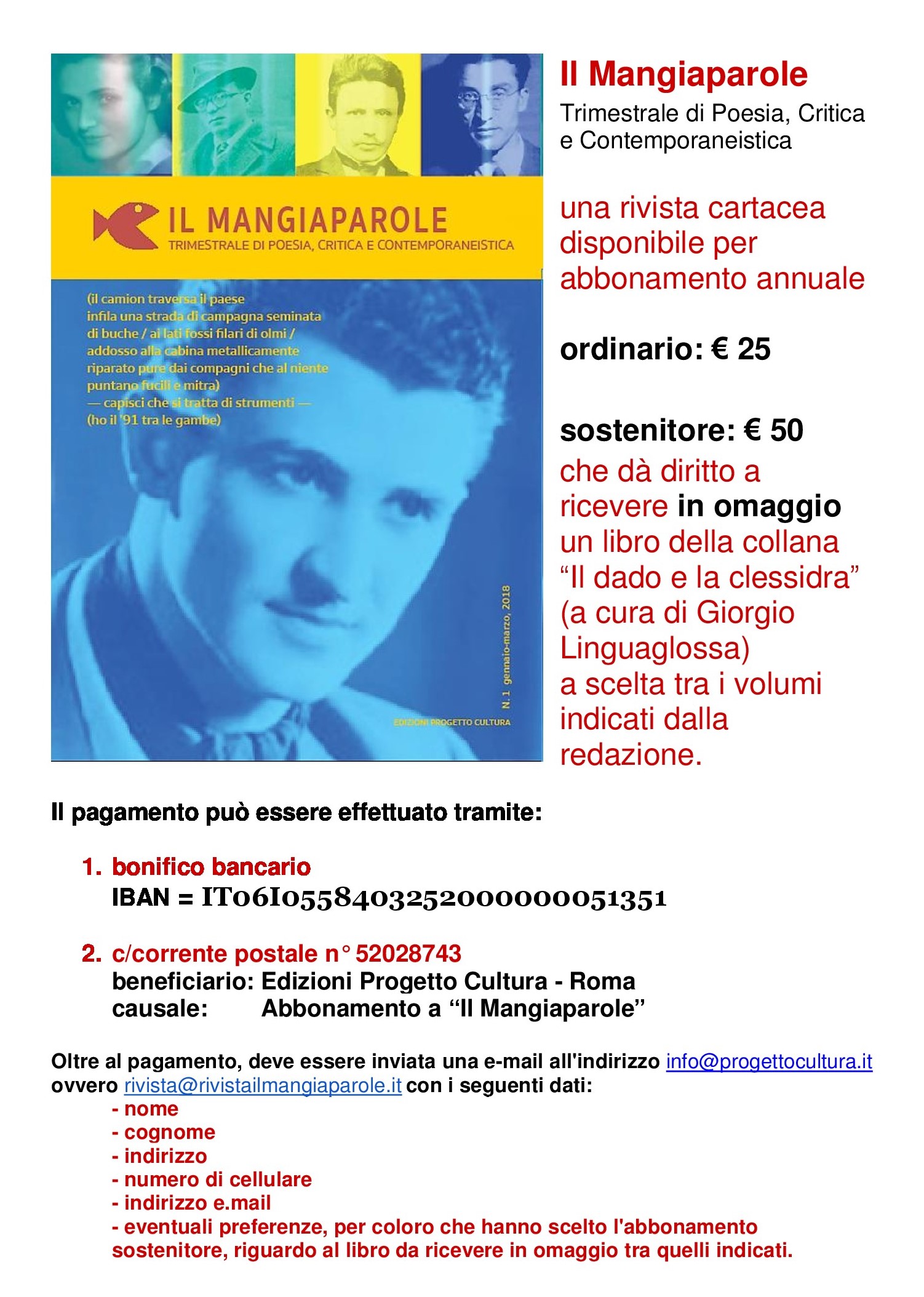
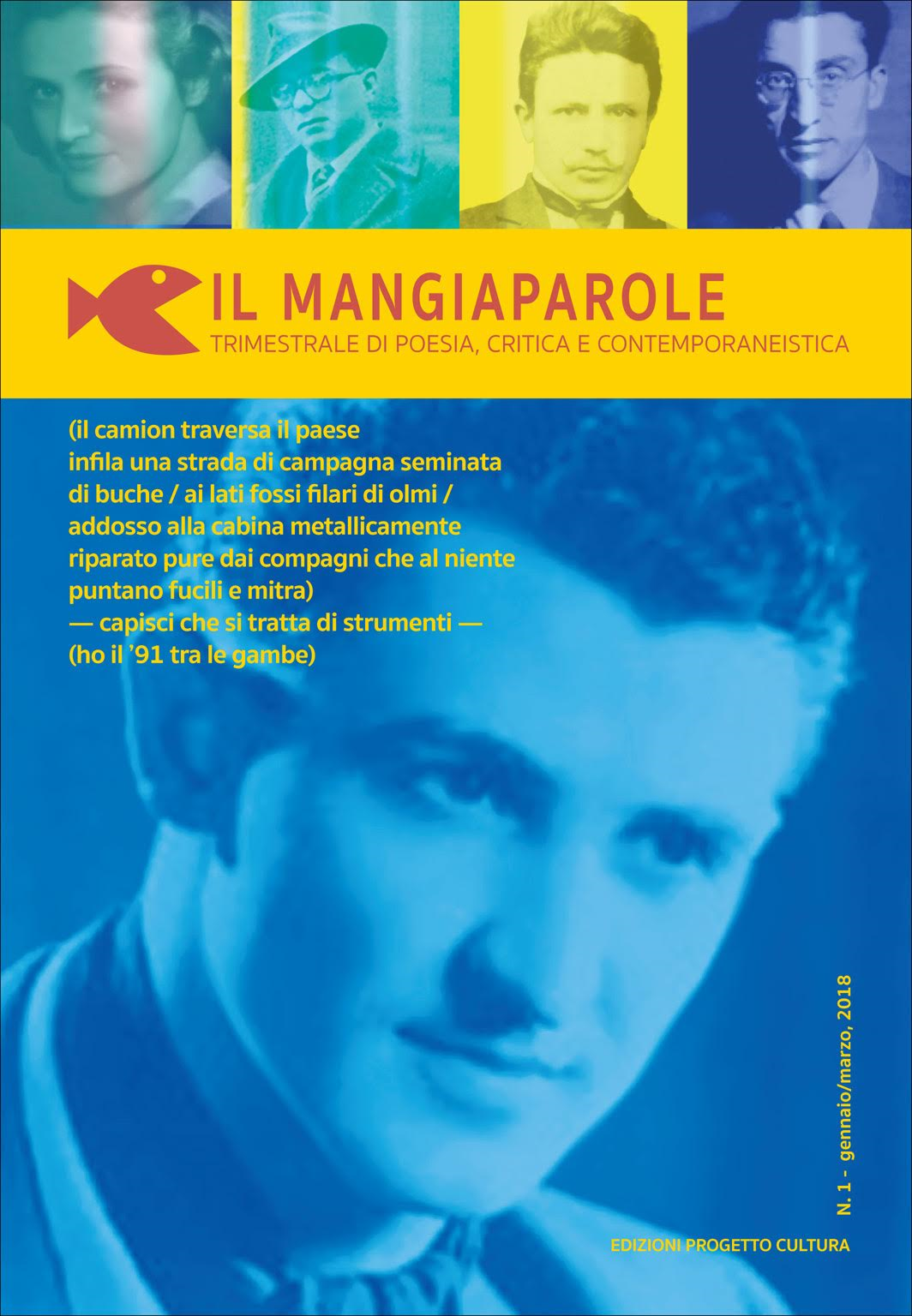

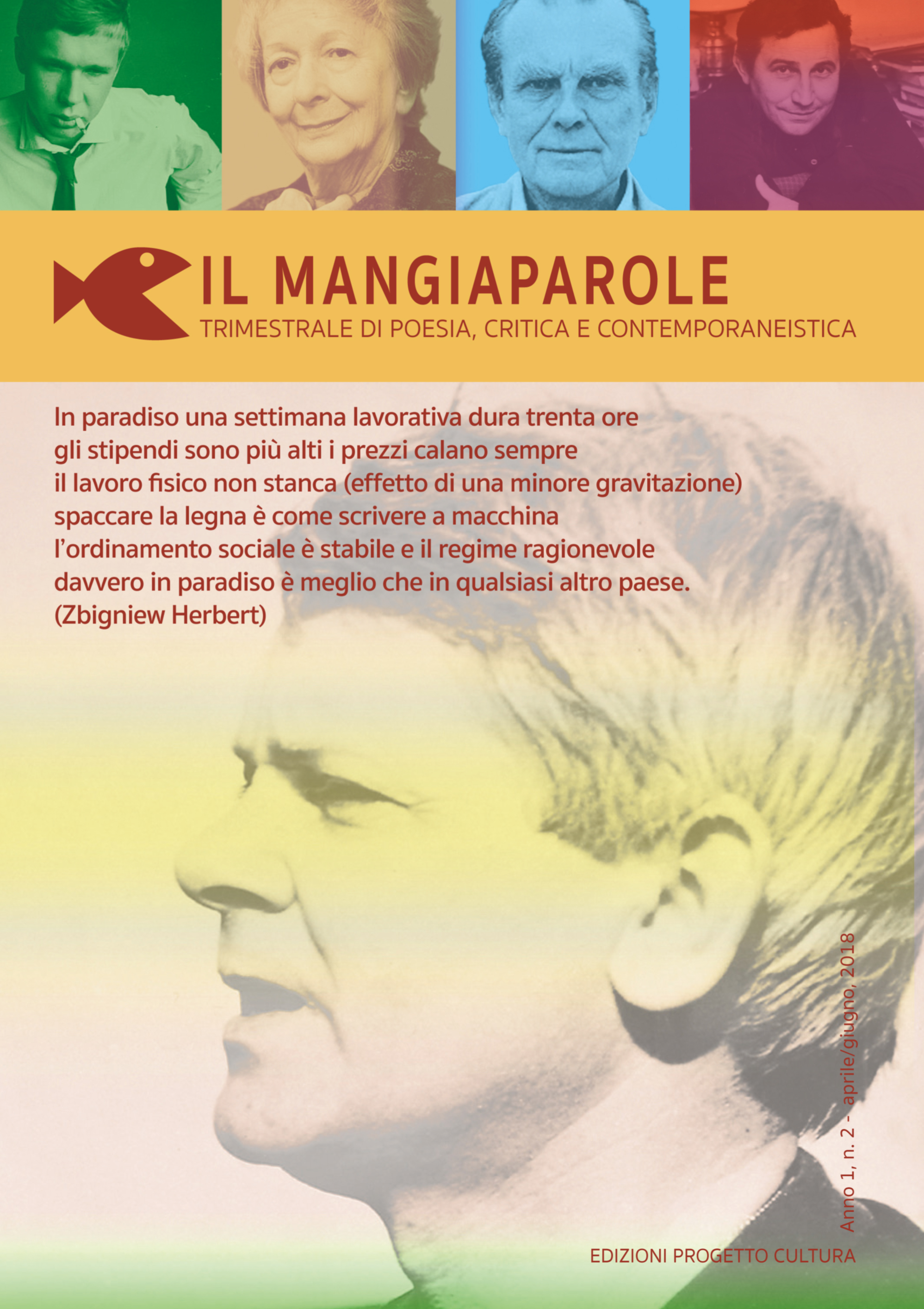



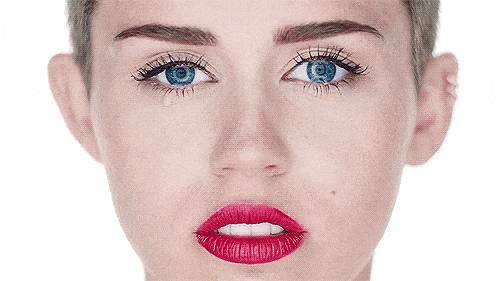
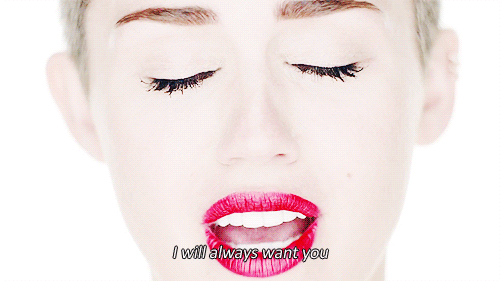
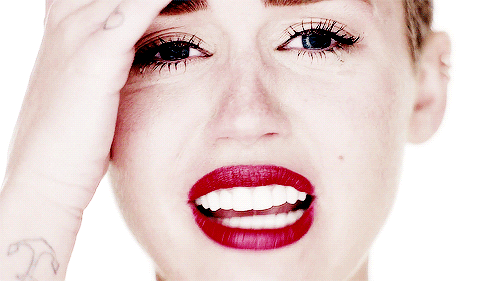
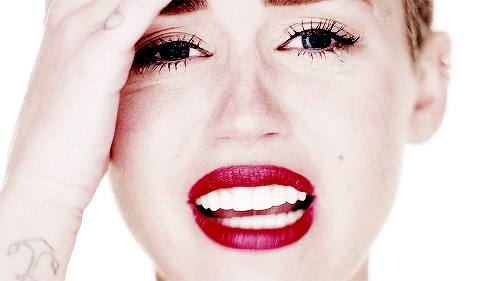
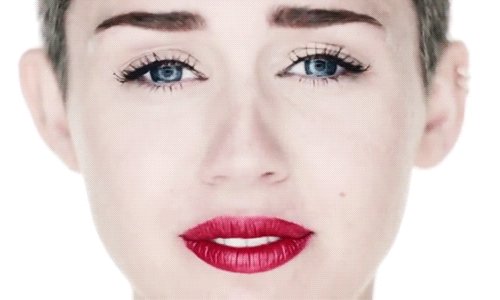



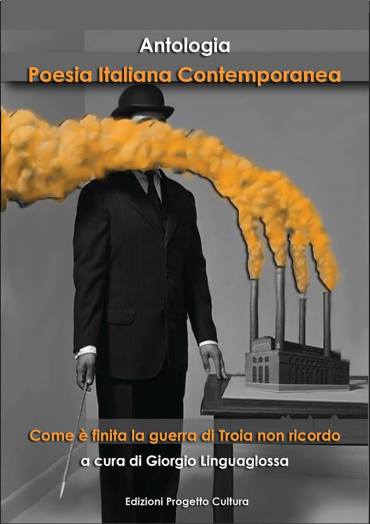




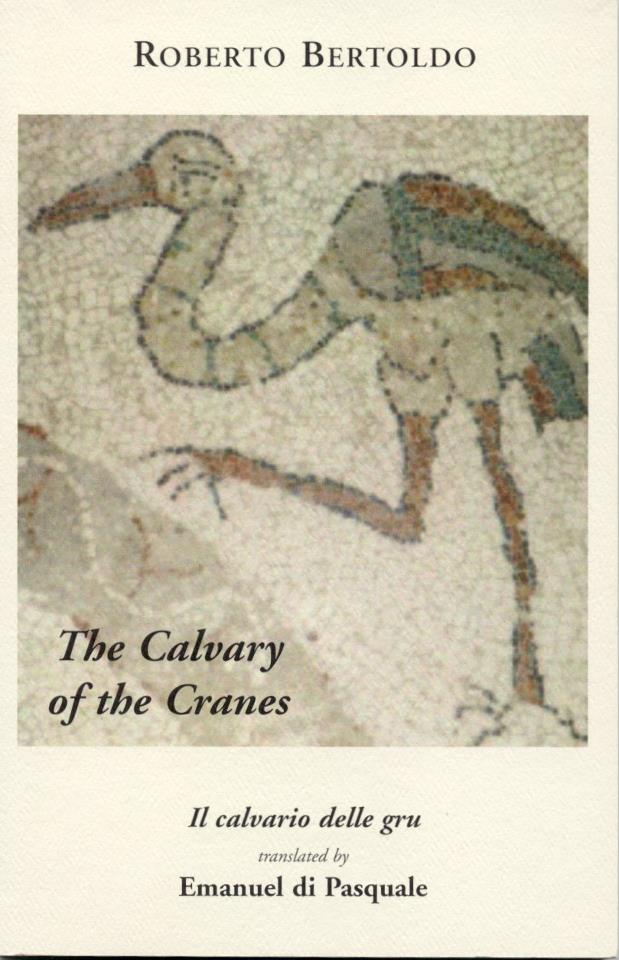
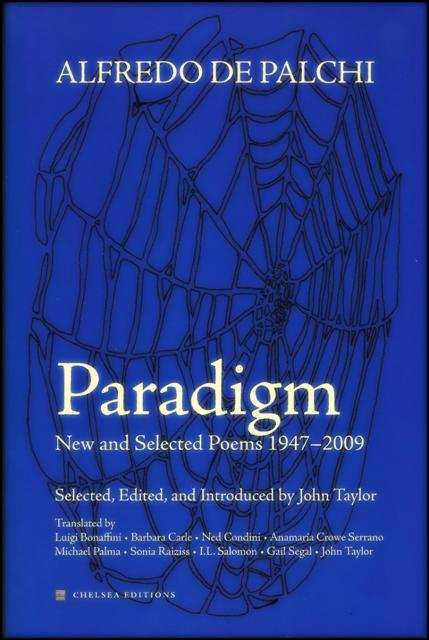


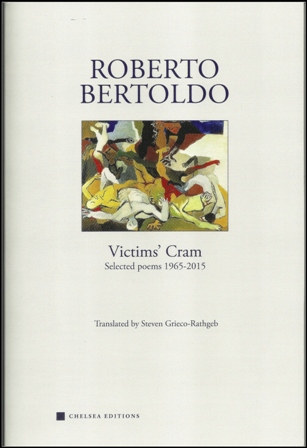





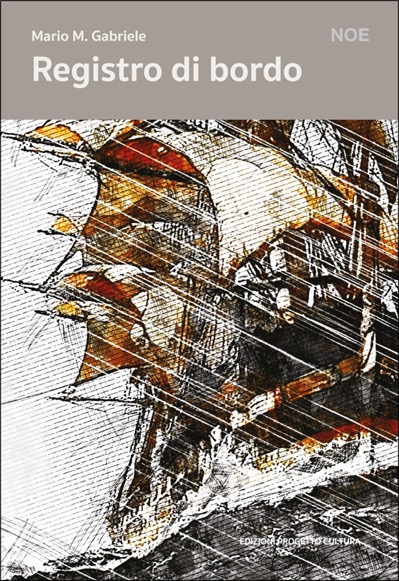

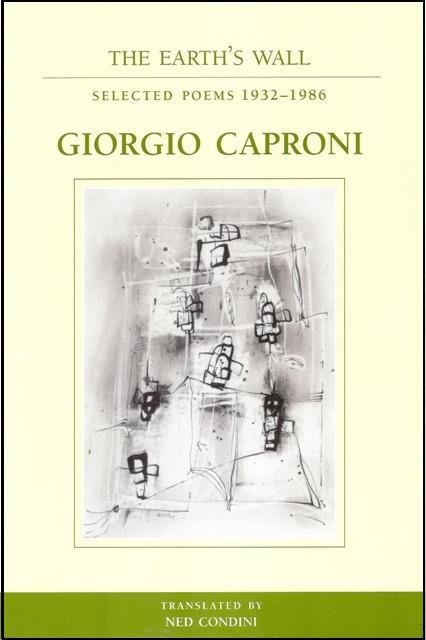
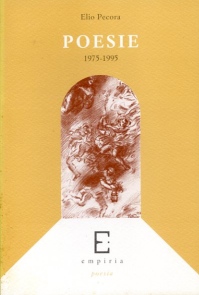

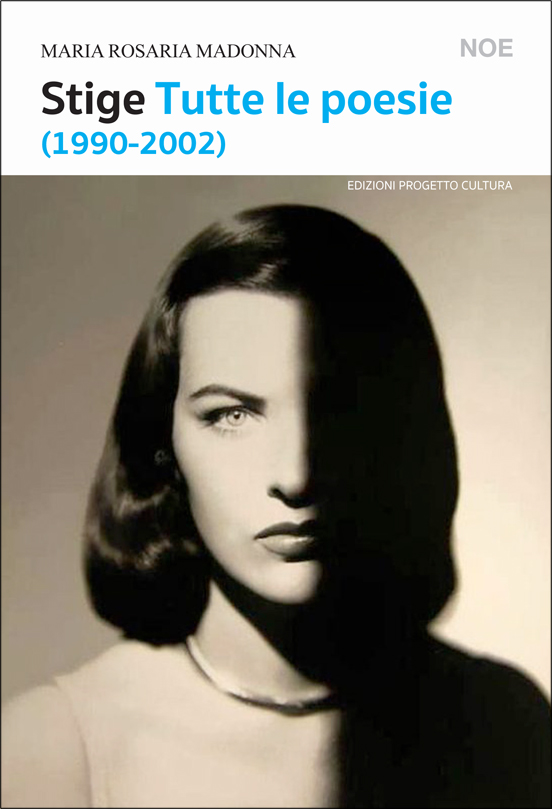

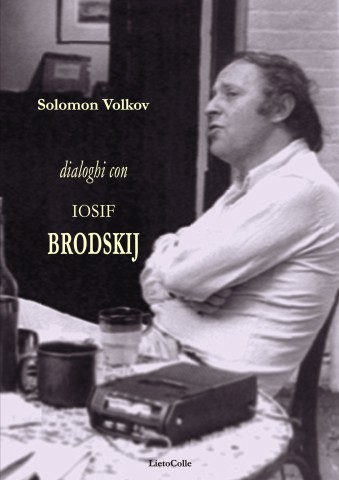




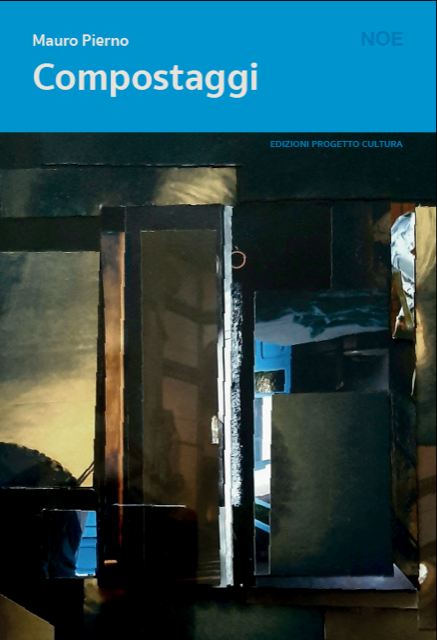
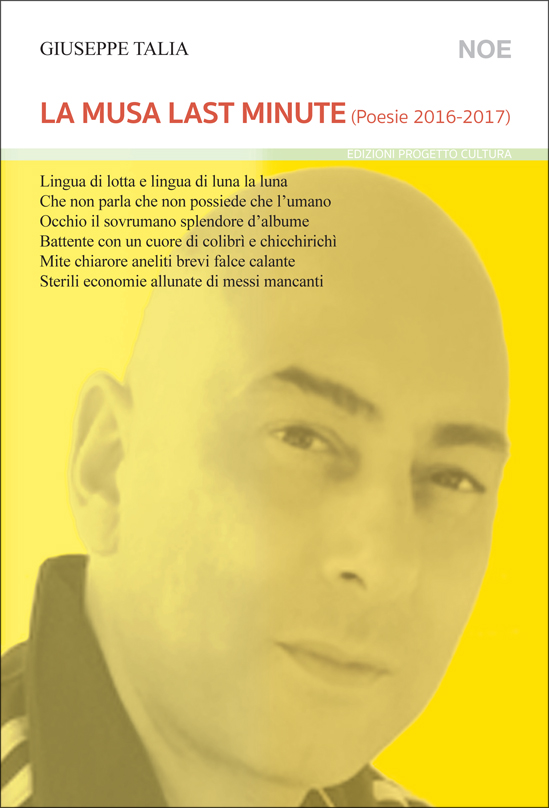


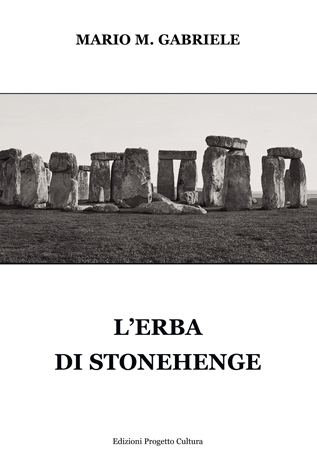
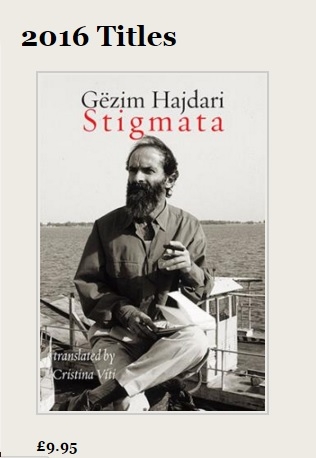
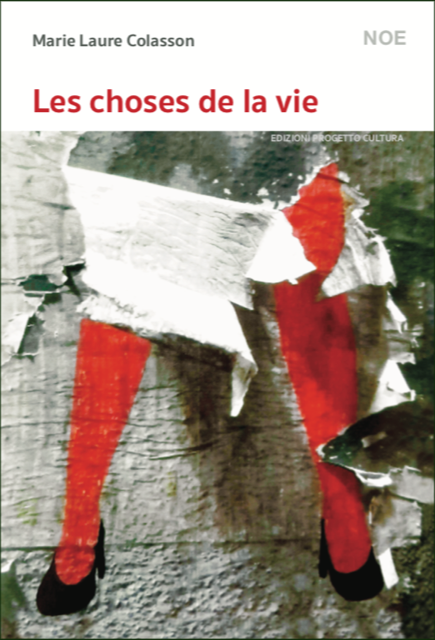




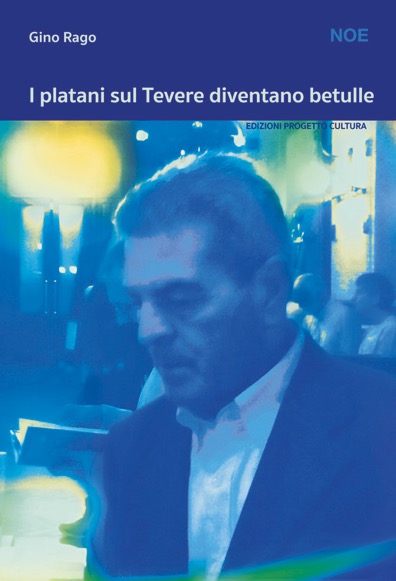
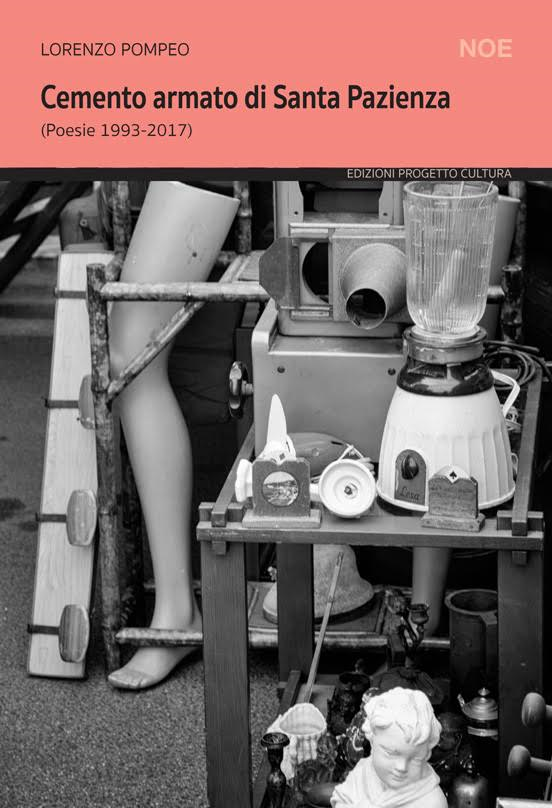
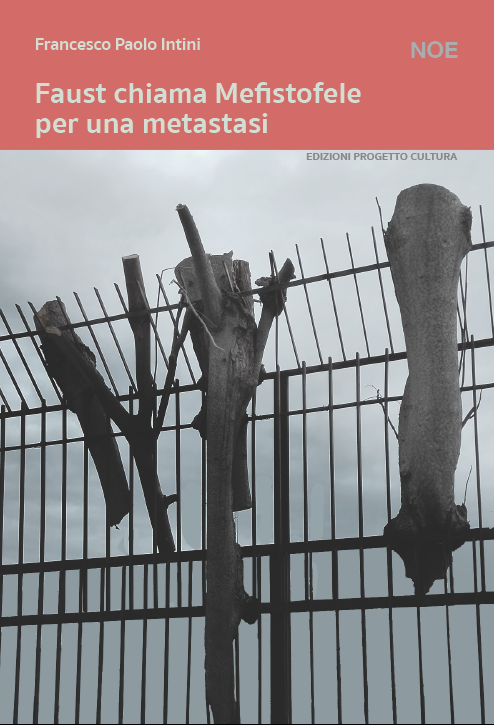

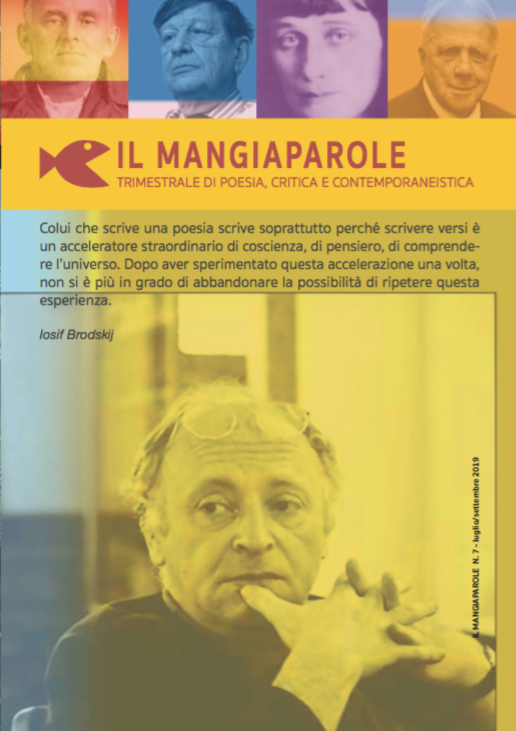




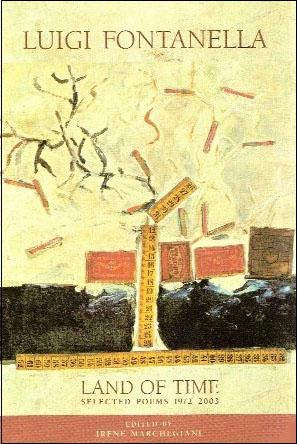








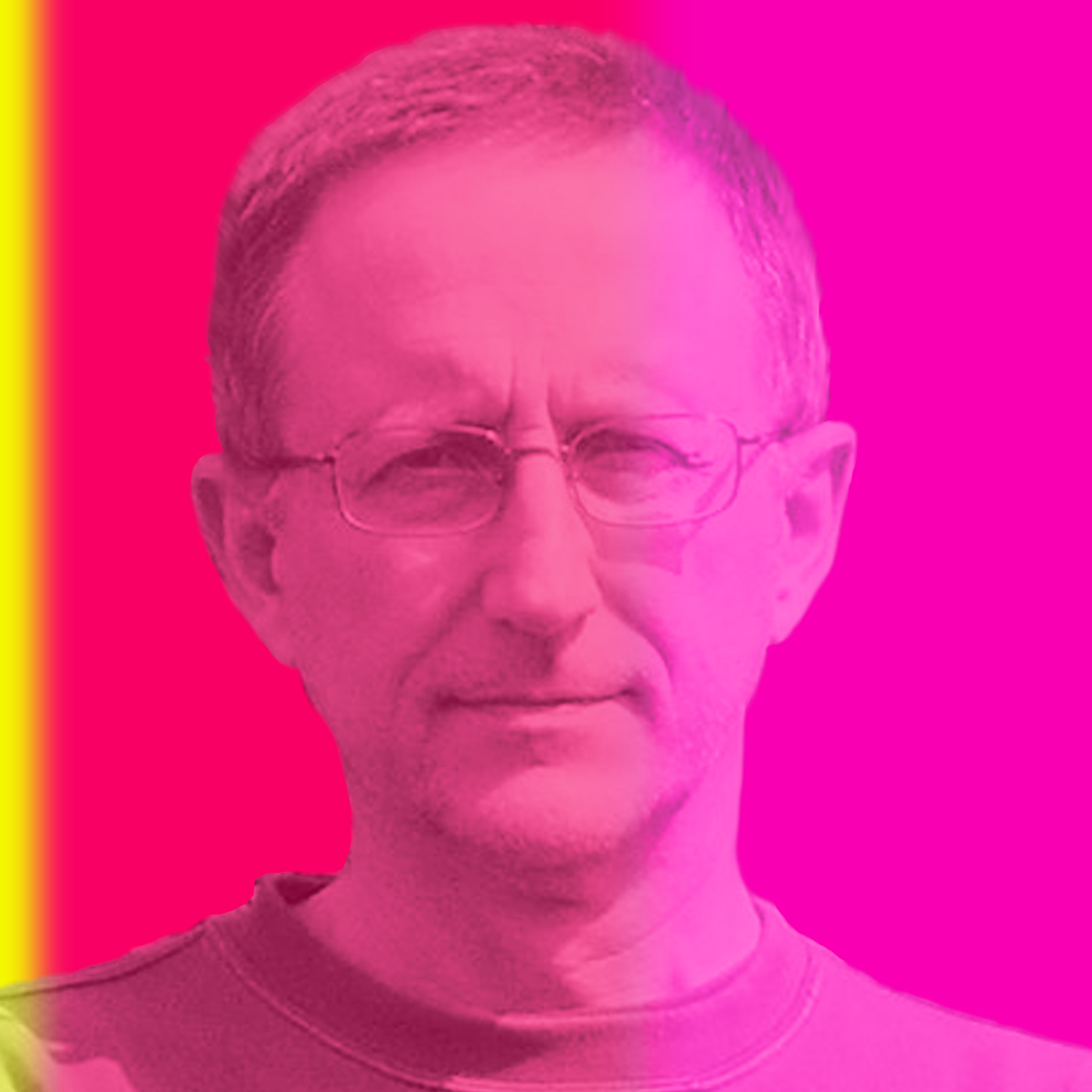







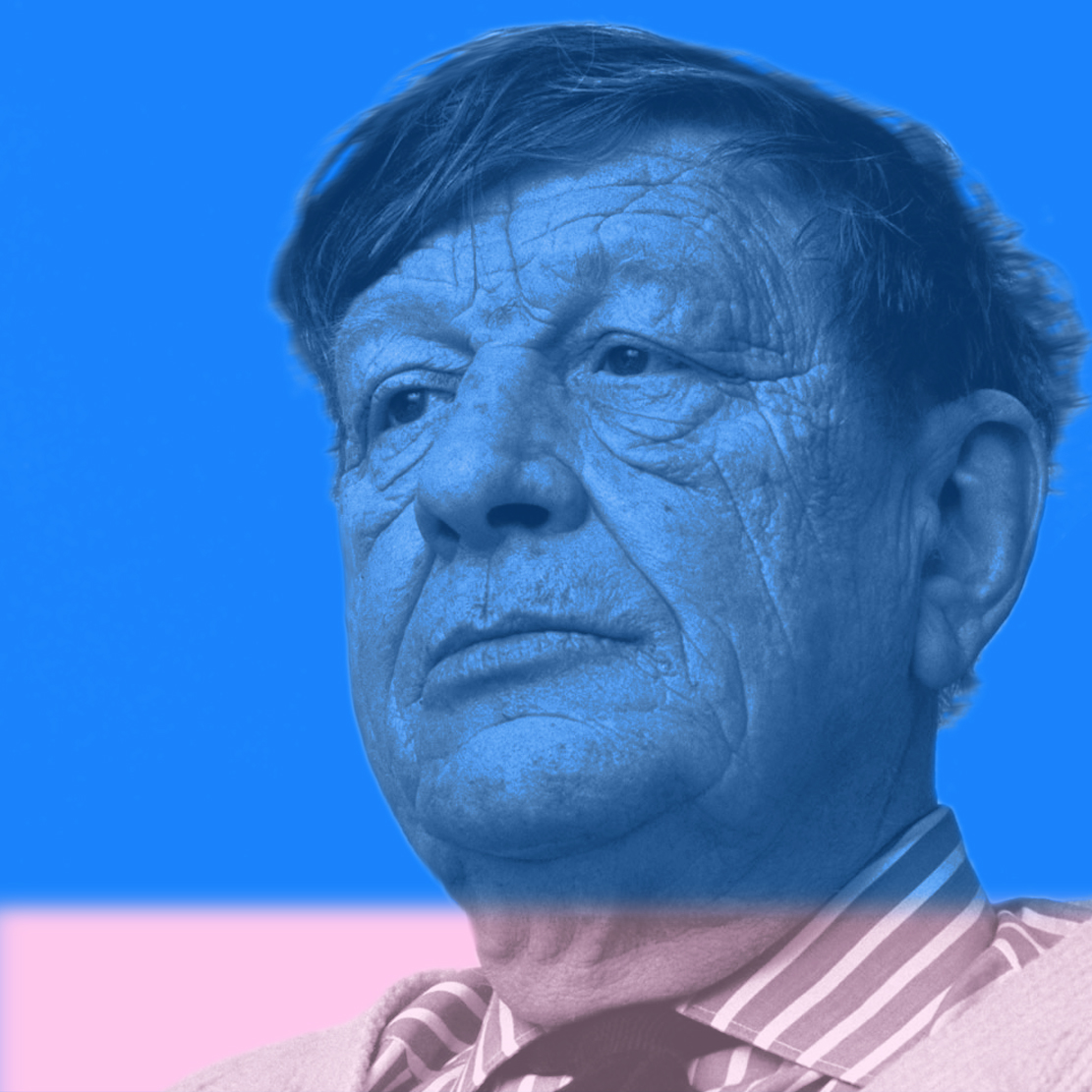



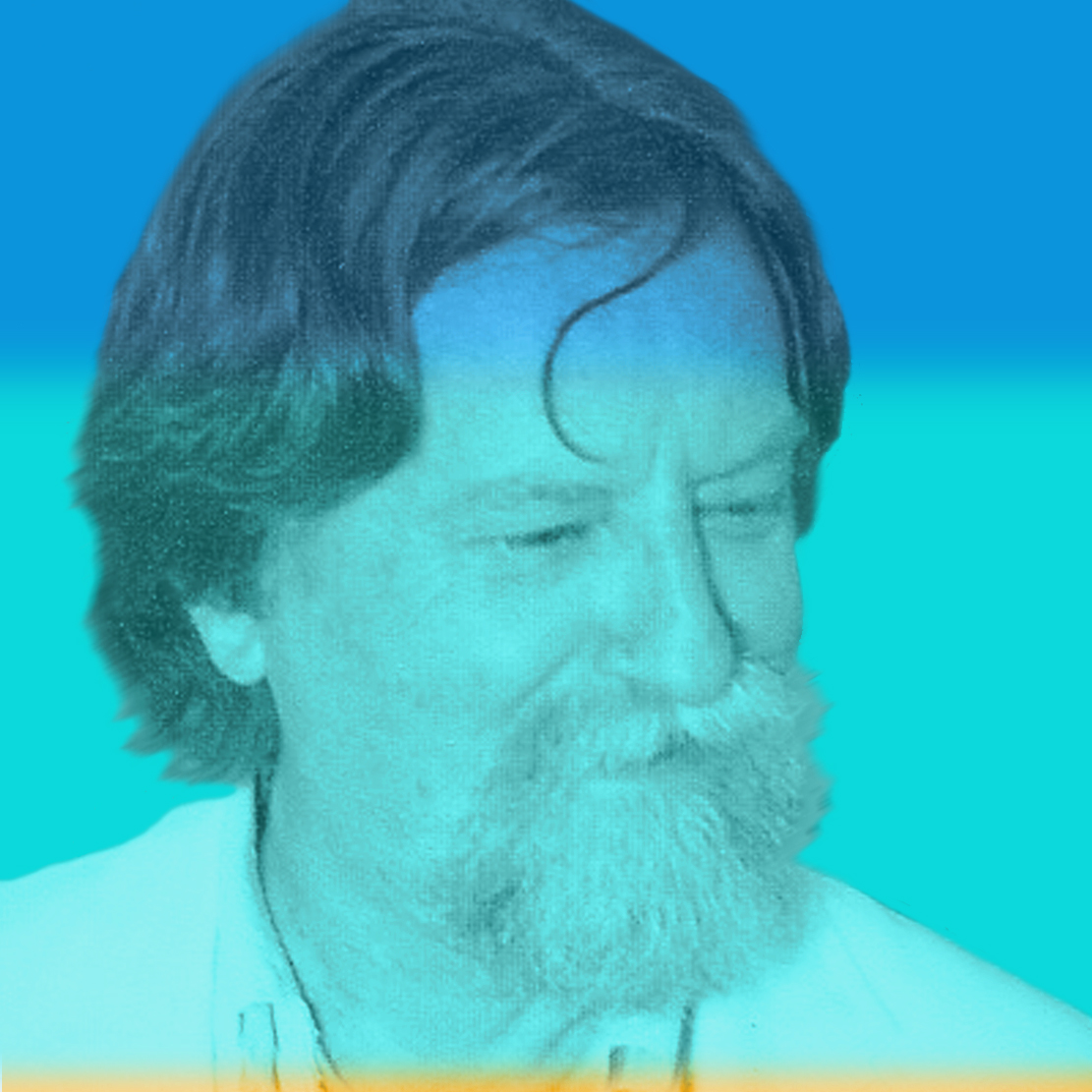
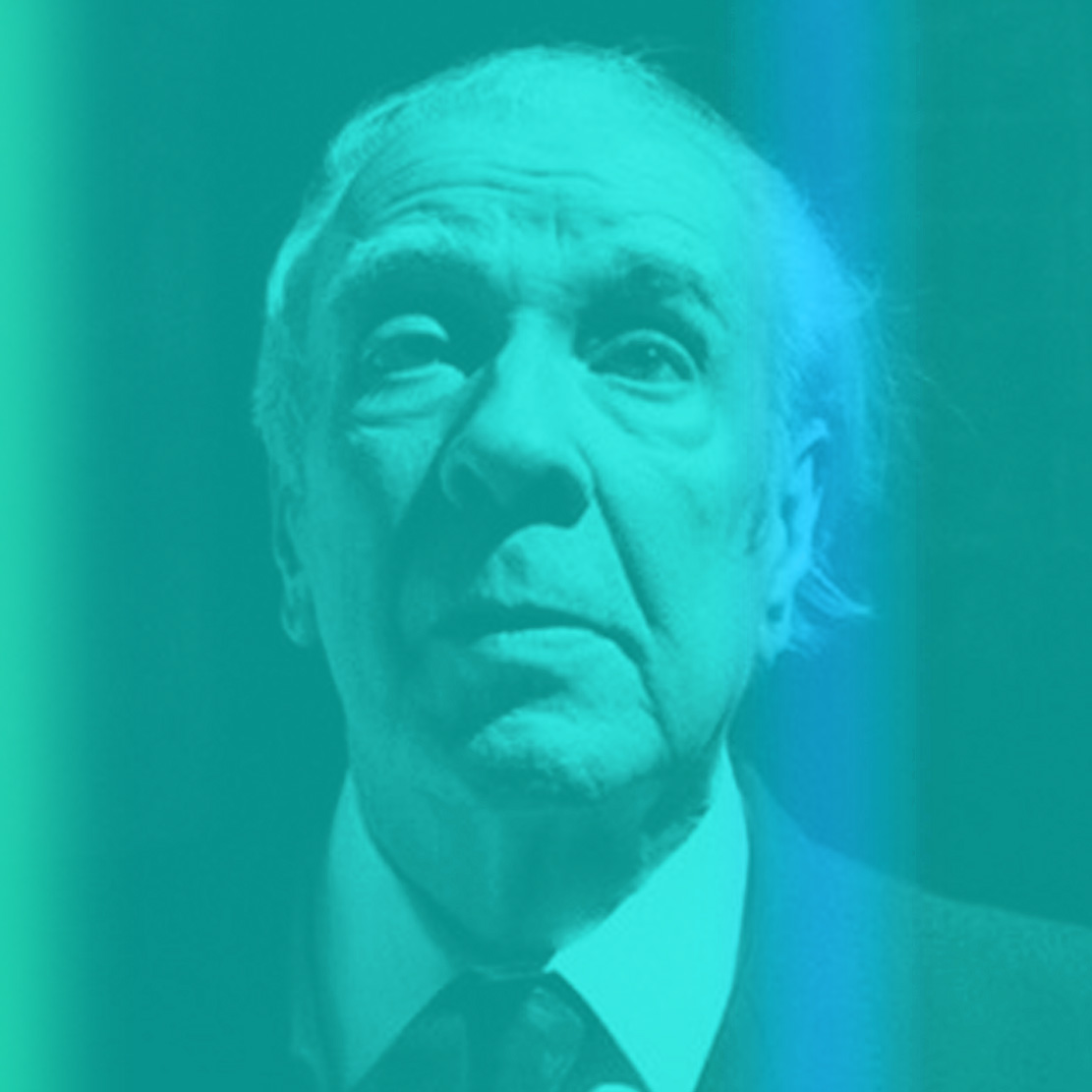




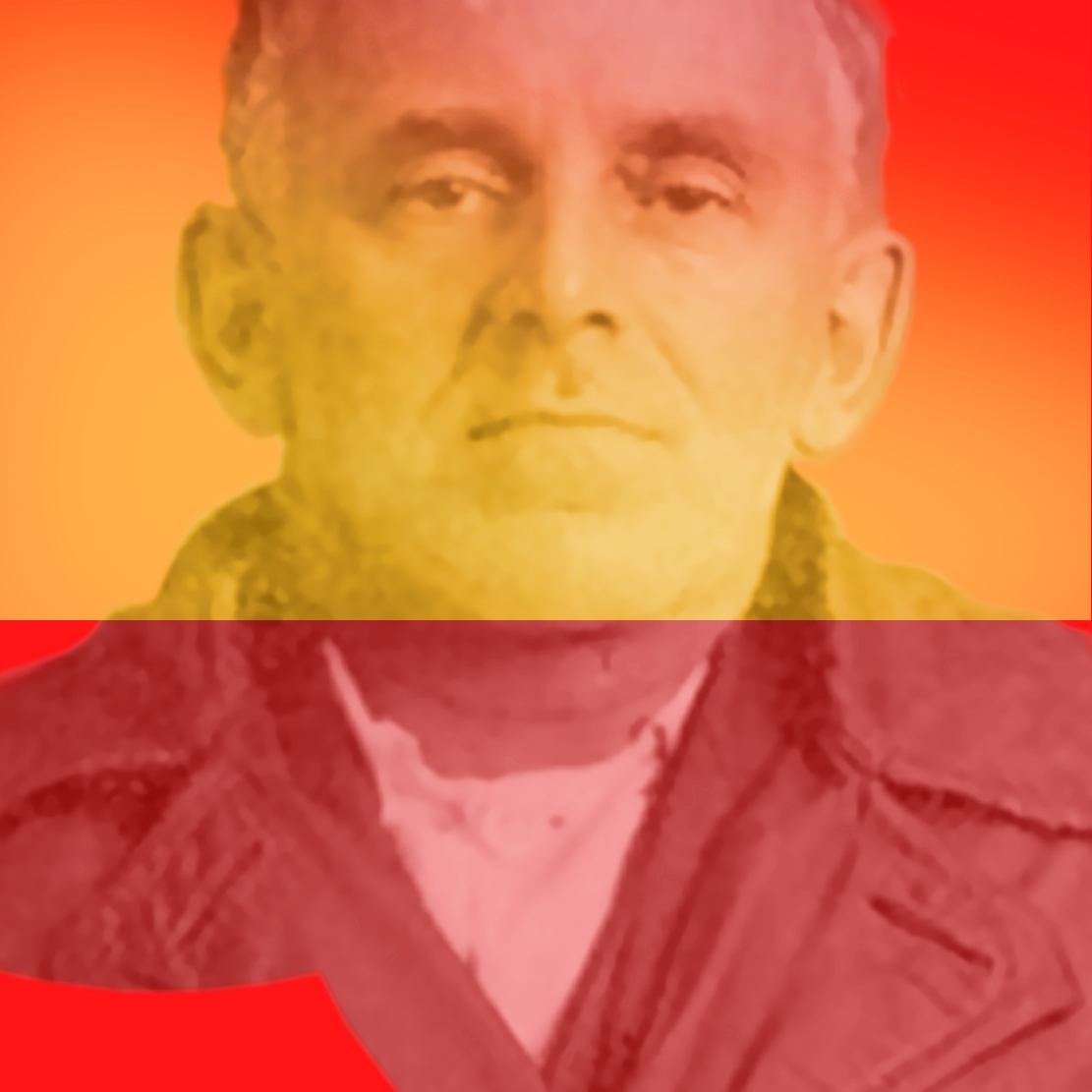






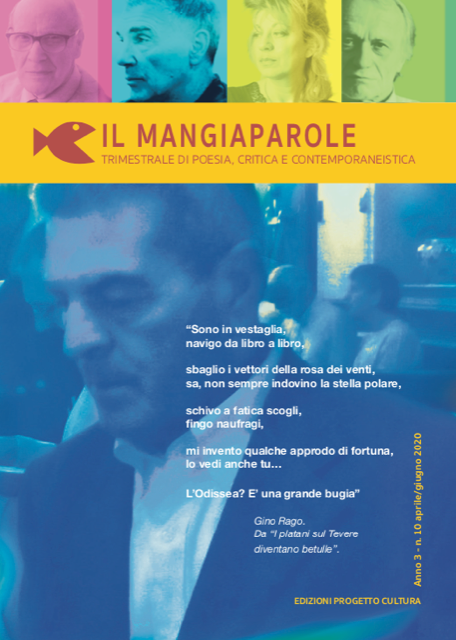




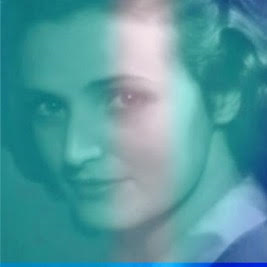
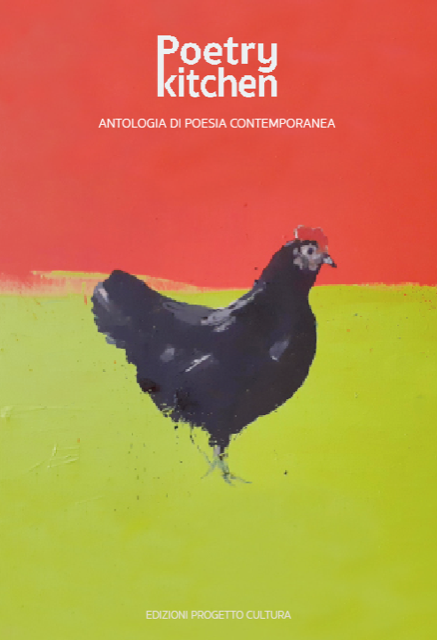



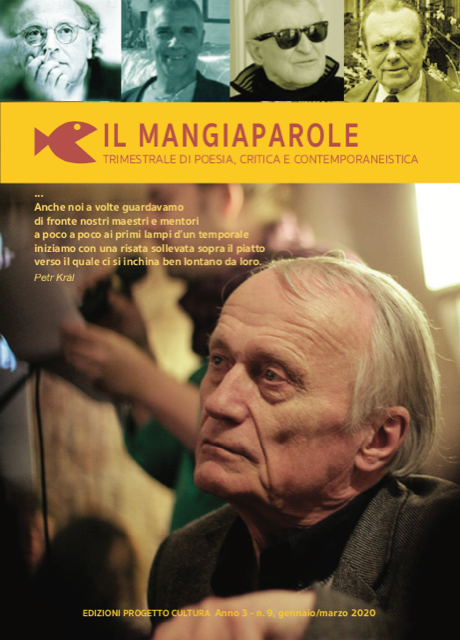











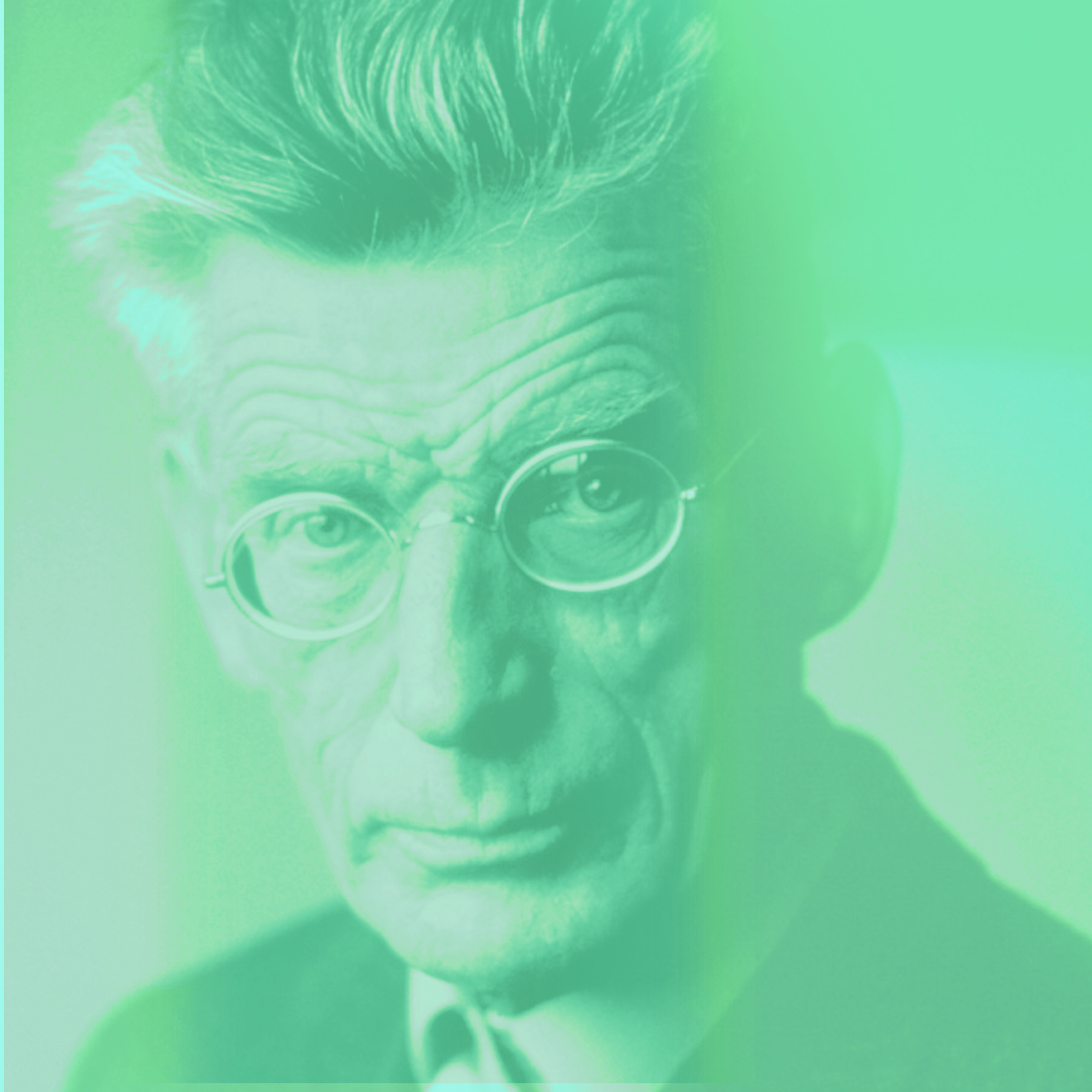
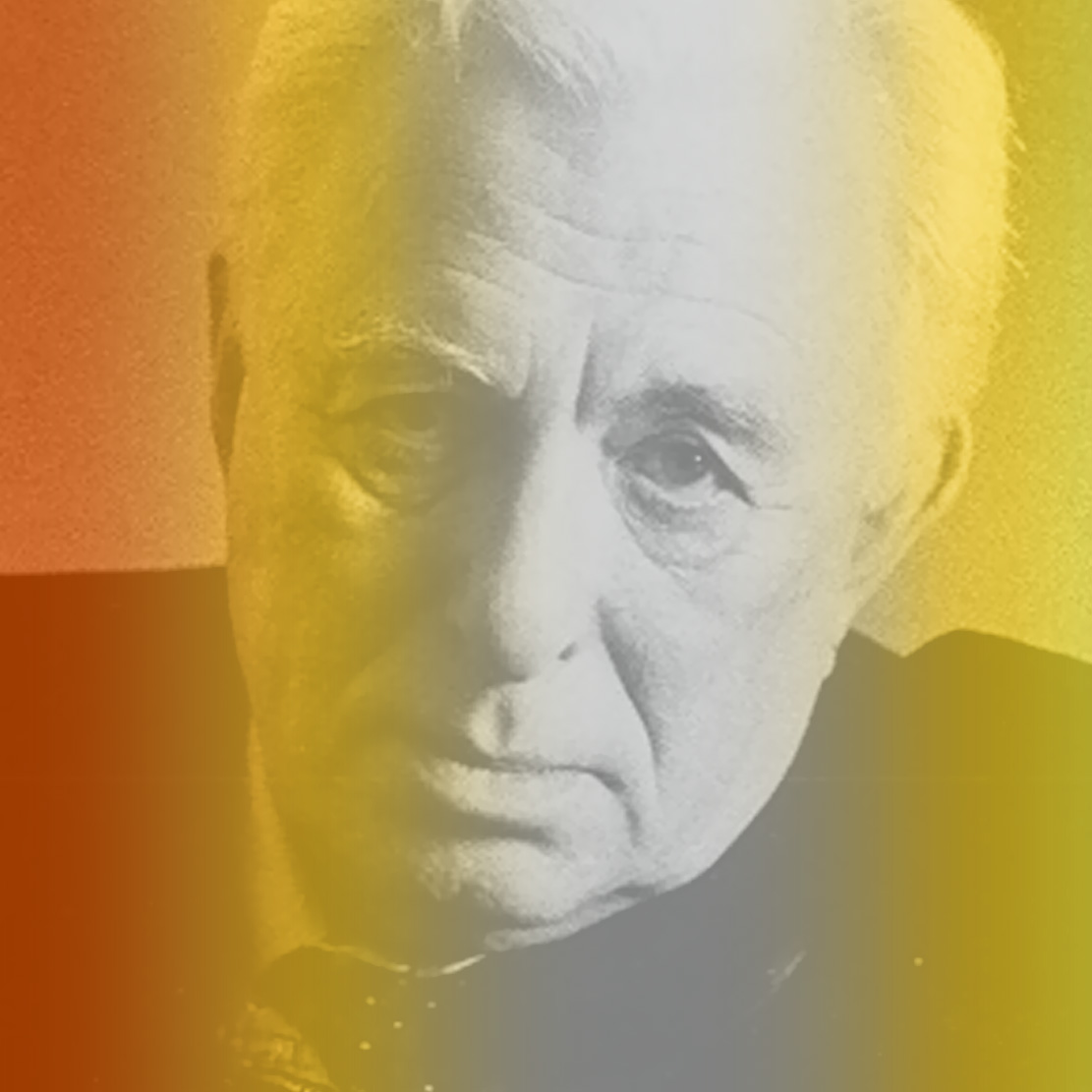









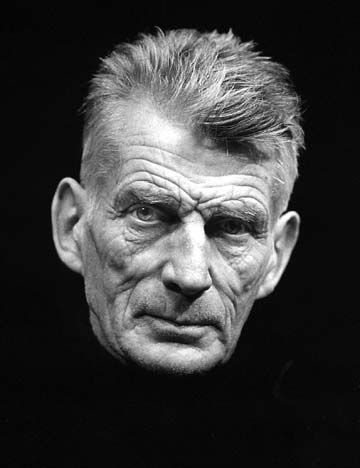


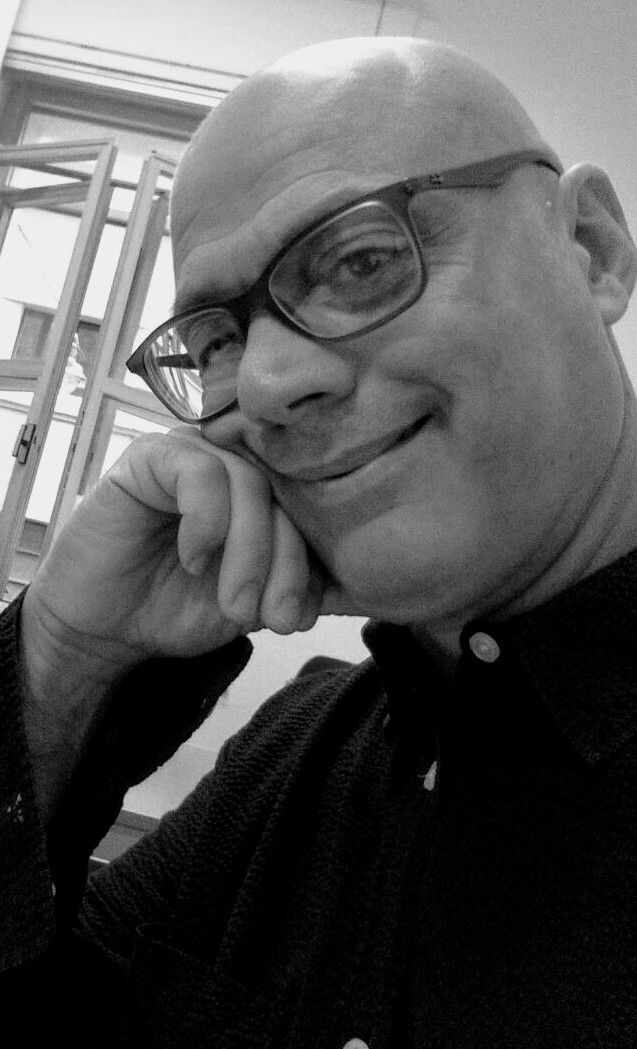
mi scusi, forse mi è sfuggito alla mia lettura veloce, le poesie sono scritte in italiano o sono una traduzione?
"Mi piace""Mi piace"
suppongo in italiano dal momento che non vi è alcun accenno a un traduttore, e l’autrice vive in italia dal 1988
"Mi piace""Mi piace"
Desidero esternare alla Sig.ra Golisch il senso del mio più profondo apprezzamento per il suo lavoro di poetessa e traduttrice. Bellissimi tra l’altro i cosidetti Summerguests dove il piccolo dramma quotidiano di un’umano altrimenti anonimo esce potente e amplificato. Grazie
"Mi piace""Mi piace"
I versi di Stefanie Golisch mi hanno messo addosso un “tremolante desiderio” fors’anche perché siamo a primavera, ma era ora, ne sentivo la mancanza. Immagini fresche e dirette quelle della Golisch che sanno giungere a destinazione.
Ubaldo de Robertis
"Mi piace""Mi piace"
“La vita è tutto questo” è un capolavoro. Un tessuto fitto di metafore, di immagini, senza segni cifrati. Espressionismo e simbolismo insieme si fondono in quel verso esemplare “Oscure selve germaniche e luminosa bellezza mediterranea”. L’ alta coscienza linguistica della Golisch, temprata anche alla lezione di Gottfried Benn, giustamente indicata da Giorgio L., guida questa poesia a far sì che “la propria voce si perda in tutte le voci”,
come esito finale d’ogni voce di poesia.
E di Gottfried Benn mi pare che Stefanie G. adotti la poetica di “fiducia in particolare nel sostantivo, meno nell’aggettivo”.
Poetica più volte enunciata dall’autore di “Poesie statiche”.
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
Come riemergendo dalle profondità marine, munito persino di un buon periscopio ho tentato di indagare, di penetrare in questi versi. Alla prima lettura non si sono riuscito, confuso tra prosa e forse poème en prose o forse poesia. Dio mio come sono invecchiato! Da non riuscire a focalizzare gli scritti di un poeta; forse ho letto troppa poesia di grandi, che a prima vista già aprivano dentro di me le cataratte della comprensione e della condivisione. E mi ostino ad usare gli stessi metri che ovviamente non funzionano, quando si tratta solo di semplici poeti. Quasi mai si affacciano alla mia lettura versi noumenici direbbe Kant, di quelli che sparigliano le carte a scopone scientifico, e ti fanno chiudere gli occhi per vedere più a fondo orizzonti, che uccidono la pura razionalità, e ti scatenano immagini come usciti da una tela di Turner. Al primo impatto i versi della Golisc vanno da un quotidiano che non diventa metafora, da un prosastico senza ritmo o cadenza, altre volte versi brevi racchiusi in un “motel” quasi provocatori sopra un cane che non esiste. “Fly and Fall” con quella ripetitività del futuro francamente noiosa, e “La vita è tutto questo” con un’altra elencazione monotona con il soggetto sempre iniziale al verso . Purtroppo le elencazioni esigono una versificazione scoppiettante,a volte imprevedibile, con accostamenti di sintassi che obbediscano a regole di poesia e non di prosa. Il “notturno” della suora mi appare decisamente un raccontino nemmeno tanto interessante. Con “Un io e la sua bestia” e “Corpo di madre sulla terra” ci avviciniamo cautamente alla poesia. Magari tornando a leggere scoprirò qualcosa che mi era sfuggito facendo ammenda di queste mie personalissime opinioni.Salvatore Martino
"Mi piace""Mi piace"
Sì, rileggendo “La vita è tutto questo” trovo che sia poesia raggiunta con alcuni versi memorabili. Salvatore Martino
"Mi piace""Mi piace"
Vorrei ringraziare di cuore a Giorgio e a tutti i lettori dei lombradelleparole per l’attenta lettura.
Si, la vita e’ tutto questo, l’insieme delle nostre letture, del nostro maldestro vivere, delle nostre preghiere, tenerezze, fallimenti… Di ogni singolo giorno di vita vissuta … In versi e in prosa… Non riesco piu’ a distinguere bene tra uno e l’altro…
Il mio saluto va all’oggi… Giorno nuovo, pronto a accogliere e contenere indistintamente tutto cio’ che accadra’…
Stefanie Golisch
"Mi piace""Mi piace"
io vorrei ringraziare Lei, per come SA scrivere
"Mi piace""Mi piace"
sono veramente belle!
"Mi piace""Mi piace"
Leggendo queste poesie ci si rende conto che ogni autore va affrontato nella sua sfera creativa e perfino staccato da ogni contesto: il contesto riguarda più il critico che il poeta. Conta l’idea, per esempio: “Raccogli quell’io pietra | nel mistero della sua | imperfezione”.
"Mi piace""Mi piace"
Ringrazio anch’io delle poesie postate da Stefanie Golisch. Cercavo di capire cosa era quella pulce nell’orecchio mentre la lggevo, sentivo qualcosa, ma non riuscivo a dire cosa. Penso che Giorgio Linguaglossa abbia proprio ragione, si sente una matrice espressionista in questa poesia. Sicuramente “Umbravitae” torna a galla, ma in modo particolare. Avendo S. Golisch un certo rigore, ha del tutto sfrondato i suoi versi dei colori accesi di quei poeti, forse si è mossa più nella direzione dell’espressionsimo astratto. Lasciando una tonalità prevalentemente bianco e nero che sembra nascere dai contenuti, ma anche li nutre e li qualifica.
Mi chiedo perö se nel mondo di oggi abbiamo dimenticato Else Lasker-Schüler? Sto pensando ad una certa asciuttezza stilistica che le due poetesse sembrano condividere. Un connubio ideale, non so.
Questo nome, Else Lasker-Schüler, talvolta suona come una nostalgia estrema di una Germania ricchissima di ingegno e di arte, in cui tutti vivevano (relativamente) indisturbati.
Ma torno qui, allo stile asciutto di S. Golisch, e alla sorprendente poesia sulla suora.
"Mi piace""Mi piace"
"Mi piace""Mi piace"
"Mi piace""Mi piace"
Due commenti migliori di questi non avrei saputo trovarli!
Scelsi prendeva una nota musicale, la apriva, apriva, apriva a dismisura fino a scorgervi dentro lo spazio cosmico, la totalità dei suoni. Nessun altro come lui ha raggiunto questi vertici. Lavorava sui microtoni, come si fa nella hindustani sangeet, la musica classica indiana.
"Mi piace""Mi piace"
molto bello anche il secondo video, con la teoria dei buchi bianchi. Si riesce benissimo ad afferrare mentalmente la possibilità, almeno matematica, di una pluralità anche infinita di universi.
"Mi piace""Mi piace"
Caro Steven,
mi fa piacere che hai colto il senso dei due commenti-video. In arte, come anche nella scienza, bisogna avere coraggio, bisogna osare. Come Scelsi con la sua musica pur in mezzo al disconoscimento generale della musica istituzionale del suo tempo (il pezzo postato è del 1959). Oggi siamo in un mondo della molteplicità piuttosto che in un mondo della globalizzazione (come da tutte le parti si dice con grande superficialità). Anche l’Impero romano era un mondo globalizzato, e infatti partorì una religione globalizzata e globale come il cristianesimo. Il mondo della complessità. Bene. Come possiamo recepirlo nella forma-poesia? Semplice, come ha fatto Stefanie Golisch, inserendo dei «frammenti» (i vituperati frammenti di chi non li digerisce proprio come i sostenitori della “poesia lirica”). Se leggiamo quella poesia capo lavoro, “La vita è tutto questo”, ci accorgeremo di come l’autrice abbia collezionato dei frammenti diversi e diversificati accostandoli l’uno all’altro per affinità o per contrasto. Il risultato che ne viene è quello della molteplicità, della confusione, del caos, dell’Entanglement, della famosa teoria scientifica della «azione a distanza» tra le particelle tanto vituperata da Einstein. Ecco, anche i frammenti così impiegati entrano nella forma-poesia rinnovandola dall’interno. I «frammenti» entrano in azione a distanza, tra di loro parlano, dialogano:
Il matto, lo chiamano lupo mannaro.
Corvi che gridano al cielo vuoto l’insensatezza del rimorso.
La copia della copia del santo bevitore.
Uomo in canottiera gialla alla finestra della cucina, fumando.
La vecchia che attende il suo giorno, ripetendo tra sé e sé
una storia della sua vita.
La ragazza finta bionda con i jeans economici,
la maglietta economica e i suoi sogni inimmaginabili.
La coppia di nani al loro primo bacio, ansiosi
di fare bella figura.
Sole di Novembre, tempo di resa,
tempo di rinascita, perdono e oblio.
"Mi piace""Mi piace"
"Mi piace""Mi piace"
Vorrei chiedere a Stefanie Golisch come mai un autore di madre lingua tedesca come te ha scelto di scrivere in italiano? Che cosa trovi nell’italiano di ospitale? E poi, riallacciandomi alla famosa tesi di Pasolini, il fatto che l’italiano sia stata per lunghi secoli una lingua soltanto letteraria mentre invece adesso è diventata una lingua nazionale, che cosa significa per la tua poesia? Voglio dire: è un limite o una possibilità? Grazie.
"Mi piace""Mi piace"
Ci vorrebbe un’intervista Linguaglossa-Golisch
"Mi piace""Mi piace"
Caro Giorgio, l’uso di frammenti per narrare una realtà frammentata come la nostra, sincopata nei ritmi, è interessante, è un tuo contributo ad una rinnovata riflessione sulla poesia. Che spero continuerai a sviluppare. Niente si ferma, tutto è in un continuo stato di flusso.
In diversi modi, i tuoi frammenti stanno vicino alla mia urgenza di rallentare il ritmo di arrivo della poesia alla fruizione del lettore.
Del tempo fa, nel contesto di un post di poesia di E. Dzieduscycka su L’Ombra delle Parole, c’è stato un interessante dialogo con il Signor Balestriere, il quale giustamente non capiva, in un primo momento, come la poesia possa avere un moto veloce e lento allo stesso tempo. Io ho cercato di spiegare che questo dipende secondo me tanto dalla mente che recepisce la poesia, quanto dalla poesia stessa.
Il frammento interrompe il flusso di ricezione, lo rende zackig, frastagliato, come dire, ma allo stesso tempo quel rallentamento libera il pensiero retrostante, libera l’ombra significante che segue le parole e le illumina. Ecco perché rallentamento in poesia si traduce spesso in un percepito aumento della velocità.
Ho studiato a lungo la poesia recente e meno recente per capire questa dinamica. Le prime volte era con i poeti moderni quando avevo 16-17 anni: mentre leggevo, d’un tratto si liberava una risonanza da una parola, o da un gruppo di parole, facendomi trasalire, come un uccello spiccava il volo e andava a posarsi in qualche altro punto della poesia, dove non avrei mai pensato: indicandomi con un sorriso segreto che la poesia stavo leggendo non veicolava soltanto pensiero e concetto, ma anche risonanze di pensiero e di concetto: e che dunque sopra la poesia, con il suo generico e pur ricco significato letterale, si estendeva una trama lucente di un altro significato, impossibile da cogliere se non per un attimo. Mi sembrava che questa trama fosse, in qualche modo, riflesso della psiche del poeta, la quale porta in sé il millenario abisso di civiltà, di cui il poeta è solo vagamente conscio – a lui, tuttavia, il merito di aver saputo veicolare quell’indicibile. Allora la poesia che leggevo mi diventava luminosissima, la riconoscevo come “grande”: un miracolo: essa esprimeva anche me: e mi dava licenza di ispirarmi ad essa perché io facessi un ulteriore passo nella ricerca del senso indecifrabile delle cose. Forse questo è il vero significato della parola “tramandare”, “tradizione”.
A scuola avevamo letto tantissimo Shakespeare, il nostro professore amava anche i poeti del Sei e del Settecento. Giustamente additava Alexander Pope come un gigante e maestro della forma classica, mai più, io penso, raggiunto. Ma quello strano sistema di risonanze che ho detto sopra lo sentivo più nei poeti dal Romanticismo in poi, e in particolar modo nei moderni, da Eliot in poi. Penso adesso che ciò fosse dovuto alla mia sensibilità di moderno. In questo senso, anche i Romantici inglesi erano moderni, grazie alla Rivoluzione Industriale. (Impossibile idealizzare l’operaio in fabbrica, come si era fatto con il contadino, nel suo idillico contesto campestre.)
Qualche anno più tardi, una volta che fui in grado di leggere l’italiano, sentii questo stesso fuggire di risonanze anche in un poeta come Montale.
Torno al concetto di rallentamento-velocità, che è un fenomeno, mi pare, nato in genere con il modernismo, e sorto forse anche involontariamente per rispecchiare l’ansia, l’incertezza esistenziale, che noi moderni abbiamo iniziato a vivere come quotidianità dopo che sono caduti gli idoli dell’Occidente, dopo che si è in genere stabilita la relatività delle cose di questo mondo.
I poeti scandinavi del secondo ‘900 sono maestri di questo procedimento. Tranströmer è solo uno di loro.
Velocità-rallentamento, in una forma molto simile, è un fenomeno fortemente presente nella modalità “dhrupad” della musica classica indiana. La quale lavora anche sui microtoni per tirare fuori la suggestione che vibra sopra al dettato musicale di base, sopra al succedersi sequenziale, lineare, delle note. Simile, come ho già detto, al poeta che scrive una poesia le cui parole suggeriscono qualcosa oltre il significato letterale. Certo, questo già lo si fa, ma si tratta, io dico, di notevolmente accrescere questa potenzialità che pure la musica, e la lingua hanno. Le parole che noi usiamo, e che siamo quotidianamente costretti ad usare quasi fossero gli spiccioli del nostro pensiero, sono antichissime, arcaiche, radicano in lingue e pensieri precedenti, in gran parte obliati, hanno una ricchezza immisurabile. E’ qui forse che sta il mistero della poesia (e della lingua) che diceva Salvatore Martino: semplicemente vaga percezione della “immensità di culture millennarie”, che appare nelle nostre parole, che però hanno anche una leggerezza assolutamente indispensabile perché gli esseri umani possano comunicare liberi fra di loro.
Poeta forse è anche colui che sa fare questo: intuire in ogni attimo quel vasto orizzonte, ma saperlo rendere leggero, fruibile all’uomo del suo tempo. Reintegrare l’uomo. Ecco perché una significativa comunicazione poetica con l’uomo di oggi non sarebbe possibile, secondo me e genericamente parlando, tramite la forma del sonetto. La comunicazione poetica già sembra impresa ardua con le forme “aperte”! Ciascun poeta dovrà attraverso i suoi tormenti trovare da sé la forma che va bene oggi, se è vero che il suo compito è prima di tutto raggiungere il lettore-ascoltatore esterno, il quale vive nella realtà di oggi, non nel passato. Le scelte a sua disposizione, e proprio grazie a questa caotica libertà che ci ritroviamo, sono molte. (Una, per esempio, è quella di Stefanie Golisch.) Non c’è niente di facile in tutto questo.
Il mistero, dunque, è ben più fitto di un verso di poesia luminoso e ben tornito.
Torno alla musica dhrupad: tutto il senso di quella musica sta nel suo continuo dispiegarsi adesso, nel suo apparente muoversi erratico, non-lineare, ciò che abbatte ogni sequenzalità stretta, aprendo molteplici spazi temporali. Perché essa tiene sempre in bilico il momento presente, affinché noi possiamo meglio afferrarne l’evanescenza. La concentrazione sul momento apre scorci impensati sugli altri tempi che pure noi conosciamo ma troppo velocemente abbiamo normalizzato e pensato di catalogare.
In poche parole: sia musica che scrittura seguono quello che appare come linearità nel tempo obbligata. Come allora suggerire quello che tutti che sappiamo, ossia che il nostro vivere, i nostri pensieri, tutto fanno fuorché seguire una traccia sequenziale obbligata?
Ecco cosa significa fruizione estetica di un’opera! Questo!
La musica classica occidentale fino a Bruckner e Wagner si basava sulla formula 1) presentazione di una problematica, 2) trattazione della stessa, 3) risoluzione della stessa – con tutte le sue complessità, chiaramente. Mahler ha sovraccaricato questa formula, l’ha inturgidita al massimo, fino a distruggerla. E infatti, dopo Mahler, alla musica occidentale liberata da quelle pastoie si è aperto un orizzonte allargato, immenso e spesso sublime. Che ha reso possibili grandissimi musicisti come Scelsi, Stockhausen, Cage, e quanti altri.
Io penso che la scelta oggi da parte di quasi tutti i poeti occidentali di ascoltare prevalentemente rock, jazz o musica classica tradizionale – e non Scelsi, Stockhausen, Ligeti, Jani Christou – spieghi in parte perché ci sono così grandi difficoltà a pervenire ad un linguaggio della poesia più in simbiosi con il presente; perché invece così spesso si finisce per praticare il minimalismo epigonico di forme già viste e variate all’infinito. La musica classica contemporanea è uno dei prodotti artistici più alti della cultura occidentale del ‘900: ha aperto una strada incredibile, ma sembra che il 90% delle personenon sanno nemmeno che esiste. Già nell’Europa orientale la cultura da questo punto di vista è molto avanzata – grazie, paradossalmente, a decenni di censura. Prendete Bela Tarr, per esempio, che nei suoi film usa musiche di Mihaly Vig, molto vicine alla avanguardia musicale del ‘900.
Sono tutte riflessioni, solo riflessioni queste, per aprire un dibattito.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Giorgio per la tua domanda.
La prima e più ovvia risposta è semplice: vivo da molti anni, dal 1988, in Italia.
Gran parte della mia vita – concretamente – si è svolta a Monza dove vivo e dove è nata e cresciuta mia figlia. In questo senso mi sono intrecciata in questo mio secondo paese, capitato casualmente. L’italiano è la lingua della mia vita quotidiana, ma non solo. Naturalmente per “accasarmi” in Italia ho cercato riferimenti e, nel mio caso, non potevano non essere letterari e soprattutto poetici.
Nei tardi anni novanta ho cominciato a tradurre. Nell’ambito delle ricerche su uno scrittore tedesco, Henry Benrath, che ha vissuto gran parte della sua vita in Italia, ho scoperto la poetessa Antonia Pozzi (da lui tradotta in modo terribilmente patetico!). Mi sono messa alla prova e ho cominciato a tradurre una parte delle sue poesie, pubblicate in seguito per una casa editrice in Austria.
Credo proprio che queste mie traduzioni di autori di lingua italiana (Cristina Campo, Camillo Sbarbaro, Lorenzo Calogero, Guido Oldani, Edoardo Sanguineti, Gezim Hajdari…) mi abbiano permesso di entrare nella linfa e nelle viscere della lingua italiana.
La mia mente però, penso, funzioni alla tedesca… e con questo intendo che amo la brevità, la sintesi, le frasi compatte…togliere invece di aggiungere… E quindi, credo, di essere una scrittrice tedesca che usa la lingua italiana, una specie di ibrido…
Ma se voglio proprio essere precisa – e in questo momento lo voglio (è sabato pomeriggio e ho tempo!) – devo confessare il mio vero grande amore che è né la poesia tedesca, né la poesia italiana (tranne Camillo Sbarbaro che rimane il mio poeta del cuore…!) ma la poesia anglo-americana.
Infatti, alcune poesie che qui sono state pubblicate, sono delle specie di traduzioni dall’inglese.
Nell’assoluta concretezza della poesia americana (di autori conosciuti e meno conosciuti) trovo quel tipico poetico non poetico che forse Sanguineti intendeva quando diceva che “la poesia non è mai poetica”. Nota bene: questo filone c’è anche nella poesia italiana – in “Pianissimo”, per esempio, si era concretizzato già all’inizio del XX secolo, ma, purtroppo, viene considerato minore rispetto ad altri autori più filosofici, apparentemente più ambiziosi, ma forse spesso solo più retorici.
Che la filosofia rimanga filosofia! E le belle paroline al loro posto tra i poeti della domenica, e idem la retorica, i superlativi, i versi…
Il mondo intorno a me non fa rima.
Io non ho nessun messaggio in nessuna lingua.
Cerco di cogliere momenti, voli e volti, smorfie e cadute, la melanconica bellezza nelle fessure del quotidiano, del nostro maldestro vivere….
Cerco di portare queste cose nella lingua, a volte in tedesco, a volte in italiano e a volte in inglese.
Mi piace viaggiare senza road map, senza meta precisa.
Tutto qui.
Un caro saluto e buoni pensieri
Stefanie
"Mi piace""Mi piace"
caro Steven Grieco,
PROBABILMENTE OGGI CHE ALLA POESIA NON è RICHIESTO PIU’ NULLA, forse proprio oggi alla poesia è posta la Interrogazione Fondamentale. Finalmente la poesia è libera, libera di non dire nulla o di dire ciò che è essenziale e inevitabile. Questo è molto semplice, è un pensiero intuitivo che tutti possono far proprio. Nel momento della sua chiusura clausura, la poesia si trova sorprendentemente libera, libera di porsi la Domanda Fondamentale, quella Domanda che per lunghi decenni nel corso del Novecento non si aveva l’urgenza e la necessità di porsi. La poesia, dunque, si trova davanti alla inevitabilità di dire ciò che è. E questa io credo che sia la più grande possibilità che il mondo moderno concede alla Poesia.
Esprimere nel modo più determinato e concreto l’inconscio che sta alle spalle del Pensiero pensato e non pensato dell’Occidente, il sottosuolo del sottosuolo che giace ancora più a fondo del sottosuolo costituito dal pensiero ordinario in cui ormai tutto viene pensato e vissuto dalla civiltà dell’Occidente.
Una poesia che si ponga l’ambizioso obiettivo di pensare l’impensato, le cose del sottosuolo more geometrico di un precedente more geometrico sotterraneo. Pensare la costruzione stilistica disabitata come la più consona ad essere abitata. Trarre dunque la forza dalla propria debolezza, mobilitare tutta la forza della visionarietà geometrica della poesia, questo è il compito che i poeti autentici oggi si trovano di fronte. E non è poco. Dobbiamo, per far questo, giungere a guardare alla poesia da un luogo ad essa esterno. E proprio questa paradossalità ci permette di seguire in ogni suo meandro il lungo percorso di un pensiero poetante che faccia di questo «tramonto» il luogo più abitabile.
"Mi piace""Mi piace"
Sì, proprio così. Esprimere l’impensato. Il pensiero, la nostra cultura, tendono a farci percorrere e di nuovo ripercorrere gli stessi percorsi gia fatti. E´ naturale, questo, per l’ogni giorno, ma non per il poeta. Su entrambi i lati della via, nella penombra, stanno le intuizioni, I pensieri impensati. Ci vuole audacia.
"Mi piace""Mi piace"
Pingback: DIALOGO tra STEVEN GRIECO RATHGEB e GIORGIO LINGUAGLOSSA sullo STATUTO del FRAMMENTO in POESIA con una composizione esemplificativa di Steven Grieco e Mario M. Gabriele La realtà frammentata; Il frammento interrompe il flusso di ricezione; Velocità-ra
Pingback: DIALOGO tra STEVEN GRIECO RATHGEB e GIORGIO LINGUAGLOSSA sullo STATUTO del FRAMMENTO in POESIA con una composizione esemplificativa di Steven Grieco e Mario M. Gabriele La realtà frammentata; Il frammento interrompe il flusso di ricezione; Velocità-ra
Pingback: DIALOGO tra STEVEN GRIECO RATHGEB e GIORGIO LINGUAGLOSSA sullo STATUTO del FRAMMENTO in POESIA con una composizione esemplificativa di Steven Grieco e Mario M. Gabriele La realtà frammentata; Il frammento interrompe il flusso di ricezione; Velocità-ra
Pingback: DIALOGO tra STEVEN GRIECO RATHGEB e GIORGIO LINGUAGLOSSA sullo STATUTO del FRAMMENTO in POESIA con una composizione esemplificativa di Steven Grieco e Mario M. Gabriele La realtà frammentata; Il frammento interrompe il flusso di ricezione; Velocità-ra
Pingback: DIALOGO tra STEVEN GRIECO RATHGEB e GIORGIO LINGUAGLOSSA sullo STATUTO del FRAMMENTO in POESIA con una composizione esemplificativa di Steven Grieco e Mario M. Gabriele La realtà frammentata; La forma aperta; Il frammento interrompe il flusso di ricezio
Pingback: DIALOGO tra STEVEN GRIECO RATHGEB e GIORGIO LINGUAGLOSSA sullo STATUTO del FRAMMENTO in POESIA con una composizione esemplificativa di Steven Grieco e Mario M. Gabriele La realtà frammentata; La forma aperta; Il frammento interrompe il flusso di ricezio
Nel leggere queste poesie, ad un primo sguardo, ho ripensato alla parola ‘frammenti’ nella sua accezione di fotogramma salvato su carta, e quindi ho pensato anche alla difficoltà in cui consiste l’operazione di trascrizione. L’impressione che ne ricevo è che dietro l’apparente ‘casualità’ delle immagini ci sia di un lavoro di approssimazione/avvicinamento cosciente, a volte sofferto, come nel caso, ad esempio, di “Corpo di madre sulla terra”, in cui è avvertibile l’estrema difficoltà di poter parlare della propria madre e, contemporaneamente, della sua morte.
Nelle poesie, per dir così, più lineari, il frammento, o il fotogramma, viene in qualche modo ingrandito, tanto da permettere alle parole di diventare fluide e costruire un racconto.
Quelle da me preferite sono quelle presentate in forma di frammento, nelle quali Stefanie Golisch mantiene integro l’impatto visivo immediato. Tra quelle ‘lineari’, poi, “Quando una vecchia suora si prepara per la notte” mi convince poco, forse per un certo moralismo di fondo.
La mia preferita fra tutte: Fly and Fall.
Molto bello il commento di Giorgio, soprattutto quando evidenzia il carattere metafisico che assume la quotidianità.
"Mi piace""Mi piace"