
il venerdì santo a Palermo, gli incappucciati
Giuseppe Gallo, è nato a San Pietro a Maida (CZ) il 28 luglio 1950, diploma di Liceo classico, laurea in Lettere Moderne, è stato docente di Storia e Filosofia nei licei romani. Nel 1983 la sua prima raccolta di poesia, Di fossato in fossato, Lo Faro editore. L’impegno civile sul territorio lo spinge a un rapporto sempre più stretto con la poesia dialettale. Negli anni ‘80, collabora con il gruppo di ricerca poetica “Fòsfenesi”, a Roma. Delle varie “Egofonie”, “Metropolis”, dialogo tra la parola e le altre espressioni artistiche, è rappresentata al Teatro “L’orologio”.
Avvicinatosi alla pittura, l’artista si concentra sui volti e gli sguardi, mettendo in luce le piaghe della modernità: consumismo e perdita dello spirito. Negli ultimi lavori ha abolito la rappresentazione naturalistica degli oggetti per approfondire i rapporti tra colore, forma e materiali pittorici. Nel 2016, con la fotografa Marinaro Manduca Giuseppina, pubblica, Trasiti ca vi cuntu, P.S. Edizioni, storia e antropologia del Paese d’origine. Nel 2017 è risultato tra i sei finalisti del “IV Premio Mangiaparole”, sezione poesia, Haiku. Dal 2006 ha esposto a Roma, Mentana, Monterotondo, Brindisi, Lecce.
Dal risvolto di copertina
Na vota quandu tutti sti hfjumari… “Una volta, quando tutte queste fiumare…” ecco l’inizio del poema, come una favola, dove cielo e terra, formano un unico paesaggio, quello della commedia umana, che è l’eterno panorama della Calabria, nei limiti di una storia indefinita perché sempre uguale a se stessa. Siamo oltre il Settecento. Alle nuove urgenze del mondo borghese e contadino si oppone il mondo baronale che tenta un vigoroso ritorno alle angherie e agli antichi privilegi feudali. Ciò che accade in tutto il Sud si verifica anche nella Contea di Maida. Uno dei suoi casali, però, quello di San Pietro, reagisce. Nasce, così,… na guerra, chiddha dell’Arringa tra Santu Pietru, Majìda e Curinga.
Dalla lotta di popolo emerge un microcosmo di uomini: il Conte Malaspina, Totu lu Rizzu, don Luciu Fabiani, l’abate Mancusu, donna Tresina, tutti con la loro dose di affaticata quotidianità che il poeta raccoglie come testimonianza di vita. Allora “Supra lu Ponte”, “Avanti Grassu” Corda e Campuluongu diventano il teatro di lotte fratricide, di eroismi e comicità. Da questa sarabanda non si salva nessuno, né San Francesco di Paola né San Nicola da Bari, nemmeno la Madonna del Carmine. Qui non c’è frattura tra paradiso e inferno. Qui, ciò che non è storia per la cultura dominante, è storia concreta per uomini di carne. Emblematica la figura di Cheli, il muto,”lu gghjegghju”, “lu scilinguatu” del paese, che attraverso una serie di peripezie riacquista la parola.

una lingua è un dialetto con un passaporto e un esercito (N. Chomsky)
Ermeneutica di Giorgio Linguaglossa
Ricordiamo la famosa sentenza di Chomsky: «una lingua è un dialetto con un passaporto e un esercito», e l’altrettanta famosa tesi di Osip Mandel’štam secondo il quale per fare una lingua occorre una burocrazia organizzata e un governo centrale con tanto di esercito nazionale. Ecco, possiamo dire che affinché si abbia un dialetto è sufficiente togliere ad una lingua la sua dimensione statuale, il governo, l’esercito e la burocrazia, ciò che rimane è un dialetto, il resto di un linguaggio che non è diventato una lingua nazionale, quindi lingua patria, ma è rimasto una lingua matria, ovvero, un dialetto.
Il fatto che l’unità d’Italia sia avvenuta con tanti secoli di ritardo rispetto alle altre nazioni europee ha contribuito a determinare quel fenomeno di entropizzazione delle lingue locali che, per mancanza di una nazione unitaria, non sono mai riuscite a diventare lingue nazionali ma sono rimaste nane, prive di una statualità, prive di codice civile, prive di una burocrazia, lingue parlate soltanto dal popolo, lingue orali, lingue della immediatezza espressiva. Quello che mancava alla lingua nazionale, l’italiano, l’immediatezza espressiva, è stata la peculiarità delle parlate negli idiomi locali. La poesia negli idiomi locali è così diventata in Italia il demanio della poesia del popolo illetterato, e questo risulta vero da Gioacchino Belli a Ignazio Buttitta e Tonino Guerra fino ai giorni nostri ultimissimi che hanno assistito alla diffusione a macchia d’olio della poesia popolare nei numerosissimi idiomi locali della penisola. In questi ultimi decenni però questo stato di cose sembra cambiato irreversibilmente con la compiuta stabilizzazione dell’italiano parlato ormai dalla quasi totalità dei parlanti italiano, grazie alla rivoluzione telematica e alla diffusione oltre misura delle emittenti linguistiche che si esprimono nella lingua nazionale.
Scrive Tullio De Mauro in una relazione alla Presidenza del Consiglio che nel 1861 «il 78% della popolazione risultò analfabeta. La scuola elementare era poco frequentata e mancava in migliaia di comuni. L’intera scuola postelementare era frequentata da meno dell’1% delle classi giovani. Secondo le stime la capacità di usare attivamente l’italiano apparteneva al 2,5% della popolazione. Un valoroso filologo purtroppo scomparso ha rivisto questa stima al rialzo, suggerendo che la capacità di capire l’italiano appartenesse all’8 o 9%».
Oggi finalmente l’italiano è parlato dal 94% della popolazione, dunque si può affermare che l’unificazione linguistica delle masse parlanti si è verificata. Si sarebbe potuto congetturare che a fronte dell’egemonia incontrastata della lingua nazionale si verificasse una decrescita della poesia negli idiomi locali, e invece è accaduto il contrario, la poesia dialettale mai come in questi ultimi due tre decenni ha conosciuto una crescita esponenziale come lingua della immediatezza espressiva. Ma si ha ragione di ritenere che ormai la grande stagione della poesia in idioma durata centocinquanta anni si sia chiusa definitivamente, i poeti dialettali venuti dagli anni settanta ai giorni nostri non sembrano avere attinto le vette dei poeti dei decenni precedenti, ormai la poesia in idioma sembra aver perduto la ragione stessa che ne ha determinato in passato la prosperità. Oggi la poesia in idioma sembra confinata in una sorta di giardino zoologico, una sorta di hortus conclusus, e si è trasformata in episodi di folclore e di costume. Ci sono ancora bravi poeti ma la stagione d’argento della poesia in idioma sembra ormai inesorabilmente trascorsa, ben venga dunque una antologia della poesia in idioma per fissare in un documento i più alti punti di riferimento della poesia dialettale, quando essa aveva ancora una forza propulsiva e rinnovatrice della poesia in lingua italiana.
La ripresa della poesia in idioma degli ultimi decenni del Novecento è un fenomeno spiegabile con la nuova alfabetizzazione di massa presso il ceto medio mediamente culturalizzato nel mentre che si assisteva ad un processo di impoverimento delle varietà dialettali e delle loro ricchezze lessematiche e fonologiche con corrispondente vertiginoso aumento della produzione lirica dilettantesca e strapaesana. Accade così un fatto singolare, che se nella prima metà del secolo molti poeti in idioma avevano cercato di attenuare le distanze rispetto all’italiano (emblematico il caso dell’impoverimento lessematico e fonologico del romanesco di Trilussa rispetto a quello del Belli), i poeti delle generazioni successive invece accentuano le distanze dalla lingua italiana, si rivolgono a idiomi dialettali tanto più periferici quanto meglio, tentano di fondare un linguaggio originario, arcaico, primigenio sfruttandone le risorse fonetiche e tono simboliche (il casarsese di Pasolini, il tursitano di Albino Pierro, il siciliano di Ignazio Buttitta), fino ai limiti estremi di incomprensibilità di moltissimi poeti in idioma di oggi. Avviene così un fenomeno paradossale, che mentre i dialetti tendono a scomparire nelle abitudini dei parlanti, si verifica una crescita a dismisura della produzione poetica in idioma come resistenza al monolinguismo e al conformismo della poesia in italiano della tradizione letteraria e all’italiano stereotipato della comunicazione telematica. È in questo contesto storico culturale che ha luogo la poesia in dialetto calabrese di Giuseppe Gallo, la forma metrica è la sestina con rime alterne e baciate.
Si ha la sensazione, leggendo questo poeta, di trovarci davanti ad una lingua urdu che ci parla di un mondo di ottomila anni fa, di un mondo patriarcale, di una civiltà contadina pagana e stregonesca insieme. Bisogna leggere questo poema come un lungo epinicio verso una civiltà sconfitta e scomparsa. Un canto di lutto, dunque.
(Giorgio Linguaglossa)

Vorisse pe’ mmu tiegnu nu panaru
cupu e cchjù fuondu de na menzalora
ed intra mu vi jiettu ogni palora
chi cca sucai de quandu m’addhattaru
Dichiarazione di intenti di Giuseppe Gallo
In questi ultimi tempi, alcuni poeti per rammentarci la condizione della poesia contemporanea e per ricalcare la necessità di badare bene a quali materiali fare ricorso per non ricadere, ancora nel soggettivismo, nel lirismo, nell’eufonia, ecc., hanno evocato la Venere Callipigia, riprodotta in cemento da Pistoletto, nel 1967, e diventata un’ icona. La Venere, simbolo della bellezza, volgendo le spalle al pubblico adocchia ironica, ai suoi piedi, un caotico accumulo di panni, richiamo al consumismo della società contemporanea. Questa Venere riassumerebbe l’urgenza inderogabile che l’arte ritorni a confrontarsi con la vita e con le sue frenetiche e contraddittorie e ambigue trasformazioni, con ciò che ha prodotto: scampoli, stracci, residui! Accanto a questa interpretazione a me piacerebbe accostarne un’altra… l’opera di Pistoletto evidenzia le spoglie, i lacerti e i rimasugli che sciabordano sulle battigie del Mediterraneo, tutto ciò che resta di chi ha attraversato quel mare, “… da cui vergine nacque / Venere” e che ora, diventato palus putredinis, si impregna di disperazione e sofferenze. Ricordate la “Profezia” del Pasolini di “Il libro delle croci”? (P.P. Pasolini, Poesia in forma di rosa, Garzanti, 1964, pp. 93-99)
Era nel mondo un figlio
e un giorno andò in Calabria:
……………………………..
Alì dagli occhi azzurri
uno dei tanti figli di figli,
scenderà da Algeri, su navi
a vela e a remi. Saranno
con lui migliaia di uomini
………………………….
Sbarcheranno a Crotone o a Palmi,
a milioni, vestiti di stracci
asiatici, e di camicie americane.
Subito i Calabresi diranno,
come malandrini a malandrini:
«Ecco i vecchi fratelli,
coi figli e il pane e formaggio!»
Da Crotone o Palmi, saliranno
a Napoli, e da lì a Barcellona,
…………………………………..
andranno come zingari
su verso l’Ovest e il Nord
con le bandire rosse
Eravamo nel primo quinquennio degli anni ’60 e Pasolini aveva profetizzato: questa parte meridionale dell’Occidente non sarà più come prima! Africani e calabresi, da vecchi fratelli, condividendo lo stesso pane e lo stesso formaggio, andranno come zingari, verso l’Ovest e il Nord, a sventolare le bandiere rosse della nuova storia…
Nel 1964 di Pasolini avevo 14 anni, nel 1967 di Pistoletto 17, e i miei paesani, i miei fratelli, mio padre e mia madre, anche senza la compagnia degli algerini, erano già sulle strade del mondo e, come loro, altre migliaia di calabresi, da un decennio circa. Nel Meridione non si respirava. Alle diaspore dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento ne seguivano altre. E se prima il mondo meridionale riusciva a ricomporsi e a ritrovare un equilibrio fra partenze e ritorni, dopo gli anni ’50 quell’instabilità si è frantumata; quella civiltà si è disintegrata, quel territorio geografico, spirituale e linguistico non ha retto più! Afferma ancora Pasolini:
Tre millenni svanirono
non tre secoli, non tre anni, e si sentiva di nuovo nell’aria malarica
l’attesa dei coloni greci. Ah, per quanto ancora, operaio di Milano,
lotterai solo per il salario? Non lo vedi come questi qui ti venerano.
Quasi come un padrone (cit. pag. 95)
L’ipotesi gramsciana della pari dignità tra la classe operaia del Nord e ceti contadini del Sud smottava, cominciava a evidenziarsi e a solidificarsi quel bisogno di salario e di consumo in cui il Meridione si schiavizzava già dai primi anni del ’50. Ecco la nuova inclinazione, il nuovo pendio del franamento: all’originale sole del Sud si sovrapponeva e si sostituiva il “meraviglioso sole del Nord”. Ed io che seppellivo quotidianamente la dolorosa acredine delle separazioni e dei distacchi, la solitudine della coscienza nella precarietà dell’esistenza, la selvaggia fraternità del sangue e dei legami familiari, cominciai a sbirciare nei “porcili senza porci”, sulle “radure color delle feci”, sulle case dirupate dai terremoti e svuotate dall’indigenza, “tra frigorifero e televisione”, nei miei stessi occhi e negli sguardi di chi mi guardava e vi trovai la presenza della morte e della dissoluzione, la ferocia e l’indelebile dolcezza degli uomini e delle donne, lo slancio vitale e l’esaltazione vigorosa o mortifera della natura. In una poesia giovanile urlavo al mondo e a me stesso:
Dimenticare ogni albero
di questa foresta
per liberarci dalla condanna degli avi!
Dimenticarci di tutto e di tutti… e seppellire il passato. Ma non poteva accadere e infatti non è accaduto. Non si possono “tranciare di netto le proprie radici solo perché si vuole inseguire il fantasma di una utopia rivoluzionaria, senza radici siamo foglie inaridite, rami secchi” su cui vagano soltanto le formiche e su cui si riversano le ombre dei morti. Degli uccisi e degli uccisori. Lo ricordava bene Carlo Levi attraverso “lu campusantaru”, il custode del cimitero di Gagliano: “Il paese è fatto delle ossa dei morti!” È realtà o metafora? I nostri paesi sono fondati, costruiti, impastati e mantenuti ancora in piedi dalle ossa dei nostri morti. Le ossa di ieri non sono altro che “gli stracci asiatici e le camicie americane”, di Pasolini e di Pistoletto di oggi.
E tra quegli stracci, a ben rovistare, ci stanno ancora i flatus voci, i mugolii e i singhiozzi, le imprecazioni e tutto ciò che era stato parola. E, ancora, in un vaneggiamento giovanile, questa volta in dialetto, mi ponevo il problema: che farne delle parole antiche in cui sentivo l’amaro del chinino, di quel chinino che i governi Giolitti avevano fatto ingoiare ai miei genitori per sconfiggere l’endemica malaria? Perché quelle parole gravavano sulle mie e sulle altrui spalle come un peso, come una macina di mulino che mi affondava, come un richiamo fatale che mi risucchiava negli echi dei secoli trascorsi. La mia risposta? Avere un paniere, cavo e capiente, e andare in giro a raccoglierle e poi bruciarle “nta lu mundizzaru”, nell’immondezzaio! Soltanto così, pensavo, sarei ritornato a confrontarmi “cu lli vivi”, con i viventi, piuttosto che rimanere ingessato e impagliato nelle larve degli avi!
Vorisse pe’ mmu tiegnu nu panaru
cupu e cchjù fuondu de na menzalora
ed intra mu vi jiettu ogni palora
chi cca sucai de quandu m’addhattaru.
Vorrei possedere un paniere
cavo e più profondo di mezzo tomolo
ed entro buttarvi tutte le parole
che qui ho succhiato da quando mi hanno allattato.

Mariella Colonna, pittura, Realismo magico
Questa la mia illusione! Distruggere tutto! Anche il gergo dialettale che mi turbava perché simbolo di sottomissione. E poi? Qualcosa sarebbe sorto e rinato! Bastava solo attendere… e attendere…
“Bubbole!” avrebbe risposto l’Ungaretti interventista dopo gli anni di trincea.
“… pareva che la guerra s’imponesse per eliminare finalmente la guerra. Erano bubbole, ma a volte gli uomini si illudono e si mettono in fila dietro alle bubbole.” (G. Ungaretti, Poesie, Ed. Corriere della Sera,, pag. 273)
Anch’io, come tanti altri giovani, mi ero messo in fila dietro alle “novissime” bubbole provocando un corto circuito fra la contemporaneità e il passato, fra i giovani e i vecchi. D’altronde tutti noi, chi più chi meno, abbiamo tentato di “uccidere” i nostri padri per sottrarci al loro controllo, per prendere il loro posto e per individuare noi stessi come soggetti su cui costruire un mondo nuovo…
purtroppo abbiamo fallito. Non ci siamo riusciti e in questa “vacatio” di salvezza ci siamo ridotti a vivere come esiliati, senza suolo e senz’anima, senza lingua e senza parole… non dovevamo uccidere i nostri padri, ma andare alla loro ricerca, non dovevamo cancellarli e annullarli perché antiquati e reazionari, ma collegarci alle loro speranze, alle loro fatiche, alle loro radici. Ricordate il giovane Telemaco? Ebbene, invece di affrontare i rischi di una navigazione incerta per incontrare questi padri ingobbiti in qualche luogo ignoto, abbiamo preferito sopravvivere a noi stessi, chiusi e piantati nella supponenza maledicendo la loro ignoranza e la loro atavica ottusità. Dovevamo, invece, cercarli questi padri: assalire il mondo, ma ancorati alle loro braccia. Abbiamo voluto essere figli senza progenitori ed oggi ne paghiamo le conseguenze.
Corrado Alvaro, nel 1930, in relazione al romanzo Gente d’Aspromonte affermava che la “nostra civiltà contadina era destinata a frantumarsi sotto la spinta del progresso nazionale…ma di questo mondo in disfacimento era necessario conservarne la memoria…”. Conservarne la memoria! Certo! Ma non basta. La memoria non è una foto ingrigita dal tempo da riguardare ogni qualvolta si voglia evocare il passato… che valore ha la rimembranza se questa non entra a far parte della nostra esistenza e della nostra storia individuale e collettiva? Storia! Ecco la chiave.
Ma Storia in che senso? Come “historia rerum gestarum”? Come “storia monumentale”? Come “storia antiquaria”? No! Avvicinandomi alla carne, alle parole e ai gesti della mia gente, a me è stato più facile considerare la Storia come “Memoria collettiva della quotidianità”, come affermava magnificamente Ferrarotti nel saggio Storia e storie di vita ( pag. 13, Laterza, Bari, 1981). E quindi come coscienza critica del presente e del passato e “come premessa operativa per il futuro”. “…storia, affermava il filosofo siciliano Bufalino, non è solo quella degli annali del sangue e della forza: bensì quella legata al luogo, all’ambiente fisico e umano in cui ciascuno di noi è stato educato. Storia è il gesto con cui s’intride il pane nella madia o si falcia il grano; storia è un nomignolo fulmineo, (Totu Lu Rizzu, tanto per citare un attore di Arringheide, un proverbio accattivante : Pàrica nci tagghjaru la vigna,) la sagoma di una tegola…” (Gesualdo Bufalino, Museo d’ombre, Bompiani, Ed. 2000, pp. 21, 22). Allora, questo è stato il mio intento: ricostruire la storia del paese e della comunità, del territorio d’origine e delle sue vicende esistenziali sottolineando la loro ambigua e tragica “melodia quotidiana” elevandola, se possibile, ad un valore di carattere generale. Così, in modo spontaneo e senza forzature, tutti i miei momenti vissuti e tutti i momenti vissuti degli antenati “sono stati”, direbbe Calo Levi, “luoghi di vita” ed hanno contribuito a intessere una “foresta primitiva di ombre e di belve”, attraverso i frammenti della loro quotidianità, sempre in bilico, tra spaesamento e disordine, sotto l’imperversare delle lotte contro la fame, contro gli uomini e i santi, contro la natura e il destino, contro se stessi e gli altri. Ricordavo prima Corrado Alvaro. Ebbene, il suo paese natale, San Luca, è assimilabile al mio: San Pietro! I nostri luoghi sono e consistono perché qui tutti hanno un nome, un segno, un simbolo e solo qui sembra che sia possibile l’esistenza… l’altro mondo, quello esterno, lontano mille chilometri o cinque, è, invece, senza nome… è ostile, ha regole diverse; di quell’altro mondo non si sa niente… si preferisce ignorarlo… ha usi e costumi differenti e un linguaggio incomprensibile… si conferma, in ogni momento, l’assunto di Rohlfs: “La Calabria non costituisce né un’unità etnografica né un’unità linguistica” (G. Rohlfs, Nuovo dizionario dialettale…, Longo Editore, Ravenna 2010, pag. 10). In Calabria ciò che ci caratterizza non è la somiglianza, ma l’opposto. “In realtà mondi differenziati e comunicanti, complementari e opposti, coesistono… spesso all’interno di uno stesso spazio paesano. L’identità, nella società tradizionale, si è definita attorno a un luogo antropologico, non di rado in contrapposizione a un altro luogo, distante a volte soltanto centinaia di metri! I contrasti e le ostilità presenti in passato tra paesi limitrofi e all’interno di una stessa comunità… segnalavano l’esperienza e il vissuto degli individui, dalla nascita alla morte” (V. Teti, Quel che resta, Donzelli Ed.,2017, pp, 124-25).
Ecco l’altro tema del “poema”. La guerra che costituisce lo sfondo delle varie vicende si svolge all’interno di un territorio fisicamente ristretto, un angolo di Calabria, a ridosso delle colline, prospicienti il golfo di Lamezia. Tre paesi, tre comunità, tre appartenenze che, spesso e volentieri, si individuano in quanto differenti e contrapposti. Oggi quei confini geografici e spirituali non esistono più. “Si sono sfrangiati, dissolti, dilatati, dispersi” direbbe ancora Teti. Quegli spazi antropologici che evocavano ciò che è stato, quello che era un mondo, oggi si presentano sotto la forma dei frammenti e degli stracci. Per cui memoria e linguaggio, tradizioni e usanze, luoghi e panorami sono solo e soltanto reliquie. Ed io, come tutti gli altri calabresi “pellegrini permanenti, erranti, sradicati”, mi porto sulle spalle, ‘na vièrtula, una bisaccia traboccante di reliquie e dentro ciò che rumoreggia di più è proprio la lingua. “Quello che resta” del dialetto. Se in Italia negli anni ’50 l’agricoltura impegnava il 42,6 degli occupati, in Calabria la percentuale era di gran lunga superiore, rasentando il 90%. Ciò significava anche analfabetismo di massa. Oggi sembra che quella eterogeneità dialettale di cui parlava Rohlfs si sia lievemente addomesticata, dando luogo a un processo di italianizzazione. E sembra anche che la lingua italiana, aulica e di manzoniana memoria, si sia regionalizzata. Ma nel momento in cui avviene questa trasformazione non si produce anche il sentore sempre crescente della diversità e della divergenza della parlata originale rispetto alla classificazione linguistica nazionale? Ricordate le feroci polemiche, ancora di Pasolini, contro quella stessa televisione che, unificando il Paese, da Nord a Sud, azzerava le differenze dei patrimoni linguistici regionali? Io mi sono trovato sul crinale della scelta tra italiano e dialetto perché sempre più percepivo che il mio linguaggio nativo era destinato al macero. Di fronte alla plateale anonimia “dell’unificazione idiomatica” portata avanti dalla lingua italiana io ho avvertito un tremore nelle carni. Così mi sono rattrappito in me stesso e ho guardato la realtà linguistica di quegli anni con occhi nuovi. Mentre prima avevo nutrito un atteggiamento di sudditanza e di sottile ostilità nei confronti del dialetto perché lo ritenevo inadeguato incapace di introdurci al progresso civile e sociale, ora mi convincevo che non ci sarebbe stata né crescita, né affermazione dei diritti, né autonomia delle comunità locali se non riappropriandoci “del patrimonio storico locale” riutilizzando il dialetto. (Tullio De Mauro, Linguaggio e società nell’Italia di oggi, Ed. ERI, 1978, pag.150). Ormai mi era chiaro. Solo “salvando le parlate dialettali, riusciamo tutti a parlare italiano” (T. De Mauro, ivi, pag. 151).
Siamo arrivati alla fine. Arringheide è una metafora dell’esilio, dalla vita reale e dal linguaggio materno.
Un’ultima precisazione.
Se le parole, e mi riferisco a quelle dell’italiano, non hanno in sé la capacità e la forza di introdurre o di perseguire un senso, perché, allora, chiedere alle stesse ciò che non possono più elargire? E perché arrischiare lo stesso tentativo con quelle dialettali? Forse perché esse sono il sostrato dentro cui abbiamo accumulato, in forme e gradi differenti, ciò che siamo stati, ciò che siamo e forse, ciò che immaginiamo di diventare: un’esperienza individuale, la mia; e un’esperienza collettiva, quella della comunità di appartenenza! Dice bene Giorgio Linguaglossa e riassumo «i linguaggi non fanno più testo, essi sono diventati zattere significazioniste che restano in auge fin quando producono segni adatti alla lallazione del “reale”»(L’Ombra delle Parole, rivista on line) “Zattere” di Parole, sia italiane che gergali, assimilabili a reliquie, alle reliquie delle nostre radici, come orme di sopravvivenza, nonostante la distruzione. La lacerazione ci ha contagiato tutti, direttamente e indirettamente; il soggetto è frantumato e non può far altro che fluttuare come un’alga. “Stamani mi sono disteso/ in un’urna d’acqua/ e come una reliquia/ ho riposato” affermava l’Ungaretti dell’Isonzo da allora la nostra condizione è quella della reliquia: senza sangue, senza vita e senza riposo: e, tuttavia, continuiamo a erodere del tempo, ad impossessarsene, a imporci come assenza e come presenza, come memoria del tutto e delle parti. Tutto si consuma, nulla resta, ma noi persistiamo ancora, non scompariamo del tutto… anche se la vita genera assenza e morte, l’uomo resiste e ritorna continuamente ad essere. Il soggetto ha un carattere doppio: morire e vivere! E perciò è soggetto, ma anche oggetto di se stesso! E la letteratura? E il linguaggio? E l’arte?
“Elevare l’oggetto corroso dal tempo a un’icona che resiste al tempo, o meglio, rendere la sua stessa caducità la forma del suo essere per sempre” (M. Recalcati, Il mistero delle cose, Feltrinelli, 2016, pag. 38).
Questo è stato il mio tentativo! Riportare sulla scena della storia gli “scarti umani”, quelli che sono ammutoliti, gli scilinguati, e con essi i loro lacerti e i mugolii di una lingua esiliata nell’anonimia territoriale e spirituale di una cultura totalmente disfatta. I miei versi? Sepolcri!
Nullità! Ed intorno ad essi… “una danza di conigli” direbbe Montale! Forse sono stato anacronistico… ovvero “inattuale” e va bene! Lo ammetto! Mi conforta, però, quanto affermava il solito Nietzsche: “Ciò che è non storico e ciò che è storico sono ugualmente necessari per la salute di un individuo, di un popolo, di una civiltà.” (F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia, Adelphi, Mi,1974, pag. 95

Giuseppe Gallo
Canto XXI
1) …………………………………..
2) Soltanto nella casupola di Germonda
splende, ancora acceso, il lume ad olio
perché il marito, appoggiato alla sponda del letto,
tentava di eliminare il cattivo odore
dei piedi e si detergeva con l’acqua
e ripuliva le unghie ad una ad una.
3) “Ah, la fortuna mia! Tutto il giorno
attraverso e mi lancio per le vie e le strade di pietra,
suono la tromba, perdo il fiato, urlo e torno indietro,
e corro per le salite e le discese!
Quanta suola consumo e quanta pelle lascio
andando dall’Ospedale alla Scalella!”
4) “E perché ti lamenti? Ma non ricordi
quando la sera noi inghiottivamo amaro?/….
5) …/ Perché non pensi, invece, agli altri
che hanno vuoti le casse e i recipienti di terracotta,
che mancano di pane, fichi e legna da ardere/…?
6) “Hai ragione! Però, ricordatelo…
che quando morivo di fame
io mi rimpinzavo facendo l’amore
e mi saziavo con i tuoi seni.
Ora, stanco morto, mi addormento continuamente
e non te lo metto più dentro, come allora!”
7) Giuseppina nel buio diventò rossa,
ma poi si pone di fronte al marito
e, avvelenata, si rivoltò contro:
“Perché non parli, almeno, più educato?
Infili, ti sazi… Caro il mio Vito,
rimani sempre un fesso! Per quant’è vero Dio!
8) Tu sai suonare solo questa trombetta
dove è sufficiente soffiare e poggiare le labbra con la bava,
ma tu moglie da te altro si aspetta
quando acconsente che tu la palpeggi.
Che dico… due carezze, un bacio,
una parola dolce e delicata…
9) Tu, invece, veloce veloce, ti svuoti
e buchi e penetri con la fantasia.
Mi lasci fredda e poi, per giunta, te ne vanti pure.
Povero scemo! Sei solo uno stupido
se credi che a Germonda fa piacere
quando si sente fottere in questo modo!”
10) Vito rimase interdetto. Il piede nell’acqua,
la mano che non andava su né giù /…
quando udì che qualcuno bussava al piano inferiore.
11) A quel rumore la moglie tace/…
Cambia colore anche il marito,
lascia il letto, svuota il bacile
e urla fuori: “Chi è?”, in preda alla rabbia.
12) “Sono Pasquale! Ho qualcosa da comunicarvi!/…
13) Aprì la porta, allora, Serratore
e si adombrò ancora di più nel viso
perché il cuore gli sobbalzò nel petto
quando di fronte a sé ritrovò
non quel Pasquale per come lo conosceva
ma un’ombra ricoperta di sporcizia.

Ma come ti sei vestito? Da uomo in maschera?
14) “Ma come ti sei vestito? Da uomo in maschera?
Ti vuoi nascondere perché nessuno ti riconosca?
Chi hai ucciso? Vuoi, forse, un ricovero?
Sei uscito pazzo?” e cominciò a ridere.
“Guarda, Giuseppina! Siamo tornati a carnevale!”
Giuseppina guardò in direzione di Pasquale
15) e lo riguardò con il sacco teso
sulle spalle e i fianchi nudi.
.………… Allora la comare
cominciò a parlargli come una madre:
16) “Perché non entri, figlio mio, e ti siedi?
Vuoi lavarti per ritornare candido?
Butta via questi stracci! Te ne regalo puliti!
Vuoi un boccone caldo e saporito
di verdura ripassata in padella
o una fetta di pane e soppressata?”
17) “Ma no, comare, non preoccupatevi.
A casa toglierò la sporcizia e la polvere!”
E poggiando per terra il sacco: -Dai! Prendete
un piatto largo così vi lascio qualche anguilla!-/….
18) “Non sono venuto a notte fonda qui per me,
compare Vito, ma per chiedervi
se, all’alba, da Santa Maria
fino a Gornelli, avvisate col bando
che i Sampietresi devono stare all’erta
perché Minaparo e i Maidesi
19) sono già in agguato nei pressi della Madonnella
e chi vuole difendere il paese
deve armarsi di falci e coltelli
e scendere, di nascosto o alla luce del sole,
al Fiume, alla Quercia e a San Giovanni,
le donne, i figli, i padri di famiglia e più anziani!”
20) “Oh mamma mia! Che paura! Sei sicuro?”
e si strinse addosso lo scialle pesante./…
21) “Poveri noi!” sospirò il banditore,
“Se le cose stanno davvero in questo modo,
per quant’è vero che mi chiamo Serratore,
corro anche allo ‘Mpiano e a Vasì,
risveglio cani e maiali, chiocce e galli
e avviso giumente e cavalli!”
22) “Più siamo, più gli rompiamo le corna!”
rispose Pasquale e, intanto, nel piatto di creta
metteva le anguille, “Perché se noi vogliamo
li facciamo tornare nei porcili.
Però se siamo tutti… perché se qualcuno
fa marcia indietro, anche se loro sono
23) delicati, smidollati e lecca culi,
con il Conte alle montagne di Corda, e Minaparo giù alla marina,
ci tolgono ogni velleità e desiderio
perché a mezzogiorno ci hanno già squartati!”
“Madonna del Carmelo, perché
ci impaurisci così questa notte?”
24) “Io non vorrei, ma comare mia,
quelli veramente ci fanno a festa
se non abbandoniamo l’indifferenza
e non solleviamo, liberi, il capo!
È meglio crepare combattendo
che essere fregati da chi ci offende!”
25) “Tu”, gli rispose, “ancora sei un ragazzo,
la vita la conosci attraverso il suo odore!
Non hai assaggiato il fiele per sapere quant’è amaro
e quant’è faticoso strappare i giorni alla vita.
Alcune volte ti alzi dal letto
con la bocca impastata e con il petto,
26) spaccato a due come un fiorone,
ma ti basta udire una colomba
o intravedere un giglio delicato
e già il cuore si apre, ride e tumulta
e si accontenta. Ma se nella terra
infradici, sepolto, perché i ferri
27) hai brandito nell’aria insieme ai coltelli
contro i prepotenti, che cosa hai ottenuto?
Non è meglio ingoiare un po’ d’aceto
piuttosto che morie di sete? O no, Pasquale?”/….
28) “Comare, non capisco, cosa dite?
Secondo voi al Conte e a Minaparo,
per respirare, a questi banditi,
noi dobbiamo dare il culo e i soldi?/…

29) “Ah, mannaggia, Pasquale, qui per sopravvivere
ognuno deve scegliere come morire
e deve liquefarsi come fosse neve!
Che strada che ci ha aperto il Redentore!
Poteva rimanere insieme al Padre
invece di infastidire noi insieme a sua Madre!
30) Tanto, Pasquale, la storia è sempre quella:
nasci piangendo, aliti e ti addormenti,
ti bagni di sudore e soffochi nella polvere.
Parlano male di te gli amici e i parenti,
se hai fortuna ficchi qualche volta
e poi sono finite le messe cantate!”
31) “Ti sembra questa l’ora di parlare a vanvera?”
disse allora Giuseppina al marito,/…
32) “È colpa mia, comare, me ne vado
ciò che dovevo fare ormai l’ho fatto.
Se c’è bisogno sono da mia moglie!”
Prese il sacco, salutò gli amici,
scese dalla Scalella e salì alla cima
di San Marco, la testa piena
33) di parole, pensieri e fantasie.
Il buio, ormai, nascondeva le casupole
e il vento raccoglieva le immondizie.
Foglie, peli, paglie e ramoscelli
volteggiavano nell’aria e fra le porte
e tutt’intorno fra le pietre sconnesse.
34) “La vita nostra”, si lamentò Pasquale,
è come dice Vito: una ventata
che ci mette sottosopra dalle radici
e ci rovescia in messo alla strada di selci
e noi, come tanti scemi, vaghiamo di qua e di là
ma nessuno sa dov’è che andiamo a finire!”
35) Intanto appoggia il piede sullo scalino/…
36) Silenzioso, accende ai piedi della scala
la lanterna, si spoglia e poi la brocca
svuota nel bacile, si abbassa dentro
e strofina il petto, i fianchi, il collo e la testa.
“Oh, che fresco! Che consolazione…”
e gira gli occhi sulla visione,
37) sulla carne dura che ha forato,
che calda calda dorme senza pensieri
insieme alla carne tenera alla quale ha dato vita…
E fu la felicità un buco.
Ancora si puliva l’ inguine
quando una mano gli urta ciò che gli pendeva fra le gambe,
38) due fiammiferi gli bruciano la schiena
e la mente, di colpo, si accalora
perché Melina con la lingua sottile
ora gli lecca la pancia calda e dura,
e l’abbraccia, lo succhia e se lo preme addosso
e con le unghie lo graffia e lo punge.
39) “Marito mio, sei tornato! Per fortuna!
Senza di te non riesco ad andare avanti
perché secca ogni sorgiva, ogni fontana
e in Chiesa non ci sono più santi!
Anche tuo figlio piange e si rivolta
e mi strappa i panni e la gonna
40) ………………………………….
41) …………………………………
42) E dopo che Melina si attorcigliò
come intorno alle radici la vitalba,
spasimando, Pasquale la coprì
sotto la scala, accanto al paiolo di rame.
Tremarono le pareti divisorie, la brocca di creta,
la giara insieme allo staccio di vimini e alle ceste.
43) “Madonna mia,” si lamentò il guanciale
“è arrivato il terremoto in questa casa?”
E l’intestino ripieno del maiale che urtò un filare
di salsicce, mentre cercava di scostarsi,
gli rispose: “Ma no! Sono i padroni
che, ci rompono ancora i coglioni!
44) Non gli è bastato scannare la scrofa
e al porco pelare la pelle,
cuocerli come i fagioli stufati
e riempire a forza le budella
con la carte tritata e, a sezioni separate con lo spago,
appenderci tutti a queste altezze
45) sotto sopra, legati a questo graticcio di canne,
per asciugare al fumo e al vento?
E no! Questa razza meschina di affamati
ci tratta come i grappoli d’uva al palmento,
ci stringe con le canne, impepa, preme e in queste paure
ci aggiusta per le feste e per i giorni di lavoro.
46) …………………………………….
47) Ci affondano nell’olio e, non contenti,
sotto le pietre e sotto i coperchi
ci seppelliscono per mesi e guai se prendi aria
perché se così accade, per tutti, diventi inutile.
E ancora questo è niente perché poi, maturi,
ci affettano tutti a coltellate!”
48) ……………………………………
49) “Tutuh! Tutuh! Tutuh” grida la tromba
e nei rioni e fra le strade strette
come una bomba carta scoppia e rimbomba,
dalla Scalella fino all’Abbeveratoio.
Impaurisce la soppressata e un mucchio
di conserva rilascia per la paura.
50) “Adesso che c’è di nuovo? Cos’altro è accaduto?
È ancora l’alba! Come mai
Vito ha svegliato tutto San Marco ?
Sono notizie buone o cattive?”
“… e si avvisano tutti i paesani,
padri, moglie, ragazzi ed anziani:
51) i Maidesi sono alla Madonnella
e se non li fermiamo questa mattina
ci tagliano la gola e gli intestini
e ridurranno il paese in polvere!
Svegliativi! Presto! È venuta l’ora
di scendere al Fiume con urgenza!”
52) “Hai sentito?” riprese la soppressata
rivolta al guanciale giallognolo,
“forse per te e per noi questo giorno
potrebbe avere un finale a sorpresa
perché se i Maidesi sono più forti
e arrostiscono queste case e queste porte,
53) noi diventiamo liberi e tranquilli,
possiamo maturare in santa pace!”
Ma una salsiccia di quelle più secche:
-Hai il cervello- le disse -di un pettirosso!
Sicuramente Pasquale non ti ha messo addosso pepe sufficiente
e neanche Melina ha dosato bene il sale!
54) Guai a chi nella sfortuna non impara
altrimenti ciò che ci accade e avviene,
e lo dico per noi, lardi e salsicce,
costringe il destino a farlo ripetere.
È inutile piangerti addosso che sta per calare il buio
quando ti contorci perché ti friggono in padella!
55)……………………………………..
56) La nostra sorte è una e non si cambia!
Possono cambiare le forchette e i denti,
e chi ci arrostisce e odora e chi ci mangia:
affamati, sazi, in carne, grassi o magri!
Siamo salsicce, siete soppressate:
moriamo tutti quanti a morsi!”
57) “Tutuh! Tutuh! Tutuh!” suona la tromba
dalla Fontana fino a Catalano.
Mezzo paese, sembra che già rumoreggi
come il vento nel grano
e ognuno esce fuori, spia e grida
e si arma pure, se è ancora in forze.
58)………………………………….
59) …………………………………
60) “Oh! Mamma mia! Signore, che sventura”.
“Ci sono i Maidesi!” “Oh, Gesù Cristo!”
“E chi potrà salvarci da questo cattivo vento?”
E bussano alle porte e fugge questo
e poi quell’altro e scappa Antonio
e, avvolta nel panno pesante,
61) Mariuzza appare sul pianerottolo esterno,
gli occhi infossati, nera, spenta.
Fa qualche passo, scalza, e poi la mano
bianca, tremando, la lascia appoggiata
a un ramo di rosa
secca ancora di più dell’asparagina.
62) “Veramente, o Signore, non ti sazi mai!”
urla tra i vasi, “Adesso chi vuoi?
Non ti ti è bastato Smeraldo che ho sepolto?
I ragazzi che l’hanno preceduto e quelli successivi?
Adesso chi ti rubi? A quale madre tocca?
A quale figlio distacchi il cuore?”
63) ………….
64) …. / E Rosicella che sta masticando il fieno
a questi pianti smette di serrare le zanne
e comincia a sgolarsi e a ragliare
sopra la mangiatoia e tra la paglia.
65) “Calmati, asina!” le urla Focoso
con la bocca ancora colma di fieno,
“Con questo raglio da niente e nasale
sei la vergogna della razza equina!
Non è meglio se dormi e ti riposi
invece di buttare l’anima per cose di questo genere?”
66) Tu vuoi, da asina, fare l’umana?”
E Rosicella, in mezzo a quel buio,
disse al cavallo con molta calma:
“Tu non sai le carezze e quante furono!
Quanto mi riscaldavano il cuore
le strigliate e le cure di Smeraldo
67) e come mi saziavano le occhiate
quando mi allungava l’acqua e l’avena!”
Focoso, allora, gli occhi per terra:
“O sei ammalata, o pazza o gravida!
Già te l’ho detto! Ma quando impari
che sono nerbate anche le carezze?”
68) ………………………….
69) Altro che banda sul palco!
E razzi con bombe e batterie!
Altro che corvi nell’agrumeto
e contese e litigi per corna e pazzie:
era come il giorno dei morti
quando diventano femmine anche i maschi coraggiosi!
70) “Tutuh! Tutuh! Tutuh!” la tromba chiama
e di sopra Fabiano alla Vianova
si sveglia chi va in campagna e chi ricama.
“Sampietresi, ascoltate la novità:
i Maidesi sono a San Giovanni!
Alzatevi, ragazzi e vecchi!
71) Impugnate con le roncole e le falci
e scendete alla Cerza e sotto Zicca!
Tagliamogli la testa a questi fanfaroni
e facciamola seccare questa razza!”
E dalle porte scure e rovinate
escono fuori anche gli ammalati.
72)…………………………….
73) E Ciccio Piedenero già scuote
nell’aria il falcetto appuntito.
Il Monaco gli cammina al fianco
e i santi che prima aveva pregato
li discende dal cielo tutti sulla terra
e insieme a mastro Giando li sotterra.
74) Tita, la grassa, dondola il sedere
e Suverato con le narici fumanti,
inciampando, cieco, e sempre solitario
bastona le scale e le porte.
Il Mùgnolo, la giacca sul braccio,
alzava la mano indenne con l’ascia.
75)……………………………………..
76) Udendo che nel rione c’è tumulto
Natalinuzza, dal pagliericcio,
si alza all’improvviso e in camicia da notte,
mette la testa fuori il balcone.
“Beh! Che accade? Dov’è che correte
con queste facce da fantasmi e da banditi?”
77) “E parli proprio tu, vecchia fradicia”
innervosito le risponde l’Anguillaro
che, anzianotto, in mezzo alla discesa
si era fermato per rifiatare, nel luogo adatto.
“Ma ti sei lavata bene, questa mattina,
o hai usato la cera per le scarpe al posto del sapone?”
78) “Se io mi sono alzata nervosa, tu senza cervello!
Con te il Padreterno ha sbagliato,
quando sei nato, perché della civetta
ti ha dato gli occhi, il naso e il becco.
Nelle fasce dovevi affogare
e dal seno succhiare veleno!”
79) ……………………………………….
80)………………………………………..
81) “Tutuh! Tutuh! Tutuh!” la tromba squilla
e il paese in ogni dove
come una botte sembra che risuoni.
“Armatevi di asce e di forconi,
ogni zappa fatela mannaia
ed ogni braccio fucile che spari!”
82) Come i passerotti, al mattino,
alle prime luci, si risvegliano
e, scuotendo le ali e la rugiada,
a frotte, cinguettano negli orti
allo stesso modo, i Sampietresi corrono al Fiume
e negli occhi hanno il sangue come luce.

Antonio Ligabue
Canto XXI
Vitu Serratore è tornato a casa dopo una giornata trascorsa a percorrere in lungo e in largo il paese. Fa il banditore. Con i piedi nell’acqua, rammenta i tempi della fame quando poteva far l’amore a piacimento. Ora, lavorando, è sempre stanco. La moglie lo riporta alla realtà. Qualcuno bussa: è Pasquale che gli racconta dei Maidesi alla Madonneddha e della necessità di avvisare, all’alba, i Sampietresi. Pasquale sale a casa, ritrova la moglie Melina e il figlio. I due fanno l’amore, ma la loro foga sveglia dal torpore “lu magularu” , “li sozizza” e “li suppressati” che si lamentano del loro destino: prima vengono macellati e affumicati, poi “mpenduti” a maturare per essere, infine, consumati “a muzzicati”. All’alba la tromba di Vitu “arribeddha” ogni ruga e il paese corre allu “Hfjume” e alli “Gurnieddhi” per fermare l’avanzata dei nemici.
1 )………………………………….
2 )Sulu nta la caseddha de Germonda
luce, appicciata ancora, la lumera
cà lu maritu, appojatu alla sponda,
cercava mu si leva lu culera
de li piedi e cu ll’acqua si stricava
e l’unghji, ad una ad una, pulizzava.
3 ) “Ah, la fortuna mia! Tuttu lu juornu
tagghju e mi minu pe’ rughi e ‘mpetrati,
suonu la trumba, spiatu, gridu e tuornu
e curru pe’ sagghjuti e pe’ calati!
Quanta sola cunzumu e quanta peddha
dassu de lu Spitale alla Scaleddha!”
4 ) “Chi ti grumiji? Ma no ti ricuordi
quandu la sira nui ‘nghjuttiamu amaru?/…
5 )… /Pecchì no pienzi, mbece, all’atri aggienti
ch’hanu vacanti cascia e salature,
chi mancanu de pane, hficu e ligna/…?
6 ) “Hai ragiune! Però, ricordatilu…
ca quandu pe’ lla hfame spachijava
io mi gurdava de cunnu e de pilu
e cu lli minni tue mi sazzijava.
Mo, stancu muortu, sempe m’addormientu
e, cuomu tandu, cchjù no ti lu mientu!”
7 )Peppina nta lu scuru arrussicau,
ma pue si para avanzi allu maritu
e, ‘mbilenata, cuntra si votau:
“Pecchì no parri, armenu, cchjù pulitu?
Mienti, ti gurdi… Caru Vitu mio,
si ssempre hfissa! Quant’è bberu Ddio!
8 )Tu sai mu suoni sulu sa trumbetta
duve basta mu hfjuffhji e mu vaviji,
ma mugghjerta de tia atru s’aspetta
quandu accunzente pe’ mmu la maniji.
Chi dicu… dui carizzi, na vasata,
na paloreddha duce e delicata…
9 )Tu, mbece, lestu lestu, ti divachi
e grupi e pierci cu lla fantasia.
Mi dassi fridda e, pue, puru t’annachi.
Pòvaru cunnu! Sini alla ciotia
si cridi ca a Grmonda hfa piacire
quandu si sente, d’accussì, hfuttire!
10)Vitu restau! Lu pede ‘mmienzu all’acqua,
la manu chi no jìa supa né sutta/…
quandu ntise ca ncunu jusu vatte.
11)A chiddhu sgrusciu ammuta la mugghjere/…
Cangia culure puru lu maritu,
dassa lu liettu, jetta lu vacile
e grida hfore: “Cuè?” , chjinu de bile.
12) “Sugnu Pasquale! Tiegnu n’ambasciata!/….
13)Apriu la porta, allora, Serratore
e nta la hfacce de cchjù s’adumbrau
cà nta lu piettu nci saddau lu core
quandu davanzi propiu si trovau
no Pasqualieddhu cuomu canuscia
ma n’umbra mascarata de lordia.
14) “Ma cuomu ti conzasti? De hforzaru?
Vue mu t’ammucci nuddhu mu ti vide?
A cu ammazzasti? Vue, hforzi, riparu?
Nescisti pacciu?” e cuminciau mu ride.
“Guarda, Peppi’! Tornammi a carnevale!”
Peppina si votau mberu Pasquale
15)e lu mirau cu llu cermieddhu tisu
supa li spaddhi e li hfjanchi alla nuda.
……………./ Allora la cummare
cuomu na mamma cuminciau a parrare:
16) “Pecchì no trasi, hfigghu mio, e t’assietti?
Vue mu ti lavi e mu tuorni pulitu?
Jetta sti hfaddi! Ti li dugnu nietti!
Vue nu vuccune caddu e sapuritu
de minestra de nterra, stranghijata,
o na hfeddha de pane e suppressata?”
17) “Ma no, cummare, no bbi preoccupati.
Alla casa mi lievu tarchju e piddha!”
E calandu lu saccu: “Dah! Pigghjati
na limba ca vi mientu ncuna angiddha!”/…
18) “No mbinni, a notte hfonda cca pe’ mmia,
cumpare Vitu, ma mu vi dumandu
si, a hfacca l’arva, de Santa Maria
alli Gurnieddhi jettati lu bandu
mu stannu all’erta li Santipetrisi
cà Minaparu, cu lli Majidisi,
19)già s’appostaru nta la Madonneddha
e cu vo’ mu difende lu paise
hfa pe’ mmu s’arma de hfaci e curteddha,
mu scinde, all’ammucciuni o alla ‘mpalise,
allu Hfjume, alla Cerza e nta Sangiunni,
hfimmini, hfigghji, patri e catananni!”
20)”Oh mamma mia! Sbavientu! Sìi sicuru?”
e ncuoddhu si stringiu lu vancaleddhu./…
21)”Pòvari nui!” hfjatau lu banditore,
“Si lli cuosi de vieru su’ accussì,
quant’è bberu ca vaju Serratore,
curru puru allu ‘Mpianu e nta Vasì,
rivigghju cani e puorci, hfjuocchi e gaddhi
ed arribbieddhu jumienti e cavaddhi!”
22)”Cchjù simu, cchjù li corna nci rumpimu!”
ncisse Pasquale e, ‘ntantu nta la limba,
mentia l’angiddhi, “Cà si nui volimu
hfacimu pe’ mmu tornanu alla zzimba.
Però, si simu tutti… cà si ncunu
si tira arrietu, puru s’iddhi sunu
23)unghji muoji, scunnati e liccaculi,
lu Conte, a Corda, e sutta Minaparu,
ni hfanu mu ni pàssanu li guli
cà a menzijuornu già ni scrapentaru!”
“Madonna de lu Carminu, pecchì
n’appaguri stanotte d’accussì?”
24)”Io no borisse, ma cummare mia,
chissi de vieru ni hfanu la hfesta
si non abbandunamu l’apatia
e non azamu, libbari, la testa!
E’ miegghju si crepamu cumbattiendu
ca mu ni hfutte cu ni sta sputtiendu!”
25)”Tu” nci rispuse, “ancora sii cotraru,
la vita la canusci pe’ l’adduru!
No provasti lu hfele quant’è amaru
e lu tirare avanti quant’è duru.
Certi vuoti ti lievi de lu liettu
cu lla vucca ‘mpastata e cu llu piettu,
26)cuomu na hficu bìhfara hfjaccata,
ma ti basta mu sienti na palumba
o mu spiji nu gigghju delicatu
chi già lu core s’apre, ride e rumba
e si cuntenta. Ma si nta la terra
ti ‘mpradici, orvicatu, cà li hferra
27)minasti all’aria nzema alli curteddha
cuntra li prepotenti, chi ti vale?
Non è miegghju mu ‘nghjutti st’aciteddha
ca mu muori de site? O no, Pasquale?”/…
28) “Cummare, no capisciu, chi diciti?
Sicundu vui allu Conte e a Minaparu
mu rihfjatamu, avimu a sti banditi,
mu nci n’hamu lu culu e lu dinaru?/…”
29) “Ah, mannaja, Pasqua’, cca mu si vive
ognunu ha pe’ mmu scegghje cuomu more
ed ha mu squagghja cuomu hfusse nive!
Chi strata chi n’apriu lu Redentore!
Si nda potia restare cu llu Patre
mbece mu sconza a nnui nzema alla Matre!
30)Tantu, Pasqa’, la storia è sempe chiddha:
nasci ciangiendu, aliji e t’addormienti,
grundi suduri e t’affuchi de piddha.
Ti chjatanu l’amici e li parienti,
si ti va bona ti hfai dui hficcati
e pue hfiniru li missi cantati!”
31) “Ti pare chista l’ura mu vaviji?”
ncisse Peppina, allora, allu maritu,/…
32)”E’ curpa mia, cummare, mi nda vaju,
chiddhu chi avia mu hfazzu, ormai, lu hfici.
Si nc’è bisuognu cu mugghjerma staju!”
Pigghjau lu saccu, salutau l’amici,
scindiu de la Scaleddha e alla curina
de Sammarcu sagghjìu, la crozza chjina,
33)de paluori, penzieri e fantasìi.
Lu scuru, ormai, ammucciava li casieddhi
e ricogghjìa lu vientu hfetenzìi.
Pàmpini, pili, hfamazzi e cimieddhi
ciolavanu nta l’aria e nta li puorti,
e ‘ngiru ‘ngiru nta li straci stuorti.
34) “La vita nostra” si lagnau Pasquale,
“è cuomu dice Vitu: na ventata
chi ni scumbina de nta lu pedale
e n’azzumbula ‘mmienzu alla ‘mpetrata
e cuomu tanti cunni nui scappamu,
ma nuddhu sa duv’è chi ni nda jamu!”
35)’Ntantu lu pede appoja allu scalune,/…
36)Cittu, appiccia alli piedi de la scala
la lanterna, si spogghja e pue la vozza
sbaca nta lu vacile, intra si cala
e strica piettu, hfjanchi, cuoddhu e crozza.
“Oh, chi rifriscu! Chi conzolazione…”
e vota l’uocchji mberu la visione,
37)mberu la carne tosta chi grupau,
chi cadda cadda dorme sprecurata
nzema allu tennarume chi criau…
E fu la cuntentizza na perciata.
Ancora si stujava li ‘ncinagghji
quandu na manu nc’iurta li pendagghji,
38)nci vrushjanu dui abbàttari la schina
e la mente, de botta, si ‘ncalura
cà Melineddha cu lla lingua hfina
mo nci licca la panza cadda e dura,
e l’abbrazza, lu suca e si lu munge,
e cu l’unghji lu grascina e lu punge.
39)”Maritu mio, tornasti! Menumale!
Senza de tia no puozzu jire avanti
cà sicca ogni surgiva, ogni cannale
e nta la Chjìesa no nci su’ cchjù santi!
Puru hfìgghjutta ciange e s’arribbeddha
e mi tira li hfaddi e la gunneddha
40)…………………………………..
41)………………………………….
42)E doppu chi Melina si torciu,
cuomu ‘ntuornu alla comba, la ligara,
spasimandu, Pasqua’ la cuveriu
sutta la scala, accantu alla coddara.
Tremaru li ‘ntalati e li lancieddhi,
la giarra cu llu crivu e li cistieddhi.
43) “Madonna mia,” ciangiu lu magularu
“vinne lu terramuotu nta sta casa?”
E l’orva chi truzzau cu nnu hfilaru
de sozizza, cercandu mu s’arrasa,
nci rispundiu: “Ma no! Su’ lli patruni
chi ni rumpenu ancora li cugghjuni!
44)No nci bastau mu scannanu la scrufa
e allu verre mu pilanu la peddha,
mu li còcenu cuomu posa tufa
e mu nc’inchjenu a fforza li gudeddha
cu lli carni accijati e, a stagghjatini,
mu ni ‘mpendenu tutti a sti curini
45)a capusutta, a st’anditu ligati,
mu asciucamu allu hfumu ed allu vientu?
E no! Sta razza loffia de ‘ncamati
ni tratta cuomu zzuppi allu parmientu,
ni ‘ncanna, mpipa, pressa e nta li schjanti
n’acconza pe’ lli hfiesti e laguranti.
46)…………………………………
47)N’affòndanu nta l’uogghju e, no cuntienti,
sutta li pietri e sutta lu cuvierchju
n’orvicànu pe’ misi e guai si sbienti
cà s’è accussì, pe’ tutti, sìi suvierchju.
E ancora è nente cà pue, maturati,
n’affeddhìjanu a tutti a curteddhati!”
48……………………………………….
49)”Tutuh! Tutuh! Tutuh” grida la trumba
e nta li rughi e ‘mmienzu alli carrieri
cuomu lu tric-trac scoppia e rimbumba,
de la Scaleddha hfina allu Bivieri.
Schjanta la suppressata e na caterva,
pe’ lla pagura, perde de cunzerva.
50)”Mo chi ni mbinne? C’atru capitau?
E’ ancora hfjacca l’arva! Cuomu mai
tuttu Sammarcu Vitu rivigghjau?
Su’ buoni nuovi oppuru sunu guai?”
“… e s’abbisanu tutti li paisani,
patri, mugghjieri, cotrari ed anziani:
51)li Majidisi su’ alla Madonneddha
e si no lli hfermamu stamatina
ni tagghjanu la gola e li gudeddha
e fanu lu paise na cacina!
Rivigghjativi! Lestu! Vinne l’ura
mu calamu allu Hfjume cu premura!”
52) “Sentisti?” rihfjatau la suppressata
‘mberu lu magularu gialinusu,
“hforzi pe’ ttia e pe’ nnui chista jornata
po’ avire nu hfinale curiusu
cà si lli Majidisi su’ cchjù fuorti,
e abbruschjanu sti casi e chisti puorti,
53)nui, diventandu libbari e squetati,
potimu maturare ‘nsanta pace!”
Ma nu sozizzu, de li cchjù siccati:
“Hai lu cervieddhu” ncisse, “de ruvace!
Certu no ti ‘mpipau bona Pasquale
e né Melina t’aggiustau de sale!
54)Guai a cui nta la sportuna no si ‘mbizza
ca chiddhu chi ni càpita e succede,
e lu dicu pe’ bbui, lardu e sozizza,
hfa lu distinu mu vene de pede.
E’ inutile ca ciangi ca ti scura
quandu ti tuorci ‘mmienzu alla frissura!
55)…………………………………….
56)La sorte nostra è una e no si cangia!
Puonu cangiare li bruocchi e li dienti,
e cu n’arrusta e addura e cu ni mangia:
‘ncamati, gurdi, chjatti, grassi o lienti!
Simu sozizza, siti suppressati:
morimu tutti quanti a muzzicati!”
57)”Tutuh! Tutuh! Tutuh!” sona la trumba
de la Hfuntana hfinu a Catalanu.
Mienzu paise, pàrica, già rumba
cuomu lu farfarieddhu nta lu ranu
e ognunu nesce hfore, spija e grida
e s’arma puru, s’ancora si hfida.
58)……………………………………..
59)………………………………………
60) “Oh! Mamma mia! Signure, chi sbintura”
“Nci su’ li Majidisi!” “Oh, Gesù Cristu!”
“E cu ni sarva de stu malu vientu?”
E vattenu alli puorti e fuje chistu
e pue chiddh’atru e scappa Totarieddhu
e, arrumbulata nta lu vancalieddhu,
61)Mariuzza affaccia supa lu vignanu,
l’uochji dui hfuossi, nigura, astutata.
Hfa ncunu passu, scaza, e pue la manu
janca, tremandu, la dassa appojata
a nna cimeddha de pijuonicara
tosta cchjù ancora de la sparacara.
62) “Certu, Signure, no ti gurdi mai!”
‘mmienzu alli grasti grida, “Mo cu vue?
No ti bastau Smeraddu chi orvicai?
Li cotrari de prima e l’atri, pue?
Mo cu’ ti arruobbi? Quale mamma tuocchi?
A quale hfigghju lu core nci stuocchi?”
63)…………………………………….
64)… / E Rosiceddha chi sta russicandu,
a sti chjanti li zzanni cchjjù no serra
e ncigna pe’ mmu abbrahfa e pe’ mmu ragghja
supa la mangiatura e nta la pagghja.
65) “Quètati, ciuccia!” nci grida Focusu
cu lla vucca de hfienu ancora chjina,
“cu stu ragghju de cazzu e mungarusu,
sii la virgogna de la razza equina!
Non è miegghju mu duormi e mu ripuosi
ca l’anima mu jietti pe’ sti cuosi?”
66)Tu vue, de ciuccia, mu hfai la cristiana?”
E Rosiceddha, ‘mmienzu a chiddhu scuru,
nci disse allu cavaddhu, chjana chjana:
“Tu no ssai li carizzi e quanti hfuru!
Quantu lu core mi hfacianu caddu
li strigghjati e li curi de Smeraddu
67)e cuomu sazzijavanu l’occhjati
quandu cu ll’acqua mi porgia l’avena!”
Focusu, allora, cu ll’uocchji calati:
“O sii malata, oppuru paccia o prena!
Già ti lu dissi! Ma quandu ti ‘mbizzi
ca su’ nervati puru li carizzi?”
68)………………………………..
69)Atru ca banda supa de lu parcu!
E furguli cu bumbi e batterìi!
Atru ca carcarazzi nta lu barcu
e ‘mbrighi e lizzi pe’ corna e paccìi:
era cuomu lu juornu de li muorti
quandu hfimmini su’ l’uomini hfuorti!
70) “Tutuh! Tutuh! Tutuh!” la trumba chjama
e de Supa Hfabianu alla Vianova
si rivigghja cu marcia e cu ricama.
“Santipetrisi, sentiti sta nova:
li Majidisi sunu nta Sangiuanni!
Azàtivi, cotrari e catananni!
71)’Mpugnati cu lli runchi li hfaciuni
e scinditi alla Cerza e sutta Zzicca!
Tagghjamunci la testa a sti spaccuni
e sta razza hfacìmula mu sicca!”
E de li puorti scuri e smendulati
nescenu all’aria puru li malati.
72)………………………………
73)E Cicciu Piediniguru già mina
nta l’aria nu cuzzune appizzutatu.
Lu Mònacu allu hfjancu nci camina
e li santi, chi prima avia pregatu,
li cala de lu cielu tutti ‘nterra
e nzema a mastru Giandu li sutterra.
74)Tita, la grassa, s’annaca lu culu
e Suveratu cu lli naschji stuorti,
stroppicandu, cecatu, e sempe sulu,
pigghja a tocciati li scali e li puorti.
Lu Mugnulu, a nnu vrazzu la giacchetta,
ma culla manu bona aza l’accetta.
75)………………………………….
76)Sentiendu ca la ruga s’arribbeddha
Natalinuzza, de nta lu saccune,
a nna vota si leva e ‘ncammiseddha,
mente la testa hfore lu barcune.
“Mbeh! Chi succede? Duv’è chi curriti
cu sti hfacci de spirdi e de banditi?”
77) “E parri propiu tu, vecchja mpurruta”
urtatu nci rispunde l’Angiddharu
chi, vecchjarieddhu, ‘mmienzu alla scinduta
si hfermau mu rihfjata, nta lu mparu.
“Ma ti lavasti bona, stamatina
o pe’ sapune usasti cromatina?”
78) “S’io m’azai storta, tu senza cervieddhu!
Cu ttia lu Patetiernu la sgagghjau,
quandu nescisti, cà de cuccuvieddhu
l’uocchji, la naschja e lu pizzu ti n’hau.
Avivi nta li fasci mu t’affuchi
e de la minna vilenu nu suchi!”
79)……………………………………..
80)……………………………………..
81)”Tutuh! Tutuh! Tutuh” la trumba sona
e lu paise a tutti li puntuni,
cuomu na gutta, pàrica, rintrona.
“Armativi d’accietti e de hfurcuni,
ogni zzappa hfacitìla mannara
ed ogni vrazzu scupetta chi spara!”
82)Cuomu li passarieddhi, la matina,
‘mmienzu alli primi luci, si rivigghjanu
e, scuotulandu l’ali e l’acquazzina,
a murri nta l’ortali, pigulijanu
li Petrisi, accussì, vannu allu Hfjume
e nta l’uocchji lu sangu hanu pe’ lume.













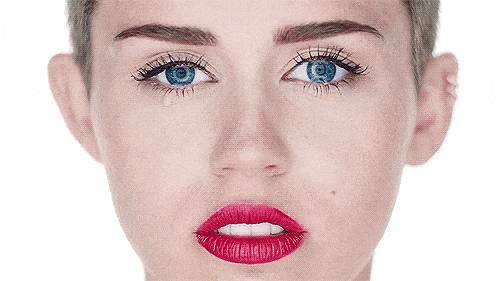
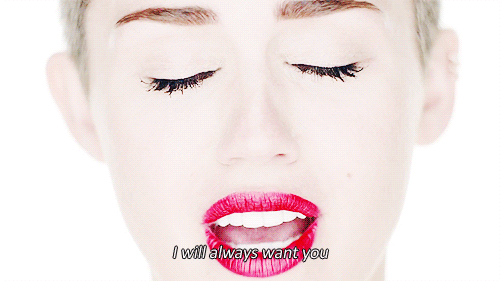


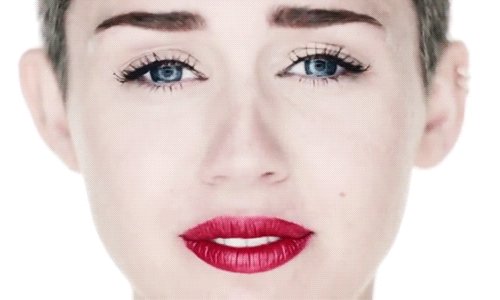








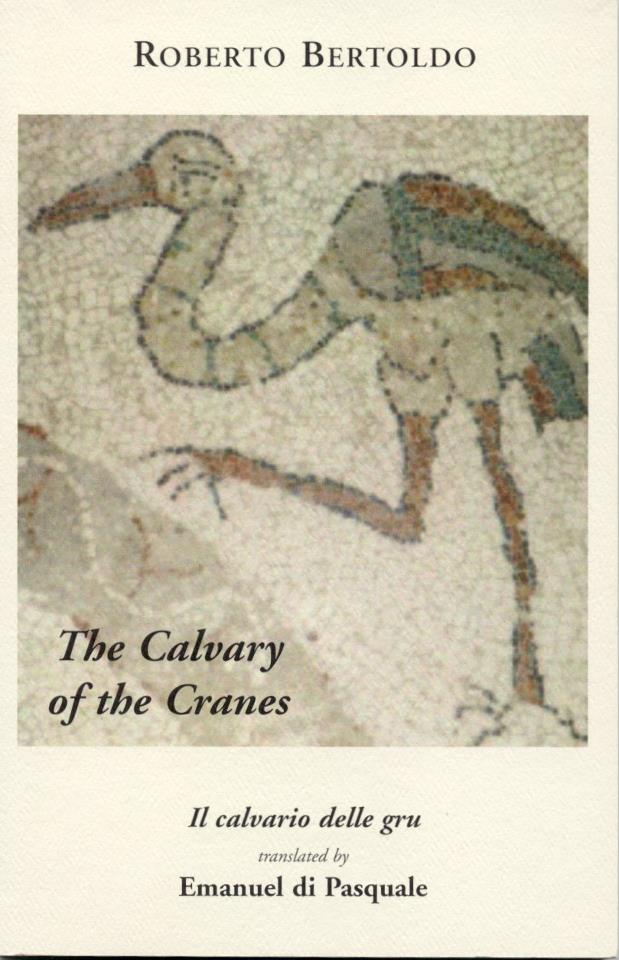
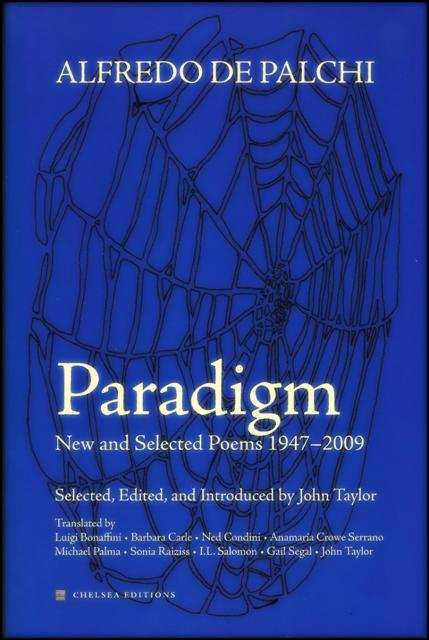


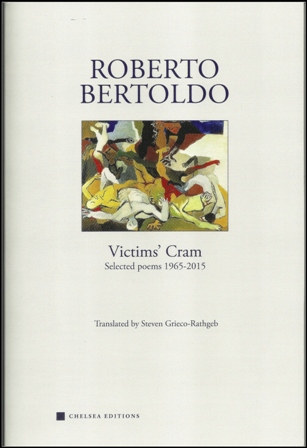





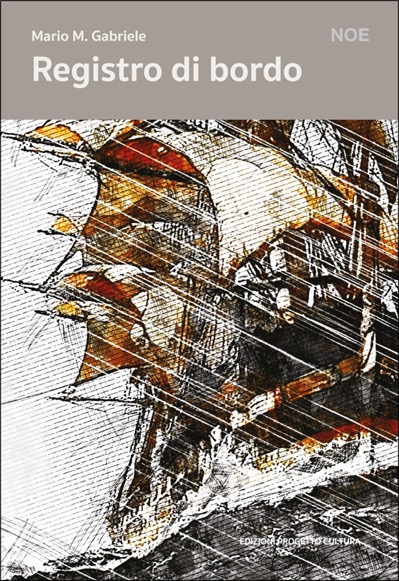

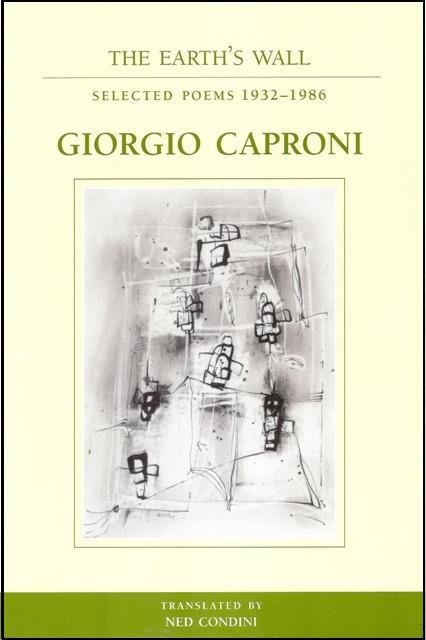
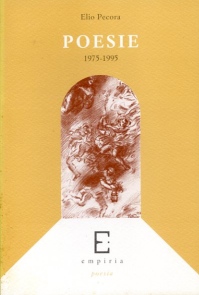

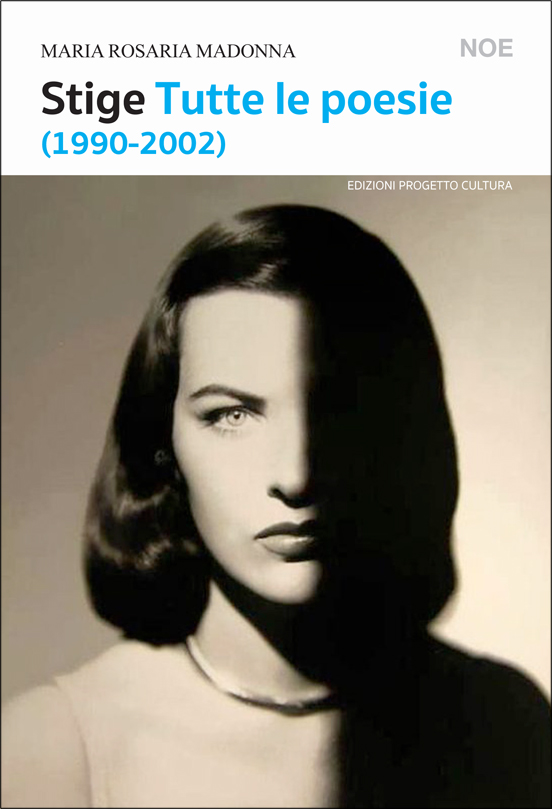

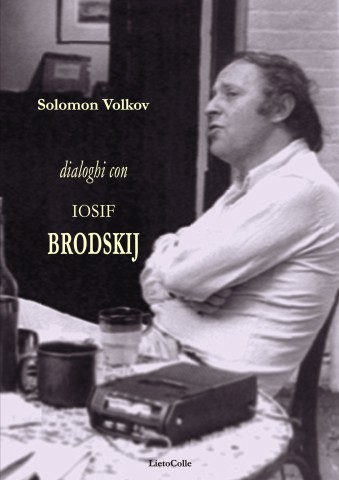




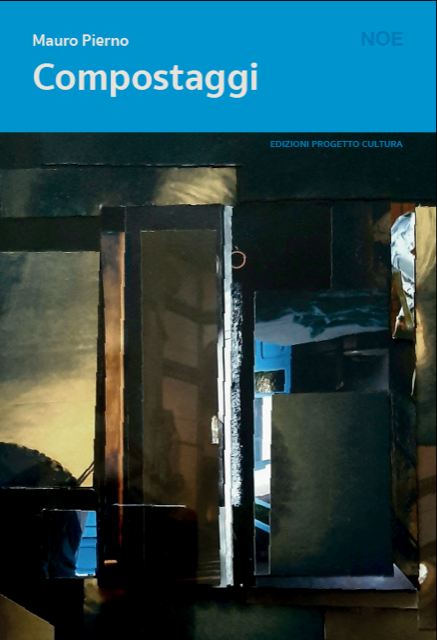




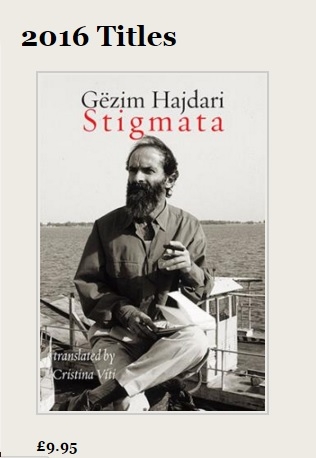






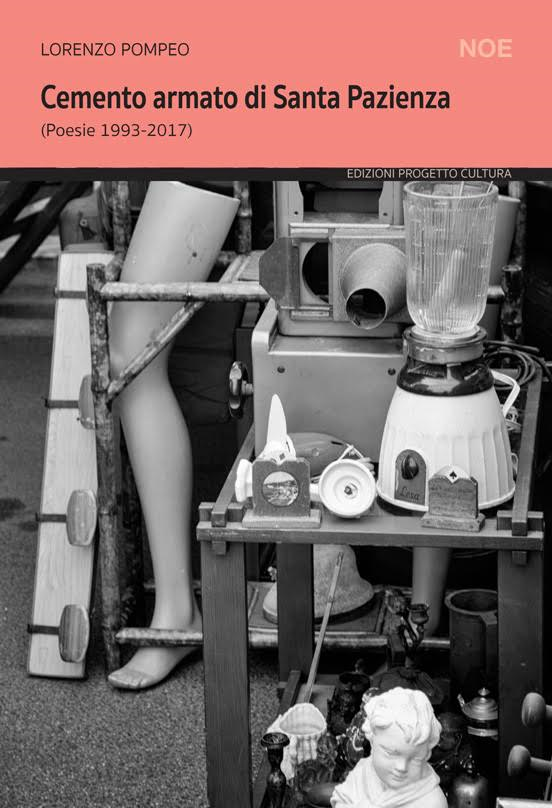







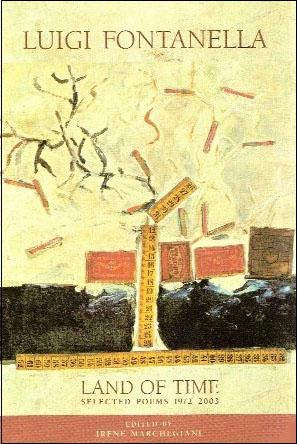








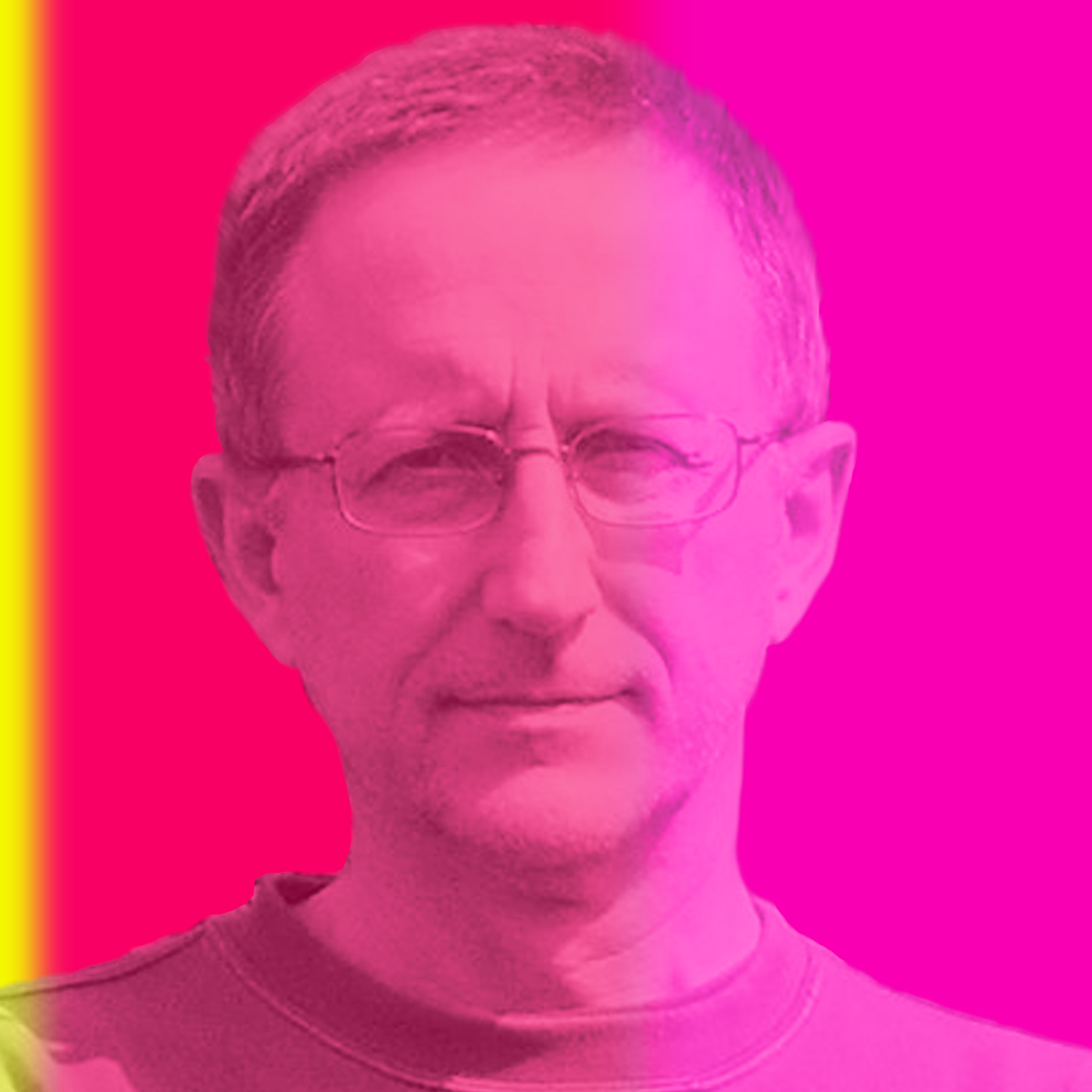







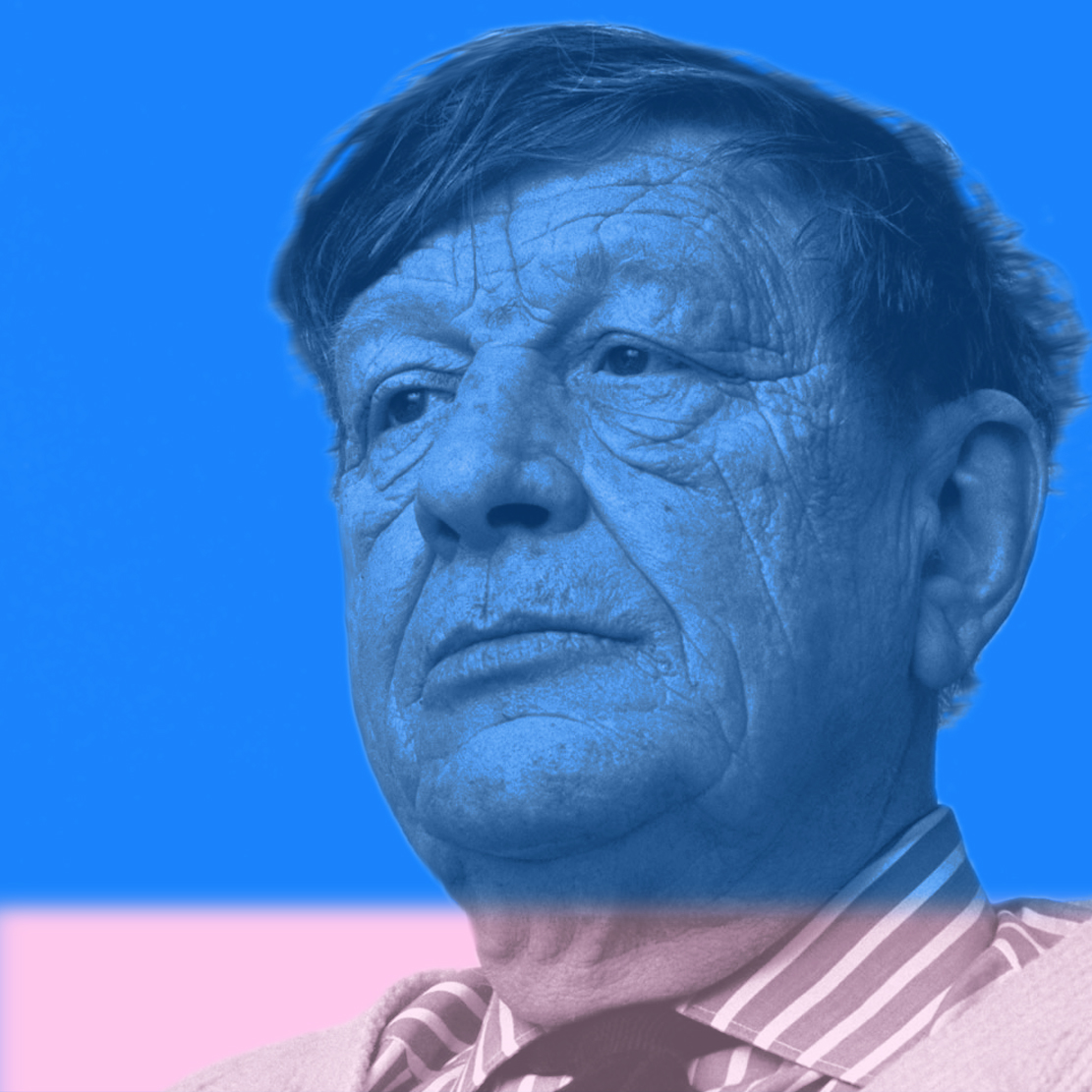





















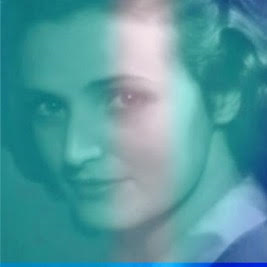































Poesia molto interessante, questa di Gallo, che coglie l’intima sostanza di una cultura antica e inestinguibile,nonostante l’assedio che l’attacca da tante parti.Gallo sa quanto peso abbiano, in questa cultura, le parole, concrete quanto le cose,e più di loro, forse, destinate a durare.
"Mi piace""Mi piace"
Per accostarsi consapevolmente alle similitudini [omeriche] delle quali è ricco questo poema di Giuseppe Gallo [un esempio struggente “Cuomu li passarieddhi, la matina,.. accussì, vannu allu Hfjume…], almeno sul piano tematico di questo XXI Canto di Arringheide, assai utile sarebbe a ogni lettore percorrere, anche per semplice lettura o rilettura d’uno stralcio, d’un brandello, di quella indicata come “La lunga marcia degli scrittori calabresi, a partire da Vincenzo Padula, e toccare o ritoccare almeno l’atmosfera d’un Alvaro, di un Seminara, di un Perri, di un La Cava, di uno Strati, di un Repaci, di un Asprea, anche se, benché quasi semisconosciute, le scritture più possenti siano state e rimangano quelle di Saverio Montalto e di Virginia Tursi.
Tornando a volo rapido d’uccello sul poema di Giuseppe Gallo, il cui respiro ampio e avvolgente trova buona parte delle sue affinità elettive sul piano linguistico in Salvatore Scervini e ne La Divina Commedia tradotta in dialetto calabrese, in particolare U ‘Nfiernu, credo che giovi il ricordare che la Calabria mostra una scarsa unità sul piano dialettologico tant’è che gli studi più rigorosi ne individuano almeno 6 aree principali:
1- Calabria Meridionale; 2- Calabria Centrale; 3 – Calabria Settentrionale;
4- Calabria Greco-ellenofona; 5- Calabria Albanese; 6- Calabria Provenzale.
Al di là di queste precisazioni linguistiche, ciò che mi piace davvero segnalare è che anche nel caso di Giuseppe Gallo si parli di ‘poesia in dialetto’ e non più con disprezzo di ‘poesia dialettale’.
Gino Rago
"Mi piace""Mi piace"
E perché ti lamenti? Ma non ricordi
quando la sera noi inghiottivamo amaro?/
Ecco, io lo ricordo. Ma è passato tanto tempo da allora. Non che adesso si inghiotta dolce, ma “a chillu amaru ndi mettimu nu poco i duci”.
"Mi piace""Mi piace"
Grande merito a questa operazione storico-poetica di Giuseppe Gallo.
Infatti di fronte alla inquietante velocità con la quale si è estinta la grande civiltà contadina, il dialetto resiste come afferma Gianfranco Contini (curatore di una importante antologia “Poeti dialettali del novecento” che raccoglie i risultati letterari più alti del genere dialettale) quale “lingua della durata, della concretezza e della differenza”, …e in Gallo non poteva essere che la lingua materna il codice orale necessario all’espressione di un’epica, questo “Idioma sottratto alla rapidità d’invecchiamento dei materiali linguistici nella società contemporanea”. Mondo arcaico contadino potente e reale amplificato dal possente dialetto calabrese: merita una lettura attenta.
"Mi piace""Mi piace"
Ringrazio L’Ombra per l’ospitalità e Giorgio Linguaglossa per la sua ermeneutica introduttiva necessaria e fondamentale per capire ciò che è avvenuto nell’ultimo secolo in Italia nei rapporti tra lingua nazionale e idiomi regionali. Il richiamo alla “immediatezza espressiva” del dialetto è qualcosa da ricalcare. Nella mia esperienza personale ogni volta che mi trovavo a scrivere qualche verso in italiano, prima dovevo ricordarmi di continuare nello sforzo montaliano di “torcere il collo alla retorica”. Con i versi in dialetto non ho mai avuto problemi del genere. Ha sottolineato, e con ragione, ancora Linguaglossa quel “fenomeno paradossale, che mentre i dialetti tendono a scomparire nelle abitudini dei parlanti, si verifica una crescita a dismisura della produzione poetica in idioma…”, però le affermazioni successive le segnalerei come interrogazione generale: è solo “resistenza al monolinguismo e al conformismo della poesia in italiano”? E proseguirei anche. Questo ambivalente ritorno alla poesia in dialetto è solo un richiamo a “un linguaggio originario, arcaico, primigenio”, a un “mondo di ottomila anni fa, di un mondo patriarcale, di una civiltà contadina e stregonesca insieme”? Non sarebbe opportuno approfondire le problematiche relative con qualche riflessione che vada oltre l’apparenza? Nella presentazione del testo io ho cercato di porre una domanda cruciale: perché tentare la poesia, oggi, quando, sia in italiano, sia in dialetto, le parole non hanno la forza di recepire o immaginare né sogni, né illusioni, né la multiforme realtà? Giorgio Linguaglossa ha parlato spesso di “lallazione”. Ebbene sono d’accordo. Mentre si scrive e mentre si parla non possiamo far altro che balbettare. Ogni parola è un amo, ma non abboccano pesci, tanto meno essenze, realtà superiori, metafisiche, ecc. ecc. Abboccano larve, reliquie, quid indefinibili. Allora perché continuare a battere i tasti di questi computer? Non è il nostro un gioco a perdere? C’è qualche altro evento dietro tutto ciò? Per la poesia in italiano e per quella in dialetto la motivazione di base dovrebbe essere la stessa… Forse qualche altra volta ho richiamato la dea Kalì, dalle tante braccia e dai molti occhi; una ghirlanda di cinquanta teschi le pendono dal collo. Ogni teschio una lettera dell’alfabeto sanscrito. Teschi non fiori, né sangue, né carne, la scrittura è solo morte che ingoia il tempo e lo denuda! Montale parlava di “ossi”. Di seppia? No! Forse è giunta l’ora degli “ossi umani!” Ringrazio Anna Ventura per il richiamo alle parole, quelle “concrete” destinate a durare, forse più delle cose; Gino Rago per la citazione, di sapore omerico: “Cuomu li passarieddhi la matina…” e per aver ribadito la necessità di andare a rileggerci qualche autore calabrese; Giuseppe Talia che ha assaporato i tempi, come tanti altri calabresi, quando si inghiottiva l’amaro senza dolce e Letizia Leone per aver puntualizzato, a ragion veduta, che la poesia in dialetto, forse ci può far riflettere anche sulla “rapidità d’invecchiamento dei materiali linguistici nella società contemporanea”.
"Mi piace""Mi piace"
caro Giuseppe Gallo,
verso la poesia in dialetto ho avuto nel corso degli ultimi trentacinque anni un atteggiamento contraddittorio, altalenante e ambivalente… guardavo spesso con sospetto il poetare di Albino Pierro, non mi convinceva quel mix di linguaggi plebei di vari idiomi che si ritrovava nella poesia di un Franco Loi… in una recensione tentai anche di esprimere il mio dissenso e i miei sospetti al poeta milanese. Il risultato fu che Loi mi iscrisse nel libro nero di coloro che erano da depennare per aver osato dire quello che pensavo. Tenni a battesimo la poesia in dialetto di Assunta Finiguerra dicendole però che la sua poesia era di matrice folklorica, e lì restava, nella sua supernicchia…
Dieci anni prima Loi mi scrisse una lettera a proposito del mio Paradiso (2000) parlando di “capolavoro” e altri epiteti encomiastici… ma poi probabilmente a seguito di informazioni non propriamente lusinghiere raccolte nei miei confronti, si guardò bene dallo scrivere in pubblico quanto mi scriveva in privato…
Tant’è, si sa che i poeti hanno di queste, diciamo, ambivalenze…
Il discorso sulla contiguità e l’estraneità tra la poesia in italiano e quella in dialetto sarebbe lungo, è poi vero che una certa piegatura verso il dialetto finiva utile alla costruzione di una supernicchia elitaria… questo era ed è un pericolo… un altro rischio è che la poesia in dialetto troppo spesso, anzi, quasi sempre si apparenta a una forma di scrittura folkloristica… ma è anche vero quello che dici tu, caro Giuseppe, quando scrivi che prima di scrivere in italiano bisogna lavarsi i panni verbali dalle incrostazioni della retorica che ci si è appiccicata sopra. Scrivere in italiano è un bel pasticcio, ne sanno qualcosa Gino Rago (che ha dovuto gettare nel Tevere i panni desueti della poesia del Sud degli ultimi quaranta anni, ne sa qualcosa Letizia leone sempre in lotta per scrivere in italiano in una lingua che non sia telefonica e radiofonica… una fatica di Sisifo, perché, nel frattempo, come scrive Cesare Viviani «La poesia è finita». Cmq, bando alle ciance.
Condivido quanto scrivi:
«Mentre si scrive e mentre si parla non possiamo far altro che balbettare. Ogni parola è un amo, ma non abboccano pesci, tanto meno essenze, realtà superiori, metafisiche, ecc. ecc. Abboccano larve, reliquie, quid indefinibili.»
Oggi più di ieri la poesia la si fa con gli stracci, le parole non abboccano più all’amo, e chi pensa di fare il furbo, di parlare della topografia della propria stanza o delle targhe delle automobili o del proprio “io” e delle sue adiacenze… non fa altro che propalare tautologie e autologie…
"Mi piace""Mi piace"
Versi, “L’esilio è solo un evento linguistico”, derivati da questa chiosa di Giorgio Linguaglossa nel commento rivolto a Peppino Gallo:
“[…]Scrivere in italiano è un bel pasticcio, ne sanno qualcosa Gino Rago (che ha dovuto gettare nel Tevere i panni desueti della poesia del Sud degli ultimi quaranta anni[…]”
Gino Rago
L’esilio è solo un evento linguistico
[Valentina a 11 anni con la famiglia se ne va a Roma]
“Di notte [peggio d’una ladra] sei scappata dal paese.
Quattro cose in una federa coi buchi,
i fichi, gli aranci, le noci ancora nei gusci,
le barche coi nomi dei Santi di vernice alle spalle.
Imparavi a chiamarla anche tu la-città-eterna
sul 19 al capolinea da Centocelle a Napoleone III.
[…]
Hai a trovato la parola esatta
per qualificare ciò che è capitato?
A volte potresti dire dramma o tragedia,
altre volte catastrofe.
[…]
Nella mente dici tutto questo “la cosa”
[perché per la cosa non c’è ancora la parola]
quest’assenza è il tuo esilio
non l’uccisione della lingua di tua madre.”
GR
"Mi piace""Mi piace"
dalla relazione da tenere il 12 agosto 2018 nella Sala Convegni del Laboratorio delle Idee nel corso della Festa dell’emigrante [Cerchiara di Calabria-la città del pane] estraggo e condivido questo passaggio:
Gino Rago
La lingua come forma di esilio, l’esilio nel grande gelo linguistico
[Agota Kristof, dal suo romanzo ‘L’analfabeta’]:
Ich bin müde, dico a Fred. Il suo viso pallido e malinconico si stira in un sorriso. Ich bin müde, è lunica frase tedesca che per ora conosco. In questo momento non voglio nemmeno imparare altro. Imparare altro significa aprirsi. E io voglio restare chiusa ancora per qualche tempo.”
Potremmo dedurne che il doversi mettere in gioco dal punto di vista linguistico può essere faticoso. Così come il desiderio di chiudersi dentro sé stessi, che per la Kristof è chiudersi nella propria lingua madre, è uno dei modi più diffusi ma forse non sempre efficaci di proteggersi.
In molti scrittori, il ricorso ad una lingua straniera rappresenta una forma desilio.
Scrivere in unaltra lingua, infatti, può essere vissuto perfino come una conquista, ma anche e soprattutto come una perdita[…]
La questione linguistica è centrale in Agota Kristof proprio nel suo romanzo ‘Lanalfabeta’ che poi è un lungo racconto autobiografico.
In questo caso, l’esilio è lasciare la propria terra. Ma è anche seppellire la propria lingua [come fu anche per altri scrittori] in seguito alla fuga di moltissimi ungheresi dopo lintervento russo del 1956…
(Altri scrittori seguirono altri percorsi rispetto alla madre lingua, come Hannah Arendt che ripudiò tanto il francese, quanto l’inglese, rimanendo fedele alla lingua tedesca, anche se era la lingua dei carnefici…)”
GR
"Mi piace""Mi piace"
Un dialogo a distanza
Giorgio Linguaglossa
“[…]Scrivere in italiano è un bel pasticcio, ne sa qualcosa Gino Rago (che ha dovuto gettare nel Tevere i panni desueti della poesia del Sud degli ultimi quaranta anni[…]”
“[…]Oggi più di ieri la poesia la si fa con gli stracci, le parole non abboccano più all’amo, e chi pensa di fare il furbo, di parlare della topografia della propria stanza o delle targhe delle automobili o del proprio “io” e delle sue adiacenze… non fa altro che propalare tautologie e autologie[…]”
Gino Rago
1- L’esilio è un evento linguistico
[Agota ora scrive nuovi versi]
Era d’inverno. Il villaggio dormiva più del solito,
ombre corte dai monti e dalla neve.
Una donna sognava di diventare un’altra persona.
Bisognava lasciare il villaggio, abbandonare la casa.
Sfidare il lago, attraversarlo dimenticando le sponde,
concentrandosi unicamente sull’altra sponda,
la più vicina. Agota diventò un’altra persona
ma non abbandonò il villaggio né sua madre.
Aveva intrapreso il viaggio in un’altra lingua.
La nuova lingua accolse la donna
come la nonna che ti attende e che ritrovi al di là dell’oceano.
La condizione che chiamiamo esilio è solo un fatto di lingua
[si può essere in esilio anche nel proprio villaggio,
nella lingua della madre, fra le ossa dei padri ]?
Agota ora scrive nuovi versi. L’esilio è in ogni lingua
che ti nega la parola esatta.
2- L’esilio è un evento linguistico
[Valentina, “la cosa”]
Di notte [peggio d’una ladra] sei scappata dal paese,
quattro cose in una federa coi buchi,
i fichi, gli aranci, le noci ancora nei gusci,
le barche coi nomi dei Santi di vernice alle spalle.
Imparavi a chiamarla anche tu la-città-eterna,
il 19 al capolinea da Centocelle a Napoleone III.
[…]
Hai trovato la parola
per ciò che è capitato?
A volte potresti dire dramma o tragedia,
altre volte catastrofe.
[…]
Nella mente tutto questo è “la cosa”
perché per la cosa non c’è ancora la parola
quest’assenza è il tuo esilio
[non l’uccisione della lingua madre].
—————————————————————-
GR
"Mi piace""Mi piace"
Considerazioni sulla poesia in dialetto oggi.
Scrive Gino Rago:
«l’esilio è lasciare la propria terra. Ma è anche seppellire la propria lingua». Giuseppe Gallo ha scelto l’auto esilio nella propria lingua, il dialetto calabrese un po’ italianizzato del suo paese di origine. La questione linguistica è centrale, è vero, ma non nel senso che il soggetto può intervenire in piena libertà nel corpus del linguaggio in idioma agglutinandolo con idiomi estranei e limitrofi come hanno fatto un Franco Loi e un Cesare Ruffato, quella era la concezione che del linguaggio aveva lo sperimentalismo tardo novecentesco, noi (intendo noi della nuova ontologia estetica) non abbiamo più quella concezione del linguaggio, l’abbiamo ripudiata, noi pensiamo che il linguaggio debba venire a noi… quello che il soggetto può fare è lasciare le porte e le finestre aperte affinché il linguaggio venga a noi.
In un noto passo dei suoi Quaderni del carcere Gramsci scrive:
«Ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, la questione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale».*
E adesso ripopongo qui la mia recensione del 2007 del libro di Franco Loi che mi procurò la cancellazione del mio nome dal suo indice di gradimento:
Franco Loi Voci d’osteria Milano, Mondadori, 2007 pp. 130 € 12,00
Operazione tipicamente post-moderna questa del poeta milanese; infatti, Franco Loi con questo libro utilizza i detriti, i materiali di risulta del suo mezzo linguistico (un milanese rifondato e ristrutturato con innesti di varia e spuria provenienza anche da altre aree dialettali): le espressioni blasfeme, il discorso tronco, le inflessioni esclamative e sospensive etc.… il conglomerato plurilinguistico che ne deriva ha la potenza rappresentativa e semantica di un socioletto e di un idioletto superindividuale.
Che cosa sono i «detriti» linguistici? Possiamo dire che essi sono i «volgarismi», quelle espressioni che allignano nel linguaggio plebeo, negli usi del corrivo-quotidiano dei ceti bassi, tutte quelle fraseologie che sopravvivono alla dissoluzione dell’alta società (della società borghese), che hanno una ricaduta dopo la scomparsa e il tramonto della scrittura colta espressione della cultura borghese. Fatto sta che Loi utilizza questo grande ipermercato della «zavorra linguistica» delle classi plebee per scrivere in un linguaggio che, paradossalmente, ha una durata maggiore della scrittura aulica. Si sa che i volgarismi e gli usi popolari sono sostanzialmente tratti dialettali abbandonati dalla «buona società» e conservati dal popolo; in una certa misura i vecchi tratti dialettali sopravvivono come caratteristiche sociolettali, nella rete sinonimica e semantica di questo linguaggio pluridirezionale quale è la koiné linguistica del poeta milanese. Sappiamo che le varianti spaziali col tempo diventano varianti sociali.
E infatti i «parlanti» di questo libro di Franco Loi illustrano un ampio ventaglio di socioletti e di idioletti, la cui funzione sociale è di identificare l’appartenenza sociale, invece qui è unicamente la funzione estetica che presiede alla selezione del linguaggio. È noto che la strutturazione verticale del linguaggio poetico è una funzione della strutturazione totale della società, ma il linguaggio poetico di queste Voci d’osteria è un linguaggio privo di destino, un linguaggio astorico, spazialmente immobile e immobilizzzato. Il modo di parlare di questi «parlanti» si spiega con la loro posizione sociale bassa in quanto minoranza deiettata dalla civilizzazione, disprezzata e confinata in un ghetto di socioletti in un ambiente linguistico dove le differenziazioni etniche o di classe, nel senso della vulgata marxista, assumono una importanza marginale e trascurabile. Non è una moderna versione del populismo quello che sta a cuore a Franco Loi: le conversazioni di queste Voci d’osteria sono un logos naturalmente e totalmente blasfemo e antiborghese nella misura in cui la particolarità di questo linguaggio denota una concezione del mondo e dei valori radicalmente diversa e complementare rispetto alla concezione del mondo propria della circolazione delle merci.
E allora, che cos’è la lingua per questi parlanti? «La lengua l’è de Diu, rassa de troj!/ Parlì cume magnì, e andì a cagà», recita la poesia d’apertura della raccolta.
In questo particolare idioma di Franco Loi le scelte del «parlante» sono determinate dall’intenzione significante rivolta al destinatario; i tratti stilistici che derivano da questa intenzione significante, ovvero, il registro basso (familiare, colloquiale, informale, emotivo etc.), informano di sé la omogeneizzazione linguistica di questo linguaggio poetico. Ma sarebbe indotto in inganno chi credesse ingenuamente che questo linguaggio «d’osteria» serva veramente alla comunicazione di messaggi significanti; dal punto di vista della lingua «maggiore» questo linguaggio è completamente estraneo quale veicolo di messaggi borghesi (nel senso di un ordinamento sociale e istituzionale dell’epoca pre-moderna), il suo telos è rivolto alla comunicazione di qualcosa che alle orecchie della lingua maggiore suona come blasfema e antiborghese, quando in realtà è semplicemente e puramente oggettiva e rappresentativa della propria espressività linguistica. Il «luogo» dove si svolgono questi monologhi è l’osteria, ovvero, un luogo a-topico e astorico, dove è vietato l’ingresso alla lingua dei parlanti «maggiori», di coloro che reggono le sorti belle e progressive della storia e che parlano mediante i siti e i riti istituzionali della lingua «maggiore». Ecco spiegata, credo, la ragione della scelta linguistica operata da Franco Loi: un antipopulismo antiborghese, dove i parlanti sono gli esclusi dalla storia, coloro che parlano mediante assemblaggi di «detriti» linguistici.
Il materialismo dei «parlanti», il carattere blasfemo del loro messaggio è qualcosa di radicalmente antiestetico e antiborghese per il semplice fatto che non c’è, dietro questo linguaggio, alcuna espressione monetaria del loro essere antiborghese: direi che la circolazione delle merci linguistiche di questo linguaggio è avulsa ed estranea alla circolazione della lingua borghese e, in un certo senso, è la risposta, nel modo tutto personale del poeta milanese (complementare e consanguinea), alla crisi del linguaggio poetico della lingua maggiore.
(Giorgio Linguaglossa)
"Mi piace""Mi piace"
Franco Loi, da Isman
Vèss òm e vèss puèta… Cum’i can
che bàjen a la lüna per natüra,
per la passiensa de stà lí a scultà…
Vèss òm e vèss puèta… ’Na paüra
de vèss un’aria, un buff… duè murí…
Vèss òm e vèss puèta… Per la scüra
del crèss tra j òmm, despèrdess nel patí,
per returnà quèl fi’sc de la memoria
che la passiensa l’à sparagnâ nel dí.
Essere uomo ed essere poeta… Come i cani
che abbaiano alla luna per natura,
per la pazienza di star lí ad ascoltare…
Essere uomo e essere poeta… Una paura
di essere un’aria, un soffio… dover morire…
Essere uomo e essere poeta… Per l’oscurità
del crescere tra gli uomini, disperdersi nel patire,
per ritornare quel fischio della memoria
che la pazienza ha risparmiato nel giorno.
"Mi piace""Mi piace"
Leggendo una poesia in dialetto, mi rendo conto di come sia infinitamente più ricca ed espressiva rispetto alla traduzione in italiano, che appare al confronto come uno scialbo fantasma.
E questo accade SEMPRE, con poesie meravigliose e con quelle modeste, con Delio Tessa e con un minorissimo delle mie parti.
"Mi piace""Mi piace"
Tanto per ribadire e dilungare, se possibile, i concetti espressi da Giorgio Linguaglossa quando afferma: “l’esilio è lasciare la propria terra. Ma è anche seppellire la propria lingua”; io direi che c’è anche un’altra forma di esilio, che non so se ha a che fare con “quell’assenza” evocata da Gino Rago. Ragioniamoci! E lo faccio riportando un brevissimo racconto di Robert Walser, tratto da Storie, Adelphi, Milano, 198., pp.17-18
Ora mi sovviene che una volta viveva un poeta povero, molto oppresso dai suoi umori, il quale, avendo contemplato a sazietà la libera e divina natura, aveva preso la risoluzione di lasciar poetare oramai soltanto la propria fantasia. Egli sedeva una sera, un mezzogiorno o un mattino, alle otto, alle dodici o alle due, nell’oscuro spazio della sua stanza e diceva alla parete della medesima: parete, io ti ho nella testa. Non darti la pena di ingannarmi con la tua fisionomia strana e placida. D’ora innanzi sei una prigioniera della mia fantasia. Dopo di che disse la stessa cosa alle finestre e alla tetra veduta che esse gli offrivano giorno dopo giorno. Quindi, infiammato dalla sete d’avventura, intraprese una passeggiata che lo condusse per campi, boschi, prati, villaggi, città, su fiumi e laghi, sempre sotto il bel cielo. Ma a campi, prati, sentieri, boschi, villaggi, città e fiumi egli continuava a dire: bricconi, vi ho ben saldi nel cranio. Non immaginatevi oltre, mia gente, di farmi impressione. Tornò a casa e continuava a ridere tra sé: li ho tutti nella testa. È dunque da presumere che egli li abbia tuttora lì dentro, da dove ( come avrei voluto aiutarli! ) non escono più. Non è questa una storia piena di fantasia???
"Mi piace""Mi piace"
Le poesie in dialetto andrebbero tradotte in inglese. Perché solo in italiano, e non anche in inglese, russo, arabo, sanscrito o cinese? se quel che conta è poesia… I dialetti sono lingue regionali, che non si intendono nemmeno tra di loro, a meno di cantarle o perché no anche di pitturarle… Fosse per me azzarderei una Italian language without capo e coda, versione export – senza dover tradurre –. Orrore? Orrore finché mancano autori capaci. Il linguaggio è accumulo di parole che sedimentano, sedimentano…
"Mi piace""Mi piace"
Gino Rago
La lingua come forma di esilio, l’esilio nel grande gelo linguistico
[dalla relazione che terrò il 12 agosto p.v. al Laboratorio delle idee in Cerchiara di Calabria]
2° Brandello
[…] E’ noto il caso umano e letterario di una narratrice di origini bengalesi che ha sempre scritto in inglese. Ma che per sua stessa ammissione ha sempre considerato la lingua della sua scrittura, l’inglese, come una matrigna, non essendo l’inglese la sua lingua madre.
Da poco questa narratrice ha adottato la lingua italiana, scrive direttamente in italiano. Alla domanda ‘Perché questa scelta?’ la sua risposta è stata laconica, chiara, indiscutibile: ‘Perché mi sento cittadina della parola, e sono sempre alla ricerca della parola giusta, della parola esatta’, paragonandosi a uno speleologo di parole nella miniera dell’animo umano.
Dopo i casi di Agota Kristof, di Hannah Arendt, di Iosif Brodskij, esaminati nelle loro condizioni di esilio nel grande gelo linguistico, quali le considerazioni possibili per chi come questa narratrice del Bengala sceglie liberamente una lingua straniera, l’italiano, nell’esercizio della sua scrittura?
Una prima considerazione potrebbe esser questa: una nuova lingua, anzi una ‘lingua nuova’ è una vita nuova perché la grammatica e la sintassi sono in grado di di ri-fondare una vita perché ti fanno scivolare in altri sentimenti, in un’altra logica, in un’altra maniera di sentire il mondo e di sentirti nel mondo, costringendoti a destrutturare la tua scrittura originaria che pure sentivi ben fondata e sicura.
Anche nel caso di due poeti a noi familiari, Edith Dzieduszycka e Gëzim Hajdari, l’una, Edith, il francese come lingua madre, l’altro, Gëzim, l’albanese come madre lingua, scrivendo da tempo i loro versi in italiano si sentono di avere acquistato o perso qualcosa? Sentono la lingua italiana come lingua straniera e/o di esilio linguistico? Destrutturando le lingue madri, il francese e l’albanese, Edith Dzieduszycka e Gëzim Hajdari, hanno anche destrutturato sentimenti e logica precedenti? Alle parole nuove della lingua nuova corrispondono le ‘cose’?
Cosa noi lasciamo quando lasciamo qualcuno o quando lasciamo una terra?
Un focolare, una casa, il passato, un paesaggio, una luce, un colore, un suono delle/nelle cose… un’idea o un progetto di futuro…
Vengono meno le stesse forze sotterranee in grado di tenere ancora in vita i matrimoni dopo l’amore, o altro?
Per un poeta che approda a un lingua nuova lasciando la propria lingua madre la questione linguistica forse è davvero lacerante, forse è come spaccare un vaso e incollarne i cocci, illudendosi che il vaso sia nuovo di zecca[…]
1- Edith Dzieduszycka
I senza nomi
In giacche d’ombra
e visiere di fango
arrancano
letali
i senza nomi
Sul ciglio del sentiero
su scogli e strapiombi
senza meta
a blocchi aggrovigliati
Le loro armature sono di pelle nuda.
Hanno perso la voce
la lingua
forse la voglia
Dai rovi
sornione s’alza
la brigata dei corvi iene sciacalli
L’orizzonte è fuggito
È andato lontano
dietro
più dietro ancora
Una mantella cupa
lo ricopre.
2- Gëzim Hajdari
Dove vanno questi uomini insanguinati
Dove vanno questi uomini insanguinati
giunti all’alba? Hanno occhi sbarrati dal terrore.
Dicono che provengono dal Delta del Niger
e non vogliono tornare indietro.
Che ne sarà dei loro destini?
Fuggono lungo il confine
insieme alle bestie impazzite
in balia delle dimore ignote
e delle voci dei defunti.
Di tutt’altro genere sono, al contrario, le considerazioni linguistiche su e per un poeta che, come per esempio Giorgio Linguaglossa, impiega la lingua madre nella scrittura dei suoi versi, come nella poesia ‘In nomine lucis’ [ che mi permetto di ri-proporre in distici per l’innegabile acquisto estetico che ne deriva]
3- Giorgio Linguaglossa
In nomine lucis
Di notte viaggiano i vagoni merci carichi di morti.
Di giorno grandi specchi ustori semoventi montati su camion
danno la caccia agli uomini che hanno ingoiato la luce.
Fuggono la luce, si giustificano, si sbracciano.
Dicono di aver bevuto luce a sazietà.
Si riparano sotto le tegole,
sotto le mensole, nelle bettole del dormiveglia,
si infilano sotto le saracinesche abbassate,
si nascondono tra le masserizie
e i rifiuti, lungo gli argini del fiume del dolore,
sotto gli alberi spogli.
[…]
Scavano fosse nella terra e ci mettono la testa.
Dicono di aver bevuto a sazietà.
Gridano: «Eloì, Eloì lema sabactani!».
E bestemmiano. Bestemmiano il nome di Dio…
– Tigri fosforescenti con passo elegante
ci ringhiano contro, divaricando orribilmente le fauci…
– Dicono di aver bevuto tanta luce.
[…]
La notte, durante il coprifuoco, gendarmi
con berretti a visiera di feltro verde
in tuta bianca portano a spasso frotte di lupi al guinzaglio.
Rifiutano la luce.
[…]
La notte, gemella dell’oscurità, partorisce il buio.
Il buio partorisce un uovo
dal quale escono i pipistrelli ciechi
che sbattono contro i fili dell’alta tensione
e copulano con gli angeli gobbi
caduti dal cielo azzurro…
4- Agota Kristof
[da i chiodi]
«Qui le persone sono così felici
che nemmeno amano
sono realizzate non hanno bisogno
l’uno dell’altro nemmeno di dio
la mattina si siedono davanti alle loro case inondate di luce
e fino a sera aspettano la morte».
E in questi versi, dove si avverte tutta la fatica di chi non per scelta ma per le crudeltà della Storia è costretta come Agota a entrare in un’altra dimensione linguistica ed esistenziale, la Kristof si riferisce ai privilegiati della Svizzera… Per i più, per i tanti come lei, «la vita non è un regalo»,
ma può essere persino una condanna.
———— ———- ————–
GR
"Mi piace""Mi piace"
Ci sono infiniti modi per comunicare; la parola,per fortuna, non è l’unico. Al supermercato mi imbatto sempre in un bambino cinese, issato sul carrello spinto dalla madre.Lui sa che ci incontreremo,ma fa finta di non vedermi,anche se io gli mando sempre un bacio con la mano.Una volta ho finto di non vederlo; lui non ha fatto una piega;ma, prima che la madre lo portasse fuori con tutto il carrello, si è girato verso il tavolo del bar, dove io ero seduta.E’ così,che ,ancora una volta,ci siamo salutati.
"Mi piace""Mi piace"
«Il dialetto è come i nostri sogni, qualcosa di remoto e di rivelatore; il dialetto è la testimonianza più viva della nostra storia, è l’espressione della fantasia». Federico Fellini
Mi sembra che questo pensiero del grande regista Federico Fellini sintetizzi molto bene il significato dell’imponente e appassionata opera in dialetto di Giuseppe Gallo. La sua Arringheide è storia filtrata dalla memoria, è recupero di un patrimonio ancestrale, riattualizzazione di un dialetto esiliato: l’idioma dei padri invano ripudiato, se, a distanza di decenni, oggi s’impone alla penna di Gallo con esiti espressivi tanto originali, sebbene, a volte, non del tutto traducibili, per la difficoltà di trasferire alla lingua quelle sottili sfumature di significato che formano tutt’uno con la propria cultura di appartenenza; una cultura, d’altra parte, ormai scomparsa.
Perciò, nei passaggi linguistici che ci sembrano più lontani dal nostro codice, senza ricorrere all’aiuto della traduzione, affidiamoci semplicemente al suono, alla musica delle parole, come davanti a una partitura; solo la musica potrà farci intendere il pathos della parola, quel qualcosa che va oltre il suo stesso significato.
E ora un omaggio musicale: Non sugnu brigante, dall’album Il brigante Musolino (Fonit Cetra, 1973) di Otello Profazio
Buon ascolto!
"Mi piace""Mi piace"
Ringrazio per gli interventi così puntuali e passibili di ulteriori approfondimenti e suggestioni. Con il racconto di Walser volevo segnalare la necessità che “un povero poeta” prima di “poetare” deve possedere nella testa non solo “la parete” della propria stanza e non solo la “tetra veduta” che gli offrono le finestre, ma anche “campi, boschi, prati, villaggi, città…”: un po’ di realtà, insomma! Magari, quanta più possibile, dato che è inane il tentativo di giocare con il mondo intero! ( Pierno docet). E per fare questo, però, deve emigrare, esiliarsi nel mondo e impregnarsi di esso. E qui non c’è lingua che tenga! Hanno tutte “il brodo primordiale” da cui far germinare le parole adatte e appropriate… , anche gli idiomi dialettali! Ma “affinché il linguaggio venga a noi” come suggerisce Giorgio Linguaglossa, bisogna aiutare i poveri poeti odierni, a “lasciare le porte e le finestre aperte”. Me lo ha ricordato lo sguardo del bimbo cinese di Anna Ventura, me lo ricordavano gli amici romani, quando in alcune serate conviviali, mi invitavano a leggere qualche sestina di Arringheide; io tentavo sempre di rifiutare con la scusa che era loro impossibile comprendere “le sottili sfumature di significato”, poi mi lasciavo andare e subito notavo un cambio d’atmosfera: prendevano, allora, il sopravvento il suono e la musica delle parole. Grazie,Donatelacostantina,dell’omaggio musicale che ci fai! Forse è ancora vero quanto cantava Otello Profazio:
“Non è peccatu, lu proverbiu dici,
fari la guerra a cu’ ni mette ‘ncruci!”
"Mi piace""Mi piace"