
Sono una strega piccola,
molto piccola
Anna Ventura è nata a Roma, da genitori abruzzesi. Laureata in lettere classiche a Firenze, agli studi di filologia classica, mai abbandonati, ha successivamente affiancato un’attività di critica letteraria e di scrittura creativa. Ha pubblicato raccolte di poesie, volumi di racconti, due romanzi, libri di saggistica. Collabora a riviste specializzate ,a quotidiani, a pubblicazioni on line. Ha curato tre antologie di poeti contemporanei e la sezione “La poesia in Abruzzo” nel volume Vertenza Sud di Daniele Giancane (Besa, Lecce, 2002). È stata insignita del premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha tradotto il De Reditu di Claudio Rutilio Namaziano e alcuni inni di Ilario di Poitiers per il volume Poeti latini tradotti da scrittori italiani, a cura di Vincenzo Guarracino (Bompiani,1993). Dirige la collana di poesia “Flores”per la Tabula Fati di Chieti. Suoi diari, inseriti nella Lista d’Onore del Premio bandito dall’Archivio nel 1996 e in quello del 2009, sono depositati presso l’Archivio Nazionale del Diario di Pieve Santo Stefano di Arezzo.
È presente in siti web italiani e stranieri; sue opere sono state tradotte in francese, inglese, tedesco, portoghese e rumeno pubblicate in Italia e all’estero in antologie e riviste. È presente nei volumi: AA.VV. Cinquanta poesie tradotte da Paul Courget, Tabula Fati, Chieti, 2003; AA.VV. e El jardin,traduzione di Carlos Vitale, Emboscall, Barcellona, 2004. Nel 2014 per EdiLet di Roma esce la Antologia Tu quoque (Poesie 1978-2013). Dieci sue poesie sono presenti nella Antologia di poesia Come è finita la guerra di Troia non ricordo a cura di Giorgio Linguaglossa (Roma, Progetto Cultura, 2016)

Foto Man Ray
Il retroterra storico della stregoneria lo si trova nel Canon episcopi che era una istruzione ai vescovi sull’atteggiamento da assumere nei riguardi di questo fenomeno. Durante il Medioevo il documento fu attribuito al Concilio di Ancira del 314; in realtà si tratta di un testo più tardo, comparso nell’opera del benedettino tedesco Regino di Prüm, il De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, risalente al 906. Il Canon episcopi definiva la stregoneria «culto verso il demonio», ma negava che le streghe potessero volare fisicamente e dichiarava che «[…] chiunque è così stupido e folle da credere a storie tanto fantasiose è da considerarsi un infedele, perché ciò deriva da un’illusione del demonio». Tali voli notturni, ritenuti materialmente impossibili e ritenuti illusori, potevano però realizzarsi con lo spirito e «pur volando con lo spirito e l’immaginazione, queste streghe sono ugualmente colpevoli, come se lo avessero fatto in carne e ossa».
Nel XII secolo il Canon episcopi creò non pochi problemi ai demonologi, per via delle sue interne contraddizioni: a partire da queste deduzioni, infatti, risultava semplice affermare che tutti gli eretici e le streghe, con il corpo o con la fantasia, avessero stretto un patto con il diavolo. Non era possibile difendersi da eventuali accuse, stante il carattere fantastico delle accuse.
Una differente lettura del Canon episcopi ne fa un documento di moderazione, che riduce la stregoneria a pura vanità, esecrabile ma punibile con provvedimenti disciplinari come l’allontanamento dalla comunità dei credenti. Verso la metà del XV secolo la maggioranza degli inquisitori e dei demonologi cominciò a trascurare il Canon episcopi a motivo della sua problematicità e preferì utilizzare nuovi e più efficienti manuali inquisitoriali, tra cui il più diffuso fu il Malleus Maleficarum (Il Martello delle streghe).
Questo il lato storico, il lato propriamente letterario di questo libro di Anna Ventura è un viaggio tra il fantastico e il fantasmatico nella memoria collettiva di ciò che erano le streghe nella civiltà contadina di cui ancora si ha notizia sporadica all’inizio della modernità in Italia. Di qui questi racconti in versi della Ventura che ci raccontano tra il serio e il faceto storie di superstizione di un mondo scomparso intriso di magia nera e magia bianca, di illusioni e di credenze condivise dalla comunità. Le poesie discorsive e quiete della Ventura si muovono sull’orlo tra il vero (la verità) e il fantastico (la finzione), e lo fanno con un tocco gentile e delicato, quasi amorevole per un mondo femminile che si è perduto per sempre, e lo fanno attraverso l’esercizio delle metafore e delle metonimie, con gli strumenti della retorica.
Scrive Gino Rago: «Quale è l’impianto poetico generale de “La casa bassa” di Anna Ventura se non quello di contrapporre in maniera stilisticamente ben riuscita un tempo “premoderno” al tempo postmoderno se non postcontemporaneo disgiunto definitivamente dalla dimensione spaziale, e un luogo antropologico ai non luoghi dello storico-antropologo Marc Augé? La Ventura non a caso parla alla maniera della Cvetaeva di ‘luogo dell’anima’.
E che fa il poeta in questo perimetro di libri, tappeti, gatti, legni di cui si conoscono perfino i respiri, perfino le voci? In questo luogo antropologico ben delimitato e sottratto all’infinito il poeta si prepara, circondato dalle sue ‘cose’, e in un’atmosfera da Antologia Palatina [“le allegre lusinghe, la musica, il canto, le coppe audaci nel brindisi e nel canto canto…tutto si spegnerà] all’ultima attesa…[…]»
Scrive Rossana Levati: «Immersa nel “grande fiume delle cose che non aspettano niente” spesso Anna Ventura ha tracciato nella sua poesia, definendoli col tocco sapiente di un’immagine densa e delicata al tempo stesso, questi luoghi-rifugio, come la “casa bassa” o il “paese di mare” di “Lettera”, dove non si può comprendere la lingua della gente “dura, parca e di poche parole” che vi abita, dove il vento è freddo e pungente ma dove si può cercare un rifugio nel caldo, dove si può entrare a ripararsi e poi ancora uscire a sfidare il vento, partire e ancora tornare perché quel luogo, duro e al tempo stesso ospitale, è anch’esso “un luogo dell’anima”.
Utopia è, come lei dice, un luogo irraggiungibile, perduto nel nostro compromesso continuo col quotidiano, dove un mondo “spietato” ci ha forse tolto le ali che servirebbero per ritrovare il luogo dove vorremo essere nati e dove vorremmo vivere: ma lei sa sempre cogliere e indicare, nelle sue poesie, le cose cui affidare se stessi e in cui far consistere l’equilibrio della vita, tra l’orizzonte e il fuori dove si vedono “altre case, altri comignoli e tetti”, e il dentro dove si possono custodire i segreti, dove la sedia, il tappeto e la lampada, macchiata dalla “pulce nera della mosca estiva”, conservano lo “splendore” necessario per affrontare la vita, quasi punti di ancoraggio nel fluire delle cose.
Mi augurerei di trovare, sulla mia strada, quella bisaccia “con dentro un pezzo di pane” e quella “borraccia con l’acqua” che tanto generosamente ha dichiarato di donare a chi dovesse passare sulle orme lasciate nel suo viaggio.»
Anna Ventura si propone di ristabilire la verità sulle cosiddette «streghe» dal punto di vista di una antropologia emancipata dalla soggezione alle credenze e alle superstizioni popolari, e lo fa con il tocco felice e il distacco che nasce da una approssimazione alla infelicità del mondo femminile e delle sue storie. Cos’è la verità? Si chiedeva Nietzsche, la «verità», è un esercito di metonimie, metafore, antropomorfismi a tal punto e così impreziosite da divenire credenza consolidata, «… le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria, sono metafore che si sono logorate e hanno perduto ogni forza sensibile, sono monete la cui immagine si è consumata e che vengono prese in considerazione soltanto come metallo, non più come monete».
Ecco, di quelle «illusioni» innocue si occupano le poesie di Anna Ventura che ci raccontano con delicata introspezione psicologica i profili delle ultime streghe di cui la memoria collettiva conserva ancora oggi una qualche cognizione.
- Nietzsche Su verità e menzogna fuori del senso morale trad. Giorgio Colli, Adelphi, 2015 p. 36
 Poesie di Anna Ventura da Streghe
Poesie di Anna Ventura da Streghe
L’amara stirpe
Non chi sta sulla nave,
ma chi resta, di sera,
sulla banchina dell’isola piccola,
è colui che veramente parte.
Dopo aver salutato con la mano
la nave che veloce si allontana,
tornerà alla casa spoglia,
all’acqua razionata,
alle cento scalette
che salgono sull’erta. L’amara
stirpe di Penelope
conosce questi inganni: restare
per partire nella lontananza del cuore,
nel silenzio dell’isola remota: Ulisse
vada ramingo:
il mare è tanto grande.
Via San Gallo
Questa è ancora Firenze: un negozietto
di tre metri quadri, pieno di mercanzia:
sono gli oggetti scampati
al tempo e alla selezione
degli antiquari veri: ora
appartiene a loro, due vecchiette avvolte
in palandrane lise; si muovono piano,
con mosse prudenti,
tra vetrinette pericolanti, stracolme.
Quel calamaio rotondo,
di porcellana sottile, verde e rosa,
è certamente francese, vi ha intinto la penna
una dama di condizioni modeste,
ma di gusto sottile. Non vale
il prezzo che le due donne richiedono,
ma sarebbe giusto, entrando,
pagare un biglietto di ingresso: questo
non è un posto qualunque,
è un’enclave, è l’ultimo lembo
di un passato gentile che ancora resiste
ai gelati e alle scarpe di gomma.
L’eletta
La contadina che vide la Madonna
non voleva dirlo a nessuno, ma poi
finì col confidarsi ad un’amica.
Perché niente esiste,
se non è raccontato.
In due tennero il segreto
e ne parlarono solo quando,
lavorando nei campi,
toccò loro un momento di riposo.
La donna sperava
in altre apparizioni e per questo
più volte tornò, da sola,
nel luogo benedetto, e pianse. Ma la Madonna
mai più volle mostrarsi.
Passarono gli anni e quando,
nello stesso luogo
e alla stessa ora, la Madonna
nuovamente apparve, la contadina
continuò a zappare: la sua fede
era rimasta intatta, ma il suo orgoglio
era stato offeso.

Anna Ventura nella grafica di Lucio Mayoor Tosi
Trompe l’oeil
Le zie erano sempre anziane
– oltre i sessanta –, e si stentava a credere
che in qualche passato
fossero state giovani.
Difficile convincersi
che avessero avuto figli, mariti,
interessi terreni.
Perfino i ricordi, che pure coltivavano
con puntigliosa chiarezza,
avevano un che di improbabile: era vero,
quello che evocavano, oppure
era frutto di una qualche finzione? Astratti
erano i biscotti fatti con l’anice, astratte
le coperte lavorate ai ferri,
astratti i capelli color cenere,
i vestiti a righine.
Ora che le zie
sono diventate ritratti,
finalmente nella mia fantasia
occupano uno spazio preciso.
Come i personaggi del cinema.
Come i protagonisti dei romanzi.
Cenere alla cenere
In una sera d’inverno
una vecchia signora
volle rileggere
tutte le sue lettere d’amore. Il fuoco
ardeva nel caminetto, la carta ingiallita
crepitava, fiori secchi
uscivano da buste rosate, un profumo
esile si spandeva intorno.
La vecchia signora
lesse le lettere del suo primo amore e poi
anche quelle del secondo e del terzo.
Al quarto il suo grembo era pieno di lettere
e un dolce torpore le fece chinare la testa.
Sognò di leggere tutte le lettere
e di constatare che tutte
provenivano dallo stesso luogo,
portavano la stessa data
e avevano la stessa firma. Al risveglio
la vecchia signora si accorse
che il fuoco del camino era quasi spento e che
molte lettere le erano cadute dal grembo.
Ma ormai sapeva
che il sogno era vero, e perciò
una lettera, una sola,
valeva per tutte.
La prese a caso
e lasciò che le altre, tutte insieme,
ridessero vita
alla fiamma languente.
In itinere
Passeggiando per la vecchia Europa
come il bambino nella stanza dei giocattoli
dovunque riconosco
cose che mi appartengono, ma il tempo
potrebbe sottrarmele.
Quel tassista miopissimo
che a Parigi ci portò
in un albergo cadente
di Rue Gobelins non era
un uomo dei nostri tempi,
era appena uscito
da una novella di Maupassant;
e a quella finestra che si apre
sul pendio ripido del Castello di Praga,
e tiene appesa accanto una gabbia di canarini,
certamente io mi sono affacciata.
Sono stata seduta
su una panchina delle Ramblas di Barcellona
come una vecchia barbona
che da sempre ci ha fatto il nido.
E così in quel caffè di Vienna,
fumoso e polveroso al tramonto,
pieno di studenti e di signore col cappello,
certamente non entravo per la prima volta.
Forse all’ospedale dei balocchi
di Firenze potrei ritrovare
i miei bambolotti perduti, e sul Ponte Vecchio,
nelle vetrine degli orefici, riconoscere
l’anello, la spilla, gli orecchini
e quel medaglione rotondo
che portavo sul petto,
quando ero una signora dell’altro secolo.
Zia
Sei passata attraverso il coacervo
di pazzi e imbecilli che comunemente
va sotto il nome solenne di famiglia.
Umile e generosa, troppo intelligente
per essere amata,
non hai mai chiesto niente
a nessuno: ti bastava l’amore
che tu davi.
Alta sulle teste di tutti,
come quelle statue di santi
che sfilano in processione,
eteree contro il cielo,
in realtà tanto pesanti
da piegare i robusti portatori,
hai attraversato questa terra arida,
indegna dei fiori che spargevi.
Prima di morire,
all’età di una parca,
sempre uguale, prima
che finalmente ti conficcassero
in un loculo sprofondato in una tomba sotterranea,
avevi già dato tutto, per cui
privasti i superstiti
della gioia della spartizione.
A me
avevi regalato un tegamino di alluminio,
che tengo ancora nella mia cucina.
E questa pagina.
I nascondigli
Certe vecchie signore ancora belle,
che sono state bellissime. Abitano
case i cui nascondigli
esse sole conoscono,
un nascondiglio
anche il loro cuore,
stremato e forte.
I fantasmi degli uomini che hanno amati
sono anche essi nascosti in queste stanze,
buie anche quando sono luminose, luminose
anche quando sono buie.
È nell’immaginario segreto
di queste donne segrete
che essi continuano a vivere:
un’eternità racchiusa in una teca d’argento,
foderata di velluto cremisi.
Da un paese
vicino alla Maiella
Se ti affacci alla finestra che guarda il bosco,
sentirai crescere i ciclamini. È un rumore sottile,
come un filo,
come una nota di Sibelius. Meglio
se ti affacci di notte,
quando c’è la luna piena. Lei
sta lì, che ti bagna di luce i capelli. Il bosco, invece,
è impenetrabile e nero.
I mille fruscii che ascolti
sono le sue tante voci: bruchi
che strisciano, volpi
che si acquattano; gufi. Poi,
quando la notte avanza,
viene il silenzio, e nel silenzio
escono i ciclamini. Al mattino
li troverai tutti nati: un tappeto rosa e viola,
che accarezza le asperità del bosco,
ne fa un unico manto. Allora sai
che l’estate è finita
e l’autunno avanza con passo regale,
col rosso e l’oro, e la Maiella,
qui vicino,
darà le sue ultime erbe magare:
è il momento di raccoglierle,
sperimentarne il potere.
Le erbe magare
Sono una strega piccola,
molto piccola: l’erba su cui cammino
è di poco più bassa di me, un topo
potrebbe stritolarmi. So
di essere in pericolo,
ma è questa, la mia forza: la forza
di un’inferiorità totale.
Vi chiederete
che ci vado facendo, io,
di notte, in un bosco già quasi autunnale,
pieno di gufi e di ciclamini. Vado
perché cerco le erbe magare, le stipo
in un cestello che ne contiene molte.
Con le erbe faccio gli infusi:
talvolta medicine, talvolta veleni.
Dipende dalle fasi lunari,
dall’umore del bosco,
dalla natura di chi beve gli infusi,
il quale, per magia, incontra se stesso:
dipende da lui,
se prende la medicina o il veleno.
Le trine rosse
Io conosco gli odori delle erbe,
li avverto pure da lontano. Oggi
è il giorno della liquirizia: il mio cesto
è pieno delle sue radici. So fare
una marmellata d’uva
intrisa di liquirizia: me la chiedono
anche le pasticcerie.
Talvolta mi ricordo
della donna che sono stata,
negletta e grigia, addosso
solo palandrane scure. Ma dentro,
nella sottoveste,
c’erano le trine rosse. Perciò
mi sono fatta strega.
Il volo immobile
Molti credono che usciamo, di notte,
a cavallo della scopa:
magari fosse vero! Ho visto streghe
addormentate come morte,
striscianti come serpenti tra le forre,
immobili ai bordi dell’acqua,
come coccodrilli. Le ho viste rotolarsi
nei declivi erbosi
e acquattarsi come orse nella neve.
Ma non ho mai visto
volare una strega. Se qualcuno lo crede
è perché alla strega il volo
pare connaturato: lo dice la sua veste svolazzante,
il suo passo veloce,
la sua voce irreale.
Ma soprattutto lo dice il suo sguardo acuto,
volto a fissare le vette, e il naso
che fiuta l’aria. Lo dicono
le sue gambe irrequiete,
le braccia lunghe,
le unghie artigliate: la strega, infatti,
è un’aquila a cui hanno tagliato le ali,
e lei
tenta di recuperarle.
 Donatella Costantina Giancaspero è nata a Roma nel 1955 dove vive. Ha compiuto studi classici e musicali, conseguendo il Diploma di Pianoforte e il Compimento Inferiore di Composizione. Collaboratrice editoriale, organizza e partecipa a eventi poetico-musicali. Suoi testi sono presenti in varie antologie. Nel 1998, esce la sua prima raccolta, Ritagli di carta e cielo, (Edizioni d’arte, Il Bulino, Roma), a cui seguiranno altre pubblicazioni con grafiche d’autore, anche per la Collana Cinquantunosettanta di Enrico Pulsoni, per le Edizioni Pulcinoelefante e le Copertine di M.me Webb. Nel 2013. Di recente pubblicazione è la silloge Ma da un presagio d’ali (La Vita Felice, 2015); fa parte della redazione della Rivista telematica L’Ombra delle Parole.
Donatella Costantina Giancaspero è nata a Roma nel 1955 dove vive. Ha compiuto studi classici e musicali, conseguendo il Diploma di Pianoforte e il Compimento Inferiore di Composizione. Collaboratrice editoriale, organizza e partecipa a eventi poetico-musicali. Suoi testi sono presenti in varie antologie. Nel 1998, esce la sua prima raccolta, Ritagli di carta e cielo, (Edizioni d’arte, Il Bulino, Roma), a cui seguiranno altre pubblicazioni con grafiche d’autore, anche per la Collana Cinquantunosettanta di Enrico Pulsoni, per le Edizioni Pulcinoelefante e le Copertine di M.me Webb. Nel 2013. Di recente pubblicazione è la silloge Ma da un presagio d’ali (La Vita Felice, 2015); fa parte della redazione della Rivista telematica L’Ombra delle Parole.
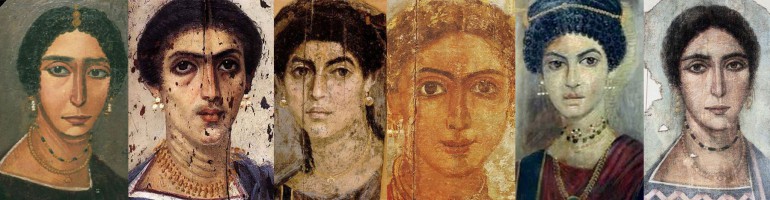
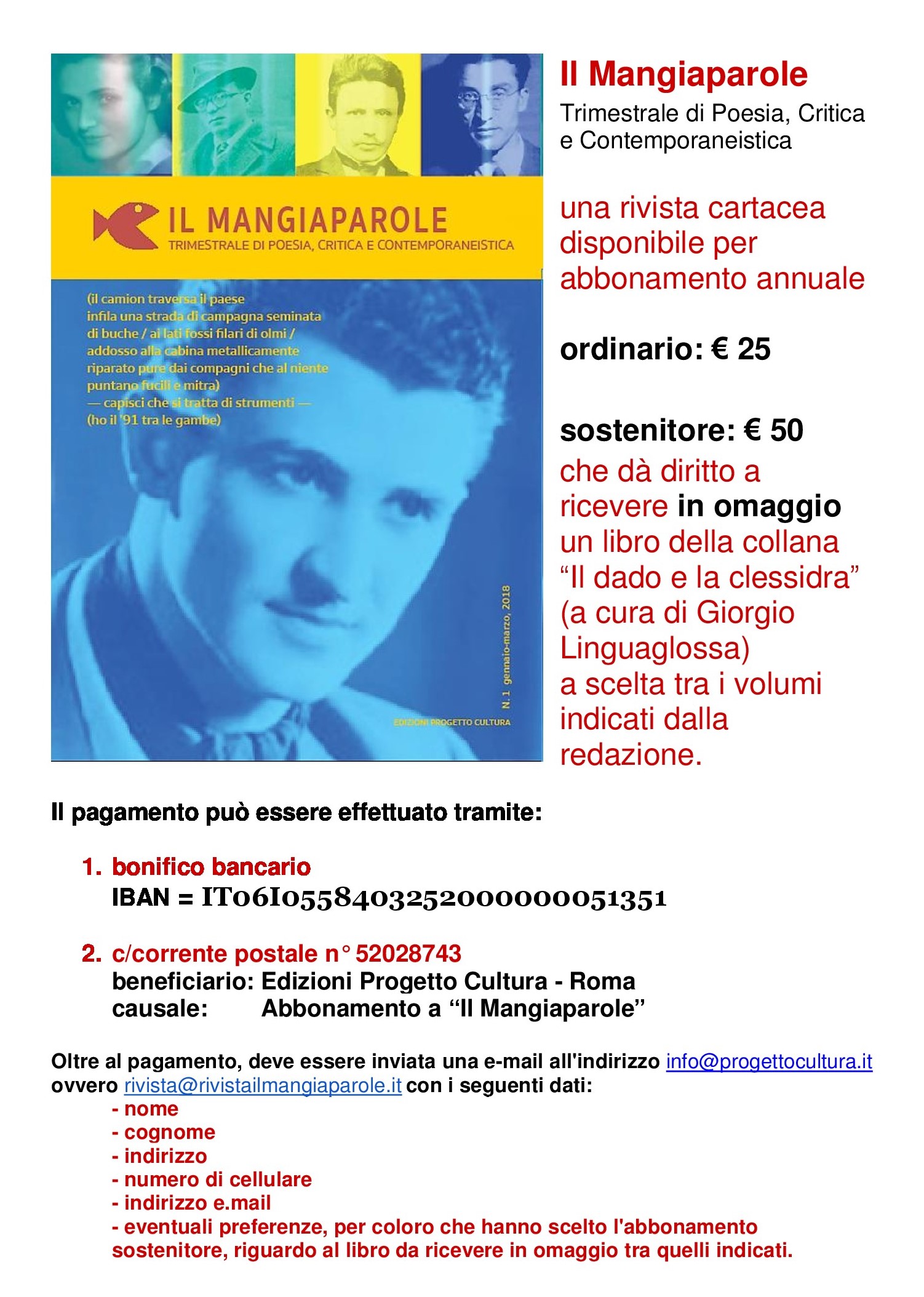
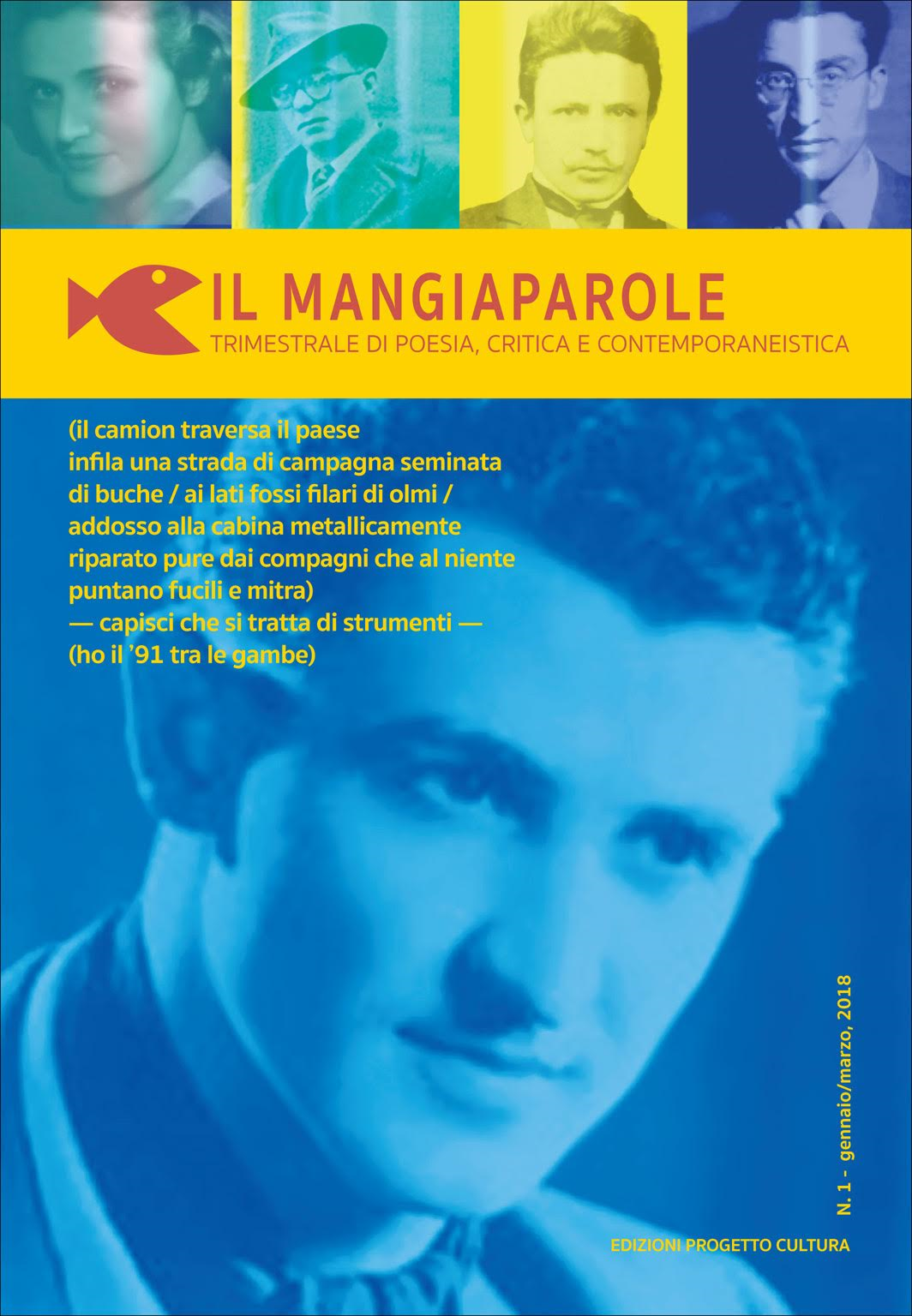

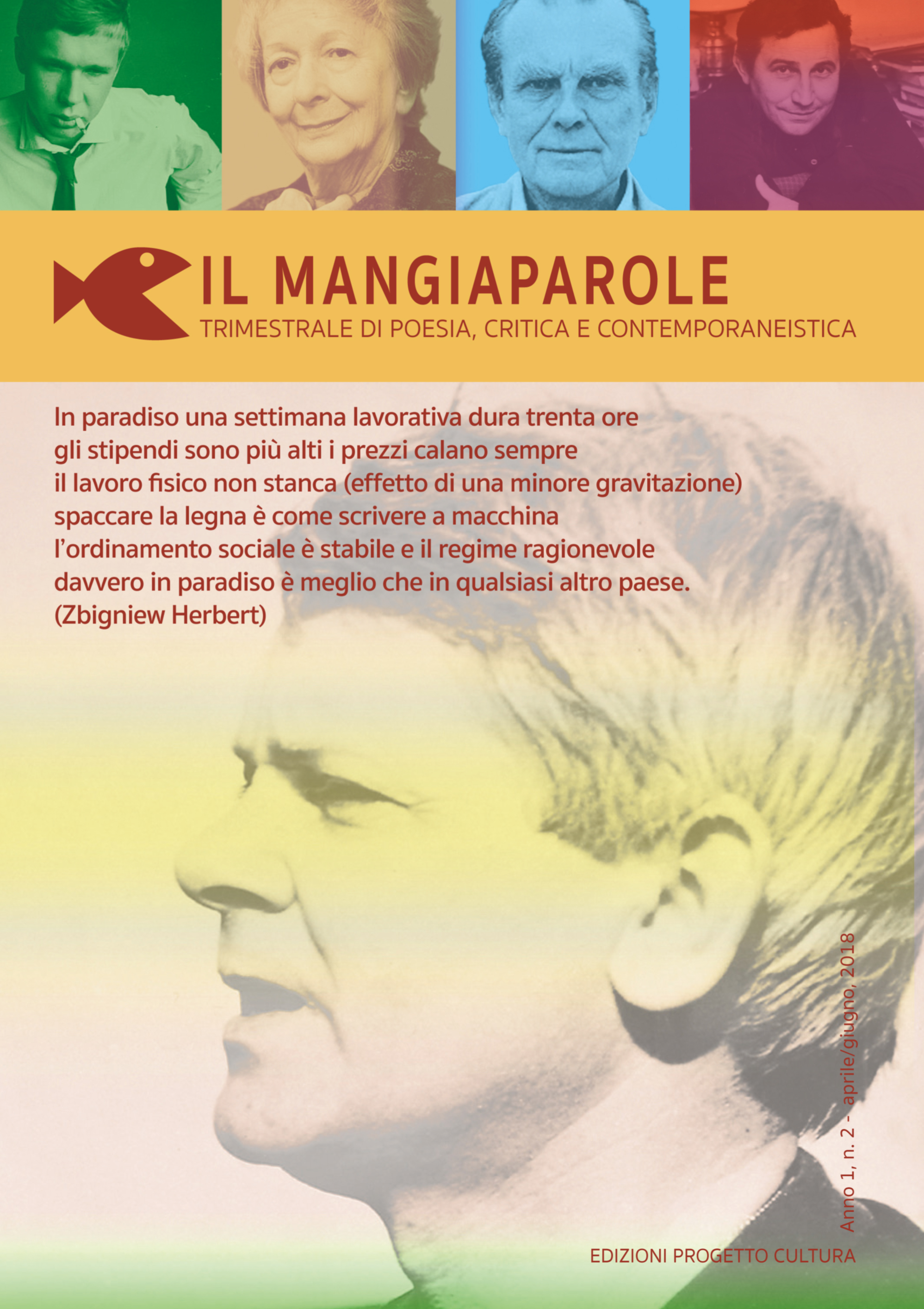



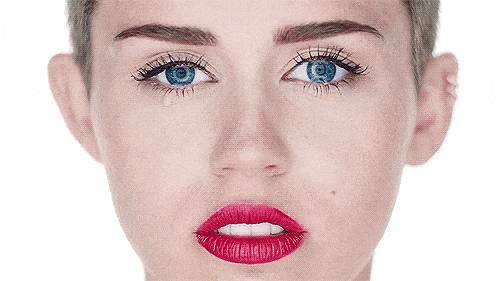
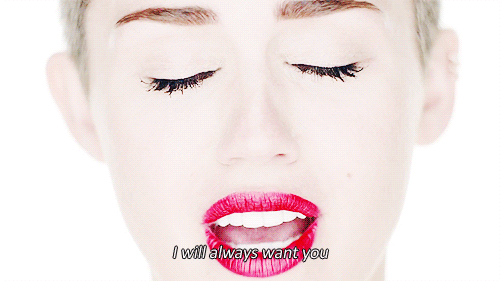
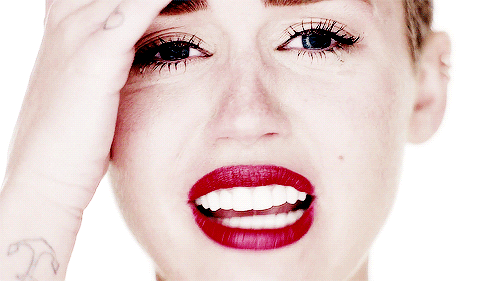
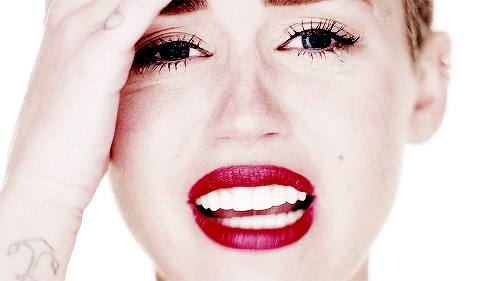
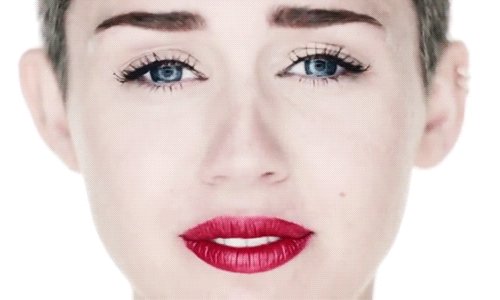



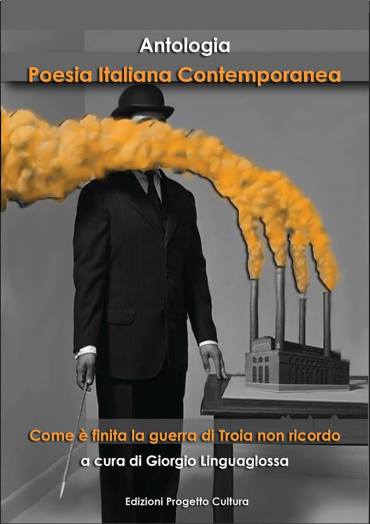




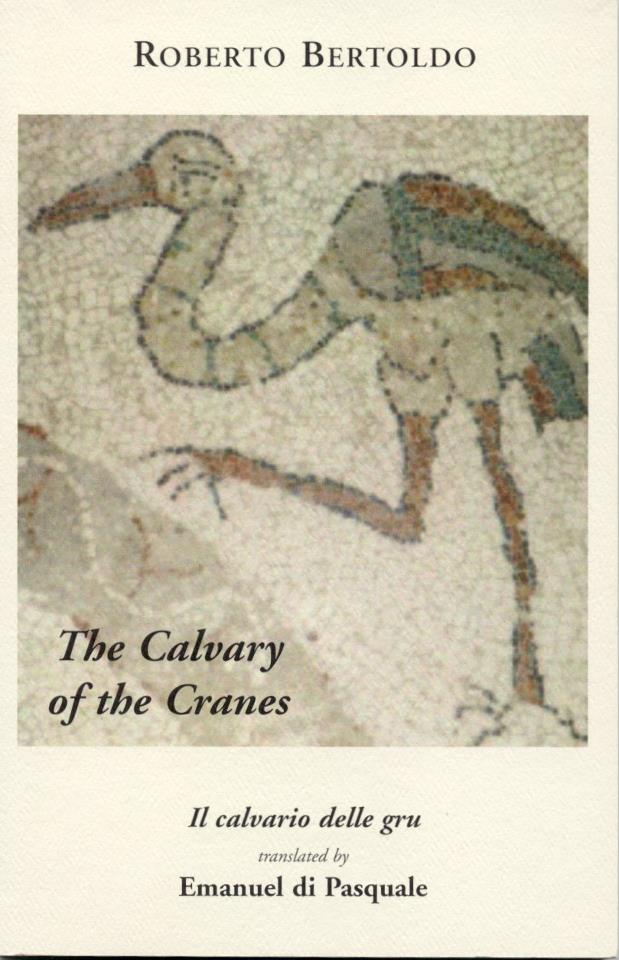
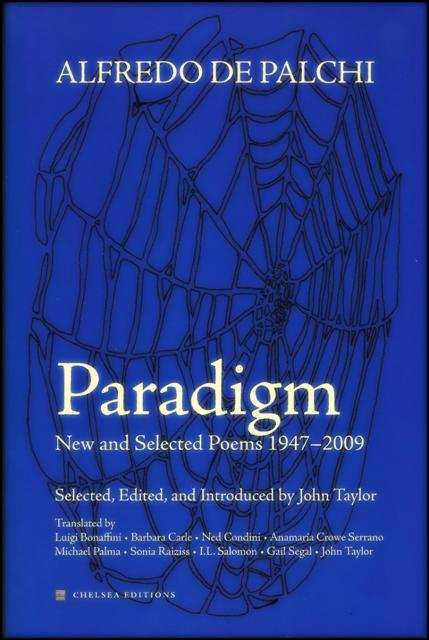


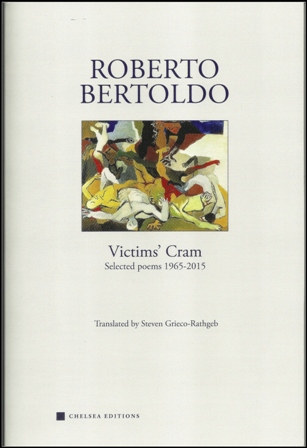





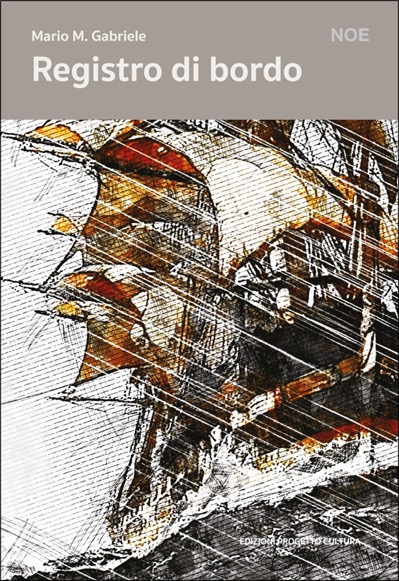

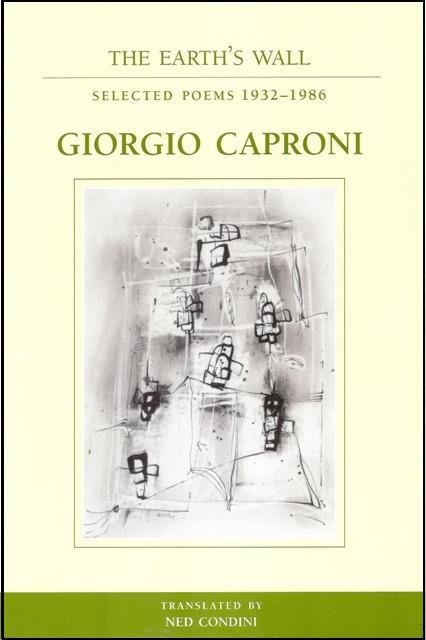
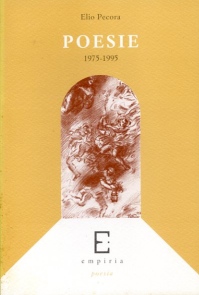

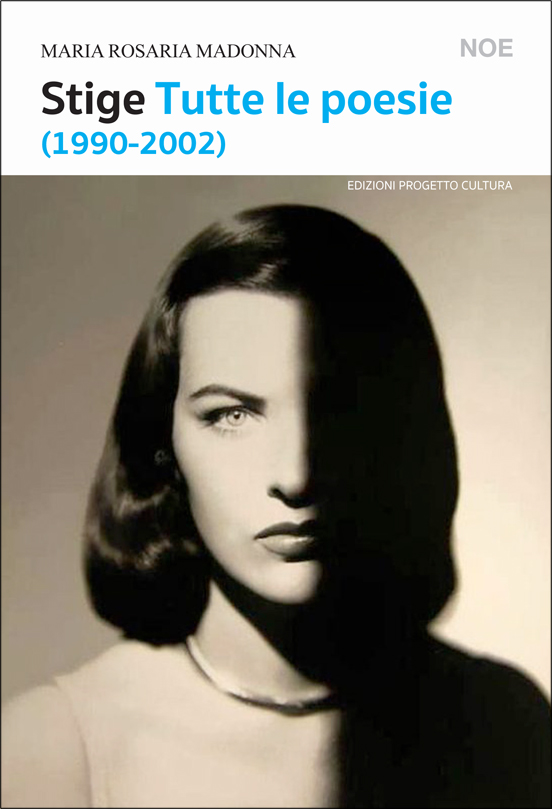

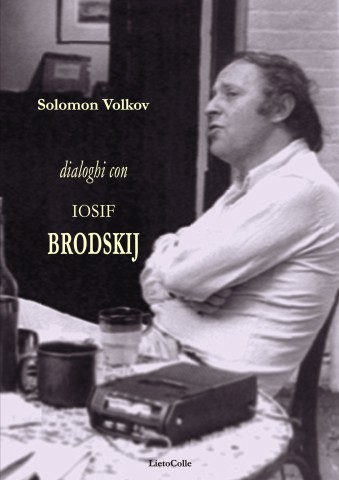




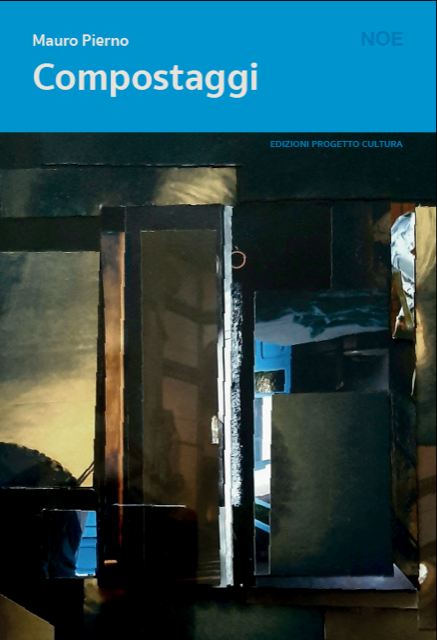
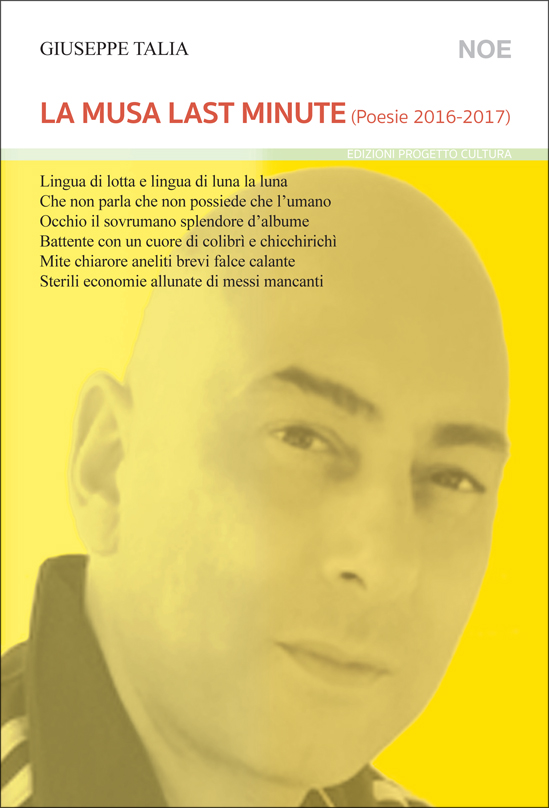


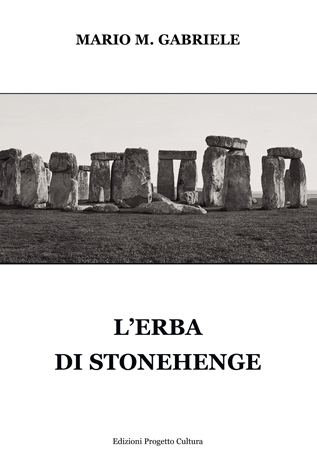
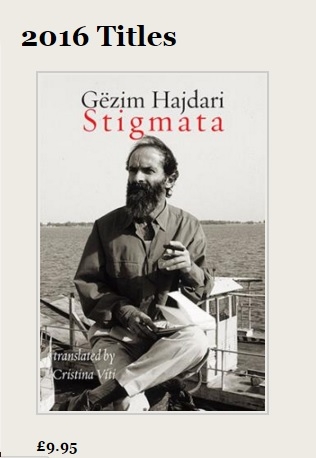
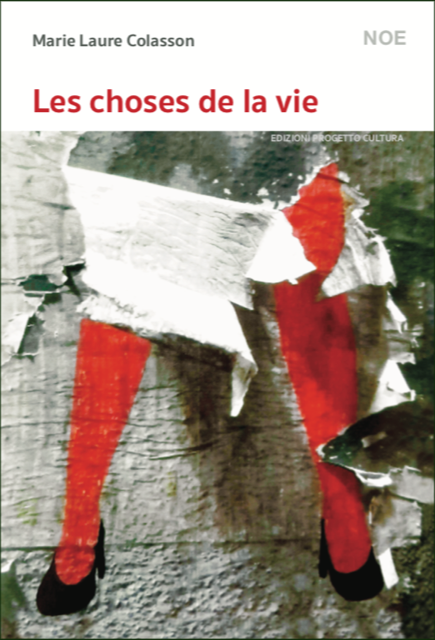




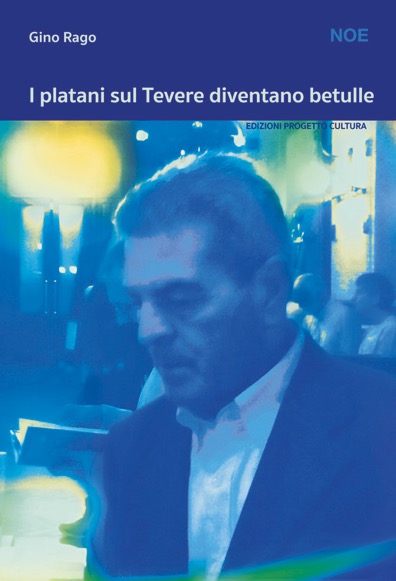
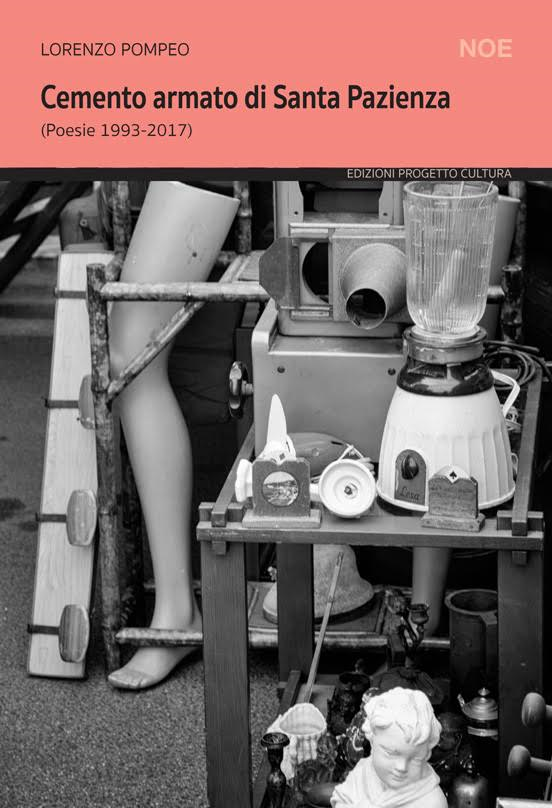
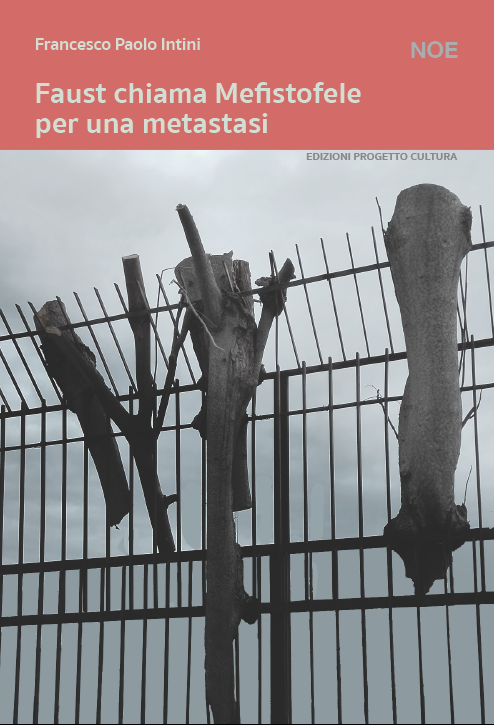

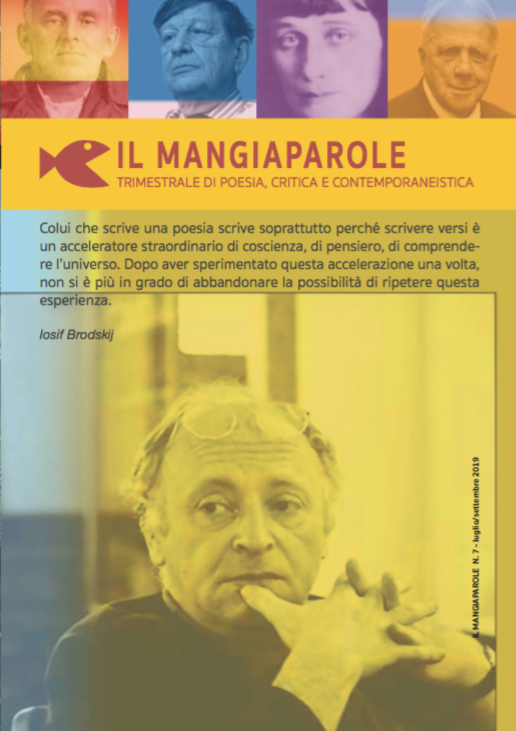




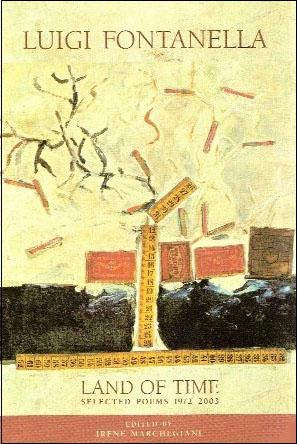








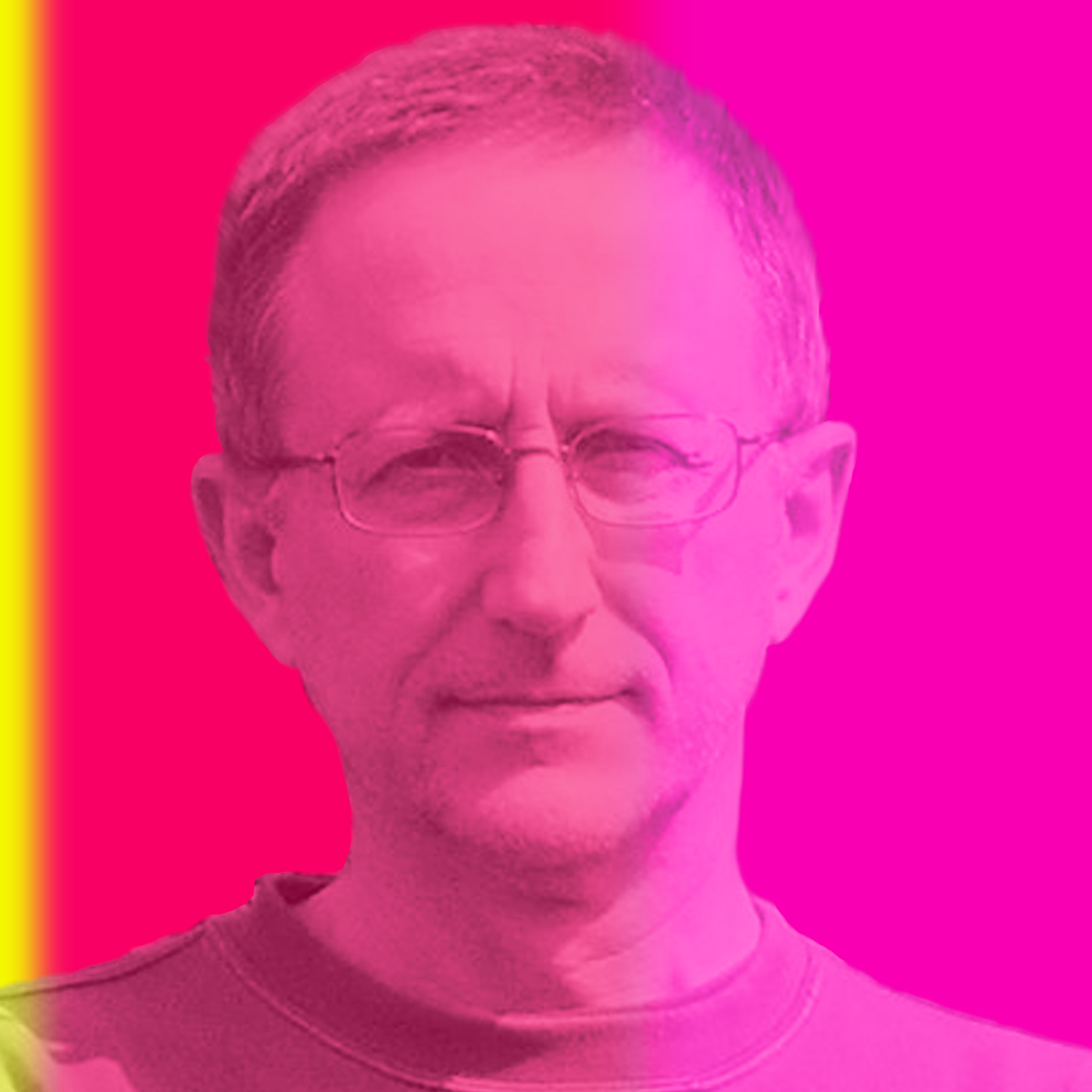







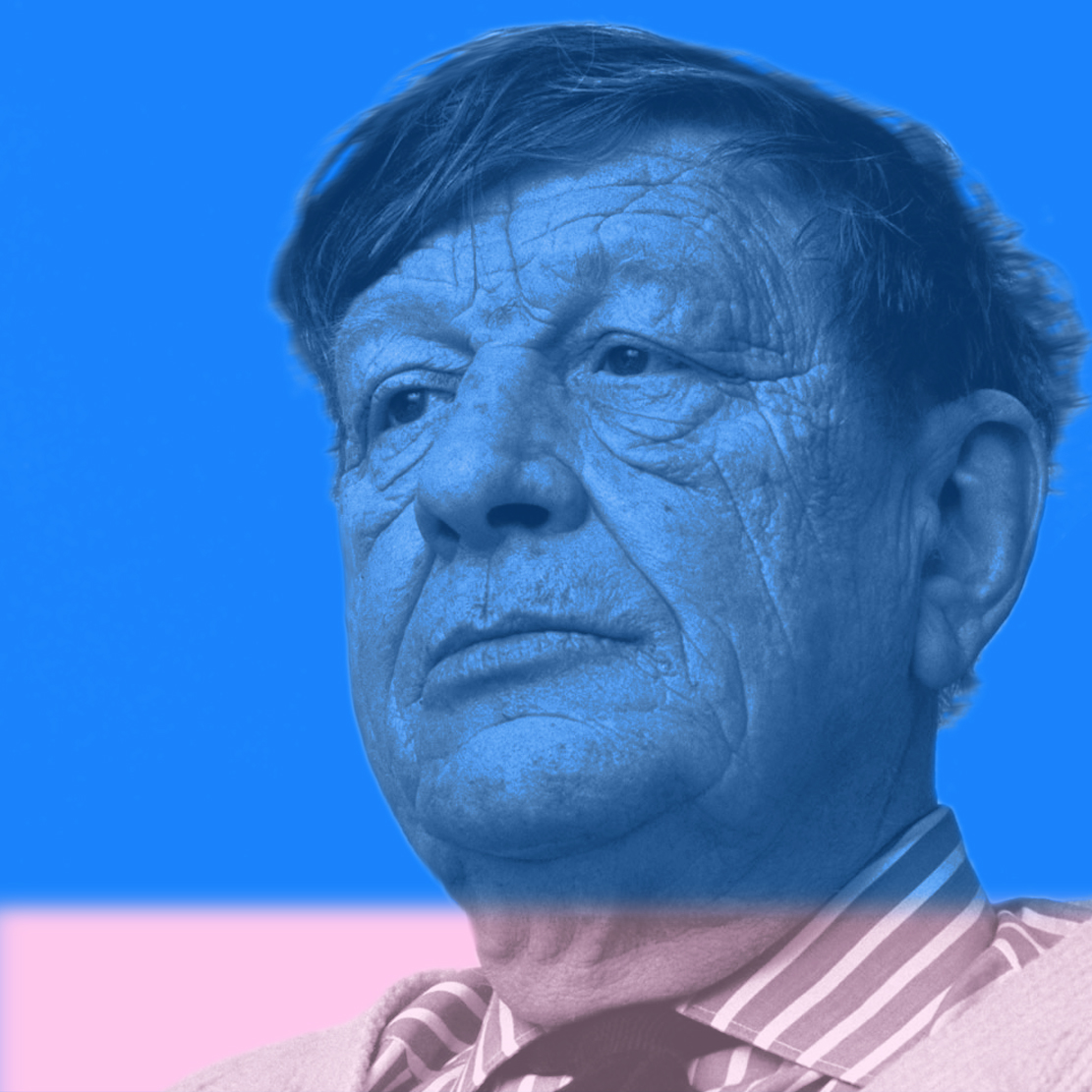



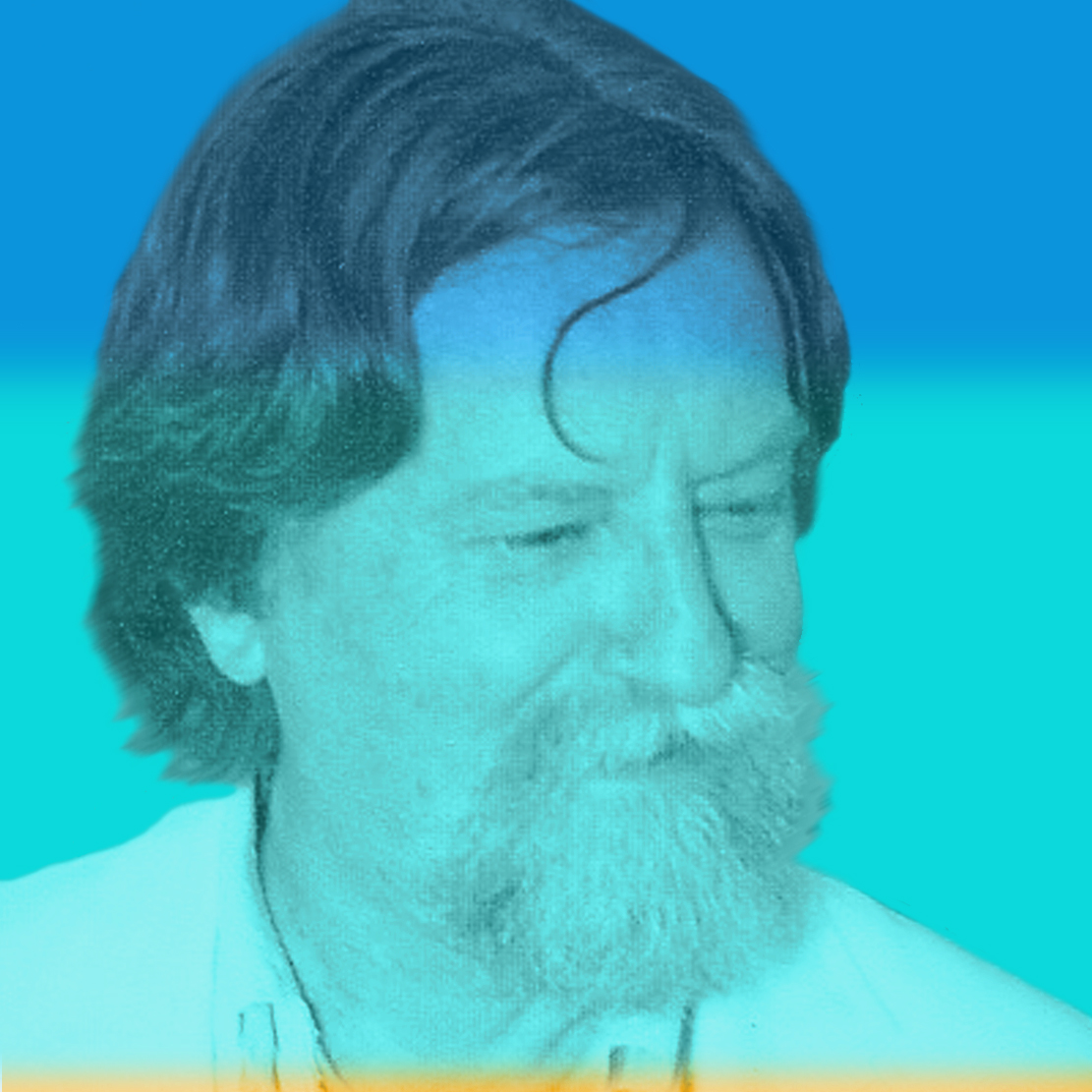
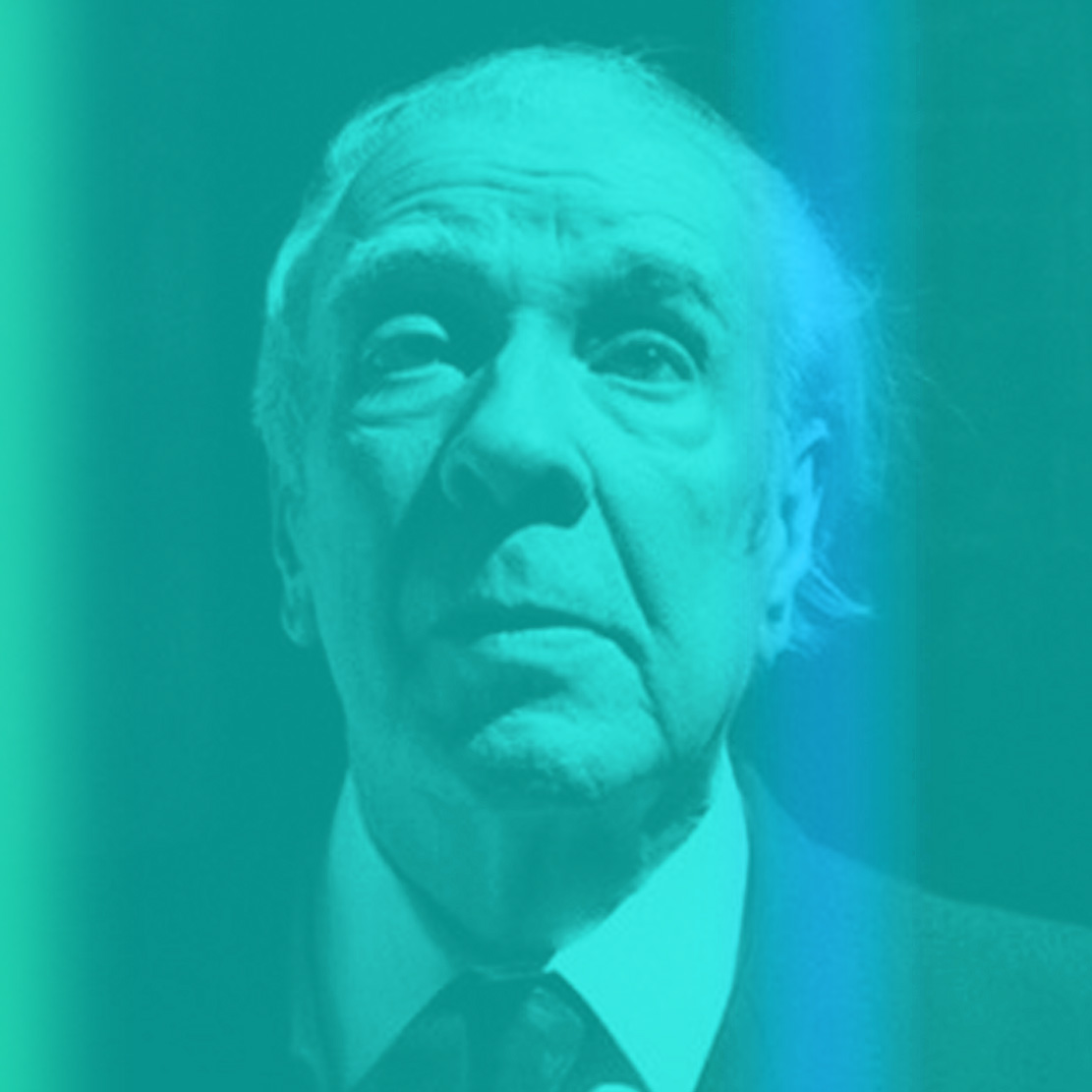




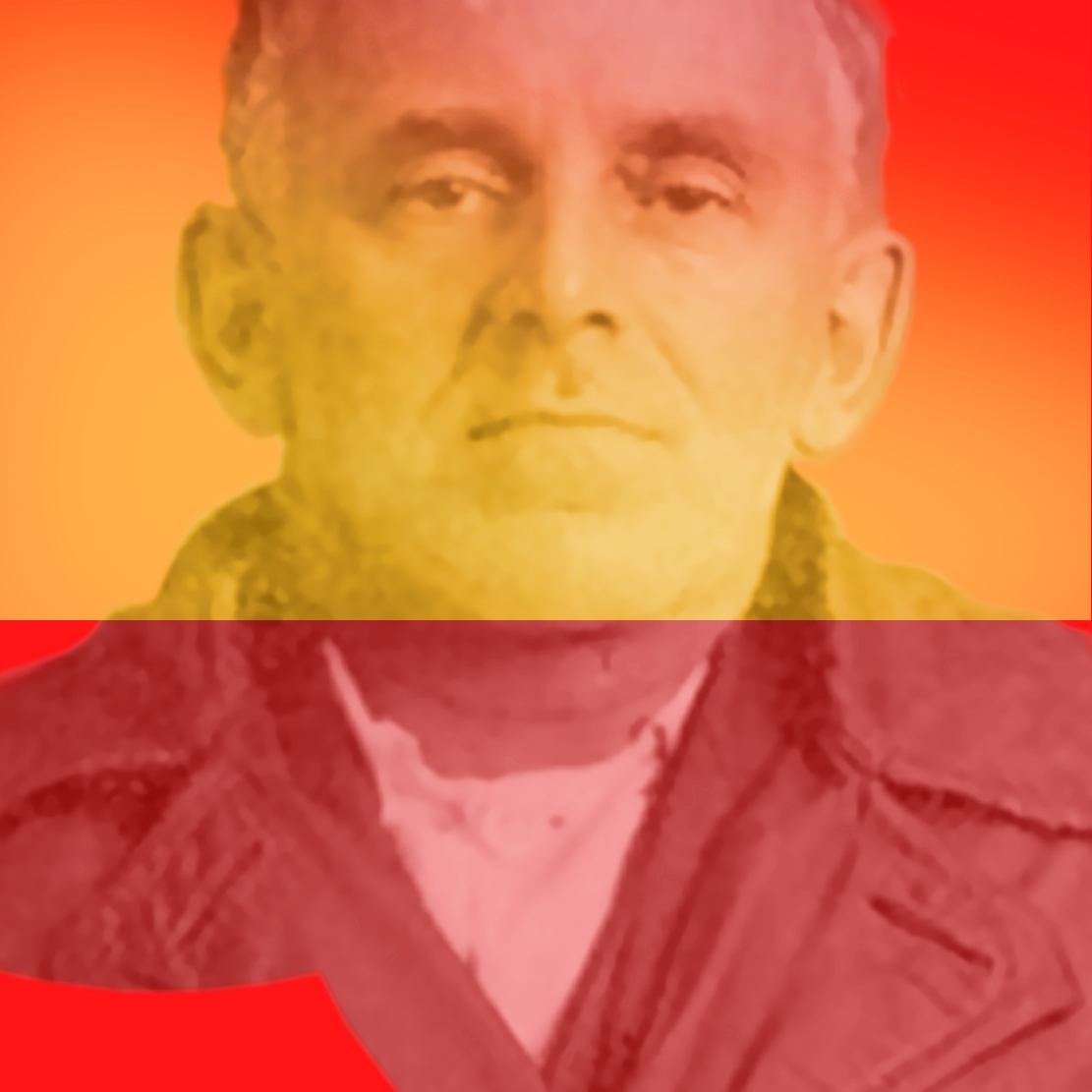






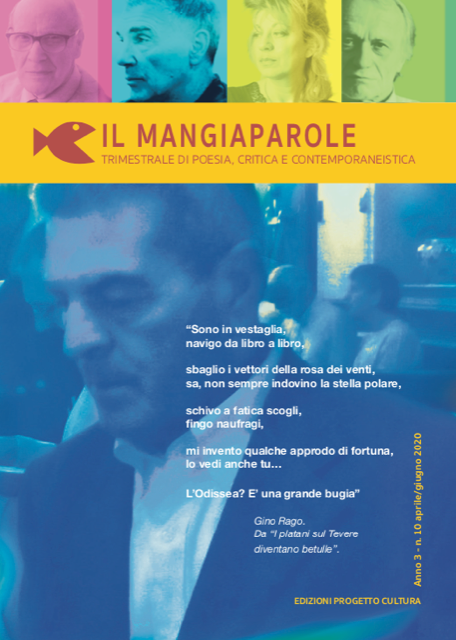




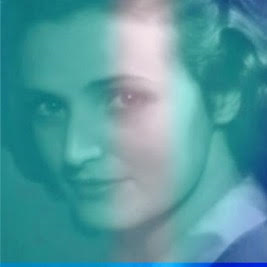
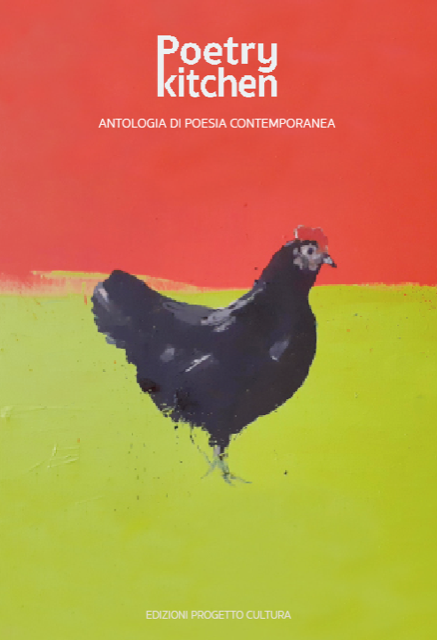



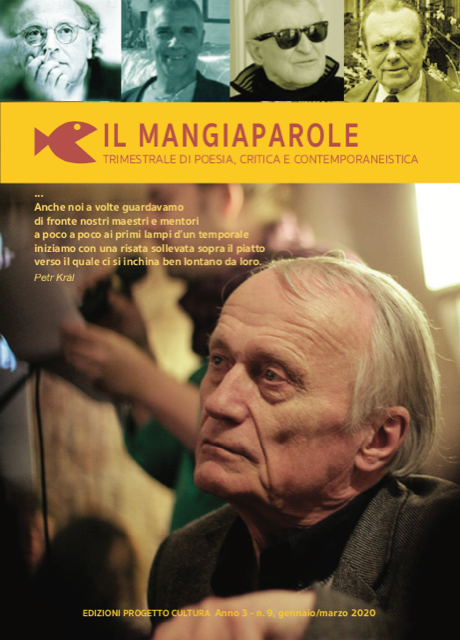











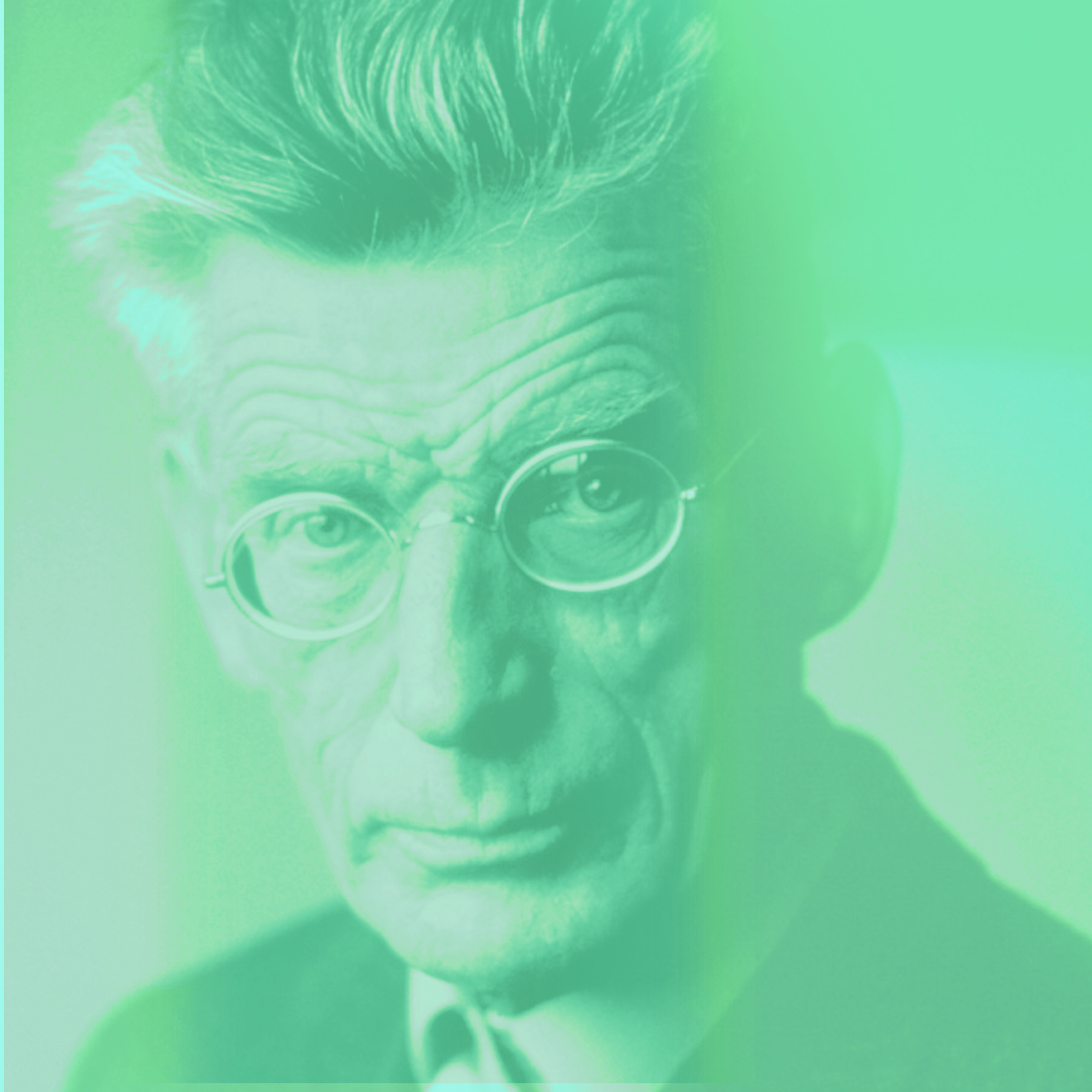
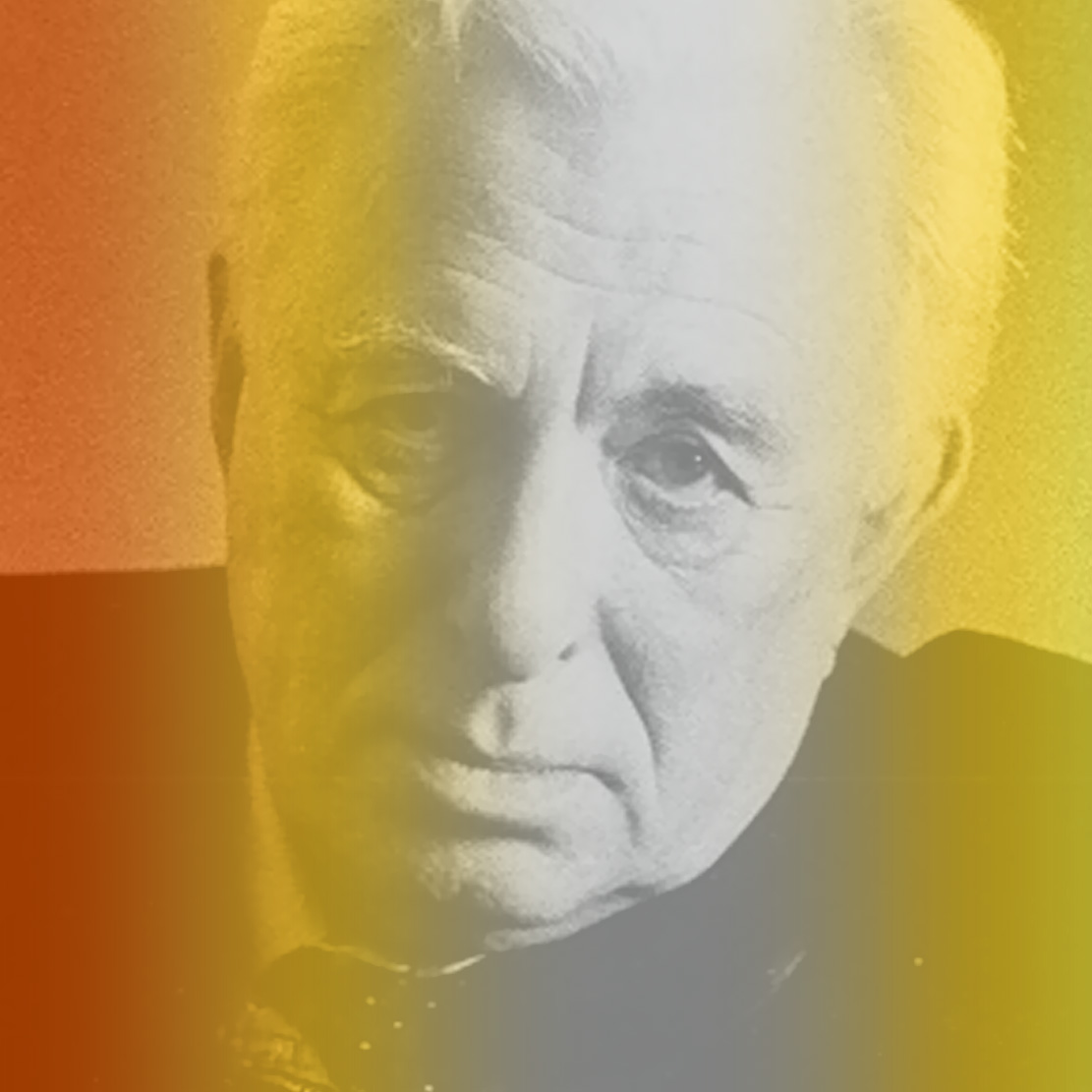









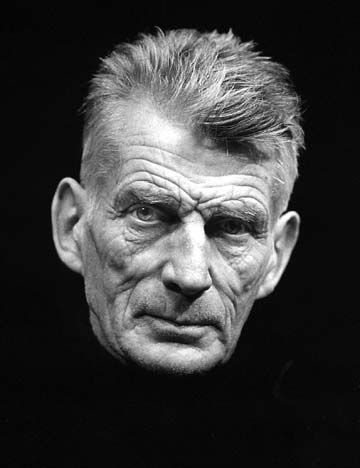


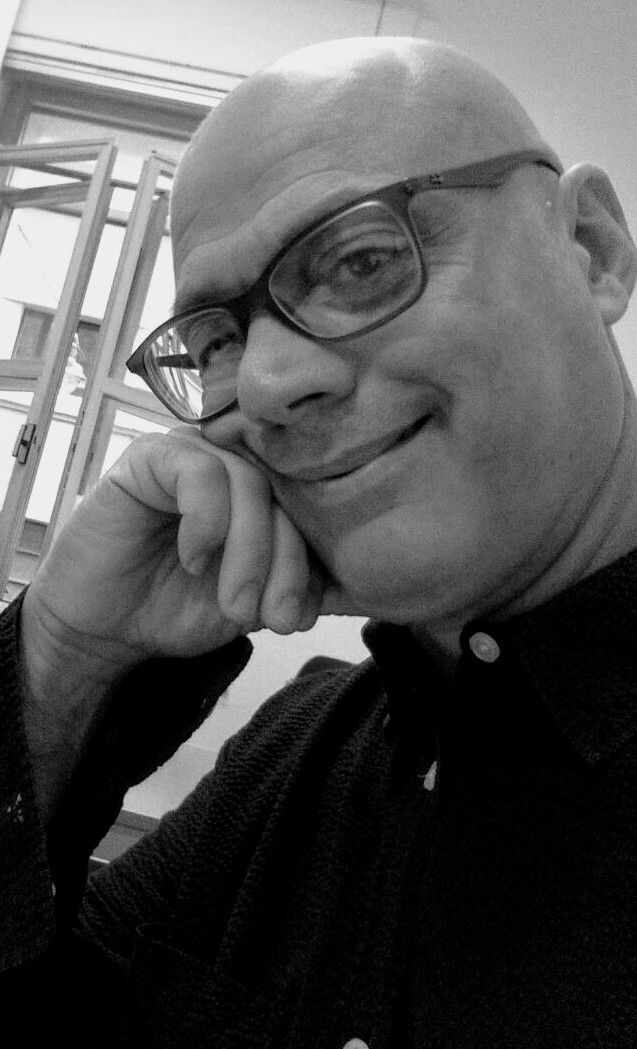
Dalla lettura delle bellissime poesie di Anna Ventura oggi pubblicate, ognuna delle quali meriterebbe un’analisi dettagliata e accurata, sono i dettagli dei luoghi e del tempo che colpiscono maggiormente: nulla è come appare, bisogna essere capaci di “guardare oltre” per comprendere le direzioni suggerite da questa realtà pesante dove si muovono con leggerezza i personaggi femminili che coltivano in se’ stesse un’altra natura e consentono l’accesso, la via per raggiungere una verità celata agli occhi di tutti: questo vale per la contadina eletta che “vide la Madonna” come per le zie che evocano ricordi incredibili, improbabili nel giudizio degli altri.
In “Cenere alla cenere” (titolo deliziosamente ironico nel suo alludere alla famosa formula del rito dei morti) è per esempio il sogno della vecchia signora che mette in comunicazione il mondo interiore, nel quale l’amore è un sentimento assoluto e indiviso, e il mondo esterno dove molte lettere lo rappresentano, ma frantumato e parcellizzato in molte identità: ma al fine del sogno tutto si ricompone, il sogno si è rivelato vero più della realtà quotidiana che lo ha tradito e distrutto, e allora una sola lettera, scelta a caso, può conservare il messaggio d’amore del sogno e le altre avranno la funzione di riattizzare il fuoco (segno simbolico della passione) ormai spento.
Altrettanto magico è quel salto tra tempi e luoghi diversi che percorre “In itinere”: la vecchia Europa è una stanza dei giocattoli dove il tempo può trasformare un personaggio di Maupassant in un tassista parigino, e dove l’autrice può ritornare alle sue vite passate identificandosi con la barbona ,la proprietaria di un castello o la signora dell’altro secolo; ognuna di queste vite è a suo modo vera e tutte si sovrappongono in un fluire del tempo che lascia le sue tracce magiche in quegli oggetti “l’anello, la spilla, gli orecchini, il medaglione rotondo” testimoni delle vite passate. Oggetti che conservano ricordi e vita come il “tegamino d’alluminio” donato dalla zia: e questo passaggio di proprietà sembra non solo un dono anonimo ma un “passaggio di qualità”, una trasmissione morale di identità e di ruoli più che materiale, un tegamino che racchiude quasi una investitura affettiva, emotiva e poetica, un passaggio di consegna come un passaggio di testimone nella corsa della vita.
Ed ugualmente, tra gli oggetti che custodiscono un mondo di affetti e ricordi, la “teca d’argento, foderata di velluto cremisi”, un nuovo luogo della memoria dove si depositano sentimenti e ricordi, naturalmente invisibili all’esterno e percepibili solo, come nel sogno davanti al fuoco, da chi conserva nel profondo i mille strati di una vita che può apparire agli altri solo in superficie e che si nasconde nella sua vera essenza, tra il buio della vita interiore, non confessata e non dichiarata, e la luce di quella esteriore e visibile che invade le stanze.
Ma tra le poesie dedicate alle “streghe”, oltre al delizioso particolare delle “trine rosse”, trasgressive e deliziosamente ammiccanti, ma anch’esse nascoste sotto le apparenti palandrane scure, un dettaglio mi ha colpita particolarmente, ne “Le erbe magare”: gli infusi che possono essere medicine o veleni, a seconda della “natura di chi beve gli infusi, il quale, per magia, incontra se stesso: dipende da lui, se prende la medicina o il veleno”. Leggendo questi versi, ho pensato a un’altra “strega”, Circe, che nella poesia di Julia Webster del 1893 offre da bere nella sua coppa a tutti gli uomini che la raggiungono. Non è altro che la coppa della Verità, in cui ognuno ritrova se stesso e la propria vera natura, accusando poi Circe di aver usato veleni per trasformare gli uomini in animali: “Ho scelto forse io che fossero quel che sono? Li ho estraniati io da se stessi con velenosi incanti? No: ogni sorso della mia coppa, fosse acqua pura o vino genuino, li rivelava a se stessi e gli uni agli altri. (…) Ci fosse stato un solo uomo vero tra di loro avrebbe bevuto il sorso come l’ho bevuto io e sarebbe rimasto lì piantato, illeso”.
"Mi piace""Mi piace"
Ringrazio Giorgio Linguaglossa,e con lui tutti i cari amici che hanno arricchito col loro prezioso contributo critico le mie “Streghe”,frutto della mia fantasia più segreta,del mio immaginario inquieto.Tutti han no contribuito(come è proprio della critica migliore) a rivelarmi aspetti a me stessa sconosciuti,pensieri sedimentati nel tempo ,quasi miracolosamente riportati alla luce da un’ispirazione capricciosa, che sceglie,a mia insaputa,che cosa perdere e che cosa conservare.Da sempre mi divido tra i suggerimenti della ragione e quelli della fantasia; oggi li sento finalmente quasi unificati.
"Mi piace""Mi piace"
Video di Gianni Godi
poesia di Michele Gentile
In Frantumi
Una fiaba scivola,
nei respiri,
ancora.
Poi questo mare si alzerà,
correrà a svegliare il faro.
Le rose torneranno a pregare
le spine a conoscere altre corone.
La cura di una carezza
senza dolore,
ancora.
Poi questo cielo piangerà
correrà a cullare
la vacuità del vero
e noi
non avremo più sogni da ordire.
Già reca silenzi
la stagione dei sorrisi,
in frantumi giace
questa nostra terra.
"Mi piace""Mi piace"
E’ davvero eccezionale vedere come Anna Ventura continua ad alzare la sbarra dell’eccellenza della sua poesia – e quindi della poesia in genere: la alza, la alza, e non è mai alta abbastanza. Incredibile, il processo di affinamento che si legge in queste poesie. Intanto, con delicatissima ironia, con allusioni afferrabili solo in parte – per cui il loro fascino rimane sempre intatto – con saggezza, con uno stile lieve, mai aggressivo o posato o falsamente intellettuale, Anna Ventura riesce a dare al lettore, “Poesia”.
Anna Ventura non appartiene a nessuna scuola di poesia, a nessun movimento. Non appartiene in realtà a niente. E’ stato, immagino, un viaggio lungo, lunghissimo: che va avanti imperterrito.
Nessun approccio teorico può costringerla dove lei non vive. Lei è solo se stessa: ma in qualche modo, in queste poesie, lei evoca per noi il mondo.
Questa sì che è una poesia che indica la via che esce dalla non-poesia che leggiamo da così tanti anni.
Proprio per questo, in punta di piedi, Anna Ventura è un ispirazione per tutti i poeti.
Grazie davvero.
"Mi piace""Mi piace"
Si dice comunemente che il linguaggio è in gioco, che ci sono cose importanti in gioco, che il gioco è un gioco… e invece nelle mani sapienti di Anna Ventura scopriamo che nella sua poesia è in gioco il linguaggio, sono in gioco nientemeno che le sorti del linguaggio, il gioco nelle sue mani diventa una leggerissima ironia frutto di saggezza e di dirittura di poesia, perché Anna Ventura sa che la poesia è gioco ma del tipo più alto, di quello senza finalità di lucro o di scopo, il gioco di queste «streghe» è un gioco serissimo che va condotto con raffinatissima ironia, una ironia leggerissima fatta di insostanzialità. Come scrive Steven Grieco: «lei evoca il mondo» con il suo semplicissimo scrivere poesia, fuori dagli schemi e dalle parole d’ordine del novecento, quel novecento che lei ha attraversato con cognizione di causa fin dal 1972 quando diede alle stampe il suo libro di esordio dal titolo significativo: Brillanti di bottiglia…
"Mi piace""Mi piace"
Gino Rago – Dalla Antologia “Tu Quoque [ 2014 ] a Streghe [2018] la poesia di Anna Ventura verso una nuova parodia
Tu Quoque [2014]
Forse è difficile apprezzare appieno l’icasticità, la leggera ironia del dettato poetico della poesia di Anna Ventura, «la Szymborska italiana» come è stata felicemente definita nel blog “L’Ombra delle Parole” da Giuseppina Di Leo, sospeso tra attenzione e ritenzione, interrogazione e risoluzione. Nella poesia della Ventura assistiamo alla poesia delle «cose», dove sono le «cose» che ci parlano tramite la loro distanza; è all’allestimento della «distanza» che qui ha luogo, l’allestimento di un luogo dove sia possibile l’incontro tra la voce parlante e l’occhio di chi legge e ascolta. È una poesia che nasce da Atena che «conosce la superficialità degli dei», dalla Sibilla che non cerca la verità delle «cose» ma il loro «evento», da Antigone, che invece cerca la verità delle «cose» al di là e al di fuori dei discorsi discordi dell’agorà, lontana mille miglia dai reumatismi dell’intelligenza e dalle insolvenze dei discorsi suasori della politica e della poesia corrotta dalla retorica e dai sofismi dei sofisti. La loro parola è ora lieve ora tragica ora soffusa di melancolia. La Sibilla, anch’essa è leggera, scrive le proprie sentenze sulle foglie degli alberi, abita la superficie della materia, cambia umore, e così cambia anche i suoi responsi. La poesia della Ventura è poesia politica e ermeneutica perché nasce dalla meditazione sopra le «cose», siano esse “Gli sposi etruschi”, o “Le case” o le poesie dedicate alle “streghe”, siano “Due fili d’erba” o qualsiasi altro argomento come il poeta Nerone, preso ad emblema della follia poetica, o Giulio Cesare che celebra inconsapevole il suo trionfo che sarà la sua rovina, o “La guardiana delle oche”, così misteriosa e insondabilmente autentica. “La neve di ovatta” è un ricordo dell’infanzia, una stregoneria che rievoca il mondo in cui tutto era un mistero. L’ultima poesia dell’antologia (che qui viene riprodotta per prima) è il testamento spirituale di Anna Ventura: la parola che pronuncia «il dissenso».
In nome dello spirito
Questi piccoli fogli bruceranno
come tutto il resto, se è già scritta
l’ora dello sterminio. Ma,
poiché ancora ci è data la parola,
pronunciamo il dissenso.
Streghe [2018]
Suggerirei al poeta del nostro tempo di recarsi nel borgo di Via delle Streghe, [borgo noto e Via ben familiare ad Anna Ventura].
Riuscirà egli a scorgervi la porta nel vicolo, incorniciata da pietra candida di quelle montagne, sulla quale le Streghe operarono la magia di poterla vedere soltanto loro, come unica via di salvezza?
Quella porta [lo afferma Cesare Ianni nel suo denso scritto nel risvolto di copertina della raccolta “Streghe” di Anna Ventura] e quella Via esistono ancora, ma non a tutti è dato di vederle… [Ergo, Via delle Streghe e Porta, invisibile ai più, come metafore della Poesia, per Anna Ventura?].
Ho voluto vedere nel dato reale che la stessa autrice rimarca e rivendica per la Città dell’Aquila la possibilità di estrarne una valenza di correlativo oggettivo o appunto di metafora: la Porta delle Streghe, esistente realmente ma visibile soltanto a certi individui portatori di ben precisi valori di cultura, di potenza immaginativa, di sentimento di apertura e di accoglienza verso l’insolito e il Mistero del vivere, è ben riuscita metafora della poesia e quegli uomini, in fondo un po’ speciali, sono i poeti.
Mi piace interpretarla così la poesia di questa recente raccolta di Anna Ventura anche perché soltanto un certo tipo d’uomo può conquistare una strega e può con lei costruire un nido. Interpretando i versi con i quali l’autrice magnificamente chiude il suo poemetto
”[…]Quando ciò accade,
l’arcobaleno ha i colori più intensi, i ruscelli
scorrono più veloci e le mucche/
fanno il latte buono.”
si nota senza sforzi che da essi si distacca la volontà luminosa del poeta di volervi
suggellare il miracolo alla portata dell’atto poetico vero, un evento del tutto simile alla “SORPRESA” di cui ha parlato Papa Francesco nella Omelia di Pasqua: «Ogni atto di Dio genera una sorpresa…»
E questa sorpresa può essere in grado di “mettere fretta” a certe persone, oppure di lasciarle nella stasi della indifferenza, come spesso succede con ‘altre’ persone.
Le donne che si recarono al Sepolcro notarono la pietra appoggiata alla parete sepolcrale e non videro il corpo di Gesù in esso depositato morto dopo la deposizione dalla Croce. Una sorpresa, per il cristiano ‘la massima sorpresa’.
E le donne in fretta si misero in moto per annunciare l’evento. Altri di fronte allo stesso evento rimasero immobili, non subirono la spinta a mettersi in movimento in fretta. Com’è forse per la poesia, per Anna Ventura la poesia-creatrice-di sorpresa
Che mette in moto alcuni, che lascia fermi altri, ma chi si mette in moto per la sorpresa poetica si mette in moto in fretta e corre verso gli altri per con-dividerne
il senso del mistero. Questa la cifra tematico-allegorica che colgo nel poemetto Streghe di Anna ventura, peraltro magnificamente arricchita da stupende meditazioni artistiche da parte di artisti di forte postura estetica.
Ma la poesia in fondo se è anche “arte conoscitiva”e come tale radicata nella Storia,
essa è preminentemente “arte del linguaggio” e come tale si radica nella lingua.
In sede puramente estetica, la poesia di Anna Ventura da Tu Quoque a questo recentissimo lavoro poetico Streghe, per il serio lavoro sul linguaggio condotto dal poeta d’Abruzzo sui nuovi versi, per senso del ritmo, per intonazione generale dell’intero poemetto, per accento, per sillabazione e per quella che vien detta ‘durata’, giunge a una personalissima prosodia in buona parte comparabile a quella
di un Różewicz
[“Queste forme un tempo così ben disposte
docili sempre pronte a ricevere
la morta materia poetica
spaventate dal fuoco e dall’odore del sangue
si sono spezzate e disperse…”]
che Giorgio Linguaglossa, nello studio magistrale dedicato al poeta di Polonia, non ha esitato a definire «sorprendentemente ricca, frastagliata, vissuta e ritmicamente snodabile…», anche se l’autrice di Streghe continua a misurarsi lucidamente con la poetica delle «cose», immergendosi ,come ha con pertinenza segnalato Rossana Levati in una nota su una poesia della Ventura,
«nel grande fiume delle cose che non aspettano niente»,
ma continuando a dichiararsi estranea a quella che, con felice intuizione, Giorgio Linguaglossa, riferendosi a Tu Quoque, propose come «poetica logocentrica».
Né poteva essere altrimenti se sono le stesse Streghe a dichiararlo [in ‘Il latte buono’, pag. 51]:
“Noi streghe non ci innamoriamo: lo vieta
il giuramento a Lilith,
nemica di Adamo[…]”
Alla lettura de La casa bassa a suo tempo scrissi questo commento [plaudo a Donatella Costantina Giancaspero per averlo ripreso nella sua densa e colta nota su Anna Ventura]:
«Quale è l’impianto poetico generale de “La casa bassa” di Anna Ventura se non quello di contrapporre in maniera stilisticamente ben riuscita un tempo “premoderno” al tempo postmoderno se non postcontemporaneo disgiunto definitivamente dalla dimensione spaziale, e un luogo antropologico ai «non luoghi» dello storico-antropologo Marc Augé? La Ventura non a caso parla alla maniera della Cvetaeva di ‘luogo dell’anima’.
E che fa il poeta in questo perimetro di libri, tappeti, gatti, legni di cui si conoscono perfino i respiri, perfino le voci? In questo luogo antropologico ben delimitato, sottratto all’infinito, il poeta si prepara, circondato dalle sue ‘cose’, e in un’atmosfera da Antologia Palatina [“le allegre lusinghe, la musica, il canto, le coppe audaci nel brindisi e nel canto… tutto si spegnerà] all’ultima attesa…[…]»
A proposito di porte, Rossana Levati rilevava: «Leggendo le precedenti poesie di Anna Ventura anch’io sono sempre stata colpita dall’immagine della porta da aprire, così ricorrente nei suoi scritti: la porta dell’orrore di Barbablù, la porta dell’armadio delle meraviglie, la porta che racchiude il giardino segreto, tutte porte “magiche”, che non è dato a tutti vedere e tanto meno aprire, ma solo a pochi eletti che ad ogni costo vogliono vedere cosa c’è dentro, o al di là».
Ne consegue che nella esperienza poetica di Anna Ventura non è possibile eludere
« la porta» e aggiungerei «il ponte» come simboli-correlativi metafisici-metafore del postmoderno, e del post- postmoderno, carichi come sono di ambiguità perché porta e ponte possono separare o unire, favorire l’incomunicabilità e la divisione o consentire la comunicazione: se è chiusa, la porta divide, se è aperta la porta unisce e fa comunicare.
Le porte di Anna Ventura vogliono unire, desiderano consentire la comunicazione fra i lettori e le cose della sua poesia dichiarandosi nel contempo estranea alle poetiche
logocentriche. E Rossana Levati nelle meditazioni a me comunicate nella stessa e-mail
osservava:
«[…]la Ventura è estranea a una poetica “logocentrica”, perchè se da una parte stanno le parole, e dall’altra le cose, è ad esse che appartiene la sua poesia[…]»
Gino Rago, 7 aprile 2018
"Mi piace""Mi piace"
Amici carissimi, temo di non sapere esprimere pienamente l’affetto e la gratitudine per tutti voi,che mi siete vicini in ogni momento della mia giornata; avete saputo dare alle mie Streghe le ali delle farfalle.A Giorgio debbo una riconoscenza illimitata per la costanza e l’affetto con cui ha seguito la mia difficile uscita dal bozzolo; perciò un filo di seta mi lega per sempre a lui,alla sua inesausta attività,al suo inesauribile coraggio.
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo Giorgio, ricevo ora il tuo prezioso volume.Lo leggerò con grande attenzione.Grazie per avermi fatta partecipe, ancora una volta, del tuo lavoro molteplice.Auguri anche per il tuo onomastico,
per la primavera viva di Trastevere.
"Mi piace""Mi piace"
Leggendo queste poesie di Anna Ventura ho incontrato per caso una poetessa (scusate questa parola che molti considerano antiquata, ma su questo non transigo) che avevo sempre in mente, ma che avevo smarrito col passare degli anni, e che ormai disperavo di ritrovare. Ho visto rinascere immagini del passato, ho provato l’emozione dei misteri svelati, ho goduto un attimo di luce e di vera poesia. Grazie Anna!
"Mi piace""Mi piace"
Grande consonanza di ispirazione nell’energia memoriale che circola nelle poesie di Anna Ventura. In particolare mi accomuna anche il lavoro di documentazione sulle fonti di un tema che ho approfondito storicamente dal punto di vista dell’Inquisizione. Dunque è con grande interesse che ho letto quest’ ultimo libro “Streghe”.
Le streghe e la stregoneria sono state sempre avvolte in un’aura fiabesca e diabolica, accomunate ad un sapere prescientifico o allo stereotipo magico. Le streghe inoltre sono state considerate le eretiche pericolose, vittime della perversione teologica dell’Inquisizione, testimoniata da testi esemplari della misoginia come il “Canon Episcopi” e il “Malleus Maleficarum”. Ora Anna Ventura, “cantadora” post-moderna, intellettuale e artista nutrita di studi classici, in questa sua raccolta poetica, segue l’itinerario di una memoria millenaria rivalutando l’aspetto antropologico e folclorico di un capitolo importante ma sotterraneo della storia del femminile. Nei versi che risuonano di quella antica sapienza accumulata in secoli di mutismo e sottomissione, la storia della donna coincide con quella dell’ “amara stirpe di Penelope”, perché qui la strega incorpora l’essere matrilineare, l’archetipo selvaggio. Così la poetessa si avventura su un territorio animico e memoriale per sondare la profonda labilità di un sentire, quello del ” restare / per partire nella lontananza del cuore”. Questa la presenzialità della poesia di Anna Ventura, così densa di “rinvio e indicatività”. Una meditazione sopra le Cose che vira il dettato poetico verso l’icasticità. Strega è il numen femminile sotto il quale sono ordinate le storie evocatrici di un mondo antico ma presente: la Donna in Nero ad esempio,
È un’antica donna siciliana, vestita di nero, unico gioiello
la fede nuziale.
Così come le protagoniste anonime di un mondo agricolo o le “vecchie signore”, che poi nell’andamento dei versi, in una sorta di procedimento incantatorio o trance interattivo, “In itinere”, per citare il titolo di un testo, e ricalcando altre identità, si fanno alter-ego dell’autrice:
Passeggiando per la vecchia Europa
come il bambino nella stanza dei giocattoli
riconosco cose che mi appartengono…l’anello, la spilla, gli orecchini
e quel medaglione rotondo
che portavo nel petto,
quando ero una signora dell’altro secolo.
Tempo interno, inter-psichico, luoghi della memoria, oppure elenco di oggetti -incubatori di affezioni che aprono squarci nello spazio-tempo, ma anche riti agricoli e paesaggi interiori, la Maiella o la natura morta del barocco siciliano: oltre al portato storico e immaginifico, una congerie di significazioni inconsce e latenti, elaborano una potente mappa animica e interattiva di corrispondenze psichico-spirituali.
E la poetessa stessa dichiara: «Da sempre mi divido tra i suggerimenti della ragione e quelli della fantasia; oggi li sento finalmente quasi unificati». Scrive Linguaglossa a proposito del linguaggio di Anna Ventura: «nella sua poesia è in gioco il linguaggio, sono in gioco nientemeno che le sorti del linguaggio, il gioco nelle sue mani diventa una leggerissima ironia frutto di saggezza e di dirittura di poesia…fuori dagli schemi e dalle parole d’ordine del novecento, quel novecento che lei ha attraversato con cognizione di causa fin dal 1972 quando diede alle stampe il suo libro di esordio dal titolo significativo: Brillanti di bottiglia…»
"Mi piace""Mi piace"
Come sempre mi succede in quest’ultimo periodo, devo esordire scusandomi con gli amici dell’ “Ombra” ed in particolare in questo caso con l’autrice cui è dedicato l’articolo, la “nostra” Anna Ventura , per l’enorme ritardo nel mio intervento, ma purtroppo esorbitanti impegni di lavoro ed un piccolo problema personale non mi consentono in questa fase di seguire con assiduità i pregevolissimi contributi della nostra rivista.In effetti ero incerto sulla pubblicazione di questo commento, proprio perché mi sento – in questo periodo di Giro d’Italia – come un corridore che giunga al traguardo fuori tempo massimo, ma alla fine mi sono convinto, complice soprattutto la mia grande “com-passione” per la poetica di Anna Ventura. Sono tante le voci conosciute, incontrate tramite l'”Ombra delle parole” che sono assurte a punti di riferimento poetici assoluti e non a caso ho utilizzato spesso anche i miei precedenti commenti l’aggettivo “antropologico” come inevitabile prerogativa aggregata al progetto di una “nuova ontologia estetica”: una “nuova ontologia” è complementariamente anche “nuova antropologia” andando a scavare, incidere nella articolazioni e nelle pulsioni più profonde dell’esistenza e della storia. Avendo personalmente sempre nutrito una tale visione della poesia, evidentemente l’incontro con la NOE ed i suoi poeti è risultato per me immediatamente coinvolgente. Oltre che nelle poetiche dei singoli autori, c’è un leit motiv che mi unisce profondamente alla “weltanschauung” dei tanti autori della NOE; come evodenziato nell’incipit della nostra rivista,”l’uomo abita l’ombra delle parole” ed è in quella zona d’ombra che i nostti poeti operano,oltrepassando i limiti convezionali della poesia degli ultimi quarant’anni ed agendo quasi da archeologi,filologi e direi persino scultori della parola,restituendole la sua versatilità la sua forza demiurgica. Quest’approccio epistemologico consente ai poeti di calarsi nelle vesti di moderni Virgilio, guidandoci alla radice della stesso fenomeno dell’esperienza espressiva ed esistenziale dell’uomo; strategia di ricerca che culmina nel travalicamento degli steccati narrativi convezionali, sintattici, temporali e spaziali della poesia e dell’arte stinte nei canoni dell’appiattimento mediatico. Mi incanta letteralmente la modalità con cui i poeti della Noe riescano in tanti casi, a procedere per sbalzi, per frammenti nella loro narrazione, ricostituendo il nucleo ontologico più profondo della parabola umana;proprio in questi giorni sono immerso nella lettura di “In viaggio con Godot” del maestro Mario Gabriele, esempio eccelso ed emblematico di questa visione e concezione poetica. In tale contesto, la poetica di Anna Ventura assume un rilievo particolare per me, per la “circolarità” della sua poetica, con la sua tendenza a “riportare tutto a casa”;. Anna segue cioè una traccia iniziale legata a temi e nuclei di ispirazione poetica che la conducono in navigazione dal particolare al generale, verso rotte universali del viaggio dell’umanità, per ricollocare le scaturigni della sua ricerca nella stessa cornice archetipica originaria, che assume per lei una funzione simbolica di punto d’osservazione, lente focale ed insieme laboratorio artigianale della sua creazione poetica, conferendole così, nella pluralità, poliformità, delle suoi itinierari, un “ubi consistam” ordinatrice, ammaliante a sua volta per la sua ancestralità. Ogni viaggio antropologico non prevede il puro smarrimento, bensì un tentativo costante di aggiornamento e dilatazione delle proprie categorie cognitive ed è dunque un costante itinerario di andata e ritorno – circolare appunto – nel quale il percorso tutto trova il suo naturale coronamento. In questa complessa traiettoria circolare si esprime dunque l’antropologia poetica di Anna Ventura, che ringrazio per il costante riferimento che la sua poetica ha assunto per me da quando ho avuto l’opportunità di approfodirla.
"Mi piace""Mi piace"
Sono lusingatissima dai vostre riscontri critici tanto acuti e pertinenti quanto onesti e sinceri. Stiamo attraversando un momento storicamente confuso,incerto e contraddittorio;se ancora si usassero le spade, saremmo in un mare di sangue; per ora, siamo solo in un mare di fango, su cui navighiamo con le nostre piccole barche a vela, le “paranze”di cui, in Abruzzo, serbiamo ancora qualche traccia.
"Mi piace""Mi piace"